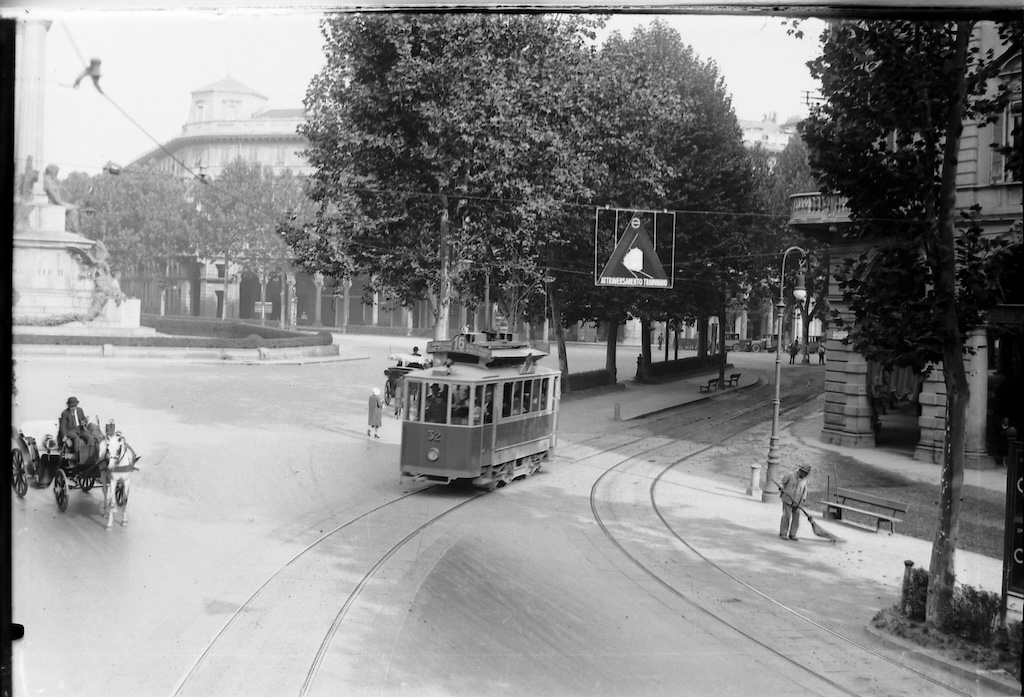Tranvài 2.0 è la nuova versione, più snella e moderna, del primo giornalino dell'Atts.
In ogni numero una selezione di alcuni articoli facenti parte queste categorie: Vita dell’Atts, Progetti significativi dell’Atts, Rapporti con altre associazioni, Restauro veicoli storici, Cronache tranviarie torinesi dai giornali d’epoca, Storia dei trasporti di Torino e dintorni, Aneddoti e fatti di costume, Curiosità dai libri dell’Atts, Tecnica tranviaria, Modellismo, I tram di… e Novità tranviarie dal mondo.

UN SECOLO ATTRAVERSO I GIARDINI REALI
di Luca Giannitti
Il 20 settembre (1870) è una data passata alla storia per la breccia di Porta Pia, a Roma, aperta dai bersaglieri del generale Cadorna, divenuta simbolo della fine dello stato pontificio e importante passo per la riunificazione d'Italia. Sempre il 20 settembre di qualche anno dopo, nel 1923, quella data venne celebrata con un avvenimento molto significativo per la città di Torino: è il giorno in cui si sarebbero dovuti aprire al traffico pubblico i Giardini Reali inferiori, ovvero la parte esterna ai bastioni della cinta muraria della città.
 Vista dei Giardini Reali nel Theatrum Sabaudiae
Vista dei Giardini Reali nel Theatrum Sabaudiae
La storia dei Giardini Reali risale al XVI secolo con il duca Emanuele Filiberto di Savoia che volle ergere Torino a capitale del suo regno e ne fece realizzare il primo nucleo in quella che era l’estrema periferia nord-est della città. Con l'occupazione Napoleonica e la demolizione della cinta muraria che portò alla realizzazione dei viali ottocenteschi circondanti la città (tra cui corsi Regina Margherita e San Maurizio), il terreno compreso tra questi nuovi assi e i Giardini Reali originari venne annesso al Giardino alto, costituendo gli attuali Giardini Reali inferiori.
 Al tempo quest'area era chiusa da un muro in mattoni e nel 1864 venne scelta per ospitare il serraglio reale, una sorta di giardino zoologico privato di Vittorio Emanuele II.
Al tempo quest'area era chiusa da un muro in mattoni e nel 1864 venne scelta per ospitare il serraglio reale, una sorta di giardino zoologico privato di Vittorio Emanuele II.
A seguito dell’apertura del prolungamento di via XX Settembre a ovest e di via Rossini a est, divenne sempre più forte l’esigenza di un’arteria intermedia tra le due vie e il Demanio concesse al Comune un’area per aprire quello che oggi è il viale dei Partigiani. Con la medesima convenzione si destinò a parco pubblico la zona del giardino basso. L'esecuzione delle opere venne deliberata nel 1914 dall'amministrazione comunale, presieduta dall'on. conte Teofllo Rossi, e nel 1916 iniziarono i lavori secondo il progetto definitivo dell'ing. Giorgio Scanagatta, capo dell'ufficio tecnico municipale. A causa della guerra, prima, e di problemi vari, dopo, i lavori procedettero molto lentamente, giungendo a conclusione solo nel 1923.
 Stato iniziale
Stato iniziale
 Progetto di fornice unico con singole colonne
Progetto di fornice unico con singole colonne
 Progetto con 3 fornici, di cui il centrale maggiore, intervallati da pilastri in bugnato
Progetto con 3 fornici, di cui il centrale maggiore, intervallati da pilastri in bugnato
 Progetto con 4 fornici di uguale dimensione intervallati da pilastri in bugnato
Progetto con 4 fornici di uguale dimensione intervallati da pilastri in bugnato
L'apertura del nuovo viale implicava due opere fondamentali: un cavalcavia per mantenere la comunicazione delle parti alte del giardino e un'apertura attraverso il palazzo del governo in piazza Castello. Per quest'ultimo erano stati presentati tre progetti che ipotizzavano tre diversi porticati che permettessero di superare l'ostacolo del palazzo, senza chiaramente abbatterne nessuna sezione. Dei bozzetti originari, qui riprodotti, alla fine fu realizzato l'ultimo con la variante delle colonne binate in pietra invece dei pilastri bugnati in laterizio disegnati. I binari, presenti fin dall'inizio, attraversavano singolarmente i fornici di piazza Castello mentre poi si affiancavano sul lato ovest e percorrevano così tutto il tragitto fino a corso Regina Margherita, passando insieme sotto all'arcata di ponente del cavalcavia.
 Una immagine dell'inaugurazione del 29 settembre 1923
Una immagine dell'inaugurazione del 29 settembre 1923
 Vista aerea del cavalcavia dei Giardini Reali con un tram della linea 18
Vista aerea del cavalcavia dei Giardini Reali con un tram della linea 18
L'inaugurazione doveva avvenire il 20 settembre 1923 alla presenza di Mussolini, ma non fu possibile a causa dei suoi impegni diplomatici a Belgrado per la questione di Fiume. Parallelamente anche la salute delle principesse Mafalda e Giovanna destava pubblica preoccupazione tanto che la cerimonia fu posticipata al sabato 29 settembre. Alle ore 10.30 del giorno inaugurale, alla presenza della principessa Letizia e del Duca d'Aosta si tiene la solenne cerimonia di apertura del cavalcavia: la principessa taglia il nastro, si sofferma a colloquiare con il direttore dell'Atm, l'ing. Giupponi, e finiti i suoi doveri si allontana a bordo di un'automobile; al contrario il Duca d'Aosta (Emanuele Filiberto di Savoia, il duca invitto commemorato dal 1937 dal monumento in piazza Castello lato via Po) e le altre autorità cittadine prendono posto a bordo di una delle tante vetture tranviarie della nuova linea 18 in sosta: con essa percorrono la salita fino in piazza Castello, dove dopo il breve viaggio scende dal tram e si allontana non senza complimentarsi per la riuscita dell'evento. Finita la cerimonia si concede la possibilità a tutti i cittadini di accedere al nuovo viale e le cronache del tempo raccontano di una diffuso apprezzamento per la novità.

Il 29 settembre si inaugurarono contemporaneamente sia la nuova linea 18 che il transito nei Giardini Reali: la linea 18 (antica Barriera di Nizza-Corso Palermo) era il risultato dell'unione della linea N (Barriera Nizza-Piazza Castello) della ex compagnia Belga con il prolungamento, di nuova costruzione, per Piazza Castello, Giardini Reali, corso Regio Parco, corso Palermo fino all'incrocio con via Bologna, dove veniva stabilito il capolinea provvisorio in attesa del completamento dei lavori della tratta fino a quello definitivo in Borgo Monterosa, nell'incrocio cioè di corso Palermo con corso Giulio Cesare (al tempo "Ponte Mosca"). Con l'istituzione del nuovo tragitto si stabilì che i vecchi abbonati alla linea N ottenessero il diritto alla libera circolazione sull'intera linea 18. Secondo le complesse tariffe del tempo la nuova linea veniva divisa in tre sezioni i cui confini sono segnati da corso Marconi (al tempo "del Valentino") e dal ponte di corso Regio Parco: la tariffa "normale" era valida per due sezioni e più precisamente per il tratto Antica Barriera Nizza-Corso Regio Parco e Corso Marconi-Corso Palermo (angolo via Bologna).

 Un momento del trasporto del monumento al Carabiniere verso i Giardini Reali
Un momento del trasporto del monumento al Carabiniere verso i Giardini Reali
Nel 1933 venne realizzato il Monumento Nazionale al Carabiniere e fu posato nei Giardini Reali. Nel corso dei decenni nulla è variato in questo angolo di Torino, solo gli alberi sono cresciuti, alcuni abbattuti durante la Seconda Guerra Mondiale, altri piantumati nuovi e nel frattempo cresciuti anch'essi...
 La linea 31 ripresa ai Giardini Reali negli anni Trenta
La linea 31 ripresa ai Giardini Reali negli anni Trenta
 La linea 18 ripresa nel 1937
La linea 18 ripresa nel 1937
Non sono molte le linee transitate in questo caratteristico punto della rete: dopo la linea 18 viene deviata per i Giardini Reali anche la linea 31 dal 1924 al 1937 quando lascia spazio alla linea 12. Con la riforma del 1966 resterà solo più la linea 31 (poi 24) gestita occasionalmente per il periodo della commemorazione dei defunti fino al 1972.
 La linea 12, deviata, ripresa nel 1992: sono gli ultimi
La linea 12, deviata, ripresa nel 1992: sono gli ultimi
Bisognerà attendere il 1994 per il ritorno del tram (sempre la linea 18, anche se post-rete'82) che vi resterà in modo (quasi) continuativo fino al 2007, anno in cui la linea 18 viene definitivamente sostituita dagli autobus. Solo nell'estate del 1998 si effettua un intervento alla geometria dei binari che sulla discesa di viale I Maggio li vede riposizionati in posizione divaricata ai due lati della strada, come anche nel transito sotto al cavalcavia. Tra l'altro il tratto in discesa risulta essere il più acclive di tutta la rete torinese: per quanto breve, raggiunge una pendenza del 8%!

Nel 2011 l'inaugurazione della linea storica 7 permetterà di rivedere il tram attraverso il verde della vegetazione che cresce rigogliosa alle spalle del centro della città di Torino, in quello che è forse il percorso più spettacolare di tutta la rete.
 2021: due tram storici ripresi nel passaggio sotto ai fornici del cavalcavia dei Giardini Reali
2021: due tram storici ripresi nel passaggio sotto ai fornici del cavalcavia dei Giardini Reali

IL RONDÒ RIVELLA
di Luca Giannitti
Nella consuetudine torinese sono presenti degli appellativi non ufficializzati dalla toponomastica cittadina: senza scomodare i casi di abbreviazioni (es. corso Vittorio) o diminutivi (es. piazza Carlina), esistono proprio dei luoghi i cui nomi non si trovano negli elenchi ufficiali, come largo Marconi (lo slargo all'incrocio con via Nizza è senza nome), Rondò della Forca (l'incrocio tra corso Regina Margherita e corso Principe Eugenio) e Rondò Rivella (corso Regina Margherita e corso Regio Parco). Quest'ultimo luogo tocca da vicino Atts perché è il punto dove transita la stragrande maggioranza dei giri con i tram storici e il suo nome resta sulla bocca di tutti, spesso senza conoscerne la storia che si cela dietro.
Partiamo dal nome. Si dice "Rondò" perché storicamente è stato una rotonda negli anni Sessanta, i binari e le automobili non percorrevano corso Regina Margherita in rettilieno ma dovevano girare attorno a una isola di traffico centrale. Solo tra gli anni Settanta e Ottanta la strada sarebbe stata nuovamente rettificata, ma nell'immaginario collettivo la rotonda è rimasta. "Rivella" invece deriva dalla coppia di edifici che incorniciano lo slargo sul lato nord e apre in modo scenografico corso Regio Parco. Gli edifici sono opera dell'architetto torinese Eugenio Vittorio Ballatore di Rosana (1880-1948, già autore dello Stadium e del Motovelodromo) che li ha realizzati nel 1929 in uno stile tardo eclettico, mescolando l'impostazione ottocentesca della "Porta urbana" (l'imbocco monumentale di un boulevard urbano) con decorazioni Art Déco e un uso delle linee geometriche prossime allo stile Novecento caratterizzato anche dall'alternanza di laterizi e fasce intonacate.
 Le torri Rivella in costruzione nel 1929.
Le torri Rivella in costruzione nel 1929.
 Vista della torre Rivella di destra con l'insegna dell'omonima pellicceria, foto anni Cinquanta.
Vista della torre Rivella di destra con l'insegna dell'omonima pellicceria, foto anni Cinquanta.
La committenza è attribuita a Francesco Rivella, ricco imprenditore co-fondatore del Casino di Saint Vincent (Valle d'Aosta) e proprietario di un atelier di pellicceria, particolarmente famoso negli anni Cinquanta e Sessanta, per il quale i nuovi palazzi sarebbero diventati l'imponente nuova sede (cosa effettivamente realizzata, come testimoniato dalle insegne sul palazzo lato nord-est posto al civico 98 di corso Regina Margherita, sede ufficiale dell'attività). Il successo dei suoi prodotti arrivò perché affiancò la conceria alla pellicceria, fu il primo a tingere le pelli di castoro nei colori che erano allora di tendenza e usò con maestria e in modo massiccio la pubblicità, segnando una strategia ripresa anche dai concorrenti e dando un forte impulso al settore. Grazie a questi successi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al sig. Francesco Rivella è stata conferita il 2 giugno 1956 l'onoreficenza di "Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana", riconoscimento destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Alla sua morte l'attività fu portata avanti, per poco tempo, dai dipendenti senza particolare successo. Francesco Rivella non ha alcuna biografia nota ma da alcuni documenti del consiglio della Val d'Aosta (dove è indicato "Gr. Uff. Francesco Rivella fu Bartolomeo") si evince che è figlio di Bartolomeo Rivella.
 "Il signor Rivella* indossante uno dei suoi vestoni" (*Bartolomeo)
"Il signor Rivella* indossante uno dei suoi vestoni" (*Bartolomeo)
Di Bartolomeo Rivella, invece, si hanno più notizie grazie alla guida "Augusta Taurinorum. Torino illustrata nelle sue Cose e nei suoi Cittadini" che, nell'edizione pubblicata nel 1901, lo cita come "Prima Conceria e Tintoria Italiana per Pelliccerie e per Vestiarii d’ogni genere, da Automobilisti, Ciclisti, ecc." con sede in Strada del Regio Parco numero 1 e che ne racconta così le caratteristiche salienti:
"Nel 1871 l’intraprendente Rivella impiantava in Torino, su modeste basi, questa industria, e la pratica che nell’articolo si era acquistata lavorando nelle primarie fabbriche dell’estero, gli assicurarono ben presto una buona fama, che, mercé il suo attivo lavoro e l’onestà del suo trattare, egli seppe sempre conservarsi.
Il Rivella fa annualmente forti acquisti negli incanti di Londra di merce proveniente dalle Americhe, e nel suo Stabilimento la merce originaria greggia si concia, si lavora e si confeziona secondo il gusto e le richieste della sua elegante clientela. Dal più piccolo oggetto di pellicceria, come boas, manicotti, ecc., ai grandi mantelli, sia per uomo che per signora, tutto si eseguisce nello Stabilimento Rivella. E questi ebbe il merito di escogitare un genere nuovo e di riuscirvi egregiamente. Intendiamo parlare dei suoi Vestoni di vitello annerito per alpinisti, automobilisti, ciclisti, cavallerizzi, amazzoni, ecc. Corazzati di simili coperture, le intemperie non possono più influire sul nostro debole corpo, che in tal modo è reso invulnerabile e inaccessibile alle influenze del vento, del freddo, dell’acqua, della neve.
Questi lavori, di cui il Rivella garantisce sempre la ottima bontà e gli effetti promessi, ottennero ovunque un grande favore: a Parigi, a quella Mostra del 1900, dove convennero migliaia e migliaia di espositori da tutte le parti del mondo, il Rivella era l’unico che presentasse questi tipi di Vestoni di vitello annerito, e per essi otteneva il Gran Premio; a Torino, al Concorso automobilistico dello stesso anno, gli veniva conferita la medaglia d’argento.
Il Berretto di riccio Umberto I, fabbricato dal Rivella, è un non plus ultra del genere; basti accennare al fatto che il compianto Re Umberto I aggradì tanto uno di questi berretti offertogli, che volle compensarne l’intelligente industriale con uno splendido spillo portante la corona e l’iniziale reale circondata da magnifici brillanti.
E qui terminerà il nostro dire non senza tributare un elogio di cuore al solerte e benemerito Rivella, che ha saputo trovare un genere tanto utile, e direi quasi umanitario, per la innumerevole classe degli automobilisti e touristi in genere."
Il figlio Francesco sfruttò in modo proficuo l'esperienza della conceria che, affiancata alla pellicceria, gli permise di confezionare capi innovativi con cuoio e pelliccia. Da notare come la posizione della conceria del padre, sita in corso Regio Parco 1, sia probabilmente il motivo principale per cui gli edifici della nuova sede sorsero proprio qui nel 1929.
 Manifesto pubblicitario anni Trenta.
Manifesto pubblicitario anni Trenta.
Altrettanto articolata è la storia dell'evoluzione della disposizione dei binari su questo incrocio. È importante una premessa: nel proseguo dell'articolo si presenterà la situazione dei binari in alcuni momenti storici e le geometrie sono state ricavate da foto e documentazione, che purtroppo non coprono al 100% né l'arco temporale, né l'intera area. Risulta ovvio che in presenza di nuovi documenti, l'articolo potrà essere corretto o integrato. Si ringraziano i soci Atts Paolo Chiesa, Antonio Accattatis, Emiliano Aichino e Michele Bordone per il supporto fornito.
La prima linea a transitare, nell'epoca dei cavalli, sull'asse che da corso Regina Margherita porta in corso San Maurizio è la linea della Barriera di Nizza (D), dal 1879, affiancata nel 1890 dalla linea dei Viali (G) e nel 1898 si apre l'asse di corso Regina Margherita con l'omonima linea che da Porta Palazzo raggiungeva la Barriera di Casale. La linea Torino-Settimo, ante elettrificazione, viaggiava sul controviale sud di Corso Regina (a binario unico) per poi svoltare al Rondò Rivella su corso Regio Parco. Ma c’era anche l'originaria linea 4 Atm che, non potendo viaggiare sui binari della Belga, occupava l’altro controviale, a nord, da Porta Palazzo fino al rondò dove poi proseguiva nel viale centrale, in un tratto di corso Regina Margherita occupato da ben 4 binari.


Il crocevia negli anni 10 con in vista i binari di corso San Maurizio e la disposizione dei binari negli anni Dieci. In verde i binari Atm, in rosso i binari della Belga e in nero il binario banalizzato della tranvia interurbana Torino-Settimo.
Nel 1923 la rete Belga riscattata dal Comune di Torino e il 20 settembre dello stesso anno si ha l'apertura dei binari dei Giardini Reali con il transito della linea 18, prima linea della nuova rete unificata, che dall'allora viale Principessa Maria Letizia si dirigeva direttamente verso corso Regio Parco.

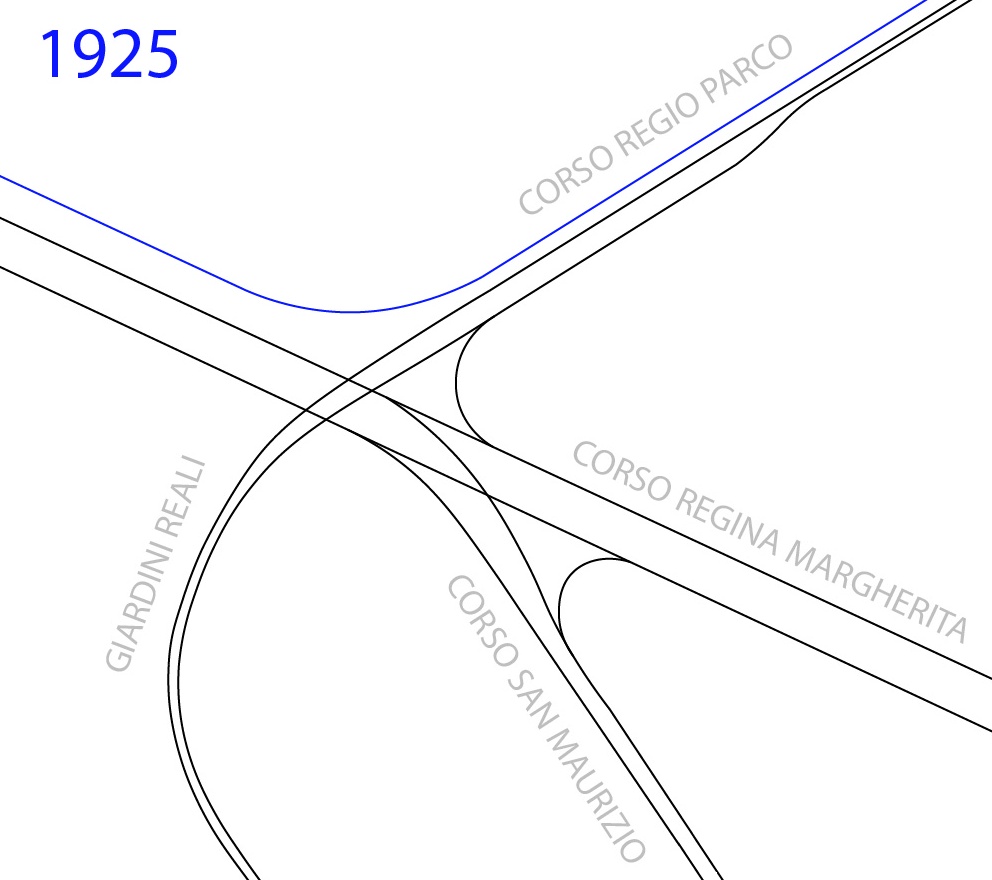
In questa carta si vede la situazione nel 1925, con le linee 7 e 17 che percorrono corso Regina Margherita, la linea 16 che svolta su corso San Maurizio e le linee 18 e 31 che dai Giardini Reali tagliano il corso per inoltrarsi su corso Regio Parco. L'immagine invece è del 1929 e ci presenta bene la geometria dei binari della parte est del crocevia.
La tranvia di Settimo, con l'elettrificazione del 1925, è stata spostata sul controviale nord di corso Regina (capolinea di fronte alla caserma dei vigili del fuoco) e svolta (sempre a binario unico) su corso Regio Parco.
 Vista delle torri Rivella, appena costruite, da corso San Maurizio, anno 1929/30.
Vista delle torri Rivella, appena costruite, da corso San Maurizio, anno 1929/30.
Nel 1939 la linea per Settimo fu ceduta dalla STEP al Comune di Torino attraverso la SATTI nell'ambito di un piano di riordino delle tranvie intercomunali torinesi. Con la nuova gestione si modifica anche il capolinea che viene spostato da corso Regina Margherita all'Autostazione Dora, si posa quindi un binario di raccordo che percorre le vie Fiochetto e Gené e i binari vengono razionalizzati.

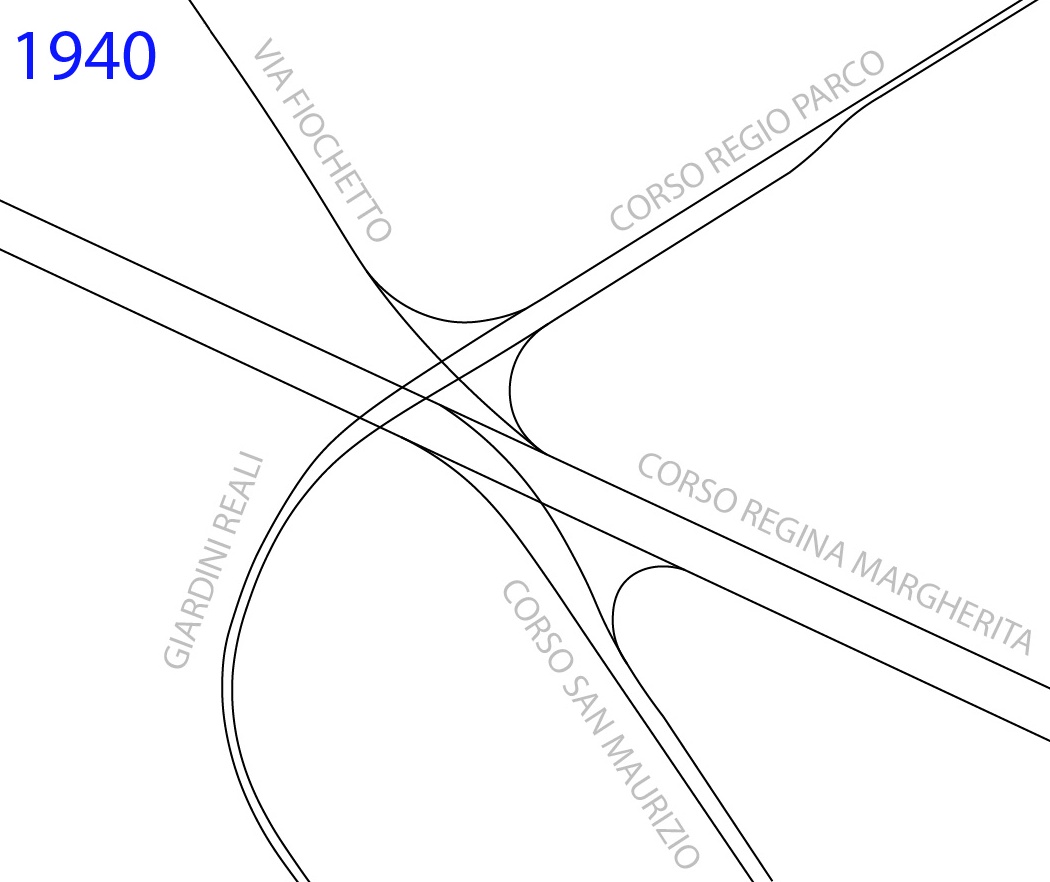
L'immagine e il relativo schema dei binari raffigura la situazione tra il 1939 e il 1955 con i binari di corso San Maurizio con lo spostamento del capolinea della linea Torino-Settimo all'Autostazione Dora con la conseguente posa di un binario di raccordo su via Fiochetto.
Il 19 novembre 1955 avviene la chiusura dei binari di corso San Maurizio con la deviazione della linea 16 su via Rossini e corso Regina Margherita. In questo momento storico avviene la creazione della rotonda e si può quindi datare il conio del termine "Rondò Rivella".


Stessa inquadratura un decennio dopo, notare i binari di corso Regina Margherita non più rettilinei ma che si allargano per la rotonda.
 Cartolina con vista di corso Regina Margherita con il "rondò".
Cartolina con vista di corso Regina Margherita con il "rondò".
L'asse dei binari di corso Regina Magherita viene interrotto da una rotonda che collega i binari dei Giardini Reali e di corso Regio Parco. Così resterà fino ai primi anni Ottanta, quando la costruzione della linea 3 di metropolitana leggera e il futuro arrivo dei tram serie 7000 impongono una serie di modifiche alla rete al fine di garantirne la circolabilità. I tram serie 7000 hanno un raggio di curvatura minimo di 25 metri, oltre 10 metri in più rispetto al resto dei tram in circolazione (serie 2500, 2700, 2800 e 3100).
Il primo intervento riporta i binari rettilinei dell'asse di corso Regina Margherita, poi all'arrivo dei due prototipi 7000 e 7001, al fine di rendere accessibile il tratto di corso Regio Parco per le prove, si realizzano due raccordi diretti che tagliano la rotonda: con i loro 25 metri di raggio minino, i tram non potevano percorrere la perimetrale. Vengono aggiunti anche dei flessi per permettere l'inversione di marcia ai nuovi tram bidirezionali. Il raccordo che da corso Regio Parco svolta a sinistra in corso Regina Margherita resterà in opera fino al 1992, quando i lavori di rinnovo binari lo elimineranno, contestualmente alla dismissione dell'impianto a lato del Cimitero Monumentale. Durante questi lavori di rinnovo viene posato il nuovo binario di scarto su corso San Maurizio, quasi a ripercorrere il vecchio sedime dell'impianto dismesso nel 1955. I tram serie 7000 potevano percorrere esclusivamente i binari di corso Regina Magherita, il binario di scarto su corso San Maurizio e potevano arrivare sul ponte di corso Regio Parco ma solo arrivando dal fiume Po.


Schema dei binari nel periodo tra il 1987 e il 1992; più a sinistra una foto di un tram serie 7000 ripreso nel 1994 al Rondò Rivella, poco dopo i lavori al rinnovo dei binari.


Oggi l'impianto dei binari presenta una rotonda tranviaria completa con l'attraversamento diretto dell'asse di corso Regina Margherita e un tronchino di scarto su corso San Maurizio, presente solo arrivando da Porta Palazzo. Vi sono 9 scambi di ingresso e 8 di uscita, due scambi sono manuali, tutti gli altri con impianto a radiofrequenza. Il raggio interno nella rotonda è compreso tra 17 e 18,5 metri.
 L'ultimo intervento ai binari sul Rondò Rivella è avvenuto nel luglio 2017 quando è stato sostituito uno scambio e un tratto di binario pesantemente rovinato nella perimetrale nord. L'immagine a lato fa riferimento alla fase iniziale dei lavori.
L'ultimo intervento ai binari sul Rondò Rivella è avvenuto nel luglio 2017 quando è stato sostituito uno scambio e un tratto di binario pesantemente rovinato nella perimetrale nord. L'immagine a lato fa riferimento alla fase iniziale dei lavori.
Rondò Rivella resta così un toponimo misterioso, una rotonda solo più tranviaria e un crocevia dalla ricca storia ma dalla poca considerazione di turisti e guide: un vero peccato, considerato che si trova a due passi dalla centralissima piazza Castello.

IL TRAM SU GOMMA
di Roberto Cambursano
In Francia nell’anno 2000 si affacciò sulla scena il “tram su gomma”, che prometteva di essere un sistema di trasporto innovativo e competitivo rispetto al tradizionale tram su ferro ma che era destinato invece a deludere presto le aspettative.
E’ un sistema che si colloca a metà strada tra il tram e il filobus: si avvale di ruote gommate portanti, mentre la guida in condizioni normali è di tipo “vincolato” al pari di un normale tram: ciò si realizza tramite una particolare rotaia centrale nella quale scorrono piccole ruote metalliche poste sotto il veicolo.
| Anno di prima apertura | Città | Nazione | Numero linee | Sistema | Lunghezza rete | Flotta veicoli | Anno di chiusura |
| 2000 | Nancy | Francia | 1 | GLT | 11 km | 25 | 2023 |
| 2002 | Caen | Francia | 2 (A+B) | GLT | 16 km | 24 | 2017 |
| 2006 | Clermont-Ferrand | Francia | 1 | Translohr | 16 km | 20 | |
| 2007 | Padova | Italia | 1 + 1* | Translohr | 10 km | 16 | |
| 2007 | Tianjin | Cina | 1 | Translohr | 8 km | 8 | |
| 2010 | Shanghai | Cina | 1 | Translohr | 10 km | 9 | |
| 2010 | Venezia | Italia | 2 (T1+T2) | Translohr | 20 km | 20 | |
| 2013 | Parigi | Francia | 2 (T5+T6) | Translohr | 19 km | 43 | |
| 2016 | Medellin | Colombia | 1 | Translohr | 4 km | 12 |

CAMPIONATO EUROPEO DEI TRANVIERI E 150 ANNI DEL TRAM A LIPSIA
di Mario Positello
Non solo a Torino si festeggiano i 150 anni del tram. Anche alcune grandi reti tedesche hanno raggiunto quest'anno, questo importante traguardo.
In particolare a Lipsia (Leipzig in tedesco) la celebrazione per i 150 anni, è avvenuta in contempoaranea con la manifestazione internazionale "Tram-EM" (European TramDriver Championship), il campionato europeo dei tranvieri, giunta alla sua nona edizione. Il 22 maggio, squadre di 2 tranvieri ciascuna, appartenenti a diverse aziende di trasporto europee si sono sfidate attraverso alcune vere e proprie gare di abilità con il tram. Il campionato, ovviamente di invenzione tedesca, si svolge ogni anno in una diversa città, ed ha visto ques'anno la partecipazione di 25 squadre, di cui l'Italia era rappresentata da Firenze. Valentina Danesi e Luigi Matino hanno chiuso al 14° posto, mentre la vittoria è andata ad Hannover cha ha preceduto Lione e Berlino.
Da segnalare la presenza di Melbourne, con l'Australia che partecipava per la prima volta, un po' sulla falsa riga degli European Vision Song Contest.
Le gare in totale erano 6, svolte su 2 turni, per la quale veniva assegnato sia un punteggio che valutato il tempo impiegato e consistevano in:
- frenare in un determinato punto in fermata;
- Posizionare manualemente vicino a un binario in curva, una sagoma, appena al di fuori della fascia di ingombro del tram, in modo tale che questi non la toccasse ma ci passase il più possibile vicino;
- Frenare a 30 km/h entro un certo punto;
- Arrestare il tram entro un cento posizione tramite la frenatura d'emergenza attraverso il dispositivo vigilante, senza intervenire sui normali comandi freni;
- "Billiardo" con il tram che spinge delicatamente una stecca da billiardo e in base a dove si ferma la biglia viene assegnato un punteggio;
- "Tram bowling" con il tram che spinge una enorme palla che colpisce dei birilli;
Data la presenza di tranvieri "forestieri" sono state utilizzate 3 vetture moderne del parco della LVB, più "familiari" da guidare rispetto ai Tatra con inseritore a pedali.
Teatro della manifestazione è stata la caratteristica Augustusplatz, uno dei principali nodi tranviari della città, dove circa 50.000 persone si sono alternate nel corso dell'evento, durato l'intera giornata. Qui di seguito alcune foto dell'evento, gentilmente concesse da Paul Schmidt dal sito l.nv-info.
A causa della interruzione dovuta al rinnovo dei binari sulla Kurt-Schumacher straße, che rappresenta il collegamento diretto tra il museo di Wittenberger Straße e la zona centrale della città, la parata è avvenuta su un breve percorso ad anello, attiguo allo stesso museo, che dal 2019 ospita una delle più grandi collezioni di vetture d'epoca a livello mondiale.
Il percorso breve ha infatti permesso di far uscire tutte le vetture restaurate del museo (comprese alcuni mezzi statici trainati) per un totale di 36 mezzi storici più le 6 vetture più moderne del parco della LVB, che si sono avvicendate nel corso della manifestazione, durata tutto il pomeriggio.

AUTOCARRO 306. UN MEZZO DI SERVIZIO NELLA COLLEZIONE ATTS
di Davide Fenoglio e Luca Giannitti
È con grande piacere che comunichiamo un nuovo e particolare arrivo, un veicolo che si aggiunge alla collezione ATTS, che non è composta da soli tram, ma anche da qualche mezzo su gomma: si tratta dell’autocarro di servizio n. 306 che vedete in foto.
Il veicolo è stato allestito nel 1982 dall’Atm sul telaio di un veicolo stradale Fiat 682 T4 del Consorzio Torino-Rivoli, acquistato nel 1956 dal Consorzio Torino Rivoli, che l'aveva poi passato all'azienda municipale dove aveva ricevuto la matricola C90. Nel 1978, dopo circa 20 anni di servizio il veicolo ha ricevuto una carrozzeria totalmente nuova realizzata con parti di ricambio di autobus Fiat 418 in consegna all'epoca e con un allestimento posteriore da carro-soccorso. In occasione del riordino dei veicoli di servizio avvenuto nel periodo olimpico, il C90 viene completamente revisionato, ricolorato in bianco (secondo la nuova livrea scelta dal GTT per gli autocarri e le auto di servizio) e rinominato 306.
Nell’azienda tranviaria, date le caratteristiche (marce ridotte e zavorra) è stato impiegato per interventi in linea sui tram, soprattutto in caso di deragliamenti. Per lunghi anni è stato assegnato al deposito San Paolo. Nell’ambito del rinnovo del parco veicoli, il veicolo è stato sostituito da un nuovo autocarro e ritirato dal servizio.
Date le peculiarità e la storia del mezzo, la rottamazione sarebbe stata una grande perdita.
Ringraziamo perciò il GTT che lo ha donato alla nostra associazione affinché venisse preservato. Sarà utilizzato in occasioni speciali, per esposizione e trasporti di materiale. Il veicolo è funzionante, ha la targa originale e presenta ottime condizioni estetiche. È allo studio la riverniciatura in arancione, colore che aveva in origine e il ripristino delle scritturazioni originarie.
IMMAGINI (foto archivio ATTS e GTT)

Presentato il nuovo tram Hitachi serie 8000
di Alessio Pedretti
In occasione della Settimana Europea della Mobilità, durante le giornate di Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022 nei pressi di Piazza Castello a Torino (lato Teatro Regio), ha fatto il suo primo esordio al pubblico la nuova elettromotrice Hitachi serie 8000 di GTT Gruppo Torinese Trasporti Torino, presentato in collaborazione con Hitachi Rail. L'elettromotrice risultava accessibile al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.00, in particolare la protagonista dell'avvenimento è l'elettromotrice matricola 8003 risultante essere in questo momento la vettura maggiormente completa, vettura che ha seguito l'ordine delle consegne dopo le gemelle 8001 ed 8002, vetture che tuttavia abbiamo avuto occasione di fotografare con comodità buttando una occhiata all'interno dello Stabilimento Tortona. La prima vettura di tale serie è giunta il giorno 11 Febbraio 2022 ed ha iniziato dopo qualche settimana ad effettuare le prove notturne di circolazione.
L'elettromotrice 8003 è stata in quest'occasione solamente trainata in Piazza Castello ed ancora non risulta essere abilitata al trasporto passeggeri, si presume che la messa in esercizio di tali elettromotrici potrà avvenire a Dicembre 2022 e la prima linea che dovrebbe vederle in esercizio è la 3 Vallette - Corso Tortona, data l'assegnazione di tali vetture allo Stabilimento Venaria. E' prevista la consegna di 70 nuove elettromotrici che andranno via via a subentrare come minimo alle vetture più anziane serie 2800. Vi è da ricordare che la nuova serie 8000 è unidirezionale (presenta un salottino finale) ed è dotata di due postazioni per diversamente abili, sono presenti vetrate superiori che donano una maggiore luminosità, mentre per le caratteristiche è importante segnalare la lunghezza di 28 metri, l'offerta di 218 posti in piedi e totale di ben 254 posti nonché una velocità massima di 60 km/h.
Nelle FOTO, tutte del 17 Settembre 2022, è possibile osservare l'elettromotrice 8003 esposta in Piazza Castello ed accessibile al pubblico, occasione durante la quale non si è persa l'occasione per darle il benvenuto grazie ad ATTS Associazione Torinese Tram Storici si è potuto organizzare ed offrire in parallelo alcuni viaggi con le note elettromotrici storiche 116 e 502; al tempo stesso è possibile osservare un'immagine delle elettromotrici 8001 ed 8002 ritratte di sfuggita presso l'officina centrale GTT.

Quell'ultimo tram
di Stelio Yannoulis con Fabio Celaia
Pubblichiamo un interessante articolo, apparso sulla rivista "4 Piccole Ruote" nel numero di luglio/agosto 2022, sui tram di Bologna di cui ATTS ha recuperato un esemplare. Ringraziamo Stefania Ponzone, Direttore responsabile di 4 Piccole Ruote, Stelio Yannoulis, Presidente onorario del Fiat 500 Club Italia, e Costantino Cellie, autore del diorama, che hanno acconsentito ad inoltrarci la documentazione.
Le immagini di questo articolo sono tratte dall’opera del socio Costantino Cellie che ringrazio per la sua disponibilità e per aver fornito lo spunto per narrare questa storia antica, ma venata di grande attualità. Costantino ha raffigurato un momento preciso: domenica 3 novembre 1963, quando un tram della linea 13 fece la sua ultima corsa a San Ruffillo, una zona residenziale della prima periferia di Bologna, prima di rientrare definitivamente in deposito.
Ma come si è arrivati alla conclusione di questa vicenda? Il 2 ottobre 1880 si inaugura a Bologna la prima linea di tram a cavalli, collegando il tratto da Piazza Vittorio Emanuele II (l’unità d’Italia è relativamente recente e vige la monarchia; diventerà “della Repubblica” nel 1943 e nel giugno 1945 “Piazza Maggiore”) fino alla stazione ferroviaria. La concessionaria del servizio è una società belga dal nome impronunciabile per i bolognesi, i quali la ribattezzano semplicemente “Società Belga”. Il servizio, spartano e non di grande soddisfazione popolare, si estenderà negli anni successivi su ulteriori linee. Vicissitudini societarie e l'esigenza dell'ammodernamento dei tram porta nel 1897 ad una nuova gestione, sempre con una società belga. L'elettrificazione avvenne tra il 1903 e il 1904; nel 1914 la rete tranviaria misurava 48 km con 16 linee sparse per la città. Con questo traguardo raggiunto mutò l'aspetto di Bologna e le abitudini dei cittadini.
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale i rapporti tra la società di gestione e il Comune di Bologna diventano difficili e tormentati a causa di disservizi e di lamentele da parte dei passeggeri riguardo la ridotta estensione della rete tranviaria, i passaggi poco frequenti e vetture poco confortevoli. Come succede anche oggigiorno, il gestore con esigenze di guadagno non riuscì a conciliare i propri interessi con quelli dell'utenza. Dopo una tribolata vicenda, nel 1924 la società acconsente ad una transazione ed il passaggio del servizio, attrezzature comprese, al Comune per una cifra di 18 milioni di lire dell’epoca (circa 15 milioni di euro attuali). L’Azienda Municipale delle Tranvie di Bologna, costituita nel 1926, realizzò l’evoluzione tecnologica e l’estensione del servizio. Nel 1939 si raggiunse la massima espansione di 82 km. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e le distruzioni subite, si procedette alla ricostruzione e all’estensione di alcune linee, le quali saranno le ultime prima della dismissione del tram a Bologna.
Nel secondo dopoguerra mutò il corso dell'economia italiana, la quale incentrò tutto sull'automobile e la politica non mise più in campo risorse per il servizio tranviario. Le nostre città erano invase dalle auto, le quali venivano considerate la modernità e anche simbolo di libertà, mentre la rete tranviaria bisognosa di importanti investimenti, venne accantonata definitivamente nel 1953 con un piano decennale per la sostituzione del tram con autobus e filobus; iniziò così un lento, ma inesorabile declino, con dismissioni delle linee arrivando poi al 3 novembre 1963 con il diorama di Costantino.
È finita l'avventura del tram a Bologna? Sì o forse no; siamo in presenza di una gara d'appalto per una linea da attivare entro il 2026 la quale collegherà Borgo Panigale, quartiere popolare e molto caratterizzato dell'estrema periferia occidentale bolognese, al centro storico di Bologna stravolgendo tutto il tracciato del percorso di questa futura tratta. Un progetto sicuramente ambizioso, che ha già diviso tutta la cittadinanza (soprattutto quella residente nei quartieri interessati), con grandi discussioni e polemiche, ma tutto ciò lo potremo raccontare in futuro.
Costantino Cellie racconta il diorama che ha realizzato: "La scena rappresenta il tram n.13 della linea San Ruffillo, matricola 211, mentre transita da Via Toscana, in prossimità del Dazio al civico 180, dirigendosi per l'ultima volta al deposito Zucca. Ovviamente nel contesto storico non potevano mancare le nostre immortali 500, colorate e numerose. Ho creato questo lavoro su una base di 31x21 cm, su scala 1:87, che in gergo ferromodellistico si chiama H0, e il tutto è illuminato da mini lampioni alimentati a 3v. Con fatica sono riuscito a trovare un tram, che successivamente ho dovuto adattare a quello originale dell'epoca. Per ricreare il Dazio, usato nei tempi per scambio e tasse di merci, ho usato materiali di ogni tipo, dal legno al tappo di un lavandino, perché l'edificio aveva una caratteristica forma tonda".

150 anni del tram a Dresda
di Mario Positello
Dopo Lipsia, anche la "rivale" Dresda, ha festeggiato i 150 anni del tram.
La DVB (Dresdner Verhersbetriebe AG), l'azienda di trasporto locale, ha scelto come luogo dell'evento, lo splendido scenario del Ponte di Augusto (Augustusbrücke), da poco riaperto dopo una completa ristrutturazione, che attraversa il fiume Elba nella zona centrale della città, adiacente al ricostruito centro storico (Altstadt). Grazie a una buona campagna pubblicitaria, sia sui mezzi che sul web, nella giornata del 24 settembre, migliaia di cittadini e di turisti hanno potuto ammirare tutti i convogli tranviari storici dinamici, messi in esposizione dall'associazione Straßenbahmuseumn Dresden e.V. che ha contribuito anche con i propri volontari.
La DVB, che ha puntato molto su questo evento, ha allestito un grande palco e vari stand, davanti alla Semperoper, dove oltre ai classici discorsi di rito dell'autorità (all'evento oltre ai vertici dell'azienda hanno partecipato anche il sindaco di Dresda e il vice governatore del Land della Sassonia), si sono svolti vari spettacoli di intrattenimento sopratutto per piccini, concerti e la possibilità di acquiastare dei classici gadget di cui spiccavano una bella collezione di francobolli realizzati appositamente per i 150 anni. Per qaunto concerne più specificamente i tram, sono stati esposti 12 convogli storici e 3 tram moderni, oltre alla presenza di un tram Gotha + rimorchio impegnato in brevi giri su Neustadt.
Tra i veicoli esposti, meritano un breve approfondimento, la piccola vettura a due assi 937, risalente al 1927, che dopo un lunghissimo restauro, durato quasi 25 anni è ritornata funzionante e operativa proprio in questa occasione, e l'ultimo arrivato del parco DVB, il "Dicke Berta", il nuovo tram Alstom (già Bombardier, derivato dalla famiglia Flexity) serie NGTDXDD. Lungo 43.5 metri, ma largo 2.65 (contro i 2.30 standard) , per permettere maggior abitabilità a parità di lunghezza, entrerà in servizio a fine anno, sulla linea 2, l'unica al momento dove potrà circolare, a cui seguirà il prossimo anno anche la linea 3.
La manifestazione si è poi conclusa nel tardo pomeriggio, con la classica parata in centro, prima che i tram storici rientrassero a Trachenberge e quelli più moderni a Gorbitz.
IMMAGINI
fig.1 Foto MP/ La vettura 937, fresca di restauro sosta in Theaterplatz.
fig.2 Foto MP/ La Kathedrale Sanctissimae Trinitatis (costruita su progetto dell'architetto italiano Gaetano Chiaveri) fa da sfondo alla motrice 1716 "Großer Hect" (Grosso Luccio). Questa vettura, appartenente a un piccolo lotto di 10 vetture dalla forma "appuntita" (da qui il soprannomme) e con avviamemto semiautomatico realizzate nel 1931.
fig.3 Foto MP/ Qualche metro verso Augustusbrücke, sosta il "Kleiner Hect" (Piccolo Luccio) 1820, versione più corta a due assi della precedente 1716.
fig.4 Foto MP/ Convoglio "Lowa" degni anni cinquanta. Dietro si intavede una vettura tipo "Gotha" sempre a 2assi. A differenza delle città italiane, dove le ultime vetture a 2 assi e rimorchio furono costruite negli anni '20, nelle Germania ex DDR la produzione di questa tipologia di vettura continuò fino al 1975.
fig.5 Foto MP/ Non potevano mancare i Tatra T4D, qui con le due vetture riportate allo stato d'origine.
fig.6 Foto MP/ L'associazione Straßenbahmuseumn Dresden e.V. ha allestito sul Tatra 224 201 uno stand con vendita di libri/modellini/gadget dell'associazione
fig.7 Foto MP/ L'unico tram storico funzionante ma non esposto staticamente è stato il convoglio Gotha bidirezionale che ha compiuto una serie di giri tra Neustädter Markt/Carolplatz/Albertplatz/Bahnhof Neustadt durante la manifestazione. Qui davanti al Palazzo Giapponese; sulla sfondo, oltre Elba si intravede lo Yenidze. Tram tipo Gotha a due assi, Kirnitzschtalbahn a pochi km da Dresda, sulla linea 87 di sono ancora regolarmente in servizio, tutti i giorni, sulla Berlino/Woltersdorf e a Naumburg.
fig.8 Foto MP/ Festa finita...l'antica vettura 309 "Berolina" + rimorchio, dopo la parata in centro si dirigono verso il deposito/museo di Trachenberge. Qui sul ponte Marienbrücke. Sullo sfondo, quella che sembra una antica moschea, è in realtà una ex fabbrica di sigarette, lo Yenidze, edificio costruito nel 1909, ora adibito a centro culturale.
fig.9Foto MP/ Sempre su Marienbrücke, anche la 937 rientra a Trachenberge.
fig.10Foto MP/ Il grande palco allestito per l'evento con concerto della banda filarmonica.
fig.11Foto SF/ Una torta a tema tranviario non si vede tutti i giorni....
fig.12Foto MP/ Interni della 937 appena restaurati.
fig.13Foto SM/ Il nuovo tram di Dresde, serie NGT-DX-DD. Si nota la maggior larghezza delle casse, al di sopra dei carrelli, per aumentare l'abitabilità interna.
fig.14Foto MP/ Tatra prototipo T6A2 in arrivo a Neustädter Markt.
Infine un breve video della manifestazione sul canale ufficiale della DVB:

Il 26 e 27 novembre 2022 presso lo spazio espositivo della Stazione Sassi in piazza Gustavo Modena 6 a Torino l’Unione Filatelica Subalpina in collaborazione con GTT ed ATTS organizza la Mostra filatelica sul trasporto pubblico urbano in occasione dei 150 anni del tram a Torino. Per l'occasione è stato realizzato uno speciale annullo filatelico dedicato ai 150 anni dei tram di Torino. Sabato 26 novembre dalle 10 alle 13 sarà in servizio il "Tram Filatelico" prenotabile a partire dal 21 novembre sul sito https://tramfilatelico.eventbrite.it
Tra gli espositori Paolo Guglielminetti, autore del presente articolo.
I VARI TIPI DI SERVIZI POSTALI TRAMVIARI
La necessità di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza postale ha richiesto nel tempo l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto che si rendevano di volta in volta disponibili. Anche le linee tranviarie, sia urbane che extra-urbane, hanno svolto questo compito, con modalità, intensità, diffusione e durata spesso diverse da paese a paese. La seguente tabella sintetizza le diverse principali tipologie di servizi postali connessi con l’uso del tram, nonché la specifica diffusione degli stessi in Italia.
| Tipo di servizio postale tranviario | Descrizione | Utilizzato in Italia |
| Trasporto dispacci postali (servizi di messaggere e scortapieghi) | Trasporto di dispacci postali per conto dell’amministrazione postale, e (talora) lavorazione della posta raccolta alle stazioni | casi numerosi |
| Cassette postali sui tram | Cassette postali agganciate alle carrozze tranviarie per l’impostazione e l’avvio celere della corrispondenza | casi numerosi |
| Trasporto di giornali e pacchi sui tram | Servizio di trasporto tranviario di giornali e/o pacchi e pacchetti, in taluni casi con sistemi di pre-pagamento attraverso l’uso di speciali francobolli | casi rari |
| Trasporto di lettere spedite da privati gestito direttamente dalle società tramviarie | Servizio di trasporto tranviario di lettere con prepagamento attraverso l’uso di speciali francobolli | utilizzo non noto |
| Tram di servizio dell’amministrazione postale | Linee tranviarie con motrici speciali dedicate esclusivamente al trasporto delle corrispondenze, generalmente tra le stazioni e gli uffici postali principali. | utilizzo non noto |
I paragrafi successivi presentano gli elementi noti a chi scrive sui concreti casi di realizzazione di questi servizi sulle reti tramviarie del nostro paese, ed alcuni cenni sugli esempi esteri soprattutto delle due ultime tipologie (non attivate in Italia).
MESSAGGERI POSTALI E SCORTAPIEGHI SU LINEE TRANVIARIE
Su alcune linee tranviarie interurbane (cosi come sulle ferrovie secondarie) la posta viaggiava in sacchi chiusi scortati da agenti ferroviari o postali, detti “messaggeri”, che erano anche addetti alla lavorazione della posta raccolta lungo il percorso (annullamento, smistamento e formazione dei dispacci diretti alle varie stazioni), o da semplici "scortapieghi", agenti subalterni che si limitavano ad accompagnare i sacchi chiusi. Le convenzioni allegate agli atti di concessione delle linee tranviarie (così come di quelle ferroviarie) prevedevano costantemente l’obbligatorietà del trasporto gratuito di tali agenti postali sui convogli in circolazione, in scompartimenti a loro dedicati:
| “I concessionari di ferrovie economiche e tramvie saranno obbligati al trasporto ed allo scambio gratuito delle corrispondenze postali, ed a far eseguire dai loro agenti, direttamente col personale dell’Amministrazione delle Poste,il ricevimento e la consegna di esse nelle singole stazioni. Lo stesso obbligo avranno per i pacchi, mediante corrispettivo.” [Legge n. 561, 27.12.1896] |
Sulla base delle informazioni a mia disposizione, è possibile identificare oltre 30 linee tranviarie interurbane con servizi di questo tipo (una lista è presente nel mio articolo su L’Annullo n.200 citato in bibliografia). Una presentazione esaustiva di tutte le tipologie di annulli note per i messaggeri tranviari va al di là dei limiti del presente lavoro. È tuttavia opportuno esemplificare alcuni casi rilevanti, focalizzandoci su alcune linee tranviarie piemontesi, data la pubblicazione di questo articolo sulla rivista della più importante società filatelica della regione.
La tranvia Torino – Brusasco – Gassino
La linea Torino – Gassino fu inaugurata nel 1880 e prolungata sino a Brusasco nel 1883. Elettrificata parzialmente nel 1908 e sull’intera tratta nel 1931, fu chiusa nel 1949. Vi furono attivati servizi di messaggere con i primi bolli del tipo a doppio cerchio con lunette a righe verticali (uso noto dal 1904), poi sostituito dal tipo «guller» noto dal 1910 al 1915.


Esempi di annulli dei messaggeri tranviari sulla linea Torino – Gassino - Brusasco
La linea Alessandria – Altavilla
La linea fu in esercizio dal 1883 al 1935 e rimase sempre con trazione a vapore. È l’unica tranvia facente capo ad Alessandria sulla quale furono certamente attivati servizi di messaggere che utilizzarono bolli del tipo a doppio cerchio con lunette a righe verticali, il cui uso è noto nelle due direzioni dal 1895 al 1906.
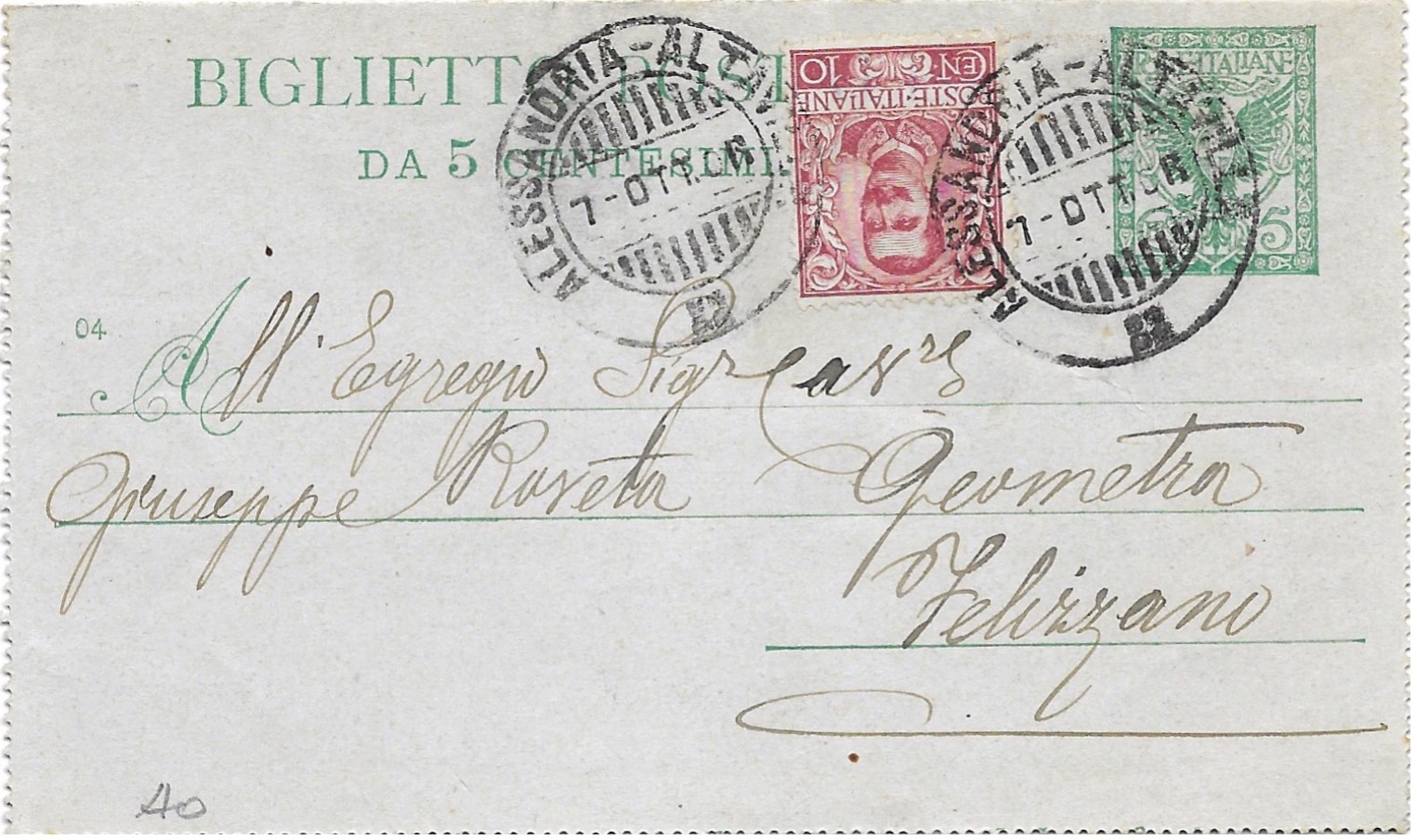
Annullo del messaggere postale Alessandria - Altavilla tipo doppio cerchio con lunette rigate in data 7,.10.1906 per Felizzano – ultima data nota
La rete di Novara e della Lomellina
Le linee della rete tramviaria interprovinciale della zona di Novara e della Lomellina furono aperte al traffico tra il 1883 ed il 1884, in concessione alla Società anonima delle Ferrovie del Ticino, e non sopravvissero alla fase di forte contrazione del sistema tranviario interurbano, ad inizio degli anni ’30 del secolo scorso. La trazione era a vapore. Questi messaggeri utilizzarono più di 20 bolli diversi, nessuno dei quali è comune. |
| Linea | Apertura / Chiusura | Periodo noto di attivazione messaggeri |
| VERCELLI – BIANDRATE – FARA | 1884 – 1933 | 1896 – 1930 |
| NOVARA – BIANDRATE – FARA | 1883 – 1934 | 1900 – 1923 |
| NOVARA – VIGEVANO | 1883 – 1934 | 1896 – 1933 |
| MORTARA – PIEVE DEL CAIRO | 1884 – 1933 | 1895 – 1931 |
| OTTOBIANO – VIGEVANO | 1884 – 1933 | 1890 – 1930 |

Annullo del messaggere tranviario Fara – Biandrate – Novara, 3 marzo 1903
La tranvia Vercelli – Casale
La linea tranviaria tra Vercelli e Casale fu inaugurata nel 1886 e chiusa al traffico nel 1935. Vi furono attivati servizi di messaggere con bolli del tipo a doppio cerchio con lunette a righe verticali il cui uso è noto dal 1913 al 1924.

Annullo del messagger\e postale Casale – Chivasso tipo doppio cerchio con lunette rigate in data 19.09.24, da Milano per Caresana, e poi re-indirizzata a Pezzana, entrambe località servite solo dalla tramvia (cosa che rende certa l’attribuzione del servizio di messaggere alla tramvia stessa, nonostante Vercelli e Casale fossero collegate anche da una linea ferroviaria)
La tranvia Vercelli-Casale risultava avere gli stessi capilinea della preesistente ferrovia Vercelli-Casale, ma con un tracciato più ad est; poiché anche sulla ferrovia furono in servizio dei messaggeri, l’attribuzione di una bollatura ad una delle due linee può essere fatta con certezza solo quando la lettera o cartolina indica la località di partenza.
Servizi di messaggere postale dotati di bolli postali furono attivati anche sulle tratte Biella – Vallemosso e Biella – Balma che furono però classificate come “ferrovie economiche” anche se per molti aspetti erano linee di tipo tranviario. Per ragioni di spazio non entro qui in dettaglio sulle relative bollature.
Va detto, inoltre, che questo tipo di servizio di messaggeria postale fu attivato anche in numerose linee tranviarie interurbane all’estero, ad esempio in Francia, in Olanda, in Germania e negli Stati Uniti.
CASSETTE POSTALI SUI TRAM
La seconda principale tipologia di servizio postale tranviario esistita in Italia è quella delle cassette postali agganciate alle carrozze tranviarie per l’impostazione e l’avvio celere della corrispondenza.
Periodo precedente la seconda guerra mondiale
Nel periodo anteguerra sono noti servizi di questo tipo su diverse reti urbane ed extraurbane. La corrispondenza così impostata veniva poi raccolta ai capilinea e quindi annullata nell’ufficio postale cui veniva affidata. Nella maggior parte dei casi noti, oltre al datario dell’ufficio veniva apposto un bollo non annullatore (di varie fogge) che indicava la provenienza dalle cassette tranviarie. Fanno eccezione il caso di Milano (servizio certamente esistito ma nessun bollo particolare noto) e quello di Roma (provenienza tranviaria direttamente indicata nel datario “roma tramways”).
Sono noti esempi delle seguenti aree: Mantova, Cremona, Milano, Brescia, Vicenza, Piacenza, Bologna e Roma. Si rinvia all’articolo a mia firma su L’Annullo n.200 citato in bibliografia per maggiori dettagli su tali servizi e le relative bollature.

Cartolina postale di Vicenza per Venezia città, datario a doppio cerchio con lunette vuote di Venezia Arrivi e Partenze del 17.11.1913 e lineare in cartella su tre righe impostazione / sulle tramvie / (vicenza).
Periodo successivo alla Seconda guerra mondiale
Il servizio di “Avviamento Celere” o “Posta Celere” di impostazione su cassette postali agganciate alla carrozzeria dei tram fu reintrodotto in alcune città nel periodo 1952-54. In particolare, fu attivato su linee tranviare (ma anche di filobus e autobus) in transito dalle stazioni ferroviarie di Napoli, Milano, Torino, Trieste e Roma per il rapido avviamento delle corrispondenze ai treni. Analogo servizio fu proposto su linee di autobus e/o filobus a Trento, Reggio Calabria, Catania, Bari e Palermo. Annulli con riferimento al servizio recavano la scritta avviamento celere oppure posta celere. Sono noti usati solo a Napoli, Torino, Roma e Milano, ed inoltre a Catania, Trento e Reggio tra le città in cui fu realizzato su autobus. Il servizio fu soppresso tra fine anni ’60 e anni ’70 (a Milano pare nel 1981). A Torino, in particolare, il servizio fu inaugurato alle 11:30 del 27 novembre 1954 alla presenza del ministro delle Poste e telecomunicazioni on. Gennaro Cassiani. | Nel giorno di inizio del servizio a Torino, il Ministro delle Poste assiste allo svuotamento di una cassetta postale tramviaria |
Una trattazione completa di questi servizi e delle relative bollature (ne esistono sia manuali che meccaniche) va oltre i limiti del presente studio. In questa presento un paio di esempi di corrispondenza impostata nelle speciali cassette a Torino con bollatura manuale e meccanica, che mi sono note nel periodo dal 1955 al 1964.

TORINO STAZ. P.N. - AVV. CELERE -, 28.09.1957 – Annullo manuale su cartolina impostata non affrancata nella cassetta tranviaria e quindi tassata

TORINO STAZ. P.N. - AVV. CELERE -, 20.12.1957 – Annullo meccanico e targhetta per le festività di fine anno
La possibilità di impostare corrispondenza su cassette postali a bordo dei tram fu attivata in numerose città di tutto il mondo. I casi più conosciti riguardano Bruxelles, Parigi, Amburgo, Sofia, e le principali città spagnole.
IL TRASPORTO DI GIORNALI E PACCHI
All’estero sono noti numerosi esempi trasporto di giornali e/o pacchi su linee tranviarie urbane ed interurbane, svolti direttamente dalle aziende tramviarie al di fuori del monopolio postale, anche con francobolli da loro emessi per consentire il pre-pagamento del trasporto. In Italia mi è noto un solo esempio di trasporto di giornali su linee tranviarie interurbane con riscossione di un "diritto fisso" per cui furono predisposte speciali marche (Ferrotramvie Provinciali di Verona, che avevano in carico l'esercizio delle tranvie urbane ed interurbane di Verona.


| La speciale marca per trasporto giornali delle ferrotranvie provinciali di Verona, ed un’immagine del locomotore tranviaria E32 che vi era raffigurato |
Anche all'estero sono noti molti esempi di trasporto di giornali e/o pacchi e pacchetti su linee tranviarie urbane ed interurbane. Si trattava sempre di servizi al di fuori del monopolio postale. L’uso di emettere francobolli per consentirne il pre-pagamento fu comune nelle isole britanniche ed in Australia, oltre che in Olanda
TRASPORTO DI LETTERE SPEDITE DA PRIVATI GESTITO DIRETTAMENTE DALLE SOCIETÀ TRAMVIARIE
Nel Regno Unito, nel 1891, il Railway Letter Stamp Act determinò la possibilità per le società ferroviarie, di emettere speciali francobolli per il pagamento del trasporto di lettere sui propri treni. La tariffa era pari al doppio del porto postale ordinario (che andava comunque corrisposto in omaggio alla privativa delle poste). Anche quattro società esercenti linee tranviarie firmarono l’Act ed emisero propri francobolli.
TRAM DI SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE POSTALE
L’esempio piu conosciuto furono gli Street Railway Post Offices negli USA, che si occupavano della raccolta delle corrispondenze dalle cassette stradali, e quindi della loro bollatura, smistamento, e distribuzione agli uffici postali. Furono attivi in ca. 15 città, dal 1891 al 1929. Analoghi casi si ebbero in Germania, Francia, Canada e Brasile.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Paolo Guglielminetti, Il tram come mezzo di trasporto della posta, Conferenza, Salerno, 12 Dicembre 2014
Paolo Guglielminetti, Il tram come mezzo di trasporto della posta, L’Annullo n.200, ANCAI, 2014
Günter H. Köhler, Post und Tram, 1998
Sergio Leali, Quando a Mantova la posta viaggiava anche con i tram a vapore, in: "Mantova 1704-2004 Trecento anni di posta", 2004
Sergio Leali, Nuove considerazioni sul bollo “Cassette Postali sui Tram”, Atti di Filatelica, S. Colombano al Lambro, 2007
Massimo Menzio, Quando la corrispondenza si impostava sul tram, Numero Unico Filsanda 2011

Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo nel periodo 1/12/2022-31/12/2023. L’ordinamento è in ordine alfabetico per paese e per città all’interno di ogni paese. Sono evidenziate in giallo le “nuove città tranviarie” e in azzurro le reti chiuse definitivamente. Per ogni città, le variazioni sono riportate in ordine cronologico. Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Urbanrail.net.
ALGERIA
MOSTAGANEM: la settima nuova rete tranviaria algerina è stata inaugurata il 18 febbraio 2023. E’ composta da due linee (T1 da La Salamandre a Karouba e T2 da Gare SNTF a Nouvelle Gare routière) per un totale di 14 km di rete. La flotta di tram in servizio è composta da 25 Citadis 402 lunghi 43 metri fabbricati da Alstom.
AUSTRIA
INNSBRUCK: Il 4 marzo 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,3 km della linea 5 alla periferia est da Schützenstraße a Rum Bahnhof. Dopo queste modifiche, il capoluogo tirolese dispone ora di una rete tranviaria di complessivi 45,5 km, con 6 linee di cui 2 interurbane (la famosa “Stubaitalbahn” e la linea 6 per Igsl).
BOLIVIA
COCHABAMBA: il 14 il 21 settembre 2023 sono state rispettivamente prolungate la Linea Rossa da E.C. San Antonio a Estación Antigua de Cochabamba e la Linea Verde da Quillacollo a E.M. Vinto, per complessivi 4,7 km di estensione. A regime sono previste 3 linee per un totale di 42 km. Sono in servizio 12 tram Stadler “Metelitsa” da 33 m a tre casse e pianale interamente ribassato.
CANADA
EDMONTON (Alberta): Il 4 novembre 2023 è stata inaugurata la Valley Line, una linea tranviaria in stile “europeo” con tracciato protetto e quasi completamente in superficie da 102 Street a Mill Woods, su una lunghezza di 13,2 km. Sono in servizio 26 motrici articolate a pianale interamente ribassato del tipo Flexity Freedom prodotte da Bombardier. Questa linea si aggiunge alle due linee esistenti, che si sviluppano separatamente su altri 24 km di rete e sono a standard di LRT “americano” con banchine alte e pianale alto.
CECA, REPUBBLICA
BRNO: l'11 dicembre 2022 la linea 8 è stata prolungata da Osová a Nemocnice Bohunice su un nuovo tratto di 0.9 km, parzialmente sotterraneo.
PRAGA: Il 27 maggio 2023 la linea 17 è stata prolungata su un tratto di 1,7 km di nuova costruzione da Levského a Libus nella periferia sud. Il 13 e il 23 ottobre 2023 sono state rispettivamente prolungate le linee 4 e 5 da Holyne a Slivenec e le linee 20 e 26 da Divoka Sarka a Dedina, per complessivi 2,5 km di estensione.
CINA
HUANGSHI (Hubei): il 28 dicembre 2022 è stata inaugurata una linea tranviaria a standard di LRT da Huangshi Avenue a Garden Expo che si snoda per 26,9 km nelle comunità di Huangshi e Daye. Sono in servizio 32 tram a pianale interamente ribassato prodotti da CRRC che montano supercapacitori. La linea aerea è completamente assente.
SHANGHAI: il 31 maggio 2023 ha cessato il servizio la linea di “tram su gomma” (sistema Translhor), in funzione dal 2010 nel quartiere di Zhangjiang alla periferia est: era lunga 10 km e impiegava 9 veicoli. La chiusura è stata motivata dalla sopraggiunta insufficiente capacità di carico sul percorso servito e dall’impossibilità di ampliare la flotta per far fronte all’indispensabile potenziamento.
SUZHOU (jIANGSU): il 28 agosto 2023 è stata attivata una diramazione della linea T2 da Hangchuanbang a Nanjing University East (1,8 km). Lo sviluppo totale della rete tranviaria, comprensivo della prima linea inaugurata nel 2014, ammonta ora a 45 km.
TIANJIN: il 1° giugno 2023 ha cessato il servizio l’unica linea tranviaria della città (tram su gomma), in funzione dal 2007: era lunga 8 km e impiegava 8 veicoli Translohr. Il tram su gomma è quindi totalmente scomparso dalla Cina, dopo che l’unica altra linea simile è stata soppressa a Shanghai.
EGITTO
IL CAIRO: a fine 2022 è stata attivata una linea tranviaria di 1,8 km presso il centro commerciale Open Air Mall nel quartiere di Madinaty. Sono in servizio, fra le 14,00 e le 22,00, 4 tram a batteria forniti dalla ditta inglese Severn Lamb, a due piani con aspetto retro.
FINLANDIA
HELSINKI: il 21 ottobre 2023 è stata inaugurata la linea suburbana 15, ad andamento tangenziale nella estrema periferia di Helsinki. Lunga 24,5 km, va da Keilaniemi a Östra Centrum correndo in parte nel comune di Helsinki e in parte in quello di Espoo. E’ costruita a standard di LRT e non è per ora interconnessa con la rete tranviaria urbana. Sono in servizio 29 tram articolati Skoda ArticX54 bidirezionali a pianale interamente ribassato lunghi 34,5 m. La rete tranviaria della capitale finlandese ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 75 km (a scartamento metrico) su 11 linee.
TAMPERE: il 7 agosto 2023 la linea 3 è stata prolungata da Pyynikintori a Santalahti su un nuovo tratto di 2 km.
FRANCIA
ANGERS: l’8 luglio 2023 sono state inaugurate due nuove tratte tranviarie, da Belle-Beille Campus a Molière (4.8 km) e da Centre des Congrès a Monplaisir (3.6 km). La rete tranviaria è stata riorganizzata su tre linee (A, B e C) e sono entrati in servizio ulteriori 20 tram Alstom Citadis X05 dotati di sistema APS.
BORDEAUX: il 29 aprile 2023 è stata inaugurata una diramazione di 4,7 km della linea A da Quatre Chemins a Mérignac Aéroport. La rete tranviaria di Bordeaux è composta ora da quattro linee e, con uno sviluppo complessivo di 80 km, è la seconda rete urbana di Francia per estensione dopo Parigi. Il parco rotabile è composto da 130 motrici a pianale interamente ribassato tipo Alstom Citadis 302/402, dotate di sistema APS.
NANCY: il 12 marzo 2023 ha cessato il servizio il tram su gomma (sistema TVR Bombardier) che operava dal 2000 su una linea (T1) lunga 11 km con una flotta di 25 veicoli. Si prevede una gestione con filobus a partire dal 2026.
PARIGI: il 24 giugno 2023 è stata inaugurata la linea T10, lunga 6,8 km, da Croix de Berny a Jardin Parisien nella Banlieue sud della capitale francese. Sono entrati in servizio 13 tram Alstom Citadis 405 lunghi 45 metri. Il 10 dicembre 2023 è stata inaugurata la prima tratta della linea T12 di tram-treno nella banlieue sud da Evry a Massy-Palaiseau (nel tratto fra Massy e Epinay-sur-Orge ha preso il posto di una diramazione soppressa della linea C del RER). La linea è lunga 20 km ed è gestita con 25 veicoli di tipo Citadis Dualis costruiti da Alstom. La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 184 km ed è composta da 14 linee gestite in modo indipendente (e per la maggior parte non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono due linee urbane tangenziali, sei linee periferiche, due linee di tram su gomma e quattro linee di tram-treno.
GERMANIA
BERLINO: il 9 settembre 2023 la linea 10 è stata prolungata nella zona ovest su un nuovo tratto di 1,5 km da Hauptbahnhof a Turmstraße. La rete tranviaria di Berlino è attualmente la terza al mondo per estensione, con 180 km e 22 linee (oltre a 20 km e 2 linee suburbane), quasi integralmente comprese nella parte est della città (ex DDR).
BOCHUM (Nord Renania-Westfalia): il 9 gennaio 2023 è stata inaugurata una diramazione di 0,6 km della linea 302 da Laar Mitte – O-Werk. La rete di Bochum/Gelsenkirchen è formata attualmente da 9 linee tranviarie con scartamento di 1000 mm e da una linea di Stadtbahn con scartamento 1435 mm. Entrambe le sottoreti hanno tratti sotterranei e tratti in superficie. La rete di Bochum totalizza 100 km ed è fisicamente collegata a quella di Essen tramite altre due linee provenienti da quest’ultima città. A sua volta, Essen è collegata ad altre reti tranviarie a formare l’agglomerazione Reno-Ruhr, il cui sviluppo totale raggiunge i 450 km.
HANNOVER (Bassa Sassonia): il 10 dicembre 2023 è stata attivata la nuova linea 13 da Fasanenkrug a Hemmingen. che percorre un tratto di 3,1 km di nuova costruzione da Wallensteinstraße a Hemmingen-Westerfeld..La rete tranviaria di Hannover è un sistema di Stadtbahn (LRT) altamente protetto con uno sviluppo totale di 123 km (di cui 19 km in sotterraneo), 13 linee e una flotta di 336 veicoli.
MANNHEIM (Baden-Württenberg): il 17 dicembre 2023 è stata inaugurata la linea 16, gestita provvisoriamente come navetta su un nuovo tratto di 1,6 km tra Bensheimer Strasse e Sullivan.
GIAPPONE
UTSUNOMYA: il 26 agosto 2023 la prima “nuova città tranviaria” del Giappone ha inaugurato il servizio, aprendo al traffico una linea lunga 14,6 km tra Utsunomiya Station East – Haga Takanezawa Industrial Park. Lo scartamento è di 1067 mm, come buina parte delle linee tranviarie del paese. Sono entrati in servizio 17 tram articolati “HU300” lunghi 30 m e larghi 2,65 m, prodotti dalla casa locale Niigata Transys.
ISRAELE
TEL AVIV: il 18 agosto 2023 è stata inaugurata la “RED Line”, che è la prima di tre linee di LRT di una rete destinata a raggiungere i 90 km complessivi. La Red Line è lunga complessivamente 24 km e comprende una ramificazione; è gestita mediante 3 collegamenti aventi il tratto centrale in comune (R1: HaKomemiyut–Petah Tikva, R2: HaKomemiyut–Kiryat Arye, R3: Elifelet-Kiryat Arye). Il tracciato si sviluppa al 50% in sotterraneo. Il parco rotabile è costituito da 90 tram articolati lunghi 34,8 m e larghi 2,65 m, a pianale interamente ribassato, prodotti in Cina da CRRC, che vengono impiegati normalmente a coppie in trazione multipla.
KAZAKISTAN
TEMIRTAU: il 1° febbraio 2023 è cessato definitivamente il servizio tranviario, causa grave ammaloramento degli impianti e dei veicoli. La rete tranviaria era operativa dal 1959 e comprendeva ormai una sola linea, lunga 11 km gestita dall’acciaieria Arcelor Mittal.
MAURITIUS
PORT LOUIS: il 23 gennaio 2023 è stata inaugurata una diramazione di 3,2 km da Rose Hill a Mahatma Gandhi, mentre il capolinea centrale è stato provvisoriamente avanzato da Port Louis Victoria a Place d’Armes, in attesa di un ulteriore piccolo prolungamento fino a Aapravasi Ghat. Lo sviluppo totale di rete ha raggiunto un totale di 29 km.
POLONIA
BYDGOSZCZ: 6 novembre 2023 è stato inaugurato un altro nuovo tratto di collegamento fra due tratti di reti esistenti di 0,6 km tra Most Kazimierza Wielkiego e Torunska/Kazimierza Wielkiego. La rete tranviaria ha raggiunto un’estensione totale di 42 km con 11 linee.
BRESLAVIA: il 15 maggio 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 3,6 km da Dmowskiego a Wejherowska nella zona nord-ovest, su cui sono state instradate le linee 18 e 19. Il 3 settembre 2023 le linee 13 e 23 sono state prolungate alla periferia ovest su un nuovo tratto di 4,6 km da Park Biznesu a Wr.-Nowy Dwór P+R. La rete tranviaria di Breslavia (Wroclaw) è composta da 21 linee e ha raggiunto un’estensione totale di 100 km.
CRACOVIA: il 4 settembre 2023 le linee 18 e 50 sono state prolungate alla periferia nord su un nuovo tratto di 3,6 km da Krowodrza Górka a Papierni Pradnickich. La rete tranviaria di Cracovia è composta da 23 linee e ha un’estensione totale di 89 km.
DANZICA: il 1 marzo 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,7 km che unisce due tratti già esistenti fra Ujescisko e Przemyska, su cui sono state instradate le linee 2, 4 e 11. La rete tranviaria di Danzica è composta da 11 linee e ha un’estensione totale di 60 km.
GORZOW: il 22 luglio 2023 le linee 1 e 3 sono state prolungate di 1 km su un nuovo tratto di percorso in comune alla periferia nord-est da Dowgielewiczowej a Fieldorfa-Nila.
KATOWICE: il 19 dicembre 2022 la linea 15 è stata prolungata di 3 km su un tratto di nuova costruzione nel territorio di Sosnowiec da Zagórze BMC a Zagórze Rondo Jana Pawla II . Il 22 dicembre 2023 la linea 25 è stata instradata su un tratto di nuova costruzione di 0,6 km da Dab Huta Baildon a Katowice Dabrowski. Quella di Katowice /Alta Slesia è la rete di maggiori dimensioni della Polonia, con un’estensione totale di 172 km e 26 linee. Ha caratteristiche interurbane, al servizio di un’agglomerazione di 2 milioni di abitanti che comprende, oltre al capoluogo Katowice, altri importanti centri come Bedzin, Bytom, Chorzow, Gliwice, Sosnowiec e Zabrze.
OLSZTYN: il 30 dicembre 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 5,9 km tra Skwer Wakara e Pieczewo, su cui sono state instradate le nuove linee 4 e 5. La rete tranviaria di Olsztyn è composta ora da 5 linee e ha un’estensione totale di 16 km.
TORUN: il 1° settembre 2023 la rete è stata riorganizzata su 7 linee. Le linee 3 e 6 sono state prolungate alla periferia nord su un nuovo tratto di 5,5 km da da Waly gen. Sikorskiego a Heweliusza. La rete tranviaria di Torun, a scartamento metrico, è composta ora da 7 linee con un’estensione totale di 28 km.
REGNO UNITO
BIRMINGHAM (Inghilterra): il 17 settembre 2023 è stata attivata una diramazione di 0,5 km all’estremità ovest della linea da The Royal a Wolverhampton Station: il capolinea di Wolverhampton si effettua ora, a corse alterne, alla Stazione ferroviaria o a St. George/ Bilston Street.
EDIMBURGO (Scozia): il 7 giugno 2023 l’unica linea esistente è stata prolungata di 4,7 km da St. Andrew Square a Newhaven, arrivando a una lunghezza complessiva di 18,5 km.
RUSSIA
EKATERINBURG: il 22 dicembre 2023 la linea 1 è stata prolungata su un nuovo tratto di 4,2 km da Volgogradskaya a Akademika Parina. La rete tranviaria di questa importante città siberiana comprende 31 linee e si sviluppa su 91 km, piazzandosi al terzo posto in Russia (dopo San Pietroburgo e Mosca) e al primo posto in Asia.
KALININGRAD: il 5 dicembre 2022 è stata riattivata la linea 3, che era sospesa dal 2015. La rete tranviaria ha ora una estensione totale di 14,2 km con 2 linee. Sono entrati in servizio 16 nuovi tram Korsar, a pianale interamente ribassato e articolati a due casse, prodotti dalla casa russa PKTS.
UST ILIMSK: dal 21 dicembre 2022 il servizio tranviario è stato soppresso. Era costituito da un’unica linea interurbana lunga 15 km che era entrata in servizio nel 1988 e che collegava il centro della città con una grossa cartiera decentrata. La flotta comprendeva 22 tram Ust Katav del tipo KTM5.
SPAGNA
MALAGA: il 27 marzo 2023 sono stati attivati due prolungamenti in sotterraneo delle linee L1 da El Perchel a Atarazanas (1.2 km) e L2 da El Perchel a Guadalmedina (0.6 km). Il tratto in comune da El Perchel a Atarazanas a dispone di 4 binari consentendo il transito separato delle due linee. La rete di LRT della città andalusa, per la sua maggior parte sotterranea, si compone di due linee per un totale di 13,45 km di rete; sono in servizio 18 tram CAF Urbos3 lunghi 31 m a pianale interamente ribassato.
VITORIA/GASTEIZ: l’11 aprile 2023 è stato inaugurato un nuovo tratto di 2,4 km da Florida a Salburua. La rete tranviaria del capoluogo basco si compone di due linee a scartamento metrico per un totale di 12 km di rete.
STATI UNITI D'AMERICA
BOSTON (Massachussetts): il 12 dicembre 2022 la linea E della Green Line è stata prolungata di 5,2 km da Lechmere a Medford/Tufts.
LOS ANGELES (California): il 16 giugno 2023 è stato aperto al traffico un nuovo tratto centrale sotterraneo di 2,5 km da 7th Street/Metro Center a Little Tokyo/Arts District ("Regional Connector”), che collega due parti di rete che prima erano separate. Conseguentemente, la rete di LRT è stata ristrutturata su 4 linee: A(blue), C (green), E (gold), K (pink). La A e la E percorrono insieme il nuovo tunnel. La lunghezza complessiva della rete di LRT è di 152 km e il parco rotabile è composto da 352 veicoli.
MILWAUKEE (Wisconsin): il 29 ottobre 2023 è stato inaugurato un prolungamento ad anello di 0,6 km da L Wisconsin Avenue a Lakefront su cui circola la nuova linea L (gestita inizialmente solo la domenica).
SAN FRANCISCO (California): dal 7/1/2023 la linea T è stata instradata sulla "Central Subway"da 4th & King/Caltrain a Chinatown/Rose Pak .
TACOMA (Washington): il 16 settembre 2023 la linea tranviaria esistente “Tacoma link” è stata prolungata di 3,8 km da Old City Hall a St. Joseph, raggiungendo uno sviluppo totale di 6,4 km.
SVIZZERA
BASILEA: l’11 dicembre 2022 è stata inaugurata la rinnovata linea interurbana 19 (che collega le località esterne di Liestal e Waldenburg. E’ ora a scartamento metrico, uniformato a quello delle restanti linee di Basilea anche se è isolata dal resto della rete tranviaria. L’identico tracciato era in precedenza servito dalla linea ferroviaria locale “Waldenburgerbahn” con scartamento di 750 mm. La linea è lunga 13,1 km e risale al 1883. Sono entrati in servizio 10 nuovi tram Stadler Tramlink lunghi 45 m della compagnia BLT.
GINEVRA: il 10 dicembre 2023 la linea 15 è stata prolungata su un tratto di nuova costruzione di 2,5 km d Palettes a ZIPLO. La rete tranviaria di Ginevra è composta da cinque linee e ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 38 km.
ZURIGO: l’11 dicembre 2022 è stata inaugurata la nuova linea interurbana 20 (Limmattalbahn) che collega Zurigo/Altstetten con le località esterne di Schlieren, Dietikon e Killwangen, lunga 13,4 km (di cui 9,7 km di nuova costruzione). Sono in servizio 8 tram Stadler Tramlink (identici a quelli della Waldenburgerbahn di Basilea) della compagnia AVA (Aargau Verkehr AG). La più grande rete tranviaria svizzera, a scartamento metrico, si estende attualmente su 129 km in totale e comprende tredici linee urbane (tra cui una storica), sei linee suburbane/interurbane e una linea a cremagliera.
TAIWAN
TAIPEI: il 10 febbraio 2023 è stata inaugurata una nuova linea LRT, la “Ankeng Light Rail” da Shisizhang a Shuangcheng, non connessa con le altre linee di LRT ma facente da adduzione alla linea Y di metropolitana alla periferia sud. La linea è lunga 7,7 km e vi fanno servizio motrici fabbricate localmente da TRSC.
TURCHIA
ISTANBUL: il 30 agosto 2023 la linea T5 (alimentazione con sistema APS) è stata prolungata di 0,9 km verso il centro da Cibali a Eminönü, andando a collegarsi con la linea T1. La rete tranviaria di Istanbul conta 3 linee moderne per complessivi 43 km (T1, T4 e T5) e 2 storiche (T2 e T3) che si sviluppano su altri 4 km. Il parco circolante conta 200 unità (+7 vetture storiche).
KAISERI: il 2 marzo 2023 è stata attivata la nuova linea T3, che percorre un tratto di nuova costruzione di 6,5 km fra Anafartalar e Kumsmall AVM.. Il 28 ottobre 2023 è stata attivata la linea T4 che percorre un tratto di 5 km di nuova costruzione da Sehit Mustafa Simsek a Izzet Bayraktar Camii. La rete di Kayseri ha raggiunto un’estensione complessiva di 46 km con 4 linee.

NOVITÀ TRANVIARIE DAL MONDO NEL 2022
di Roberto Cambursano
Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo nel periodo 1/12/2021-30/11/2022. L’ordinamento è in ordine alfabetico per paese e per città all’interno di ogni paese. Sono evidenziate in giallo le “nuove città tranviarie” e in azzurro le reti chiuse definitivamente. Per ogni città, le variazioni sono riportate in ordine cronologico. Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Urbanrail.net.
BELGIO
BRUXELLES: l’11 dicembre 2021 la linea 9 è stata prolungata da Arbre Ballon a Roi Badouin su un nuovo tratto di 1,7 km. La rete tranviaria della capitale belga conta attualmente 17 linee e 133 km di sviluppo.
BOLIVIA
COCHABAMBA il 13 settembre 2022 un nuovo paese tranviario si è aggiunto all’elenco mondiale: si tratta della nuova rete tranviaria della città di Cochabamba, che sfrutta sedimi ferroviari abbandonati. In questa prima fase sono state attivate 2 linee (Rossa da Estación Central San Antonio a UMSS-Facultad de Agronomía e Verde da Estación Central San Antonio a Quillacollo) per uno sviluppo complessivo di 20 km, mentre a regime sono previste 3 linee per un totale di 42 km. Sono in servizio 12 tram Stadler “Metelitsa” da 33 m a tre casse e pianale interamente ribassato, fabbricati in Bielorussia.
CECA, REPUBBLICA
OLOMOUC: il 1° novembre 2022 le linee 3 e 5 sono state prolungate da Trnkova a U. Kaplicky su un tratto di nuova costruzione di 1,2 km.
PRAGA: il 9 aprile 2022 la linea 5 è stata prolungata da Sidliste Barrandov – Holyne su un nuovo tratto di 1 km.
CINA
FOSHAN (Guangdong): Il 29 novembre 2022 la Nanhai line (LRT) è stata prolungata di 4,9 km da Sanshanxinchengbei a Linyuedong, raggiungendo uno sviluppo totale di 14,3 km.
JIAXING (Zheyang): il 15 gennaio 2022 è stato attivato un prolungamento in sotterraneo di 0,6 km dell’unica linea tranviaria esistente tra Fanggong Rd e la Stazione ferroviaria principale. Il 25 giugno 2022 è stato attivato un ulteriore prolungamento di 2,6 km da Jiaxing Railway Station a East Zhongshan Rd/Anle Rd, portando la lunghezza della linea a 13,8 km. Sono in servizio 20 tram a pianale interamente ribassato prodotti in Cina da CRRC che montano supercapacitori. La linea aerea è completamente assente.
WUYI il 31 dicembre 2021 è stata inaugurata una linea tranviaria interurbana a carattere essenzialmente turistico nel distretto di Wuyi. Ha uno sviluppo totale di 26,2 km, in sede totalmente propria, e collega le stazioni ferroviarie di Nanping e Nanyuanling. Vi fanno servizio 12 tram a pianale interamente ribassato prodotti in Cina da CRRC.
DANIMARCA
ODENSE: il 29 maggio 2022è stata inaugurata la prima linea della seconda nuova città tranviaria danese: è lunga 14,5 km da Tarup Center a Hjallese Station. Sono in servizio 16 tram a pianale interamente ribassato Variobahn forniti da Stadler.
FINLANDIA
HELSINKI il 17 ottobre 2022 la linea 9 è stata prolungata di altri 1,2 km a nord da Eesterinportti a Ilmalantori. La rete tranviaria della capitale finlandese ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 50 km (a scartamento metrico) su 10 linee.
FRANCIA
CAEN: il 29 agosto 2022 la linea T3 è stata prolungata di 600 m nel comune di Fleury-sur-Orne da Collège Hawking a Hauts de l'Orne. La rete tranviaria della città normanna ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 17 km su 3 linee. Il parco veicolare è costituito da 26 tram articolati Alstom Citadis X05 a pianale interamente ribassato.
PARIGI: il 6 luglio 2022 è stata inaugurata la prima tratta della linea T13 di tram-treno nella banlieue ovest da Saint Cyr a Saint Germain-en-Laye. La linea è lunga 18,8 km ed è gestita con 11 veicoli di tipo Citadis Dualis costruiti da Alstom. La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 157 km ed è composta da undici linee gestite in modo indipendente (e non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono una linea urbana tangenziale, cinque linee periferiche, due linee di tram su gomma e tre linee di tram-treno.
GERMANIA
AUGUSTA (Baviera): il 12 dicembre 2021 la linea 3 è stata prolungata su un nuovo tratto di 4,6 km alla periferia sud della città da Haunstetten West (Inninger Straße) a Königsbrunn Zentrum. La rete tranviaria di Augsburg, a scartamento metrico, si sviluppa su 45 km e conta 5 linee.
CHEMNITZ (Sassonia): il 31 gennaio 2022 è stato attivato un nuovo tratto di collegamento di 0,4 km fra la rete tranviaria (Technopark) e quella ferroviaria, consentendo il prolungamento delle linee di tram-treno C13 e C14 rispettivamente a Thalheim e Aue (trazione diesel). Dopo questo intervento, la rete tranviaria di Chemnitz ha raggiunto lo sviluppo totale di 150 km, dati dalla somma della rete urbana (30,5 km con 5 linee) e della rete di tram-treno (119,5 km, al netto delle sovrapposizioni con la rete urbana, con 4 linee).
DARMSTADT (Assia); il 25 aprile 2022 la linea 2 è stata prolungata di 1,1 km da Hochschulstadion (Jahnstraße) a TU-Lichtwiese/Campus.
KARLSRUHE (Baden Württemberg): Il 12 dicembre 2021 è stato inaugurato il sistema di sottovie tranviarie centrali detto “Kombilösung”. Ha una configurazione a “T” e si sviluppa per un totale di 3,6 km di doppio binario lungo la Kaiserstrasse (est-ovest) e la Ettlingerstrasse (nord-sud), tra loro congiunte da scambi a livello sotto la Marktplatz. Karlsruhe dispone di una smisurata rete interurbana di 581 km che, sommata a una rete urbana di 63 km, forma la più grande agglomerazione tranviaria del mondo.
STOCCARDA (Baden- Württenberg): il 12 dicembre 2021 la linea U6 è stata prolungata oltre il confine comunale sud-est da Fasanenhof Schelmenwasena a Flughafen/Messe su un tratto di nuova costruzione lungo 3,2 km, comprendente due sezioni sotterranee. La rete tranviaria di Stoccarda è un sistema di Stadtbahn (LRT) altamente protetto con uno sviluppo totale di 129 km (di cui 24,5 km in sotterraneo), 13 linee e una flotta di 204 veicoli. Vi è inoltre una linea a cremagliera (linea 10) lunga 2 km.
GRECIA
ATENE: il 15 dicembre 2021 è stato inaugurato un nuovo tratto di 2,5 km di rete nella zona del Pireo (nuovo capolinea ad Akti Poseidonos). La rete tranviaria della capitale greca ha raggiunto un’estensione complessiva di 29,5 km, con una conformazione a “T” e due linee (la linea 6 che collega il centro della città e la linea 7 parallela alla costa). La flotta è composta da 35 Sirio di AnsaldoBreda e 25 Alstom Citadis 305.
ITALIA
MILANO: il 1° ottobre 2022 ha cessato il servizio per obsolescenza la linea Milano-Limbiate, ultima tranvia interurbana milanese. I progetti di ammodernamento e riattivazione attendono i finanziamenti.
LUSSEMBURGO
LUSSEMBURGO: l’11 settembre 2022 la linea tranviaria esistente è stata prolungata da Gare Centrale a Lycée Bouneweg su un nuovo tratto di 1,4 km. Il parco rotabile è composto da 32 tram CAF Urbos 100 articolati da 45,4 metri a pianale interamente ribassato, equipaggiati con il sistema ACR a supercapacitori.
MAROCCO
RABAT: il 16 febbraio 2022 sono stati attivati due prolungamenti della linea 2, per complessivi 6 km, alle due opposte estremità, da Hôpital Moulay Youssef a Yacoub Al Mansour e da Hassan II a Hôpital Moulay Abdellah. La rete di Rabat è composta da due linee con uno sviluppo totale di 26 km.
MAURITIUS
PORT LOUIS: l’8 maggio 2022 la linea interurbana esistente (il “Metro Express”, che parte dalla capitale Port Louis) è stata prolungata di 3,6 km da Quatre Bornes a Phoenix. Il 10 ottobre 2022 la linea è stata completata con l’attivazione dell’ultimo tratto da Phoenix fino a Curepipe, raggiungendo uno sviluppo totale di 26 km. Il materiale rotabile è costituito da 18 tram Urbos LRV bidirezionali a pianale parzialmente ribassato costruiti da CAF.
MESSICO
PUEBLA: il 31 dicembre 2021 è cessato il servizio sulla linea di tram-treno che era stata inaugurata nel gennaio 2017. Era lunga 17,2 km e utilizzava il binario di una ferrovia locale merci non elettrificata; erano impiegati due veicoli diesel Tramlink costruiti da Vossloh, provenienti dal fallito progetto di tram-treno di Léon in Spagna.
NORVEGIA
BERGEN: il 21 novembre 2022 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria della città, da Byparken a Fyllingsdalen terminal. Dopo un primo tratto in comune con la linea 1, la linea 2 si diparte da Bystasjonen seguendo un nuovo tracciato lungo 8 km (di cui 4,5 km sono in tunnel). Attualmente la rte tranviaria di Bergen si estende per un totale di 28,4 km su due linee; il parco rotabile è costituito da 34 tram Variobahn a pianale interamente ribassato prodotti da Stadler.
POLONIA
CRACOVIA: il 28 agosto 2022 è stato inaugurato un nuovo tratto tangenziale di rete tranviaria lungo 1,6 km alla periferia sud-ovest tra Lagiewniki SKA e Kurdwanów, includente una fermata sotterranea, su cui sono state instradate le linee 10, 11 e 50. La rete tranviaria di Cracovia è composta da 23 linee e ha un’estensione totale di 89 km.
POZNAN: il 23 aprile 2022 la linea 10 è stata prolungata su un nuovo tratto di 1,7 km da Lechicka/Naramowicka a Blazeja. La rete tranviaria di Poznan è composta da 18 linee e ha un’estensione totale di 73 km.
QATAR
LUSAIL: il 1° gennaio 2022 è stato inaugurato il primo tratto della nuova rete tranviaria di questa città-satellite che confina a sud con la capitale Doha: si tratta della sezione da Energy City a Legtaifyia-south (stazione di interscambio con la “linea rossa” della metropolitana di Doha), lunga 5,5 km, della “Orange line”, la prima delle 4 linee previste. Sono in servizio 28 tram Alstom Citadis X05 con APS parziale.
REGNO UNITO
BIRMINGHAM (Inghilterra): il 17 luglio 2022 la linea tranviaria esistente (“West Midlands Metro”) è stata prolungata di 1,1 km da Library/Centenary Square a Edgbaston Village.
ROMANIA
ORADEA: il 15 dicembre 2021 le linee 5 e 7 sono state prolungate su un tratto di nuova costruzione lungo 3,8 km da Calea Aradului a Lotus.
RUSSIA
EKATERINBURG: il 31 agosto 2022 è stata inaugurata la linea interurbana 333 da: Frezerovshchikov a Verkhnyaya Physhma, su un nuovo tratto di rete tranviaria di 8,5 km alla periferia nord. La rete tranviaria di questa importante città siberiana comprende 31 linee e si sviluppa su 87 km, piazzandosi al terzo posto in Russia (dopo San Pietroburgo e Mosca) e al primo posto in Asia.
KRASNODAR: il 31 marzo 2022 le linee 8,15,21 e 22 sono state prolungate su un tratto di nuova costruzione di 2,5 km da Solnechnaya a Ul. Petra Metal'nikova.
SPAGNA
BILBAO: il 25 marzo 2022 la linea tranviaria esistente è stata prolungata di 2,3 km da Atxuri a Bolueta.
CADICE: il 26 ottobre 2022 è stata inaugurata la linea T1 di tram-treno da Cadiz a Chiclana Pelagatos. E’ lunga 24,1 km (di cui 10,4 km fra Cadiz e Rio Arillo su binari ferroviari RENFE), a scartamento “largo” spagnolo (1668 mm); la flotta in servizio è formata da 7 tram-treni, a pianale parzialmente ribassato (al 55%), lunghi 38,1 m, alimentati a doppia tensione (3000 Vcc e 750 Vcc) di tipo TT fabbricati da CAF.
VALENCIA: il 17 maggio 2022 è stata inaugurata la nuova linea tranviaria 10, da Alacant a Natzaret, lunga 5,3 km di cui 2,3 km in tunnel. La rete tranviaria di Valencia è ora lunga in totale 26 km e conta 4 linee; la flotta è composta da 44 tram Bombardier.
STATI UNITI D’AMERICA
BOSTON (Massachussetts): il 18 marzo 2022 la linea D della Green Line (LRT) è stata prolungata di 1,7 km da Lechmere a Union Square.
LOS ANGELES (California): il 7 ottobre 2022 è stato inaugurato il primo tratto della nuova linea K (Pink line), quinta linea di LRT della città: è lunga 9,7 km da Expo/Crenshaw a Westchester/Veterans.
SAINT LOUIS (Missouri): nell’agosto 2022 è stata ripristinata la linea tranviaria storica (“Delmar Loop”), che era stata inaugurata il 16 novembre 2018 e soppressa già il 29 dicembre 2019 per insufficiente redditività economica. E’ lunga 3,5 km ed è gestita dal giovedì alla domenica con tre tram, di cui uno ex-Melbourne originale e due “Replica-cars” riassemblate dalla ditta locale Gomaco Trolley.
TEMPE un nuovo nome si è aggiunto all’elenco delle città tranviarie americane, con l’inaugurazione, avvenuta il 20 maggio 2022, di una linea lunga 4,8 km situata nel comune di Tempe, all’interno dell’area metropolitana di Phoenix. Vi fanno servizio 6 tram articolati a pianale parzialmente ribassato “Brookville Liberty NXT” di produzione locale, lunghi 20,4 metri e dotati di batterie, in grado di marciare autonomamente su un tratto di percorso intermedio di 1,6 km sprovvisto di linea aerea di alimentazione elettrica. Il “Tempe Streetcar” incrocia in due punti la linea di LRT già esistente a Phoenix (“Valley Metro”), con cui condivide scartamento e alimentazione elettrica.
TAIWAN
KAOHSIUNG: la linea esistente di LRT (futura circolare) ha avuto due prolungamenti, il 16 dicembre 2021 (+1,8 km) e il 5 ottobre 2022 (+2,4 km). Provvisoriamente la lunghezza complessiva da Kaisyuan Park a Heart of Love River ammonta a 17,0 km. Sono in servizio 15 tram Alstom Citadis 305 dotati di supercapacitori, e 9 CAF Urbos (dotati di sistema ACR). L’intera linea è completamente sprovvista di catenaria: la ricarica si effettua alle fermate tramite contatto dall’alto con apposite sezioni di alimentazione.
TURCHIA
BURSA: il 2 luglio 2022 è stata inaugurata la linea tranviaria T2, costruita a standard di LRT, fra Kent Meydani e Terminal. E’ lunga 9,5 km e vi fanno servizio 23 tram “Silkworm” a pianale interamente ribassato costruiti in loco dalla ditta Durmazlar.

UN TROLLEY FESTIVAL SPECIALE
di Davide Fenoglio
Durante il corso di tutto il 2022 l’ATTS ha festeggiato i 150 anni del tram a Torino. Infatti, dopo l’inaugurazione ufficiale avvenuta il 29 dicembre 1871, prendeva avvio il 2 gennaio 1872 il servizio di trasporto pubblico sulla prima linea tranviaria d’Italia fra Piazza Castello e la Barriera di Nizza con trazione a cavalli.
I festeggiamenti per questo importante avvenimento sono iniziati con il Trolley Festival del 2021, durante il quale per la prima volta si è realizzata a Torino una grande parata di tram e si sono conclusi il 3 e 4 dicembre 2022 con due eventi di portata storica.
Sabato 3 dicembre il convegno “Il tram, patrimonio culturale delle città” ha visto la partecipazione di oltre 80 persone, provenienti da diversi paesi europei e non solo. I relatori, scelti fra i massimi esperti tranviari mondiali, erano rappresentanti di 14 paesi ed hanno portato le loro testimonianze su importanti realizzazioni nel campo del trasporto tranviario storico. Da Canada e Nuova Zelanda provenivano i relatori che hanno affrontato il viaggio più lungo per venire nella nostra città. Lo scopo principale del convegno è stato quello di mettere a confronto le esperienze migliori e più rilevanti a livello mondiale nel campo del trasporto tranviario storico. Il convegno non si è svolto solo al chiuso di una sala, ma ha portato i partecipanti a pranzare sul Ristocolor e Gustotram, a visitare il deposito Tortona e l’Officina Centrale Gtt di via Manin, ad ammirare le Luci d’artista a bordo dei tram 2847 e 2759, a viaggiare da Sassi a Superga sulla storica cremagliera. I giri hanno suscitato molto entusiasmo così come la visita ai comprensori aziendali dove erano presenti anche i nuovi tram serie 8000, molto fotografati ed oggetto di numerose attenzioni. E non è mancato il modellismo come potete vedere in questo video.
(Foto di Davide Fenoglio e Antonio Lagrosa)
Domenica 4 dicembre il Trolley Festival si è svolto con una formula nuova. Al mattino la “Sarabanda tranviaria” ha aperto i festeggiamenti. Ben 15 tram storici hanno circolato continuamente con ingresso e uscita da piazza Castello su tre diverse direzioni: Giardini Reali, via Po e via Pietro Micca. L’autobus storico a due piani era dedicato al servizio passeggeri: fin da subito si è formata una lunga coda per salire. Fra le 12 e le 13 si è svolta una grande parata con la partecipazione di tutti i mezzi disponibili della flotta storica, integrati da esemplari di tram moderni, speciali e di servizio, per un totale di 22 veicoli. La parata, che ha percorso tutta via Po fino in piazza Vittorio, è iniziata con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadinee d è stata trasmessa in diretta. Hanno aperto il corteo la vettura più antica (la 116 del 1911) e la più giovane (la 8004 del 2022). La chiusura trionfale è stata lasciata al bus CV61. Al pomeriggio 6 tram e l’immancabile autobus hanno trasportato tantissime persone. Tra i passeggeri si aggiravano curiosi personaggi in costume: erano i rievocatori dell’associazione “Le vie del tempo”, da tempo amici dell'ATTS e entusiasti di "animare" i nostri tram. Tra i tantissimi appassionati era presente anche l’Associazione Storicbus, che ha organizzato un viaggio con uno storico autobus “370” per venire a trovarci. Il gazebo è stato operativo fino alla sera, ma già dal pomeriggio molti oggetti erano esauriti, tanto è stato l’entusiasmo con il quale l’iniziativa è stata accolta dai cittadini e dai turisti. Su tutti i mezzi era presente il logo dei 150 anni, grazie al generoso sostegno di IGP Decaux. Schiere di fotografi, appassionati o semplici curiosi hanno ammirato durante tutto il giorno il passaggio dei tram.
Queste giornate rimarranno sicuramente impresse nella mente e nei ricordi di tutti i soci che, in tanti modi, hanno impiegato il proprio tempo e le proprie straordinarie capacità per realizzare con passione questa grande festa dei tram. Un grande contributo è arrivato anche dal Gruppo Torinese Trasporti e dal Comune di Torino i quali hanno promosso e sostenuto organizzativamente l’evento.
I tantissimi ringraziamenti, le parole di stima e stupore insieme, l’attenzione delle autorità cittadine e il calore del pubblico non possono che essere di stimolo ad andare avanti su questa strada. Torino può considerarsi a pieno titolo la Capitale italiana del tram.
(Foto di Rebin Hadad, Antonio, Lagrosa, Alessio Pedretti, Mauro Ponzio)
Video (cliccare sul titolo per vedere il video):
- Trolley Festival 2022, che spettacolo!
- Trolley Festival 2022. Tutti i protagonisti
- Trolley Festival 2022. La parata
- Trolley Festival 2022. Il taglio del nastro
- Trolley Festival 2022. Autobus Viberti CV61 ATM Torino 2002
- Trolley Festival 2022. La diretta della parata
- Aspettando il Trolley Festival 2022
- Modellismo al convegno internazionale del 3 dicembre 2022

Aggiornamenti sul restauro del tram 614
di Davide Fenoglio
Su Tranvai di gennaio 2022 avevamo scritto del progetto di recupero del tram 614. Ora vi aggiorniamo sulle modifiche al progetto intervenute nel corso dello scorso anno e concretizzatesi con il trasferimento del tram lo scorso 16 gennaio.
Inizialmente si era pensato di lavorare ad un progetto di “Tram di quartiere” coinvolgendo la Casa del Quartiere “Cecchi Point” di via Antonio Cecchi a Torino, ma nel corso del 2022 questo luogo è diventato non più disponibile perché oggetto di un cantiere. Perciò si è individuato un altro spazio presso Cascina Falchera, che è un bene della Città di Torino concesso al Consorzio Kairos sino al 2040 con l’obiettivo di valorizzarne la vocazione educativa e trasformarlo in un hub di Innovazione sociale. Il 16 gennaio 2023 il tram è stato traferito dal deposito di Collegno al Cortile di Cascina Falchera in strada Cuorgnè 209, dove sarà oggetto in un primo tempo di restauro solo estetico grazie al contributo di FONDAZIONE CRT. Il restauro sarà a cura di ATTS ma le maestranze sono gestite dal Consorzio Kairos Torino coinvolgendo il progetto di falegnameria sociale (RE)Made of wood: un falegname professionista seguirà il lavoro pratico di restauro svolto da donne fragili al fine di un loro reinserimento lavorativo.
Il trasferimento è stato documentato con questo video.
L'intervento di restauro è realizzato grazie al contributo di Fondazione CRT ![]()

SOTTOVIE TRANVIARIE A TORINO
di Roberto Cambursano

IL TRAM TATRA K2 TORNA SUI BINARI DI PRAGA
di Gianpiero Bottazzi
I tram articolati K2 sono stati prodotti da Tatra nello stabilimento di Praga per ben 17 anni ma, fino ad ora, non avevano mai viaggiato con passeggeri sui binari della capitale ceca. La prima volta è stata domenica 5 febbraio 2023 quando la motrice 7000 ha fatto servizio sulla linea storica 42. E’ stato un vero e proprio evento a cui hanno partecipato tanti appassionati a bordo del tram e per le strade a scattare fotografie.
Il K2 è stato il primo tram articolato di serie costruito da ČKD Tatra tra il 1966 e il 1983 con funzionamento completamente elettrico. Negli anni precedenti erano stati realizzati due prototipi del tram articolato K1, ma il progetto non ebbe seguito per problemi all’impianto elettropneumatico.
Il prototipo del modello K2 è stato costruito nel 1966 e le corse di prova senza passeggeri sono state in gran parte effettuate sulle strade di Praga. E’ stato poi presentato alla Fiera Internazionale di Brno e in quest’ultima città ha fatto servizio regolare fino al 1988.
Il tram che ha esordito sulla linea 42 è stato invece prodotto nel 1977 per l’azienda dei trasporti di Bratislava e, per 32 anni, è stato utilizzato come scuola guida senza mai essere messo in servizio passeggeri. Per questo motivo non ha subito modifiche strutturali ed è rimasto con l’aspetto originale degli anni ’70. La motrice, dopo essere stata accantonata per 12 anni in un deposito di Bratislava, è stata acquistata nel 2021 da DPP (l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Praga) per un prezzo simbolico di 1.000 euro. Il restauro è poi stato effettuato dai tecnici dell’azienda dei trasporti di Brno. Il numero di matricola 7000 ha un valore simbolico in quanto era quello del prototipo del primo tram articolato K1 (che non entrò mai in servizio) e anche quello del prototipo K2 quando è stato presentato alla Fiera Internazionale di Brno nel 1966. Nei prossimi mesi il tram 7000 tornerà in officina per gli ultimi interventi di restauro e da maggio sarà impiegato in modo permanente sulle linee storiche di Praga.
Foto di František Zahnáš

Storie da oltreoceano: la realtà delle donne nei trasporti pubblici
Intervista a Maria Lucia Santagata
di Marcela Luque
Nove anni fa, quando l’anno 2014 stava per tramontare una studentessa universitaria acquistava in un’edicola della Estación Once il calendario 2015 della Asociación Amigos del Tranvía di Buenos Aires senza immaginare che in meno di dieci anni sarebbe diventata la Community Manager della nota associazione argentina per il recupero e la conservazione dei tram storici.
“La verità è che fin da adolescente mi sono interessata di trasporto pubblico e in particolare di ferrovie,” spiega, facendo un balzo indietro nel tempo Maria Lucia Santagata, 31 anni, laureata in Lettere e Community Manager presso la Asociación Amigos del Tranvía di Buenos Aires, Argentina.
E fu proprio in quella stazione ferroviaria del 1882 il cui nome fa riferimento alla rivoluzione dell’11 settembre del 1851 (Once de Septiembre) e che dagli abitanti di Buenos Aires è semplicemente conosciuta con il nome di Estaciòn Once che la corsa di Maria Lucia ebbe inizio.
“Conoscevo l'associazione di nome e ogni sabato vedevo passare il tram a pochi isolati di distanza dalla Facoltà di Lettere dove studiavo”. E aggiunge: “sono sempre stata favorevole alla conservazione del patrimonio storico e culturale”. Ed ecco che sul calendario appena acquistato vi era l'indirizzo della associazione, perciò, con soli 24 anni e ancora studente universitaria Maria Lucia decise di associarsi.
“Mi hanno accolto molto bene, con un'ottima predisposizione sin dall’inizio, “ricorda facendo un salto nel passato. Certo che di gavetta la futura Community Manager ne fece parecchia: “all’inizio e per molto tempo ci andavo solo un fine settimana al mese di solito come accompagnatrice,” racconta. All’epoca la Asociación Amigos del Tranvía non aveva un account Instagram, si raccontava tramite il proprio sito web e su Facebook.
“Quando Instagram esplose e visto il successo delle foto dei tram che avevo caricato sul mio profilo personale, ho suggerito di aprire l’account Instagram della associazione,” ricorda “visto che è un network che punta sul visivo e sull'immediato, ho pensato anche che fosse un buon modo per avvicinarsi ai creatori di contenuti.” Il Consiglio di Amministrazione dell’associazione fu subito d’accordo e l’account Instagram divenne un successo raggiungendo i 25 mila follower dopo soli tre anni.
Dopo il ruolo dei tram, del loro recupero, manutenzione, sicurezza e messa in funzione probabilmente sono quella della comunicazione e delle pubbliche relazioni le funzioni più importanti e decisive per una associazione che mira a restituire alle persone quel ritaglio di patrimonio storico che rappresentano i trasporti. “Dall'area della comunicazione e delle pubbliche relazioni, cerchiamo sempre di gestirci in modo chiaro; le persone sono molto interessate a conoscerci, quindi dobbiamo essere trasparenti con orari, luoghi e particolarità del servizio.”
E dall’incontestabile peso di Instagram quale motore per raggiungere la maggior quantità di persone Maria Lucia si dà da fare mirando sempre a “messaggi concisi ma completi, facili e piacevoli da leggere “senza escludere il pubblico che insieme ai tram diventa il vero protagonista di ogni corsa per via della pubblicazione delle foto che le persone inviano e rispondendo sempre ai loro commenti.
Essendo quella del Community Manager una collaborazione gestita attraverso la rete, il suo ruolo all’interno della Asociación Amigos del Tranvía non implica per Maria Lucia una grande rinuncia. È vero che molte volte andare al servizio significa non vedere la mia famiglia che abita in provincia, ma per lo più riesco ad organizzarmi per gestire i miei compiti quando posso e ho tempo.”
La città di Buenos Aires dove Maria Lucia vive e lavora e dove i tram della Asociación Amigos del Tranvía fanno i giri storici del sabato e della domenica vantava, a inizio del XX secolo una delle reti tranviarie più estese e non c’è da stupirsi vista le dimensioni della città stessa.
Come accadde nelle città europee gli anni Sessanta furono per Buenos Aires una svolta per il trasporto tranviario, ma a differenza di tante città dove i tram fecero retromarcia per ritornare qualche decennio dopo, la scelta di Buenos Aires fu quella di potenziare la metropolitana a discapito dei tram il quale una volta congedato non avrebbe fatto mai più ritorno.
Di donne tranviere quindi non ve ne furono allora ma ce ne sono oggi; quelle che con fierezza cercano di conquistare qualche centimetro di terreno quali lavoratrici dei trasporti pubblici. “Attualmente non ci sono donne che guidano i treni di superficie, sì invece la metropolitana” racconta Maria Luisa descrivendo la propria realtà “e ogni accesso a una nuova posizione da parte delle donne è accaduta solo dopo una grande lotta e tanta resistenza da parte di alcune strutture che hanno avuto difficoltà ad aggiornarsi”.
Il panorama si presenta ben diverso all’interno della Asociación Amigos del Tranvía nella quale altre donne oltre a Maria Lucia svolgono diverse mansioni di volontariato “non so se c'è qualcosa che le donne possono dare per la loro condizione di donne, ma l’inclusione di identità non maschili, può contribuire affinché le generazioni future (oggi ragazze) possano costruire la loro vocazione e i loro sogni per il futuro in modo più ampio, trovando donne di riferimento in mestieri e professioni prima per loro impensabili.”
In effetti nel primo decennio del nuovo secolo Buenos Aires non offriva uno scenario nel quale il binomio donna-trasporti potesse essere considerato all’interno di una rete interamente a gestione privata nella quale l’autobus rimane il mezzo di trasporto più utilizzato seguito dalla metropolitana.
Negli ultimi dieci anni -seppure timidamente- lo scenario è iniziato a mutare consentendo ad alcune donne di diventare autisti di mezzi pesanti, di taxi e di autobus mentre il numero di guardie e autiste della metropolitana continua a crescere. “Sento che a poco a poco -dice Maria Lucia con un segno di soddisfazione- ci stiamo aprendo a un accesso più equo a diverse posizioni nel trasporto pubblico per le donne.”
Tuttavia, l'accesso alla guida ferroviaria non è ancora consentito alle donne. Maria Lucia però si mostra ottimista in quanto “I risultati che le donne nel trasporto pubblico hanno raggiunto sono sempre stati associati all'attività collettiva”. Ciò grazie all’organizzazione e alla coordinazione tra le donne che lavoravano nei trasporti che hanno combattuto per posizioni di maggiore gerarchia oppure per una maggiore visibilità. “La sfida è non abbandonare l'organizzazione collettiva e non tagliarsi fuori – sostiene- in quanto tutte le conquiste sono state fatte insieme ad altre compagne e non credere che tutte le lotte siano già state risolte”.
I trasporti appartengono a quel gruppo di lavori che storicamente in Argentina sono stati prettamente maschili e per quanto lo scenario ad oggi si presenti diverso Maria Lucia invita a non abbassare la guardia: “Ci sono ancora strutture patriarcali da discutere, violenze e molestie che non dovrebbero essere ignorate.”
E conclude: “Ecco perché credo che, anche se molto è stato fatto, non dobbiamo rilassarci o smettere di lottare per ottenere quelle posizioni che sono ancora chiuse.”




Donne che muovono le nazioni
Maya Angelou: la prima bigliettaia di colore sui tram di San Francisco
di Marcela Luque
Era lì, sempre seduta da parecchi giorni. Ci arrivava all’apertura dell’ufficio e andava via solo quando le segretarie facevano altrettanto. Aveva sempre un libro in mano che leggeva per fare passare il tempo. E fu così giorno dopo giorno. Finchè un uomo bianco uscì da uno degli uffici e le disse “Vieni qui,” e chiese “perché vuoi il lavoro?”. “Perché mi piacciono le uniformi e poi mi piacciono le persone,” rispose. E Marguerite Annie Johnson più conosciuta come Maya Angelou, scrittrice ed attivista per i diritti delle minoranze, diventò la prima donna di colore a lavorare sui tram di San Francisco.
Era nata nel Missouri nel mese di aprile del 1928. Figlia di un portinaio e di una infermiera, per diversi problemi familiari Marguerite dovette trascorrere gran parte della propria infanzia a casa della nonna paterna. La nonna era “una sorprendente eccezione” alle durissime condizioni economiche degli afroamericani dell’epoca, ricordava Marguerite già divenuta Maya. Prosperò durante la Grande Depressione e anche durante la Seconda Guerra Mondiale per via del suo emporio che commercializzava generi di prima necessità e anche perché "generava saggi e onesti investimenti”.
E fu proprio in tempi di guerra che Maya diventò la “prima negra sui tram di San Francisco” come lei stessa si descriveva. Nella sua autobiografia del 1970 I Know Why the Caged Bird Sings (Il Canto del Silenzio) Maya ricorda questa singolare esperienza di lavoratrice tranviaria nei primi anni ’40.
Nell’autunno del 1943 Maya decise di prendersi una pausa dalla George Washington High School che allora frequentava e di fare esperienza nel mondo del lavoro. Il suo primo pensiero fu quello di lavorare in qualcuno degli impianti tra i tanti che ce n’erano per via della guerra. Tuttavia il programma dovette subito mutare perché "richiedevano i certificati di nascita, e il mio avrebbe rivelato che avevo quindici anni e non ero idonea al lavoro". Sapeva che le compagnie tranviarie assumevano donne, "e il pensiero di girare su e giù per le colline di San Francisco in una uniforme blu scuro, con un portamonete alla cintura, attirò la mia fantasia".
Dopo aver visto un annuncio pubblicato dalla Market Street Railway sul San Francisco Chronicle nel quale si richiedevano “motorettes e manovratori” si recò all'ufficio principale della compagnia -al 58 di Sutter Street- per fare domanda. Appena arrivata si chiese se volesse prendersi il disturbo di lavorare per una compagnia "dall'aspetto così povero e squallido". Marguerite pretese di compilare la domanda ma le segretarie negarono di fornirglielo. Questo fece sì che Maya diventasse ancora più determinata grazie all’incoraggiamento di sua madre. "Vai giù ogni giorno - le consigliò la mamma - e sii lì prima che arrivino le segretarie e siediti ad aspettare mentre leggi quel tuo libro russo." Angelou stava leggendo Fyodor Dostoevskij in quel momento. "E rimani seduta finché non se ne vanno a casa."
E così fece, tornando in quello squallido ufficio ogni giorno per due settimane fino a quando si aprì una porta e un uomo bianco le chiese il motivo per il quale ci teneva tanto a quel lavoro. Finalmente le fu concesso di compilare una domanda.
Iniziò la compilazione con il suo nome legale, Marguerite Johnson, ma poi "le domande standard mi hanno ricordato la necessità di mentire abilmente", a cominciare dalla sua età, che ha indicato come 19. Al momento di elencare le precedenti esperienze lavorative decise di inventare la “favola” di essere stata “compagna e autista della signora Annie Henderson (una White Lady) a Stamps, Arkansas”. Infine Maya ottenne il lavoro.
Il primo giorno di lavoro
Allora tram e funivie avevano squadre operative di due persone. I bigliettai nella parte posteriore delle vetture e i manovratori (motormen sui tram e gripmen sulle funivie) che guidavano le vetture nella parte anteriore. I due ruoli avevano requisiti diversi. Le prime bigliettaie di tram, soprannominate "motorettes", furono assunte sia da Municipal Railway che da Market Street Railway durante la seconda guerra mondiale, quando gli uomini che svolgevano quei mestieri furono chiamati alla guerra.
Maya Angelou era una motorette quindi lavorava sulla piattaforma posteriore dei tram elettrici, riscuotendo le tariffe e garantendo la sicurezza dei passeggeri. “La mamma mi diedi i soldi per farmi cucire il vestito blu e ho imparato a compilare le carte di lavoro, a far funzionare il portamonete e a dare il resto. All’inizio dondolavo ma verso la fine anche quando il tram diventava affollato io rimanevo sul retro del carrello rumoroso, sorridendo dolcemente e dicendo ai passeggeri di ‘fare un passo avanti, per favore’".
Margherite fu assunta dalla Market Street Railway Company, nel suo ultimo anno prima di essere rilevata dalla Municipal Railway di proprietà della città di San Francisco. Nei cinque mesi di lavoro quasi certamente svolse il suo ruolo in più linee comprese la 7-Haight e la 5-McAllister.
Angelou racconta che sua madre l'ha accompagnata in macchina al "deposito del tram ... vicino alla spiaggia" per iniziare il suo turno prima dell'alba, poi l'ha seguita nell'automobile di famiglia durante il suo primo viaggio in centro. Il deposito presso la Sutro Division tra la 32esima Avenue e Clement Street era quello più vicino alla spiaggia. Si trattava del Boneyard, un blocco urbano all'aperto tra Lincoln Way e 14th Avenue strapieno di tram abbandonati dove partivano le corse delle linee 7 e 17, così come la 6-Masonic linea, che arrivava fino al Ferry Building.
In Caged Bird, scrive: “Mi sono fatta strada rumorosamente e mi sono fatta strada lungo Market Street, con le sue case per i marinai senzatetto oltre il tranquillo rifugio del Golden Gate Park e lungo le abitazioni chiuse e poco abitate del Sunset District. " Quella descrizione corrisponde all'allora percorso del tram 7-Haight, che transitava da Market Street a Haight Street attraverso quello che in seguito fu chiamato Haight-Ashbury District. Con ogni probabilità ha lavorato sia sulle linee 5 che 7, e probabilmente su altre che sono arrivate al Ferry Building nel 1943. Questo mix di incarichi sarebbe stato normale per una neoassunta all’epoca e potrebbe anche spiegare il motivo per il quale Maya non riuscì mai a ricordare in quale linee aveva lavorato.
"Poiché il suo mandato è durato solo cinque mesi, è improbabile che sia mai riuscita a rimanere su una linea per molto tempo", sostiene Larry Bernard, operatore di tram in pensione presso la Municipal Railway. “Inoltre, avrebbe potuto trasferirsi da un deposito all'altro o essere stata assegnata 'secondo necessità, per la durata', per così dire”.Bernard, afferma che quando è entrato a far parte della Municipal Railway nel 1979, l’organizzazione del lavoro era cambiata di poco rispetto a decenni prima. I nuovi assunti appena terminata la formazione erano assegnati al “tabellone extra” fino alla successiva iscrizione, raccogliendo qualsiasi corsa di cui l’azienda avesse avuto bisogno.
Indubbiamente per la giovane Maya quella prima esperienza di lavoro vissuta in una varietà di linee si sarebbe tradotta, anni dopo, in una vasto ventaglio di ricordi.
Il peso della diversità
Per anni Maya ha pensato di essere stata la prima persona di colore a lavorare nei tram di San Francisco il che è certo in termini di genere ma non invece in termini di razza.
Già nel 1941 la Municipal Railway di San Francisco aveva assunto il primo operatore tranviario di colore: Audley Cole, un altro esempio di tenacia e perseveranza. Cole riuscì a passare gli esami e ottenere il lavoro per non aver compilato il campo “race” al momento di fare domanda. Tuttavia, una volta assunto gli operatori bianchi si rifiutarono di fornirgli la formazione necessaria e l’unico collega che era disposto a farlo fu picchiato a sangue. Cole, dovette imparare direttamente dal Responsabile della Formazione quattro mesi dopo di essere stato assunto.
Maya però questo non lo sapeva perciò dopo averto scoperto la vicenda di Cole decise di ridurre la sua descrizione a quella di “prima bigliettaia di tram nera a San Francisco”. Resta il fatto che la certezza non è del cento per cento visto che gli archivi di occupazione della Municipal Railway e della Market Street Railway non esistono più. Tuttavia nulla toglie il fatto che Maya Angelou sia stata una pionera che racconta una storia di grande coraggio e notevole tenacia.
“Ciò che trovo davvero notevole è la sua determinazione -sostiene Larry Bernard- di accettare all'età di quindici un lavoro tenuto quasi esclusivamente da maschi bianchi in un momento in cui la sua presenza sulla piattaforma posteriore di un tram, in uniforme, a richiedere il pagamento dei biglietti potrebbe forse aver provocato delle reazioni molto spiacevoli”. E prosegue: “parte dell'esperienza della signora Angelou deve essere stata provante, per non dire altro. Certo, era una donna eccezionale e, con il suo spirito indomabile, trovava molto da amare nel lavoro. È davvero un'ispirazione per tutti noi!”
In effetti, nei suoi scritti, Maya Angelou si concentra sugli aspetti positivi dei suoi cinque mesi sui tram di San Francisco. In un'intervista con Oprah Winfrey, ha raccontato che dopo essere tornata al liceo sua madre le chiese cosa avesse imparato su se stessa dopo aver lavorato sui tram. Maya rispose che veramente non lo sapeva ma sua madre la rassicurò: “Hai imparato che sei molto forte, hai determinazione e dedizione. Puoi andare ovunque nel mondo”.
Dopo la discesa dal tram
Come nei mesi delle corse in tram su e giù tra le colline di San Francisco Maya intraprese diversi percorsi una volta scesa dalla piattaforma posteriore dei tram della Municipal Railway.
Fece ritorno a scuola e pochi giorni dopo aver ottenuto il diploma diede alla luce suo figlio a soli 17 anni. Svolse una grande quantità di lavori molto diversi: cuoca, cameriera, spogliarellista, insegnante, prostituta, giornalista, ballerina e cantante.
Al momento della sua morte accaduta nel 2014, Maya aveva pubblicato ben sette libri autobiografici nei quali narra le sue esperienze di vita durante la prima adolescenza. Il suo primo libro Il Canto del Silenzio (I Know Why the Caged Bird Sings) fu pubblicato nel 1970 e riscosse un notevole successo. Scrisse anche tre libri di saggistica e numerose raccolte di poesia, libri per bambini, drammi teatrali e sceneggiature per programmi televisivi.
Poco prima della sua morte Maya Angelou ricevette il premio della Conference of Minority Transportation Officials (COMTO) nel contesto della sessione "Women Who Move the Nation". La COMTO è il principale sostenitore nazionale della diversità occupazionale, dell'inclusione e delle pari opportunità nel settore dei trasporti.

Foto:
- copertina: Maya ai tempi della High School www-streetcar.org
- foto 1: Maya Angelou -Conferenza MSU, settembre 2011 - https://www.montana.edu/
- foto 2 Maya e il presidente Obama - Google search
Fonti
- The Washington Post, "Why Maya Angelou wanted to become a streetcar conductor", Brown, DeNeen L., 26/06/2014.
- The Star Phoenix, "Angelou's optimism overcame hardships", Ferrer, Anne; 30/05/ 2014.
- Washington Post, “Maya Angelou honored for her first job as a streetcar conductor in San Francisco”, 12/03/2014.
- Mulley, C. (2022), "Women and Work in Public Transport: Historical and Contemporary Evidence", Wright, T., Budd, L. and Ison, S. (Ed.) Women, Work and Transport (Transport and Sustainability, Vol. 16), Emerald Publishing Limited, Bingley.

La ferrovia Rimini San Marino, 12 anni di esercizio e quasi 70 passati in galleria
di Alessio Pedretti
Recentemente la Repubblica di San Marino è finita sul palco della ribalta internazionale grazie alle notevoli iniziative legate al parziale ripristino della Ferrovia Rimini - San Marino, un piccolo capolavoro ferroviario (32km di cui 19,8 in territorio sammarinese, 643m di dislivello, 17 gallerie, scartamento 950mm e tensione 3000v c.c.) che ha avuto vita assai breve in quanto è stata esercitata solo tra il 12 Giugno 1932 e il giorno 11 Luglio 1944, giusto per appena 12 anni e un mese, purtroppo a causa dei pesanti bombardamenti subiti nella Seconda Guerra Mondiale. Le stranezze e curiosità di questa ferrovia, oltre che essere comunque "internazionale", consistono nel fatto che parte del materiale rotabile è stato ricoverato ed abbandonato per decenni in una galleria sino ad almeno il 9 giugno 2011 ovvero per quasi 70 anni diversi rotabili sono rimasti chiusi in galleria. Solo negli ultimi tempi grazie anche alla particolarmente attiva ATBA Associazione Trenino Bianco Azzurro operante nella Repubblica più antica del mondo, si è potuto recuperare prima staticamente e poi integralmente l'elettromotrice AB03 realizzata da Carminati & Toselli e TIBB nel 1932.
L'argomento "Trenino" è particolarmente sentito nella piccola Repubblica tanto che lo stesso è stato protagonista delle manifestazioni natalizie del dicembre 2022 con tanto di esposizione di trenino colorato con luci natalizie presso Piazza Libertà ed ancora è stato protagonista grazie all'apertura ed allestimento di una mostra dedicata ad esso presso la Galleria della Cassa di Risparmio nel cuore dell'antico borgo, con esposizione di reperti e fotografie storiche.
L'elettromotrice AB03 è stata recuperata nel giugno 2011 dopo esser rimasta in una galleria per quasi 70 anni, indi è stata riportata alle migliori condizioni estetiche sia internamente che esternamente e dulcis in fundo in ultimo è stata resa funzionante onde poter percorrere un tratto di circa 800 metri all'interno della Galleria "Il Montale", con tanto di corse accessibili al pubblico nel periodo natalizio, tornando così a trasportare passeggeri dopo circa 78 anni. Le immagini ritraggono l'elettromotrice AB03 all'incirca un'oretta prima della celebrazione avvenuta il giorno 28 dicembre 2022, anno in cui tra l'altro si sono celebrati i 90 anni della ferrovia "per Rimini", sebbene 78 di questi trascorsi senza effettuare alcun servizio passeggeri. L'elettromotrice è stata agghindata per Natale, mentre recentemente dovrebbe esser stato convalidato un finanziamento da parte della RSMN per portare il binario in avanti verso il Piazzale ex Stazione per circa 150 metri.
Proprio presso il piazzale della ex Stazione in un angolo è stato preservato un carrello di riserva originariamente adottato sulle 4 elettromotrici serie AB01/AB04 realizzate da Carminati & Toselli - TIBB nel 1932, ricordando che la AB01 si trova ancora ricoverata in attesa di restauro presso il deposito di Stato di Galavotto (RSMN); le elettromotrici AB02 ed AB04 vennero cedute negli anni Novanta del secolo scorso alla FGC Ferrovia Genova Casella anche se a quanto pare la prima è stata distrutta da un incendio doloso nel 1995 quando ancora si trovava dentro la galleria in territorio sammarinese mentre della AB04 la piccole ferrovia genovese ha recuperato carrelli e motori in seguito utilizzati sulla elettromotrice genovese A2 e sul locomotore B51 in seguito ceduto a TT Trentino Trasporti per la ferrovia Trento-Malè-Mezzana, essendo a sua volta un ex FEVF Val di Fiemme.
Dal 26 Novembre 2022 e sino al 8 Gennaio 2023 (in seguito prolungata sino al 30 Gennaio successivo) presso la Sala della Cassa di Risparmio nel cuore di San Marino Città e nell'ambito delle manifestazioni legate all'evento natalizio "Natale delle Meraviglie", è stata allestita e resa visitabile una mostra dedicata alla Ferrovia di San Marino con fotografie storiche ed esposizione di cimeli, successivamente spostata presso il piazzale ex Stazione ovvero se non erro presso la sede di ATBA Associazione Trenino Bianco Azzurro. Era possibile osservare reperti e modellini ed alcuni componenti dei rotabili che nel frattempo nello stesso periodo hanno compiuto i 90 anni di esistenza, di cui incredibilmente almeno 78 trascorsi al chiuso in una galleria.
Immagini della elettromotrice AB03, del carrello e della mostra allestita presso presso la Sala della Cassa di Risparmio (foto Alessio Pedretti)

CON LA GONNA IN TRAM: LE ORIGINI DEL PIANALE RIBASSATO
di Roberto Cambursano
Può sembrare incredibile, ma già nel 1912 circolarono a New York i primi tram a pianale ribassato della storia, con il pavimento alla strabiliante altezza di soli 25 cm dal piano del ferro (!), su progetto dell’ingegnere Frank Hedley, direttore della “New York Railways Company” e del suo collaboratore JamesDoyle. La casa costruttrice Brill di Filadelfia fornì tre differenti prototipi del cosiddetto “one step car”, anche detto “stepless car”, tutti bidirezionali e atti alla gestione con doppio agente (guidatore e bigliettaio): erano veicoli altamente innovativi e vennero immessi in regolare servizio pubblico a Manhattan sulle linee della rete gestita dalla neo-costituita New York Railways Company.
Figura 1: Traffico di tram di tipo "One step car", costruiti dalla Saint Louis Car Company, sulla Broadway a New York (USA). Cartolina d’epoca,1914. |
Dunque, una sorprendente sensibilità ante-litteram verso i portatori di handicap? Niente affatto! A quanto pare, la finalità dell’adozione del pianale ribassato era quella di favorire l’incarrozzamento delle donne delle classi benestanti che frequentavano i teatri di Broadway: infatti in quell’epoca andavano di moda le scomode gonne lunghe e strette al fondo (“hobble-skirts”), e il pianale alto costringeva a sollevarle mostrando le gambe in salita e in discesa!
Figura 2: Vista interna del prototipo Brill nr. 5000 di “stepless car” per New York (USA). Da “Brill Magazine”, 1912. |
Il primo prototipo (n. 5000) era un tram lungo 14,2 e largo 2,51 metri, dotato di una sola porta centrale su ogni fiancata composta da due ante scorrevoli, con cassa in acciaio e presa di corrente sotterranea (sistema “conduit”); il pavimento era del tutto privo di gradini interni, grazie all’adozione di due carrelli di tipo 62E-“maximum traction” e alla collocazione dei motori a sbalzo verso le estremità del tram, il che permetteva di estendere il ribassamento del pavimento fino ad oltre la mezzeria dei carrelli, con una impercettibile pendenza interna che raccordava il centro del veicolo con le due zone di estremità dove erano collocati i “salottini” costituiti da sedili disposti a semicerchio. Poteva caricare 90 passeggeri, di cui 51 seduti e 39 in piedi. Il tram era dotato di equipaggiamento Westinghouse: due motori 553R3 da 50 Hp, controller elettro-pneumatici PK1 e freni pneumatici.
Figura 3: Figurino, in pianta e sezione, del prototipo Brill nr. 5000 per New York (USA). Da “Brill Magazine”, 1912. |
Dopo il successo della sperimentazione, questo tram venne poi costruito dalla Brill in una serie di 36 esemplari per alcune città californiane minori e altri singoli prototipi circolarono in Canada a Vancouver e in Australia a Perth e Brisbane.
Figura 4: IL carrello Brill tipo 62E “maximum traction”. Da “Brill Magazine”, 1912. |
La parte del leone la fece però la casa costruttrice rivale Saint Louis Car Company, che a partire dal 1914 ne costruì su licenza altri 175 esemplari per New York, numerati da 5001 a 5175: questi ricalcavano il prototipo 5000, ma presentavano due vistosi paraurti alle estremità che fuoriuscivano dalla sagoma formando una sorta di “becco d’anatra”, collegato a una protezione in lamiera dei carrelli sui due lati. Nella Grande Mela questi tram rimasero in servizio per pochi anni: infatti vennero tutti alienati già nel 1925, dato che la loro unica porta centrale non consentiva la trasformazione ad agente unico (operazione che l’azienda esercente fu costretta progressivamente a fare a causa di grossi problemi finanziari).

Figura 5: Un tram a pianale ribassato di tipo Hedley-Doyle ("One step car") della serie 5000 costruita dalla Saint Louis Car Company, in servizio a New York (USA). Archive Library of Congress, Anni 1910. |
Il secondo prototipo (n. 6000, soprannominato “Broadway Battleship”) era un tram a due piani di grandi dimensioni che poteva caricare 171 passeggeri (di cui 83 seduti e 88 in piedi), anch’esso alimentato col sistema sotterraneo “conduit”. Non ne venne mai avviata una produzione di serie: la Brill produsse un secondo prototipo simile per la città di Columbus, dove circolò dal 1914 al 1918, mentre a New York questo tram rimase un esemplare unico e fu ritirato dal servizio già nel 1922: a causa del grosso volume di carico e della presenza di una sola porta su ogni lato, l’esercizio risultò infatti eccessivamente lento e antieconomico.
Figura 6: Figurino, in pianta, prospetto e sezione, del prototipo Brill nr. 6000 per New York (USA). Cartolina d’epoca,1912. |
Figura 7: Il prototipo Brill nr. 6000 di “stepless car” a duepiani in servizio a New York (USA). Cartolina d’epoca,1912. |
Come si vede dalle immagini, anche in questo caso il pavimento era mantenuto tutto basso ad eccezione delle parti sopra le estremità dei carrelli; anche le due cabine di guida avevano il pianale più alto per permettere la rotazione dei carrelli (due Brill 62-E maximum traction). Il tram era dotato di equipaggiamento Westinghouse: due motori 310G3 da 60 Hp, controller elettro-pneumatico e freni pneumatici. L’altezza complessiva superava di poco i 4 metri ed il piano superiore era raggiungibile tramite due scale interne di estremità; la vettura era “convertibile” in inverno con l’aggiunta di pannelli e finestrini.
Figura 8:Figurino, in pianta e prospetto, del prototipo Brill nr. 7000 di “stepless storage battery car” per New York (USA).Da “Brill Magazine”, 1912. |
Il terzo prototipo (n. 7000) era un tram di piccola taglia pensato per rivitalizzare le linee secondarie finora rimaste alla trazione equina, a due assi con alimentazione esclusivamente ad accumulatori, sempre con una porta centrale su entrambi i lati e con una capacità di carico di 62 passeggeri (di cui 34 seduti e 28 in piedi).
Al prototipo fece seguito una produzione di 115 unità di serie che prevedevano alcune modifiche, la principale delle quali riguardava le porte, apribili a libro e più larghe di quelle del prototipo. La trazione tranviaria a batterie a New York ebbe termine però già nel 1919, con un successivo effimero ripristino di una singola linea fra il 1920 e il 1931: evidentemente i risultati di gestione risultarono fortemente negativi sia dal punto di vista tecnico sia per i costi del personale (non dimentichiamo che anche su questo piccolo veicolo erano presenti due agenti).
Figura 9:Vista laterale del prototipo Brill nr. 7000 di “stepless storage battery car” per New York (USA).Da “Brill Magazine”, 1912. |
Un altro esempio di tram a pianale basso da segnalare è quello delle eleganti vetture a due piani di Vienna entrate in servizio nel 1915, con il pavimento a 40 cm dal piano del ferro e con un solo gradino interno, che presentavano un originale restringimento di sezione “a vita di vespa” nella parte centrale avente lo scopo di ridurre lo spanciamento del veicolo in curva.
Le due vetture bidirezionali, costruite dall’azienda locale SPG e battezzate “Tipo F”, erano chiaramente ispirate al prototipo Brill di New York. Erano lunghe 13,5 metri e avevano carrelli “maximum traction”; nonostante la stazza, il restringimento di qualche centimetro della larghezza della cassa nella sua parte centrale consentiva loro di percorrere curve di soli 17 metri di raggio (senza divieto d’incrocio con le vetture circolanti in senso opposto). Tuttavia, i numerosi limiti a cui erano soggette (presenza di due bigliettai, eccessivo peso e scarse prestazioni, instabilità di marcia, altezza eccessiva per la circolazione su tutta la rete) costrinsero l’azienda esercente a ritirarle dal servizio già negli anni Trenta.

Figura 10: Un tram SPG del tipo F in servizio a Vienna (Austria). Da Archiv Stadtwerke Wien, 1915. |
Doveva passare mezzo secolo prima che il pianale ribassato tornasse ad essere adottato sui tram come regola, e questa volta con ben altri scopi….

Il ritorno dell'ATTS Show
di Davide Fenoglio
Dopo tanti anni, è tornata una delle manifestazioni più amate dal nostro pubblico, l’ ATTS Show.
Dal 2015 infatti, il deposito della Stazione Sassi non apriva più le porte ai visitatori. Per compensare questa lunga assenza ATTS ha pensato di fare le cose in grande. Due giorni di apertura, una bellissima mostra, un inedito mercatino di antichità tranviarie, l’esposizione di molti pezzi della nostra collezione storica hanno caratterizzato questa edizione. Ma andiamo per ordine partendo dai mezzi circolanti che, dallo scenografico capolinea di piazza Coriolano, hanno portato il pubblico fino in piazza Vittorio. Durante le due giornate si sono alternati i nostri tram più particolari rappresentanti un po’ tutte le epoche: 116, 2592, 201, 3501, 2759. Non poteva mancare il mitico bus a due piani rosso crema, che suscita sempre ammirazione nei passanti. I nostri mezzi erano anche esposti nel piazzale e nella rimessa della stazione. Il 209 del 1911, unico tram della società belga STT ancora esistente e una rimorchiata aperta della cremagliera risalente al 1884 hanno accolto il pubblico sul secondo binario della stazione. La 2598 ha ospitato la ricca collezione di pezzi storici recentemente restaurati: un controller milanese K35, alcune vecchie obliteratrici, un manipolatore di marcia, un interruttore di linea, un indicatore di uscita, un numeratore e tanto altro. Il curioso autocarro C90 è stato esposto per la prima volta al pubblico dopo la recente acquisizione da parte dell’ATTS. All’interno della rimessa la 502 è stata oggetto di molte foto e ammirata per i particolari interni in legno. Naturalmente non poteva mancare il modellismo con il plastico ATTS e la Gran Madre in Lego. Tanti ospiti ci sono venuti a trovare esponendo bellissimi diorami a partire da quello rappresentante la stazione di Castellamonte, quelli di Londra o Stoccarda e gli scorci ferroviari di Arcamodellismo. Una mostra di cartelli di fermata e biglietti ha attirato la curiosità di molti visitatori. Uscendo all’esterno e dopo qualche acquisto al gazebo o al mercatino era ancora possibile visitare lo spazio espositivo del Gtt che ospita l’ultimo tram a cavalli ancora esistente, oltre ad una ricca collezione di cimeli, fotografie, documenti. Nella Sala Martiny è stata allestita la coloratissima mostra “Sono un tram di Torino” con gli acquerelli di Tommaso Garosci. La mostra resterà aperta fino al 2 luglio.
L’ATTS Show è stata una vetrina per le attività dell’associazione, un’occasione per conoscere vari aspetti del trasporto pubblico e incontrare appassionati, curiosi e gente comune interessata al mondo dei tram. La grande affluenza di pubblico ed i numerosissimi apprezzamenti sono stati il giusto riconoscimento per il grande impegno dei soci.
Perciò vi diamo appuntamento alla primavera 2024 con i festeggiamenti per i 140 anni della Sassi – Superga!
Scopriamo l'ATTS Show grazie al video di Antonio Lagrosa e al servizio di GRPtelevision.
Foto di Davide Fenoglio, Rebin Hadad, Antonio Lagrosa, Francesco Piperata

VAG Friburgo: alla scoperta di una rete tranviaria interessante, partiamo dalle decane (1° parte)
di Alessio Pedretti
Iniziamo il nostro viaggio da Friburgo, città extracircondariale della Germania sud-occidentale presso la quale risiedono all'incirca 236.150 abitanti, quarta per dimensioni (in termini di abitanti ovviamente) nel proprio Land del Baden-Wurttemberg dopo Stoccarda, Mannheim e Karlsruhe. Porta ufficiale della Foresta Nera (tanto da avere come specialità culinaria proprio la "Torta della Foresta Nera"…) nacque dopo l’anno 1000 come piccolo insediamento e grazie alla presenza di vicine miniere di argento la città ha iniziato ad avere un certo benessere e godere di rapida crescita. Curioso osservare come nella storia moderna, esattamente in seguito al Trattato di Campoformio del 1797 la città venne assegnata ad Ercole III d'Este, Duca di Modena e Reggio, il quale tuttavia rinunciò a prenderne possesso a causa del basso reddito cittadino. Merita ancora ricordare che nel corso della Seconda Guerra Mondiale la città subì danni rilevanti, il 27 Novembre 1944 un pesante bombardamento rase al suolo l'intera parte settentrionale della città vecchia e gran parte di quella occidentale, in seguito la città venne successivamente ricostruita rispettando la planimetria originale anche se furono ricostruiti in modo fedele solo gli edifici pubblici o di particolare valore storico. Gemellata con l’italiana Padova, Friburgo curiosamente possiamo dire che non ha visto nascere personaggi particolarmente famosi che hanno fatto la storia d’Europa, se non un gran numero di sportivi di ogni genere e giusto come cameo possiamo citare il fatto che tra i nativi della zona vi è il direttore della Galleria degli Uffizi a Firenze Eike Schmidt.
LA RETE TRANVIARIA E COLEI CHE LA GESTISCE OVVERO VAG
La rete tranviaria di Friburgo, oltre che essere la rete tranviaria tedesca più meridionale dal punto di vista geografico (escludendo dunque eventuali sconfinamenti degli svizzeri a Basilea...), viene spesso citata come esempio da seguire a livello nazionale tanto che l'ampliamento della rete avvenuto a partire dal 1980 è considerato come un esempio della rinascita del tram in Germania (mentre noi continuiamo sempre a pensare di essere i più furbi...). La storia del tram elettrico a Friburgo ha inizio il 14 Ottobre 1901 per ampliarsi continuamente sino al 1914 indi la rete venne ritoccata solo nel 1925 con una ulteriore apertura, qualche ulteriore variazione nel 1928 e 1931 per poi subire un processo di soppressioni dal 1959 al 1962 e riprendere con nuove estensioni dal 1983 ad oggi, periodo nel quale solo ad un paio di soppressioni sono corrisposte le aperture di nuovi tracciati ed itinerari. La rete tranviaria gestita oggi da VAG Freiburger Verkehrs AG può contare su una rete di 35,7 km su cui si estendono 5 linee che insieme costituiscono una rete esercita di 42,6 km che rispetta 78 fermate, merita giusto ricordare che lo scartamento è metrico (1000) mm e la linea aerea era alimentata a 600v c.c. sino al 1983 per poi passare agli attuali 750v c.c.. L’azienda nel suo insieme riesce a trasportare 63,4 milioni di persone con 73 elettromotrici che viaggiano su una rete dove non si possono superare i 70 km/h, merita ricordare che nelle notti tra venerdì sera e domenica mattina il servizio viene svolto no-stop con frequenze adeguate.

Di seguito le 5 linee esercite a tutto Giugno 2023:
1 Littenweiler – Landwasser, 22 fermate per 9,9 km, 29 minuti di percorrenza, frequenza 6 minuti, 15 vetture utilizzate
2 Gunterstal – Hornusstrasse, 20 fermate per 8 km, 30 minuti di percorrenza, frequenza 10 minuti, 8 vetture utilizzate
3 Vauban – Haid, 21 fermate per 9,2 km, 32 minuti di percorrenza, frequenza 6 o 7,5 minuti, 11 vetture utilizzate
4 Freiburg Messe – Zahringen, 20 fermate per 9,2 km, 32 minuti di percorrenza, frequenza 6 o 7,5 minuti, 12 vetture utilizzate
5 Europaplatz – Rieselfeld, 15 fermate per 6,3 km, 19 minuti di percorrenza, frequenza 6 o 7,5 minuti, 8 vetture utilizzate
Prima di esaminare i veicoli possiamo già riportare alcune interessanti caratteristiche della rete: le vetture unidirezionali (con una sola cabina, meglio note come GT8 nelle varie sottoserie K ed N) non possono essere utilizzate sulle linee 2 e 5 in quanto queste due linee presentano almeno un capolinea ad asta e non a racchetta, inoltre durante la nostra prima visita (Aprile 2022) in seguito a lavori nella parte settentrionale della rete (spostamento dell'asse tranviario da Komturstrasse alla più ampia Waldkircher Strasse, modifica messa in opera a metà Giugno 2023) e solo eccezionalmente per quel periodo, anche la linea 4 doveva essere effettuata con vetture bidirezionali essendo limitata a Okenstrasse non potendo raggiungere il suo capolinea settentrionale di Zahringen ed analogamente la linea 2 risultava essere attestata alla fermata F. Ebert Platz.
Analogamente nel Giugno 2023 a seguito di lavori di rinnovo dell'armamento in zona Haid e nei pressi del deposito (VAG Zentrum), la linea 3 risultava essere attestata all'anello di Bissierstrasse con varie fasi e lavori che spesso accomunano le varie città europee in questo periodo. In questi diversi casi veniva comunque garantito un servizio sostitutivo meglio noto come "SEV" (teorica contrazione di "Schienenersatzverkehr"...) gestito sia direttamente con autobus di VAG Friburgo che con vetture di altri operatori su gomma, come vedremo.
Passando ad altro, risultano essere interessanti sicuramente la fermata di Stadion sulla linea 4 che viene osservata solo in direzione città nel nuovo tratto tranviario aperto solo il 13 Dicembre 2020 tra Technische Fakultät e la Fiera di Friburgo (fermata peraltro al servizio del nuovo Stadio e disposta su un tratto leggermente in trincea per non essere di disturbo alla pista del vicino Aeroporto…) e giova anche essere citato il bellissimo tratto meridionale della linea 2 verso Gunterstal, graziosa località ove il tram raggiunge il centro della borgata attraversando una porta e per di più con un tratto a binario unico che termina presso un capolinea ad asta che di fatto, come abbiamo già scritto, inibisce l'utilizzo delle vetture unidirezionali sulla linea 2, tratto per altro che risulta essere stato tra i primi ad esser attivato nel lontano 1901.
Meritano inoltre di esser citati altre due aspetti: il capolinea settentrionale di Zahringen (altrimenti noto anche come Gundelfinger Strasse) che per pochissimi metri invade il territorio comunale del vicino paese di Gundelfingen, mentre merita di essere citata la moderna attuale fermata della Stazione ferroviaria ovvero Hauptbahnhof (servita da 4 linee sulle 5 esercitate, manca solo proprio la linea 5) disposta a ponte sulla stazione, con possibilità di scendere direttamente dalla banchina tranviaria alle banchine ferroviarie, fermata e nuove rampe di un nuovo ponte realizzato ed aperto nel Settembre 1986 al posto di un precedente itinerario di cui sopravvive solo il vecchio ponte che attraversa la stazione nella sua zona meridionale.
VETTURE TRANVIARIE
La rete tranviaria di VAG Friburgo può contare su 73 elettromotrici suddivisibili sostanzialmente in tre grosse famiglie (GT8, Combino ed Urbos) suddivisibili a loro volta in 6 sottoserie: le Duewag originali e varie derivazioni (declinabili in GT8K, GT8N, GT8Z), i noti Combino (suddivisibili in Basic ed Advanced) ed infine i CAF Urbos (già incontrati a Besancon, se ricordate, vedi precedente mail). In particolare nel dettaglio sono utilizzate nell’esercizio quotidiano le seguenti vetture:
- 2 elettromotrici unidirezionali GT8K serie 205/214 costr. Duewag del 1981/82 (ultime in attività matr. 212-214)
- 10 elettromotrici unidirezionali GT8N serie 221/231 costr. Duewag del 1990/91
- 26 elettromotrici bidirezionali GT8Z serie 241/266 costr. Duewag del 1994
- 8 elettromotrici bidirezionali Combino Basics serie 271/279 costr. Siemens del 1999/2000 (matr. 272 radiata)
- 10 elettromotrici bidirezionali Combino Advancedserie 281/290 costr. Siemens del 2004 e 2006
- 17 elettromotrici bidirezionali Urbos serie 301/317 costr. CAF del 2015, 2017 e 2020/21
A queste a breve si aggiungeranno ulteriori 8 elettromotrici CAF Urbos ordinate (serie 318/325) previste in consegna nel 2023/24 e che dovrebbero mandare in pensione almeno le ultime elettromotrici GT8K ed una buona metà delle consimili GT8N. Lasciando alcune caratteristiche ed ulteriori dettagli alle didascalie delle immagini, possiamo citare il fatto che il Combino Basic matr. 272 è stato “precocemente invecchiato” e successivamente radiato onde studiare gli effetti di quella che diventerà poi nota come "debacle” dei Combino, la stessa Siemens consegnerà in sostituzione della vettura citata il Combino Advanced matr. 290. Merita giusto ricordare che le “Duewag” unidirezionali non possono circolare sulle linee 2 e 5, relazioni che presentano almeno un capolinea ad asta, le elettromotrici Combino e Urbos non posso circolare sulla linea 2 in quanto non abilitate al caratteristico capolinea di Gunterstal (causa lunghezza limitata dell'asta terminale) ed infine le elettromotrici GT8Z bidirezionali comunque per scelta dell’azienda non vengono utilizzate sull’importante linea 1 semplicemente perché la loro capacità viene ritenuta troppo bassa, trattandosi della linea più trafficata della rete.
Da ricordare infine i depositi tranviari: sostanzialmente ne sono esistiti tre o meglio due riuniti in un terzo in epoca recente, identificabili con i punti cardinali: il deposito Sud nei pressi di Urachstraße/Lorettostraße attivo sino al 1994 è tuttora esistente e viene ora utilizzato in parte dai Vigili del Fuoco ed in parte come Museo e base per le vetture storiche destinate alla linea storica 7, essendo la struttura tuttora raccordata alla rete; il deposito Nord in Komturstrasse ha perso anch’esso importanza a seguito dell’apertura del deposito Ovest, ha infatti resistito sino al 2007 ed in seguito è stato demolito per fare spazio ad edifici residenziali. Infine possiamo dire "tutto è confluito" nel deposito Ovest, sede generale VAG (fermata VAG Zentrum), gigantesca piazza d’armi ove vengono ricoverati autobus e tram, ha assorbito i compiti dei depositi Nord e Sud. Da ricordare che esisteva poi un deposito per la manutenzione dei binari nella zona nord-occidentale in Kaiserstuhlstraße e che dovrebbe esser arrivato sino agli anni ottanta del secolo scorso come zona accantonamento e demolizione delle vetture, ora probabilmente ancora esistente ma ceduto a terzi con scopi non aventi più a che fare con l’azienda.
Proviamo dunque a fare una passeggiata per Friburgo… iniziando con una prima parte di quattro dedicate alla rete tranviaria. Partiamo proprio da quelle elettromotrici che potrebbero venire ben ben ridimensionate con il prossimo inverno.
FOTO
(tutte del 19 e 20 Aprile 2022 e 22 Giugno 2023)


212-Bertoldstraße-Stadtteather
212-Vauban-retro
L'elettromotrice 212 risulta essere la decana tra tutte, o meglio anche quella con la matricola più bassa, regolarmente impegnata in servizio sulla linea 1 mentre transita presso lo StadtTheater il 20 Aprile 2022 e sulla linea 3 al capolinea di Vauban il 22 Giugno 2023. Tale macchina risulta essere in servizio dal 1981 realizzata a tre casse dalla Duewag, facente parte di una serie di 31 macchine suddivisibili tra 1° serie 201/204 del 1971/72 (fanale unico o due ravvicinati in seguito, radiate nel 2001, cedute a Lodz in Polonia ove sono state a loro volta radiate tra il 2012 e 2015), alle quali solo nel 1981/82 ha fatto seguito la 2° serie 205/214 note come GT8K di cui sopravvivono in servizio appunto solo le matricole 212 e 214. Da notare la parte centrale della cassa non ribassata, il pantografo monobraccio ed i nuovi indicatori di linea elettronici, aspetti che ringiovaniscono la vettura, oltre alla livrea pubblicitaria integrale di una nota bibita.

221-Bertoldstraße
Le successive elettromotrici GT8 di 3° serie matricole 221/231, meglio note ora come GT8N, sono nate invece nel 1990/91 a distanza di ben due decenni dai primi esemplari di cui conservano la filosofia, si tratta quindi di 11 esemplari i quali, a quanto pare, sin dalla nascita hanno sempre presentato la porzione centrale della cassa ribassata e curiosamente il pantografo "gemellato o a forbice" che tuttora hanno in dotazione, a differenza del monobraccio delle precedenti unità, che per noi invece solitamente risulta essere segno di evoluzione e non involuzione di tale strumento. L'elettromotrice capostipite 221 è ritratta sulla linea 3 diretta ad Haid nell'Aprile 2022, presenta una livrea parzialmente pubblicitaria dato che sullo sfondo si percepisce comunque il bianco crema e rosso amaranto della livrea cittadina. Si noti la sezione centrale a pianale ribassato (originale e non postuma od applicata successivamente) e il vecchio indicatore a matrice di punti gialli.


222-Kaiser Joseph Straße-Bertoldsbrunnen
222-Kaiser Joseph Straße-Martinstor
In una città particolarmente portata come esempio in tutta Europa per il suo modo di vivere e per il rispetto per l'ambiente, un luogo ove si può vivere senza automobile, l'elettromotrice 222 del 1990 si candida anche come protagonista della autopromozione di VAG con la campagna ""#EVERYDAYFORFUTURE" e la sua interessante livrea, la incontriamo in due momenti differenti della giornata mentre è impegnata sulla linea 3 presso Bertoldsbrunnen ovvero il punto centrale della città ed anche dove si incontrano ben 4 linee tranviarie. Con i loro 32,8m tali elettromotrici non risultano essere né un ingombro né un particolare pericolo per l'incolumità dei pedoni, per i quali forse sono ben più pericolosi i simpatici rivoletti d'acqua che caratterizzano diverse strade del centro storico...


224-Hauptbahnhof-
224-Stadttheater
Davanti al Teatro di Friburgo il 22 Giugno 2023 transita l'elettromotrice 224 del 1990 impegnata sulla linea 1 mentre attraversa i binari della linea 5 con la stessa livrea anonima ed anomala bianca con imperiale rosso (forse in attesa di una pellicolatura integrale pubblicitaria...) che non risulta essere la livrea aziendale come avremo modo di vedere con altre vetture della stessa serie. Livrea "non livrea" che mostrava anche nell'Aprile 2022 frangente nel quale l'abbiamo catturata mentre scende dalla fermata "a ponte" della Stazione ferroviaria dirigendosi verso il centro cittadino. Per le GT8N o "GT8 di 3° serie" che dir si voglia, per ora l'unica elettromotrice mancante risulta essere la matricola 223 coinvolta in un incidente e rottamata nel 2019, il cui "lato B" dovrebbe esser stato recuperato per l'elettromotrice matr. 230, tuttora in servizio. Da notare come nell'immagine ove è ritratta di coda, la collina sullo sfondo rappresenta già la fine del centro storico di Friburgo, mentre nell'altra immagine i due campanili sullo sfondo sono posti oltre la ferrovia e dunque al di fuori del centro storico della graziosa città.


225-Bertoldstraße-Stadtteather
225-Haid-interni
Dell'elettromotrice 225 possiamo osservare anche gli interni, e la foto è stata scattata proprio dai caratteristici sedili posti al centro del corridoio prima di scendere alla parte ribassata centrale della vettura. Da notare come le pellicolature pubblicitarie a Friburgo coinvolgono tutta la vettura (dettagli del frontale compresi!) segno evidente che molto probabilmente ogni cliente pubblicitario evidentemente "impegna" la vettura per diversi mesi, dato che ne viene fatto un lavoro così meticoloso. Da notare alcuni aspetti degli interni tra cui la disposizione dei sedili 2+1, la presenza delle emettitrici a bordo e dei sedili con imbottiture. Lascia ovviamente di stucco la pubblicità nei riquadri, ove due personaggini animati (di nome Kela e Uku dal pianeta Upsyla!) che spiegano agli studenti in 8 semplici capitoli alcuni dettagli del trasporto pubblico.

226-Bertoldstraße
Tre simboli di Friburgo in una sola immagine: biciclette utilizzate con buon senso senza invadenti e scriteriate piste ciclabili, il trasporto pubblico rappresentato dall'elettromotrice 226 del 1990 impegnata sull'importante linea 1 e dotata della livrea pubblicitaria di turno mentre si avvicina all'importante incrocio/fermata di Bertoldsbrunnen ed infine sulla sinistra (in curva a lato delle biciclette) i tipici canaletti di Friburgo ove scorre acqua corrente ed in cui spesso i bimbi amano far correre piccole barchette o paperelle, canalette note come "Bächle". Peccato non esserci caduti dentro in quanto si dice che "chi accidentalmente ci cade dentro è destinato a sposare uno o una del posto".

227-Salzstraße
Canaline o meglio "Bächle"che possiamo osservare anche sulla Salzstrasse impegnata dall'importante linea tranviaria 1 qui rappresentata dalla matricola 227 del 1990 che si presenta con quella che dovrebbe essere stata la livrea ufficiale aziendale per le elettromotrici tranviarie sino a qualche anno or sono e che dovrebbe esser stata superata da quella applicata ai CAF Urbos ed alle elettromotrici GT8Z (che ancora dobbiamo incontrare...) a seguito della loro ultima revisione. Da notare il pantografo "a forbice", il quale secondo un modo di vedere nostrano sembra essere più antiquato del monobraccio. Le elettromotrici tranviarie transitano in questa strada sin dal Dicembre 1901, pochi mesi dopo dall'attivazione della prima linea tranviaria elettrica, risalente invece all'Ottobre 1901.

228-Bertoldsbrunnen
Presso il centro e cuore della città ovvero Bertoldsbrunnen (una fontana posta all'incrocio tra Bertoldstrasse, Salzstrasse e la Kaiser Joseph Strasse), l'elettromotrice 228 del 1990 impegnata sulla linea 3 sta svoltando a destra in arrivo dalla Stazione ferroviaria ed è diretta a Vauban (e di cui ne pubblicizza persino la farmacia locale!), noto quartiere cittadino moderno, ottimo esempio di riqualificazione del territorio essendo un quartiere nato prima di tutto al posto di una ex caserma ma studiato anche e proprio con al centro di tutto il pedone, le biciclette e soprattutto una linea tranviaria. Un quartiere ove le automobili ricoprono un luogo marginale...

229-Schwabentor
La rete tranviaria di Friburgo in ben due particolari casi transita esattamente sotto o per meglio dire "attraverso" due simboli della città ovvero la Schwabentor nella piazza omonima (linea 1) e la Martinstor nella Kaiser Joseph Strasse (linee 2 e 3). Presso la prima torre citata, la Schwabentor o tradotta letteralmente "Torre di Svevia" possiamo osservare il passaggio della elettromotrice 229 (pellicolata in maniera tetra grazie ad un gioielliere..) impegnata sulla linea 1 mentre è appena entrata in centro essendo diretta verso Bertoldsbrunnen, indi la Stazione e successivamente per raggiungere Paduallee ed infine il capolinea di Landwasser che per fortuna da queste parti è un semplice quartiere (raggiunto solo nel Giugno 1985 presso un piccolo laghetto di Moosweiher, toponimo spesso usato per indicare il medesimo capolinea), niente a che vedere con il noto e "sovraesposto" ponte omonimo di Filisur, sulle ferrovie Retiche RHB in Svizzera.

230-Vauban
L'elettromotrice 230 si presenta in quella che dovrebbe essere la livrea ufficiale aziendale per queste vetture e che potremmo anche dire "troppo spesso" viene nascosta da pellicolature pubblicitarie integrali particolarmente invasive tanto che si applicano anche a frontale e posteriore delle vetture, nei minimi dettagli. L'elettromotrice impegnata sulla linea 3 si sta avviando dalla fermata di Paula-Modersohn-Platz verso il capolinea vicino di Vauban (noto anche come Innsbrucker Strasse) e sta per iniziare a percorrere la spina dorsale del grazioso e già citato quartiere di Vauban ove il pedone, il trasporto pubblico e la mobilità alternativa è posta al centro dell'attenzione mentre per contro il mezzo privato viene trascurato. Da notare come tale tratta sia stata attivata solo il 29 Aprile 2006, il quartiere è dotato di tutti i servizi necessari tra cui anche il curioso hotel verdeggiante a sinistra, da ricordare inoltre che a quanto pare "il lato B" di tale elettromotrice dovrebbe esser appartenuto in passato alla gemella 223, unica radiata e demolita tra la serie delle GT8N.

231-Vauban-particolare-1
Giusto un particolare dedicato alla cassa centrale ribassata, di cui le elettromotrici GT8N "3° serie" del 1990/91 sono state dotate dalla Duewag sin dalla loro nascita. Apparentemente infatti senza saperlo si potrebbe quasi pensare che la cassa sia stata aggiunta come in altri casi ed altre città, tuttavia al contrario già nel 1990 e poco prima si pensava a vetture con una porzione a pianale ribassato.

nd-ex deposito Lorettostraße-Urachstraße
Merita un'immagine il deposito storico "Sud" VAG di Lorettostrasse (due T, confermiamo!) raccordato alla fermata omonima sulla linea 2 poco fuori dal centro verso meridione, situato per l'esattezza in Urachstrasse. Primo deposito cittadino in quanto attivo dal 1901, è stato dismesso dal servizio regolare nel 1994 con l'apertura del deposito Ovest ovvero il VAG Zentrum, unico deposito tranviario attivo attualmente in città essendo di dimensioni notevoli ed al servizio anche del comparto su gomma oltre che sede aziendale. La struttura è rimasta raccordata alla rete in quanto è ora sede dei "Freunde der Freiburger Straßenbahn" e nella campata a sinistra ricovera vetture storiche (tranviarie e non solo...) mentre la campata a destra è stata destinata ai locali Vigili del Fuoco. Da notare l'ordine e la pulizia del piazzale, le automobili sono contingentate...

VAG Friburgo: proseguiamo con le GT8Z a pianale parzialmente ribassato (2° parte)
di Alessio Pedretti
Proseguiamo il nostro viaggio esaminando VAG Friburgo, in ordine cronologico passiamo alle elettromotrici modello GT8Z nate a pianale parzialmente ribassato.

(tutte del 19 e 20 Aprile 2022 e 22 Giugno 2023)

















VAG Friburgo: tra i Combino di due specie (3° parte)
di Alessio Pedretti
Proseguiamo il nostro viaggio con questa 3° parte e sempre esaminando VAG Friburgo, in ordine cronologico passiamo alle elettromotrici modello Siemens Combino Basic ed Advanced non senza una "coda" di ultime GT8Z

(tutte del 19 e 20 Aprile 2022 e 22 Giugno 2023)

















VAG Friburgo: ancora qualche Combino ed il futuro spetta agli spagnoli Urbos della CAF (4° parte)
di Alessio Pedretti
Concludiamo "sul ferro" con una quarta parte dedicata alla rete tranviaria di VAG Friburgo, come di consueto alleghiamo ed inseriamo come immagine la mappa della rete tranviaria per orientarsi leggendo le didascalie.

(tutte del 19 e 20 Aprile 2022 e 22 Giugno 2023)

















L'ASCENSIONE A MONTSERRAT
Testo e foto di José Banaudo, traduzione di Michele Bordone
Il massiccio montagnoso di Montserrat culmina a più di 1200 metri d'altezza ad una cinquantina di chilometri a nord di Barcellona. L'erosione vi ha scolpito delle forme fantastiche nelle alte e fragili falesie che dominano le gole dove scorre il Rio Llobregat. Il carattere impressionante del sito, il suo isolamento e la sua difficoltà di accesso ne hanno fatto molto presto un luogo spirituale. L'abbazia benedettina fondata nell'undicesimo secolo a Montserrat, dedicata alla Vergine Maria, è divenuta il luogo di pellegrinaggio più importante della Catalogna e di tutta la Spagna.In mille anni di storia, l’abbazia di Montserrat ha subito diverse vicissitudini, saccheggi, incendi ed anche molti rifacimenti e ricostruzioni. Gli edifici attuali risalgono per lo più al diciannovesimo e ventesimo secolo.
La facciata che dà sulla spianata nasconde perciò gli elementi più graziosi dello stile barocco. Al fondo della navata troneggia la "Moreneta", la Vergine Nera della quale la tradizione attribuisce la scoperta da parte di un pastore nell’anno 880. Si dice che il suo colore nero sarebbe dovuto ad una vernice a base di piombo che la ricopre oppure al fatto che riceve tutti i peccati degli uomini! Quale versione preferite?
Il titolo di questa descrizione è "L’ascensione a Montserrat". In effetti, da qualsiasi parte si arriva, il pellegrino o il semplice turista deve arrampicarsi per accedere a questo sito: a piedi per i più coraggiosi, in automobile ma soprattutto in treno ed in funivia. Due mezzi di trasporto che noi andremo a scoprire... Ci sono anche due funicolari delle quali parlerò in un altro capitolo.
Montserrat ha beneficiato a partire dal 1892 della prima ferrovia a cremagliera della Spagna, aperta in partenza dalla stazione di Monistrol Norte. Esercita dalla società Ferrocarril de Montana a Grandes Pendientes (FMGP) per più di 60 anni, la linea soffrì della concorrenza di una funivia, della guerra civile e di un grave incidente; pertanto queste difficoltà condussero alla sua chiusura nel 1957.
All’attuale stazione di Monistrol Vila, la locomotiva 021T n° 4 "Monistrol" costruita nel 1892 dalla ditta francese Cail, è esposta con una vettura d’origine coeva sotto una tettoia.
Un piccolo museo evoca la storia della linea e la sua particolarità più celebre: il cane vestito da capo-stazione che indica la via libera ai convogli!
La linea Barcellona - Manresa delle Ferrovie Catalane, oggi FGC, passa ai piedi della montagna di Montserrat, sulla riva opposta del rio Llobregat. A partire dal 1930, una funivia lunga 1357 metri collega la fermata di Aeri de Montserrat, specialmente attrezzata su questa linea, alla "montagna sacra" dei Catalani che la raggiunge dopo 544 metri di dislivello.
L’istallazione, una delle prime in Spagna, è stata realizzata dalla ditta tedesca Adolf Bleichert che costruirà quattro anni più tardi la funivia della Bastiglia a Grenoble.
Le due cabine di forma dodecagonale offrono ciascuna una capacità teorica di 35 posti più una persona di servizio.
L’Aeri passa al di sopra della stazione inferiore della funicolare di Santa Cova che visiteremo presto.
Malgrado le distruzioni subite alla fine della guerra civile, l’Aeri de Montserrat è un’attrazione perchè funziona tuttora con le sue cabine ed i suoi meccanismi originali, regolarmente adattati con le norme attuali di sicurezza.
Dopo la chiusura della ferrovia a cremagliera nel 1957, solamente la funivia d’una capacità limitata ed una strada a pedaggio permisero l’accesso a Montserrat.
Il governo della Catalogna ha deciso nel 1999 di riaprire la ferrovia a cremagliera riutilizzando una parte del tracciato dell’antica linea. La messa in servizio è avvenuta nel 2003.
Esercita da FGC, la nuova cremagliera parte dalla stazione di Monistrol de Montserrat e si sviluppa su 5238 metri, di cui 4110 equipaggiati di una cremagliera sistema Abt.
Il parco motore si compone di sette automotrici articolate costruite dalla ditta svizzera Stadler a 1500 volt in continua, battezzate con i nomi delle cime del massiccio di Montserrat: Da 1 a 5 consegnate nel 2003 (qui sopra la 4 "Els Flautas" e la 5 "Les Agulles" a Montserrat) e la 10 e 11 recentemente trasferite dalla linea di Nuria (qui sotto la 11 "La Cadireta" a Monistrol Vila).
Nella stazione di Monistrol de Montserrat (anticamente Monistrol Central), la ferrovia a cremagliera dispone di un binario sul primo marciapiede in corrispondenza con i treni della linea R5 Barcellona - Manresa delle FGC. Da qui la linea attraversa il rio Llobregat e descrive un lungo giro per elevarsi nella falesia destra della valle.
Dopo aver attraversato due tunnel, il nuovo tracciato della ferrovia a cremagliera attraversa la valle del rio Lloregat su di un imponente ponte a undici campate lungo 480 metri: il Pont del Centenari.
Appena oltre il ponte, la moderna stazione di Monistrol Vila è dotata di un immenso parco per il ricovero delle vetture e degli autobus.
A partire da questa stazione, la cadenza della circolazione dei treni è doppia sino a Montserrat. La cremagliera inizia all’uscita della stazione ai piedi delle spettacolari formazioni rocciose del massiccio di Montserrat.
I treni s’arrampicano sul fianco della montagna con una rampa di 156 mm/m sull’antico tracciato della cremagliera del 1892.
A metà percorso i convogli si incrociano su uno scambio telecomandato al PK 2+600 dove il raddoppio, lungo 420 metri, permette l’incrocio dinamico dei treni senza arresto del convoglio.
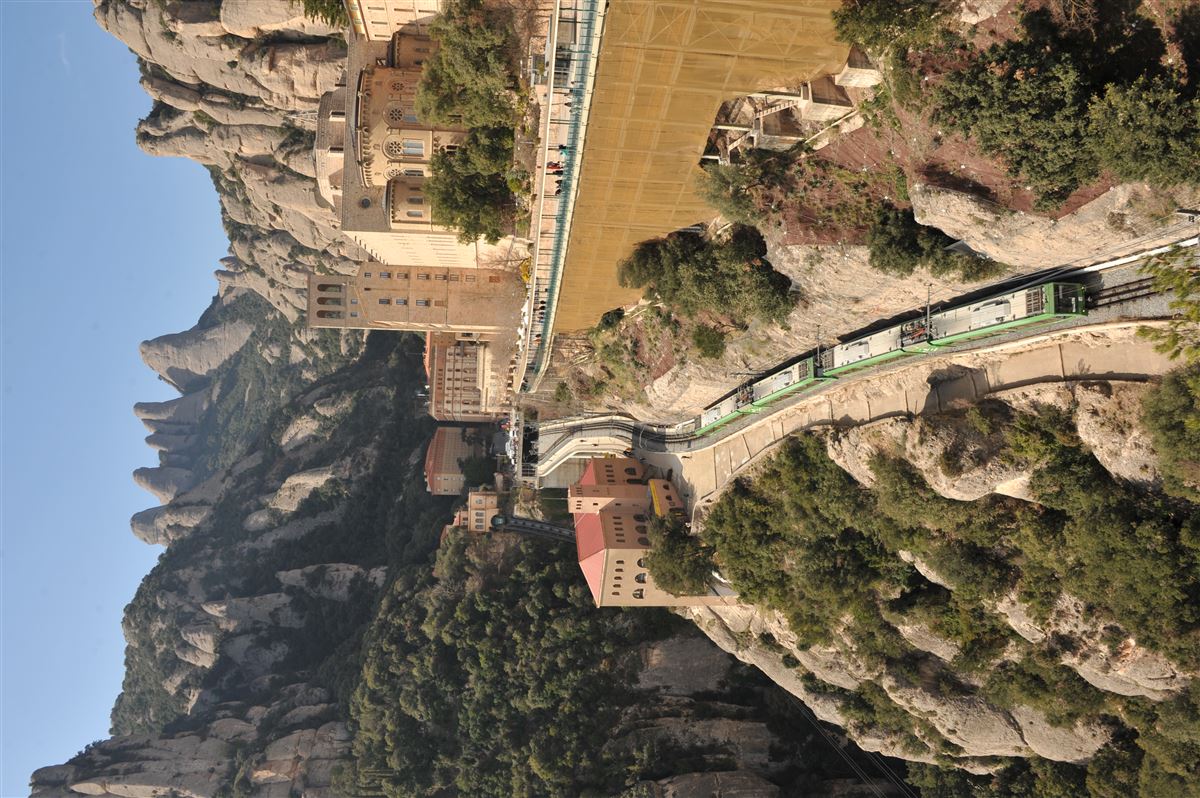
Ed infine l’arrivo a Montserrat, dove la stazione terminale è situata tra la stazione della funivia e la spianata dell’abbazia.

HEAG Darmstadt: una puntatina in Assia a caccia di tram... (1° parte)
di Alessio Pedretti
Come esempio studiato in ambito di reti di trasporto cittadine tedesche, vediamo il caso di Darmstadt, visitata solo a Giugno 2023 posizionata tra Francoforte e Mannheim: nella città risiedono 162.250 abitanti, è l’unica tra quelle che abbiamo visitato posizionata nello Stato federato dell’Assia ed è la quarta per numero di abitanti nel proprio Stato, dopo ovviamente Francoforte sul Meno e le meno note Wiesbaden e Kassel, nell’ordine nazionale in termini di abitanti Darmstadt è la 51° città in Germania mentre per quanto riguarda i trasporti, ad esempio è la 19° rete tranviaria tedesca per estensione, anche se di solo 5 km meno estesa rispetto ad esempio alla ben più nota e francese Strasburgo, che per contro grazie a circa 6km risulta essere leggermente più ampia della già studiata Friburgo.
Posto e premesso che non si riesce a dare un’origine al nome della città (esistono più versioni, non particolarmente interessanti), Darmstadt sembra esser stata fondata dai Franchi nell’ottavo o nono secolo dopo Cristo, ha avuto il suo periodo di massimo splendore culturale tra il 1688 ed il 1790, momento a partire dalla quale venne a fare parte del Granducato d’Assia per poi confluire nell’Impero Tedesco e conseguenzialmente nella brutta pagina del nazismo, momento in cui la città detiene due piccoli tristi momenti tra cui l’aver dato la cittadinanza onoraria al “pittore spiantato austriaco che si faceva la nipote” ed anche per esser stata la prima città a costringere i negozi ebraici alla chiusura all'inizio del 1933, appena subito dopo che i nazisti erano andati al potere.
Proprio in merito alla Seconda Guerra Mondiale, Darmstadt venne bombardata per la prima volta il 30 luglio 1940, e purtroppo ciò avverrà ancora in altre 34 incursioni successive tra cui il bombardamento britannico dell'11 Settembre 1944 in cui il centro storico venne raso al suolo. Questo attacco fu un esempio della tecnica “firestorm” (tempesta di fuoco), ove vennero sganciate attorno alla città un gran numero di bombe incendiarie per poi successivamente lanciare le "normali" bombe esplosive, innescando così un processo di combustione auto-alimentato dalle correnti d'aria generate dall'incendio. In tale frangente si stima che da 11.000 a 12.500 abitanti morirono bruciati, e da 66.000 a 70.000 rimasero senza un tetto, più di tre quarti del centro di Darmstadt venne distrutto. La ricostruzione del dopoguerra fu compiuta in uno stile architettonico relativamente semplice, stravolgendo completamente la maglia e disposizione delle strade cittadine, alcuni edifici storici vennero ricostruiti nel loro aspetto originale dopo che la città era stata conquistata dalla 4° Divisione Armata USA il 20 marzo 1945, tra le successive ricostruzioni è memorabile il caso del centralissimo Luisencenter in Luisentplatz, centro commerciale aperto nel 1976 oggi al centro della città e cuore pulsante commerciale anche se all'apertura venne ampiamente criticato e fu oggetto di lanci di uova e pomodori! La città oggi si caratterizza per avere una forte connotazione studentesca avendo quattro Università molto legate a tecnologia e scienza, addirittura risulta essere forse l’unica città al mondo a cui è stato dedicato un elemento chimico ovvero il Darmstadio!.

HEAG UNA RETE INTERESSANTE...
La rete tranviaria di Darmstadt è in carico ad HEAG Mobilo il cui acronimo originale dovrebbe essere "Hessische Eisenbahn-AktienGesellschaft", gestore nato nel 1912 e più volte mutato (la sua denominazione attuale "HEAG Mobilo" risale al 2016!) anche indirettamente di linee su gomma (vedremo poi di specificare una lieve differenza di gestione...), presenta in tutto circa 800 dipendenti, a grandi linee possiamo dire che la rete tranviaria presenta una lunghezza di 42km ma la rete di linee esercite arriva a ben 105 km, rete che è stata realizzata a scartamento metrico 1000mm ed elettrificata a 600v c.c., ragnatela su cui sono disposte 164 fermate di cui 124 senza barriere, fermate rispettate indicativamente da 48 elettromotrici e 30 rimorchi come vedremo poi, numero destinato ad ampliarsi prossimamente grazie all’arrivo dei nuovi convogli Stadler Tina serie ST15.
Abbiamo trovato traccia che riporta alla data del 25 Agosto 1886 la nascita della rete tranviaria a vapore (trazione parzialmente giunta sino ai nostro giorni, come vedremo!) mentre per la prima elettrificazione si deve aspettare il Novembre 1897. La stessa rete presenta alcune peculiarità decisamente insolite ed interessanti: ad esempio è una rete in cui ancora oggi vengono utilizzati i rimorchi (a pianale ribassato spesso accoppiati ad elettromotrici a pianale alto, semplice soluzione a cui nessuno riuscirà mai ad arrivarci a Milano…) od ancora in alcune giornate festive estive, senza particolari proteste, gli abitanti vedono circolare un trenino a vapore noto come “Feuriger Elias“ mentre fa sorridere che uno dei tre depositi aziendali si chiami Frankenstein! Od ancora possiamo citare il caso della linea 6 che salta alcune fermate lungo il suo lungo percorso (pur condiviso con altre linee!) con corse indicate come "Schnellzug", od ancora decisamente caratteristico è il fatto che, come vedremo nel trafiletto dedicato ai rotabili, tutte le elettromotrici sono classificate con una matricola le cui prime due cifre risultano essere l’anno di immissione in servizio!.
Passiamo alle linee tranviarie, risultanti essere sulla carta ben 10 (di cui però due attualmente sospese ed una potremmo dire "fantasma") curiosamente il doppio del numero delle linee di Friburgo pur avendo oltre 25 elettromotrici in meno rispetto ai colleghi della Brisgovia (!), tuttavia è interessante ricordare alcuni distinguo che vedremo a breve, rete pur distribuita sostanzialmente sui quattro assi cardinali ovvero verso Nord (Dreieichweg e Kranichstein), verso Sud (Lichtenbergschule ed Am Hinkelstein) e verso Ovest (Griesheim) mentre ad Est da anni è stata abbandonata la meta della Ost Bahnhof (pur sopravvivendo alcuni binari, cosa abbastanza insolita in Germania ove viene tolto tutto subito...) e potremmo considerare come “est” i capolinea a sud-est di Bollenfalltor e Lichtwiese Campus, quest'ultimo attivato ad Aprile 2022. Ma vediamo le linee:
Linea 1 Hauptbahnhof – Frankenstein giornaliera
Linea 2 Hauptbahnhof – Lichtwiese Campus feriale lun/ven intero percorso, limitata al Congresszentrum il Sabato e Domenica
Linea 3 Hauptbahnhof – Lichtenbergschule giornaliera
Linea 4 Griesheim Platz Bar le Duc – Kranichstein Bahnhof SOSPESA
Linea 5 Kranichstein Bahnhof – Hauptbahnhof SOSPESA
Linea 6 Kongresszentrum – Frankenstein – Am Hinkelstein giornaliera, corse Express saltano fermate tra Rhein Neckarstrasse e Wartehalle
Linea 7 Lichtenbergschule – Frankenstein poche corse
Linea 8 Kongresszentrum – Frankenstein – Am Hinkelstein giornaliera, limitata causa lavori
Linea 9 Griesheim Platz Bar le Duc – Bollenfalltor giornaliera
Linea 10 Wagenhalle – Hauptbahnhof giornaliera
In sostanza possiamo affermare la presenza di 8 linee oltre a 2 momentaneamente sospese ed una abbastanza in uno stato confusionario (linea 7), vediamo il perché andando a raccontare alcune situazioni particolari: la prima caratteristica è il curioso caso delle linee 2 e 3 che avviene dall'Estate 2020, in quanto risultano essere "abbinate" presso la Hauptbahnhof ovvero quando una vettura arriva in Stazione dalla linea 3 prosegue come linea 2 cambiando indicatore ed ovviamente viceversa dalla linea 2 le vetture "passano" alla linea 3. Un ulteriore aspetto interessante: a seguito dei lavori sulla Frankfurterstrasse sino ad Ottobre 2023 e molto probabilmente anche in seguito per via della carenza di vetture, la linea 4 Griesheim Platz Bar le Duc – Kranichstein Bahnhof risulta essere sospesa, analogamente la linea 5 è sospesa anch’essa sul percorso Kranichstein Bahnhof – Hauptbahnhof. La linea 6 viene classificata come “linea rapida”, è stata attrezzata con semafori intelligenti che le consentono di risparmiare 9 minuti saltando 9 delle 36 fermate presenti sul percorso, momentaneamente a causa dei lavori in Frankfurtstrasse non raggiunge Dreieichweg ma si attesta all’anello centrale intorno allo Schloss (Palazzo residenziale) ovvero al Kongresszentrum. La linea 7 come abbiamo scritto risulta essere un mistero (tipo il leggendario “18 rosso di Milano”) in quanto viene effettuata con alcune corse singole spaiate nei due versi ad orari improponibili, tipo tra le ore 23.00 della notte e le ore 06.00 del mattino con qualche sconfinamento alle 21.00 di sera o con due sole corse in una sola direzione (!) al sabato mattina tra le 8.00 e le 9.00 in direzione di Lichtenbergschule. Infine resta da citare il fatto che la linea 8 attualmente effettua lo stesso percorso della 6 Express osservando però tutte le fermate, essendo interrotta a nord a causa dei lavori della Frankfurtestrasse, mentre in un recente passato è esistita anche la linea 24 "storica", garantita nei Sabati d’Avvento, sebbene a quanto pare la stessa non risulti più esser stata effettuata dopo la Pandemia.
Come anticipato è opportuno ricordare che al momento della nostra visita (Giugno 2023) veniva garantito un servizio sostitutivo automobilistico come linee 5E ed 8E gestito nella parte nord della città con autobus, a causa appunto dei citati lavori alla Frankfurterstrasse, aspetto che ha generato nella centralissima Luisenplatz la presenza di numerosi autobus di ogni genere, una vera manna per l’appassionato di passaggio, come vedremo. Da ricordare che l'intera rete tranviaria risulta essere quasi del tutto a doppio binario, servita da elettromotrici esclusivamente unidirezionali: esistono tuttavia alcuni casi e tratti particolari abbastanza brevi a binario unico ovvero a Griesheim tra Wagenhalle e Platz Bar le Duc (linea 9, tratta in opera credo dal 1926), presso Lichtenbergschule (linea 3, in opera credo dal Marzo 1966) esattamente tra le fermate di Weinbergstrasse e Ludwigshohstrasse ed infine una piccolissima porzione del recente prolungamento a TU Lichtwiese Campus attivato il 25 Aprile 2022 per la linea 2.
Un cameo dedicato ai depositi: l'attuale rete tranviaria di Darmstadt vede l'esistenza di due strutture aziendali: una a nome Bollenfalltor presso il capolinea omonimo della linea 9 presenta diversi binari tronchi pur essendo le vetture unidirezionali, il secondo decisamente più ampio è noto come deposito di Eberstadt, Comune presso la quale è situato, anzi potremmo dire che è posizionato sulla direttrice meridionale diretta ad Alsbach (linee 6 ed 8) ed è raccordato alla fermata di Frankenstein, nome curioso dato che più o meno a tutti forse vi sarà scappato un sorriso pensando al noto romanzo di Mary Shelley. Oltre a questi due siti in attività sono poi presenti le strutture di Wagenhalle presso la fermata omonima a Griesheim, ormai in disuso e non più raccordato ma ancora esistente mentre ancora più curioso è il caso della struttura di Kranichstein al capolinea nord-est di Kranichstein Bahnhof, una sorta di struttura edificata recentemente (il tram ha raggiunto tale capolinea solo nel 2003!!) che inizialmente e sino alla pandemia sembrava esser stato congegnato come semplice capannone museo con alcuni binari tronchi, ma che attualmente è stato svuotato da vetture storiche (sfrattate presso un... bowling!) ed è in corso di ristrutturazione per ricoverare a breve termine le nuove elettromotrici Stadler Tina famiglia ST15. E' interessante citare due aspetti in tema di depositi: il primo è che nel 2021 è stato dichiarato da HEAG che il deposito attualmente in attività di Bollenfalltor a medio termine dovrà essere dismesso e sostituito da una nuova struttura capace di accogliere sia tram che autobus, posizionato nella zona di Wixhausen, a nord della città. Il secondo aspetto è una semplice considerazione: è interessante notare come VAG Friburgo con circa 75 elettromotrici (tra cui numerose di lunghezza ben 42m) possieda un solo deposito, come abbiamo osservato precedentemente; al contrario HEAG Darmstadt pur con sole 48 elettromotrici (bene o male anche più corte ovvero da 28m) e 30 rimorchi (da 15m) ha bisogno di due strutture (Frankenstein, Bollenfalltor) che non basteranno nemmeno con l'arrivo delle prossime unità Stadler. Il che fa dell'accoppiata Friburgo/Darmstadt una simpatico binomio/dualismo, simbolicamente intendiamo, tra il "metodico che fa tutto con precisione e programmazione" (Friburgo...) ed il "fuori classe che si disinteressa e campa alla giornata organizzando la propria vita con confusione... per poi piazzare il colpo gobbo dei nuovi tram a 44m in un mondo in cui si è sempre pensato ai 28m" ovvero Darmstadt!. Ma giusto che ne parliamo ci conviene dunque passare ai...
VEICOLI, AD OGNI FAMIGLIA IL SUO NUMERO PROGRESSIVO...
Come abbiamo anticipato, la flotta di veicoli in dotazione a HEAG Mobilo è costituita da 48 elettromotrici e 30 rimorchi, tuttavia prima di vedere le semplici e sole "quattro serie" (rimorchi compresi), è importante citare anche in questo caso due aspetti: il primo è che ogni serie di elettromotrici viene contraddistinta da un codice ST1, ST2, ST3 e così via in ordine cronologico, in modo tale che siano chiaramente distinguibili sia per il personale interno ma anche nelle comunicazione con i passeggeri ove ST per le elettromotrici sta per “Straßenbahn-Triebwagen” ed SB per i rimorchi sta per “Straßenbahn-Beiwagen”, soluzione logica e semplice ideata molto probabilmente nel 1946. Un secondo aspetto molto interessante è che a partire dal 1976 si è provveduto a classificare le elettromotrici (con i rimorchi è avvenuto solo dal 1994 ovvero con la consegna degli ultimi ed unici attualmente in esercizio) con matricole a 4 cifre di cui le prime due indicano l’anno di consegna della serie, pur con qualche minima eccezione come vedremo poi nelle didascalie: per fare un esempio l’elettromotrice 9115 è stata consegnata nel 1991, il rimorchio 9432 nel 1994 e così via, i futuri Stadler Tina ST15 per la prima volta riceveranno una matricola a 5 cifre ovvero da 22101 in poi, anche se effettivamente forse entreranno in esercizio solo nell’Autunno 2023.
Proviamo dunque ad analizzare il parco elettromotrici di HEAG Mobilo nelle sole serie attuale utilizzate nel servizio passeggeri in questo periodo ed a breve termine nei prossimi mesi:
- ST12, 10 esemplari serie 9115/9124, costr. Waggon Union-AEG del 1990/91, 27m su 3 casse, non ribassati
- ST13, 20 esemplari serie 9855/9874, costr. LHB-AdTranz del 1998, 27,8m su 3 casse
- ST14, 18 esemplari serie 0775/0792, costr. Alstom, Vossloh, Bombardier del 2007, 27,8m su 3 casse
- ST15, 25 esemplari serie 22101/22125, costr. Stadler del 2021/23, 43,9m su 5 casse e 6 carrelli, in corso di consegna (10 esemplari consegnati sinora, impegnati in corse prova) in servizio si stima da Autunno 2023
- SB9, 30 rimorchi serie 9425/9454, costr. LHB-AdTranz del 1994, 14,7m con 3 porte, a cassa singola, strutturalmente gemelli delle ST13 ed utilizzati con ST12-ST13-ST14
Non sembrano esserci particolari vincoli sull'utilizzo dei vari tipi di vetture sulle varie linee: l'unico vincolo rilevato sembrerebbe essere il non poter utilizzare le elettromotrici più anziane ST12 "a pianale alto" sulla linea 3, relazione su cui a quanto pare non si possono utilizzare i rimorchi (probabilmente a causa della fermata Willy Brandt Platz molto corta in quanto situata in sostanza in curva in mezzo ad un incrocio tranviario) e pertanto gioco forza le elettromotrici di tale linea devono essere sempre a pianale ribassato. Per tale motivo e per quanto esposto precedentemente, essendo la linea 3 abbinata alla 2, le anziane ST12 non vengono utilizzate gioco forza nemmeno sulla linea 2.
La futura immissione in servizio delle nuove elettromotrici Stadler Tina (previste inizialmente in 14 esemplari, saliti a 25) dovrebbe risolvere i problemi di carenza di vetture al momento parzialmente mitigati dal fatto che 2 linee risultano essere sospese ed una limitata, il loro arrivo porterà, oltre che al ripristino delle linee ora non effettuate, anche alla certa radiazione delle elettromotrici ST12 risultanti non essere a pianale ribassato nonché magari anche alla quasi certa riduzione di attività per le successive ST13 con conseguente minore necessità di rimorchi SB9, i quali andranno a perdere parzialmente la loro funzione originale ovvero quello di essere accoppiabili ad elettromotrici con piano di calpestio alto. Infine prima di passare alle immagini citiamo il fatto che alcune elettromotrici di varie serie sono state intitolate ad altre città europee e non solo, tra cui spicca il singolare caso della matricola 9122 (famiglia ST12) intitolata all’italiana Brescia! Merita infine di esser segnalato il fatto che numerose elettromotrici pregresse già alienate da tempo da HEAG (modelli ST7-ST8-ST10-ST11) sono stati quasi tutti ceduti alla rete tranviaria della città di Iasi in Romania ove hanno ritrovato colleghe da Augsburg, Berna, Oberhausen ed Essen, in parte probabilmente accantonate con l’arrivo nella città rumena di nuovi tram Pesa e Bozankaya.

9115-luisenplatz-darmstadt
Le elettromotrici più anziane in servizio sulla rete tranviaria di Darmstadt risultano essere quelle appartenenti alla cosiddetta famiglia delle ST12 ovvero la serie 9115/9124, dalla matricola è facilmente intuibile l'anno di immatricolazione ovvero "91" anche se eccezionalmente solo la prima vettura è giunta in città nel Dicembre 1990 ed è proprio la qui ritratta matricola 9115 (intitolata a Bursa, città turca...) ritratta in arrivo a Luisenplatz come linea 2 diretta a TU Lichtwiese Campus. Curiosamente queste macchine sono state tutte intitolate a città europee ad eccezione della 9124 rimasta priva di battesimo, merita un cenno la matr. 9122 intitolata all'italiana Brescia!. La soluzione di abbinare un rimorchio a pianale ribassato a vetture con pianale alto è forse una delle soluzioni più semplici ed immediate



9117-9435-rheinstrabe-
9117-rheinstrabe
9117-rheinstrabe-ernstludwigplatz-darmstadt
Tre immagini che ritraggono un'anziana (ma più che accettabile..) elettromotrice ST12 con un rimorchio SB9: il convoglio dovrebbe essere in servizio sulla linea 6 "Schnellzug" e sta svoltando dalla Rheinstrasse in Ernst Ludwig Platz onde effettuare l'anello e ritornare verso sud sul lungo tracciato sino ad oltre Eberstadt. La matricola della ST12 è la 9117 battezzata con il nome della città norvegese di Trondheim, nome curiosamente ripetuto anche sulle fiancate del veicolo; resta interessante ed insolito il tipo di porte ad espulsione dell'elettromotrice, l'accoppiamento con il rimorchio 9435 nato con tre porte ed a pianale ribassato all'incirca tre anni dopo l'elettromotrice stessa, ovvero nel 1994 come serie 9425/9454, il quale poi tra l'altro risulta essere pellicolato con la classica livrea autopromozionale di HEAG... con cui si cercano nuovi collaboratori da assumere!

9120-marktplatz-darmstadt
Le elettromotrici ST12 possono trasportare 150 persone di cui 62 sedute (con il rimorchio SB9 arriviamo a 238 persone trasportate), hanno una lunghezza di 27m (43m con i rimorchi SB9) e non presentano vincoli particolarmente ostativi nella circolabilità sulla rete se non appunto il fatto di non poter circolare sulle linee 2 e 3 in quanto sulla 3 non sono ammessi i rimorchi. L'elettromotrice 9120 battezzata "Szeged" città ungherese (nota anche come Seghedino) traina il rimorchio 9440 su quella che dovrebbe essere la linea 8 nei pressi della Marktplatz.

9121-rheinstrabe-darmstadt
Come abbiamo visto ogni elettromotrice della famiglia ST12 è stata battezzata con il nome di una città, nome ripetuto sulle fiancate mentre sul frontale è presente anche il simbolo o stemma del Comune a cui l'elettromotrice è intitolata. Nel caso della matricola 9121 la città è Freiberg da non confondere con la ben più note Freiburg im Breisgau (Friburgo) o la svizzera Friburgo, si tratta infatti di una cittadina in Sassonia in Germania con circa 40.000 abitanti ovviamente gemellata con la stessa Darmstadt. Da ricordare che le ST12 sono state realizzate dalla nota AEG per la parte elettrica ma anche dalla WU Waggon Union che ha operato in un periodo relativamente breve in quanto sorta nel 1971 da fusioni di aziende locali (DWM e SEAG) per confluire nel 1990 in ABB Henschel, in seguito divenuta poi come sappiamo AdTranz. L'immagine ritrae bene il fatto che tali elettromotrici sono composte da 4 carrelli e 3 casse, derivarono da una serie di elettromotrici costruite inizialmente per Karlsruhe e sostanzialmente risultano essere identiche alla precedente serie ST11 sempre di HEAG, già radiata ed anch'essa a 3 casse, nonché anche alle ancora più anziane ST10 a 2 casse, radiate da tempo anch'esse.

9123-luisenplatz-darmstadt
Un'ultima immagine di tale famiglia è dedicata alla matricola 9123 intitolata a "Gyonk", altra città ungherese. Con il prossimo arrivo delle elettromotrici ST15 alias Stadler Tina serie 22101/22125 è prevista la radiazione di tutte le elettromotrici della famiglia ST12, operazione annunciata nel 2020 ma per ora non ancora attuata visto che prima di tutto si attende con l'autunno l'immissione in servizio delle stesse ST15 (almeno 10 consegnate per ora) considerando tuttavia che al momento attuale se tutte le linee tranviarie fossero in esercizio HEAG si troverebbe a corto di vetture per coprire tutto il servizio, considerato ad esempio che delle 10 elettromotrici ST12 esistenti, almeno 2 risultano essere già temporaneamente? ferme ovvero le matricole 9119 e 9124. Dubito saranno ripristinate avendo ormai le giornate contate avendo le ST15 alle calcagna...

9425-ernstludwigplatz-
Curiosamente a Darmstadt le prime vetture a pianale ribassato sono state.... dei rimorchi! Nel 1994 sono entrati in esercizio almeno 30 "rimorchi a pianale ribassato" noti come famiglia SB9 e con matricole da 9425 a 9454, aventi una lunghezza di 14,7m, capaci di trasportare 88 passeggeri di cui 46 seduti. Realizzati da AdTranz ed LHB ove sotto tale sigla si cela la Linke-Hofmann-Busch nata nel lontano 1839 a Salzgitter, costruttore di treni ma anche trattori confluito in Alstom nel 1998 anche se la denominazione è sopravvissuta sino al 2009, momento a partire dal quale è diventata ufficialmente Alstom Transport Deutschland. Possiamo osservare il primo rimorchio matricola 9425 stilisticamente allineato e non sgraziato rispetto alle elettromotrici delle famiglie ST13 ed ST14 realizzate tuttavia successivamente nel 1998 e 2007.


9430-luisenplatz-darmstadt
9438-luisenplatz-darmstadt
I rimorchietti viaggiano continuamente sulla rete e su tutte le linee, non avendo visitato la città in una giornata festiva non sappiamo se vengono utilizzati anche nei festivi, per certo sappiamo che non possono essere utilizzati a quanto pare sulla sola linea 3 e di conseguenza la gemellata linea 2. Possiamo osservare due casi di pellicolature decisamente curiose, la matricola 9430 veste una livrea particolarmente gustosa di una nota catena nazionale teutonica di supermercati (ove viene anche indicato che potete trovare una filiale aperta anche nei Festivi in Stazione!) mentre il rimorchio 9438 veste una livrea perfettamente coordinata con l'elettromotrice a cui è stato assegnato, ovvero l'ennesima azienda locale fornitrice di energia la quale, in questo caso per di più, fa capo alla stessa holding di HEAG.

9454-luisenplatz-darmstadt-
La visione del posteriore del rimorchietto 9454 con la presenza di fanali anche bianchi ci porta a ricordare che gli stessi possono essere utilizzati anche per manovre in retrocessione con una cabina di guida improvvisata e probabilmente con un bancone nascosto, ragionamento a cui si arriva anche osservando il piano binari dei depositi di Bollenfalltor e Frankenstein, ove sono presenti tanti, forse anche troppi, binari tronchi pur in una rete ove circolano esclusivamente vetture unidirezionali, anche in questo caso curiosa l'analogia con Friburgo ove invece sono presenti numerosi veicoli bidirezionali per una rete dotata più che altro di capolinea ad anello. Giusto il tempo di aggiungere che, a quanto pare, sembrano essere solo 3 i rimorchi battezzati con un nome ovvero il 9426 "Magdeburgo" (a quanto pare la motivazione deriva dal fatto che in tale città circolano elettromotrici simili), il 9432 "Griesheim" (località ad ovest di Darmstadt raggiunta dalla rete tranviaria) ed il 9435 "Kassel", il cui motivo dovrebbe essere perché è stata la prima città tedesca ad utilizzare automotrici a pianale ribassato con una percentuale di pianale ribassato superiore al 50%.

9855-rheinstrabe-darmstadt
Nell'anno 1998 giungono in città finalmente delle elettromotrici a pianale parzialmente ribassato, la famiglia ST13 consegnata in 20 esemplari serie 9855/9874 realizzate sempre da AdTranz e dalla citata LHB, futura Alstom di Salzgitter. Con 27,8m di lunghezza e 163 passeggeri trasportati (di cui 74 seduti) possono essere utilizzate sulle tutte le linee senza particolari problemi e possono essere accoppiate ovviamente anche con i rimorchi SB9 realizzati quattro anni prima dagli stessi costruttori. Ricordiamo che macchine molto simili sono state realizzate ad esempio per Magdeburgo. L'elettromotrice 9855 impegnata sulla linea 2 è rivestita da una sgargiante pellicolatura pubblicitaria e sta effettuando servizio sulla linea 2 in direzione Hauptbahnhof, una volta giunta in tale luogo passerà alla linea 3.

9856-ernstludwigplatz-
Le elettromotrici serie ST13 come tutte le recenti serie di elettromotrici "darmstadtiane" risultano essere unidirezionali, si presentano con 3 porte a doppia anta ed una porta anteriore ad anta singola come ci dimostra l'elettromotrice 9856 in servizio probabilmente sulla linea 3 e quindi sottinteso anche sulla linea 2 essendo le due linee abbinate, peraltro con una piacevole pellicolatura probabilmente dedicata alla squadra locale di calcio. E' interessante ricordare che nell'ambito della serie ed all'inizio della loro vita lavorativa (o quasi...), l'elettromotrice 9858 ha effettuato prove sulla rete tranviaria di Cottbus (Estate 2003), l'elettromotrice 9869 è stata per quasi un mese ad Ulm (Estate 1999) mente l'elettromotrice 9864, attualmente ferma a quanto pare, è stata per un paio di settimane in prova nell'Autunno 1998 sulle reti di Mannheim (OEG ed MVG), Heidelberg e Ludwigshafen, in seguito tutte riunite dal 2004 nell'attuale RNV, come avremo anche modo di vedere!. Altra realtà che poi invece andrà a scegliere il modello Variobahn, declinandolo in diverse varianti.

9858-9438-luisenplatz-
Come osservato precedentemente, i rimorchi vengono utilizzati non solo con le elettromotrici ST12 a pianale alto ma anche con quelle a pianale parzialmente ribassato come le ST13 ed ST14 talvolta circolando cromaticamente abbinate all'elettromotrice ovvero con la stessa pellicolatura pubblicitaria della macchina da cui sta venendo trainato, in questo caso il solito caso di fornitore di energia Entega, "parente" dell'azienda che esercita il servizio tranviario, essendo sotto la stessa holding HEAG. Incontriamo dunque l'elettromotrice 9858 curiosamente non pellicolata sulle testate, l'effetto estetico è notevole e coordinato, abbastanza curioso considerando che i rimorchi sono giunti ben quattro anni prima delle stesse elettromotrici.

HEAG Darmstadt: una sigla per ogni famiglia da buoni tedeschi... (2° parte)
di Alessio Pedretti
Procediamo con una 2° parte dedicata sempre alla rete tranviaria di HEAG Darmstadt, su cui ci piacerebbe tornare ad osservare ulteriori aspetti, come di consueto alleghiamo ed inseriamo come immagine la mappa della rete tranviaria, giusto per orientarsi leggendo le didascalie...

FOTO (Tutte del 19 Giugno 2023)

9861-ernstludwigplatz-darmstadt
Sarà forse un caso ma molto probabilmente è una decisione di HEAG, noterete infatti che le pellicolature pubblicitarie vengono applicate alle sole elettromotrici delle famiglie ST13 e rimorchi SB9, sembrano escluse le famiglie ST12 ed ST14. Prendiamo ad esempio il caso dell'elettromotrice 9861, una ST13 impegnata a quanto pare sulla linea 3 in direzione Hauptbahnhof e con pellicolatura pubblicitaria "autopromozionale" dato che riguarda HEAG e la ricerca di collaboratori e dipendenti, già osservata tra l'altro sul rimorchio 9435 che nel giorno della nostra visita era abbinato alla più anziana ed "alta" 9117 della famiglia ST12 (vedi precedente mail). Curioso il caso invece della matricola 9872 che viene data per ferma sin dall'anno 2016 quindi molto probabilmente irrecuperabile dato che risulta essere ferma da ormai 8 anni...

9865-rheinstrabe-ernstludwigplatz-darmstadt
La livrea ufficiale di HEAG Darmstadt a quanto pare risulta essere quella molto elegantemente mostrata dall'elettromotrice 9865 tuttavia sembra essere la livrea ufficiale solo per quanto riguarda i veicoli tranviari in quanto per gli autobus HEAG passa ad un classico giallo, tipico ad esempio dalle parti di Berlino e Dresda. La spiegazione non è particolarmente misteriosa in quanto semplicemente il settore su gomma formalmente è gestito da una controllata di nome HEAG MobiBus nata nel 1998 dalla fusione di precedenti gestori. E' interessante scoprire come la gestione del trasporto pubblico sia formalmente divisa a livello societario tra il settore tranviario e quello automobilistico, dato che poi osserveremo servizi sostitutivi su gomma perfettamente integrati con quello tranviario.

9873-luisenplatz-darmstadt
Concludiamo la nostra carrellata di presentazione della famiglia ST13 con l'elettromotrice 9873 dotata a sua volta di una pellicolatura pubblicitaria riguardante un colosso tedesco nel settore delle vernici in cui infelicemente nel simboletto una povera pennellessa sembra essere finita in parti non ambite dello stesso simbolo, un elefantino, osservabile anche nell'immagine. Da ricordare che tali elettromotrici sono state realizzate bene o male abbastanza simili tra loro da diversi costruttori (spesso hanno cambiato semplicemente nome a seguito di fusioni) per ben 4 città tra cui oltre a Darmstadt anche per Magdeburgo (ove hanno debuttato nel 1996 ed hanno raggiunto il quantitativo di 83 esemplari), Gera e Braunschweig. E' corretto ricordare che a tale famiglia appartengono anche le successive ST14.

0776-rheinstrabe-
E proprio per dimostrare tale parentela e somiglianza, giusto nello stesso punto (all'angolo tra la Rheinstrasse e la Ernst Ludwig Platz) e con la stessa inquadratura della precedente immagine possiamo osservare la matricola 0776 appartenente alle successiva famiglia ST14, realizzata in 18 esemplari serie 0775/0792 nel 2007 da quella che ormai non è più LHB ma è diventata Alstom Germania. E' cambiata la fanaleria, qualche piccolissimo dettaglio della livrea (ad esempio la parte superiore del parabrezza frontale presenta un filetto bianco a differenza delle ST13 ove è completamente in blu), presentano invece in comune con le ST13 la stessa potenza, stesso peso e stessa lunghezza e... stessa capacità dei passeggeri trasportati ovviamente.

0777-hauptbahnhof-darmstadt
Nei pressi della Hauptbahnhof ad ogni singola corsa le linee 2 e 3 effettuano una piccola magia, passando da una linea all'altra: ad esempio la matricola 0777 del 2007 è in arrivo come linea 2 da Lichtwiese Campus essendo passata per il centro da Luisenplatz via Rhein/Neckarstrasse mentre da pochi secondi ha iniziato a "velettare" come linea 3 in direzione di Lichtenbergschule, ripasserà dal centro (Luisenplatz) transitando però dalla Willy Brandt Platz (vedi mappa). Al contrario la linea 3 in arrivo dalle nostre spalle (dal centro via Willy Brandt Platz) poco prima di effettuare la fermata della Stazione (alle nostre spalle) cambierà indicatore mostrando la destinazione di linea 2 verso Lichtwiese Campus. Le due linee risultano essere "gemellate" dall'Estate 2020

0778-hauptbahnhof-darmstadt
E girandoci proprio di 180° gradi alla stessa fermata della Hauptbahnhof possiamo osservare la matricola 0778 che da pochi secondi è giunta come linea 3 da Lichtenbegrschule ed è diventata la linea 2 in direzione di Lichtwiese Campus. Alle spalle è evidente l'edificio della Hauptbahnhof DB di Darmstadt, come potete notare ampio spazio è stato lasciato ai pedoni. Sullo sfondo l'edificio principale della Stazione realizzato nel 1912 e probabilmente ricostruito fedelmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un cenno su questa matricola, giusto per ricordare che per qualche settimana ad inizio Estate 2007 venne provata sulla rete tranviaria di Krefeld, non lontano da Duisburg e Dusseldorf.

0779-9425-ernstludwigplatz-
Ricostruito nei minimi dettagli risulta essere anche il Residenzschloss al centro della città, nato con tale forma a metà del 1700 secondo un progetto che inizialmente lo aveva previsto molto più ampio di come è stato effettivamente realizzato, in seguito appunto fedelmente ricostruito nel ventennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Davanti ad esso transita l'elettromotrice 0779 con il rimorchietto 9425 quasi sicuramente impegnati sulla linea 9 diretta a Griesheim, possiamo escludere che non si tratta delle linee 2 e 3 per via della presenza del rimorchietto e per via anche di quel numeretto dietro al parabrezza che sembra essere quella che a Milano si definisce "tabella". Una curiosità: la rete tranviaria a tutt'oggi circonda l'intero Palazzo Residenziale, senza particolari problemi di sorta.

0780-marktplatz-darmstadt
Sempre il Palazzo residenziale funge da sfondo all'elettromotrice 0780 impegnata sulla linea 9 in questo caso diretta a Bollenfalltor, capolinea sede anche di un deposito tranviario. A differenza delle più anziane elettromotrici ST12 solo una minima parte della famiglia ST14 è stata intitolata ad altre città nel mondo tra cui ad esempio l'inglese Chesterfield abbinata alla qui ritratta matricola 0780, abbiamo poi Alkmaar in Olanda (0775), San Antonio negli USA Texas (0782), Liepaja in Lettonia (0786), Troyes in Francia (0789) ed Uzgorod in Ucraina (0791).


0783-ernstludwigplatz
0783-luisenplatz-darmstadt-2
L'elettromotrice 0783 della famiglia ST14 presenta alcune prerogative del tutto particolari, tanto che da HEAG è stato definito e presentato a Maggio 2023 come "Inno-Tram" ovvero il Tram della Ricerca. Dotata di una livrea particolarissima, tale elettromotrice nasconde diverse innovazioni come ad esempio sistemi di assistenza alla guida (ad esempio la classica frenata che rallenta automaticamente in modo non traumatico il convoglio, non appena i sensori e le telecamere rilevano un ostacolo sui binari) e si prevedono anche test per il funzionamento telecomandato, mentre già dal 2019 la 0783 è stata dotata di telecamere e sensori e da allora ha raccolto numerosi dati durante il servizio, telecamere e sensori intuibili ad esempio sul frontale (i vari rettangolini neri in basso). L'aspetto curioso è che a fine Giugno 2023, all'incirca poco meno di due settimane dopo la nostra visita, la stessa vettura è stata dotata di un sistema "a sensore e senza contatto della mano" per l'apertura delle porte passeggeri dall'esterno, curiosamente pubblicizzato da HEAG bene o male con il concetto "ora ti sentirai come Luke Skywalkwer nell'aprire la porta" facendo riferimento ai Jedi della nota pellicola di Guerre Stellari!. Probabile che l'elettromotrice sia stata chiamata in Officina giusto qualche giorno dopo il nostro passaggio in quanto nell'immagine scattata il 19 Giugno non era presente il dettaglio invece osservabile alla seguente pagina:https://www.heagmobilo.de/de/


0786-marktplatz-darmstadt
0789-ernstludwigplatz
Tutte le elettromotrici ST14 non sembrano essere minimamente interessate da pellicolature pubblicitarie integrali, ne consegue una certa eleganza e pulizia del veicolo, specie quando abbinato ad un rimorchio. E' il caso ad esempio dell'elettromotrice 0786 (da notare l'insolita distanza e geometria dei binari nei pressi della Marktplatz) o dell'elettromotrice 0789 ritratta qualche decina di metri più avanti e battezzata con il nome della città francese Troyes, il rimorchietto in questo caso presenta una pellicolatura classica parziale pubblicitaria. E' interessante notare come con il prossimo arrivo di 25 elettromotrici Stadler famiglia ST15 e con la conseguente radiazione delle anziane ST12, diverrà decisamente meno importante il compito dei rimorchi SB9.


0790-luisenplatz-darmstadt
0792-luisenplatz-darmstadt
In attesa e sperando di tornare per vedere proprio le future ST15, godiamoci in ultimo due immagini di elettromotrici ST14 di passaggio nella centralissima e trafficatissima Luisenplatz. L'elettromotrice 0790 con rimorchio è probabilmente impegnata sulla linea 6 "Schnellzug" od anche nota come "Schnell sechs" mentre sulla sinistra possiamo notare il Luisencenter, centro commerciale aperto in pieno centro città alla cui inaugurazione nel 1976 sono volati pomodori... mentre l'ultima elettromotrice della serie la 0792 è ritratta sulla linea 3 diretta a Lichtenbergschule, itinerario dotato di un tratto a binario unico tra le fermate di Weinbergstrasse e Ludwigshofstrasse, poco prima di giungere al capolinea citato.

UN GIORNO SULLA FERROVIA MUSEO BLONAY-CHAMBY
di Gianpiero Bottazzi
Un sogno diventato realtà e che continua a vivere dopo quasi 60 anni. L’avventura nasce nel maggio 1966 quando il collegamento ferroviario a scartamento metrico da Blonay a Chamby viene chiuso a seguito della scarsità di passeggeri. Siamo nella Svizzera Romanda sulle colline del lago di Ginevra, tra Vevey e Montreux. Subito dopo la chiusura, un piccolo gruppo di appassionati lancia l’idea di far rinascere la linea come ferrovia turistica a vapore. Dopo qualche mese si tiene l’assemblea costituente della “Società per la creazione della ferrovia turistica Blonay-Chamby” con ben 82 soci fondatori. I volontari si mettono subito al lavoro per definire i complessi aspetti legali per ottenere la concessione, oltre che per la manutenzione dei binari e la ricerca del materiale rotabile. Dopo poco più di due anni, nel luglio 1968, viene inaugurata la ferrovia turistica con grande partecipazione di pubblico (20.000 passeggeri nel primo anno). Nei decenni successivi continua la raccolta di rotabili ferroviari, viene realizzato ed ampliato il deposito museale e poi gli spazi per l’officina e per l’accoglienza dei visitatori.
Passare una giornata sulla ferrovia museo Blonay-Chamby è un’esperienza emozionante. Quando sali sulle carrozze ti senti un passeggero di fine Ottocento, con i suoni e gli odori tipici delle ferrovie di una volta. I treni storici con locomotiva a vapore salgono nel bosco per quasi tre chilometri superando una profonda gola con uno spettacolare viadotto, lungo 78 metri e alto 45. Arrivati a Blonay, il treno torna indietro per alcune centinaia di metri e, attraverso un raccordo, raggiunge il museo/deposito di Chaulin. E’ un luogo affascinante che ospita nel deposito 80 veicoli storici su rotaia di cui più di 50 dinamici. Nel museo si possono ammirare, tra l’altro, una carrozza passeggeri realizzata per la linea del Moncenisio e anche numerosi tram provenienti da Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna e Neuchâtel. Durante la visita si avverte l’entusiasmo dei volontari impegnati in svariate attività: dalla guida delle locomotive al controllo biglietti, dall’accompagnamento dei visitatori al restauro in officina. Ci si sente a casa e sembra di rivivere l’atmosfera che c’è in Atts che ha molte caratteristiche in comune, nonostante sia nata più recentemente. Anche per la nostra associazione l’obiettivo di una linea storica è stato raggiunto, con l’inaugurazione della linea tranviaria 7 nel 2011, e ora ci stiamo impegnando per realizzare un museo del trasporto su ferro. Gli amici dell’associazione Blonay-Chamby ci sono riusciti, perché il sogno non potrebbe diventare realtà anche a Torino?
Foto di Enrico Piccablotto

Per un attimo superiamo di qualche kilometro il confine tra Francia e Germania e studiamo il caso della cittadina di Mulhouse (ma torneremo in Germania per Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg e Stoccarda! Ri-saltellando in Francia per Strasburgo...), la quale ha visto rinascere il tram nell’anno 2006 giusto dopo quasi mezzo secolo, visto che gli “ancien tramway” in città hanno circolato dal 1882 al 1956/57 ca. Il tram moderno è tornato a Mulhouse in quel periodo che potremmo definire come "terza generazione francese" ovvero nell'attuale secolo. E' sempre doveroso ricordare che le uniche tre reti tranviarie francesi rimaste sempre in esercizio risultano essere state Saint Etienne (1881!), Marsiglia e la Lille-Roubaix-Turcoing a cui hanno fatto seguito le “progenitrici della rinascita” ovvero Nantes, Grenoble, Strasburgo, Rouen ed una parte di quanto sinora realizzato a Parigi. A differenza tuttavia di altre reti in cui lo stesso rilancio del tram è stato un volano con ulteriori espansioni, diventando un vero e proprio modello nazionale (su tutte potremmo citare Strasburgo, Grenoble, Montpellier e Lione) nel nostro caso la rete tranviaria non ha subito ulteriori cambiamenti od evoluzioni dopo l’anno 2010, momento nel quale si decise di rinviare ogni ulteriore prolungamento per motivi economici, sebbene la realizzazione della rete tranviaria di Mulhouse sia stata a tutt’oggi una delle meno costose in assoluto in Francia, battuta solo dalla ancor più "economa" e più recente Besancon, non lontana.
Mulhouse è una città con circa 108.000 abitanti, la seconda per dimensioni in Alsazia dopo ovviamente Strasburgo ed è la quarta nella Regione del Grand Est, in tal caso superata anche da Reims e Metz. Fondata secondo la leggenda intorno ad un mulino ad acqua, per secoli è stata città-stato diventando persino Repubblica e rendendosi indipendente dal Sacro Romano Impero. Impegnata nella rivoluzione industriale, venne definita la “Manchester francese” (ogni nazione aveva la sua Manchester…. quella tedesca risulta essere Augusta, in Italia invece ne avevamo più di una in quanto il “titolo” viene spesso associato a Terni, Schio e Legnano!) mentre solo più recentemente Mulhouse è stata definita "la città dei Musei tecnici” in quanto è presente il Museo “Citè du Train” SNCF (che analizzeremo per bene a fondo in futuro, preparatevi…) ed il Museo Nazionale Francese dell’Automobile od anche il Museo Electropolis (il più grande in Europa dedicato alla corrente elettrica!) oltre che un Museo della Stampa su Tessuto.
Caso curioso vuole che Mulhouse sia appartenuta dal 1515 al 1586 alla Confederazione Elvetica (...) indi è passata ai francesi dal 1798 al 1871 per ritrovarsi in Germania sino alla Prima Guerra Mondiale, per poi ritornare in Francia con tutta la Lorena tra le due guerre mondiali ed ancora essere stata riconquistata dalla Germania nazista, il tutto per poi fortunatamente tornare francese alla fine della Seconda Guerra Mondiale, caso che la rende una città abbastanza insolita dato che, come a Strasburgo, vi sono diversi toponimi di chiara origine tedesca pur trovandoci ora in una città francese che per anni è stata denominata Mulhausen!
Decisamente interessante la pletora di personaggi famosi nati a Mulhouse: su tutti per noi milanesi, anche se personaggio minore in confronto agli altri che citeremo successivamente, non possiamo non citare il noto Philippe Daverio storico dell’arte in passato molto presente in televisione ed ex assessore milanese purtroppo ora mancato, possiamo poi citare personaggi storici come il famoso Alfred Dreyfus la cui vicenda ha diviso in due la Francia (il noto “affare Dreyfus”) oltre al matematico Jean Henri Lambert, il chimico Alfred Werner alias Premio Nobel della Chimica ed infine caso curioso, il poco noto regista William Wyler autore di pellicole come “Vacanze Romane” e “Ben Hur” nato nella Mulhausen tedesca!. Concludiamo con alcuni dettagli curiosi ed interessanti: la città è gemellata con l’italiana Bergamo, presenta una Moschea la cui facciata assomiglia incredibilmente al Palazzo Mondadori nei pressi di Segrate a Milano (che talvolta si vede ancora nei Telegiornali) e merita di essere citato il fatto che viene definita anche la città delle “delle 136 nazionalità”, espressione usata spesso in quest’ultimo secolo, onde designare la grande diversità della popolazione cittadina, sebbene in anni recenti (2017) le nazionalità maggiormente presenti in città risultavano essere turchi, algerini e marocchini, pur non senza dimenticare ben 1.500 italiani, nulla a che vedere tuttavia con la tedesca Mannheim ove ogni 200 metri è presente un ristorante italiano!
SOLEA L’AZIENDA GIALLOROSSA DEDITA ALLA GESTIONE DI UNA RETE OVE NON MANCA IL TRAM TRENO!
Quando si parla di Tram-Treno spesso si fanno subito riferimenti alla non tanto lontana e teutonica Karlsruhe, patria fondatrice del suddetto concetto moderno, tuttavia pur non mancano tanti altri casi presenti in Germania, Austria, Svizzera… sebbene si arrivi ad utilizzare tale definizione talvolta anche in maniera impropria come ad esempio nel caso delle “sarde” Cagliari e Sassari. Limitandoci ai casi francesi possiamo citare sicuramente Nantes e Parigi (in quest’ultimo caso abbiamo anche documentato il caso della T4 anche se formalmente è un tram che corre su una ex ferrovia e non promiscuamente con convogli ferroviari, vedi anche altri casi più recenti parigini) oppure Lione ove abbiamo anche avuto modo di documentarlo anche se nuovamente anche in questo caso ci troviamo davanti più che altro a dei tram che circolano su ex linee ferroviarie ma non promiscuamente con altri convogli ferroviari (Aeroporto da un lato e Tram de l’Ouest dall’altro, vedi precedenti mail). Nel caso specifico di Mulhouse possiamo invece proprio distinguere3 linee tranviarie tradizionali (aventi numero semplicemente 1-2-3) gestite con un tipo di convoglio prettamente tranviario ed una quarta linea definita come vero e proprio Tram-Treno (linea TT) che invece circola promiscuamente con convogli ferroviari in una determinata tratta del proprio percorso, pur circolando anche sulla rete tranviaria utilizzando tensione e segnalamento differenti, peraltro con elettromotrici Siemens Avanto sostanzialmente simili a quelle circolanti sulla linea parigina T4 tra Aulnay e Bondy, tanto che sono state classificate nella stessa serie e maniera per conto di SNCF. Ma andiamo con ordine.
SOLEA Mulhouse è una azienda nata nel 2010 che serve la cosiddetta “agglomeration” locale (concetto quanto mai incapace di entrare nella testa italiana…) toccando 39 Comuni in cui abitano 278.000 abitanti e servendo una superficie di 430 kmq, garantendo 6,3 milioni di km l’anno ovvero come se si facesse 150 volte il giro del Mondo!. I suoi principali azionisti risultano essere il noto gruppo di trasporto Transdev (67,8%), l'altrettanto e forse ancor più noto operatore di trasporto parigino RATP (20%), non manca ovviamente Mulhouse Alsace Agglomération (10%) e l'operatore di trasporto TRACE di Colmar (1%).
La rete consta di 3 linee tranviarie, 1 linea di tram-treno, 24 linee automobilistiche tra cui una “ad alto livello di servizio”, 17 istituti scolastici sono serviti appositamente dalle linee "Tribus" e 2 navette elettriche sono al servizio del centro città di Mulhouse. In termini di veicoli possiamo conteggiare 34 convogli tranviari di cui 12 destinati alla linea di tram-treno, 142 autobus di cui 44 articolati oltre a 18 di piccole dimensioni, mentre se vogliamo indagare la loro forma di alimentazione possiamo citare 33 veicoli alimentati a biogas (di cui 15 snodati) e 7 elettrici di cui 2 di piccole dimensioni; mentre il numero dei dipendenti potrebbe aggirarsi tra 550 e 600 unità.
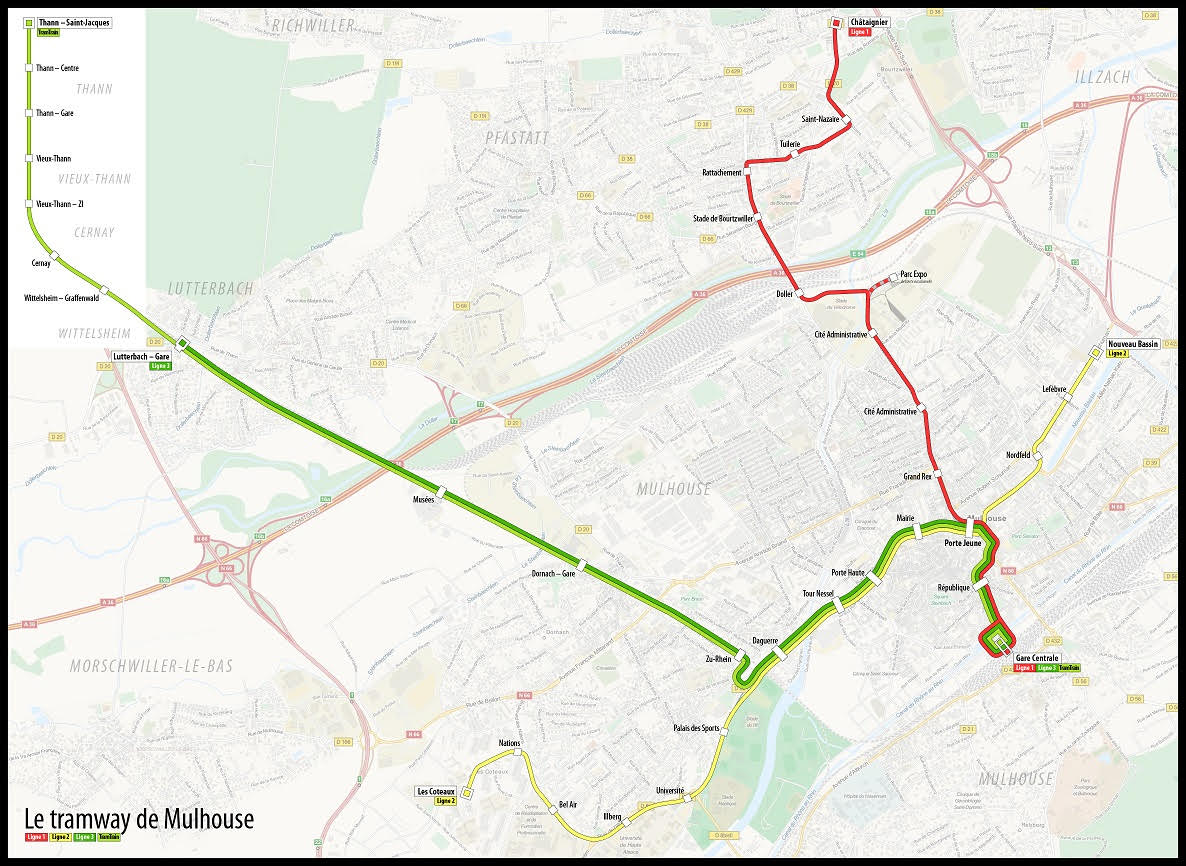
Limitandoci per ora alla rete tranviaria possiamo stabilire che ha una lunghezza di 16,2 km a cui bisogna aggiungere 19 km destinati alla linea Tram-Treno (sebbene sia difficile stabilire l’esatto confine tra le due reti, si presume poco fuori la fermata di Lutterbach), in dettaglio le linee esercite:
Linea 1 Châtaignier – Gare Centrale RFF-SNCF - 5,8 km, 18 minuti di percorrenza, 12 fermate, servita con Alstom Citadis serie 2000
Linea 2 Coteaux – Nouveau Bassin - 6,2 km, 18 minuti di percorrenza, 14 fermate, servita con Alstom Citadis serie 2000
Linea 3 Lutterbach Gare RFF-SNCF – Gare Centrale RFF-SNCF - 7 km, 19 minuti di percorrenza, 11 fermate, servita con Alstom Citadis serie 2000 e Siemens Avanto serie TT
Linea TT Thann Saint-Jacques / Thann Gare RFF-SNCF – Gare Centrale RFF-SNCF -22 km, 42 minuti di percorrenza, 18 fermate, servita con Siemens Avanto serie TT
Premesso lo scartamento ordinario, la tensione risulta essere di 750v c.c. tuttavia decisamente poco noto risulta essere il fatto che la linea di TT Tram-Treno dopo la fermata di Lutterbach (ovvero quando effettivamente entra nella giurisdizione ferroviaria di RFF) passa alla tensione di 25kV monofase e pertanto risulta essere percorribile solo dalle elettromotrici “bitensione” Si
Passiamo finalmente al materiale rotabile, in città sono presenti solo due tipi di materiale rotabile, ben diversi tra loro visto il diverso costruttore:
22* elettromotrici Alstom Citadis 302 serie 2001/2027, lunghezza 32,5m, costr. Alstom del 2006
12 elettromotrici Siemens Avanto serie TT16/TT27, lunghezza 37m, costr. Siemens del 2010, bitensione 750v c.c. / 25 kV c.a.
L’asterisco sugli Alstom Citadis è velocemente spiegabile: a seguito della rinuncia della costruzione di ulteriori estensioni della rete da parte della Comunità di Mulhouse (linea 1 da Chataignier a Bosquets du Roy e linea 2 da Nouveau Bassin a Jonquilles), le elettromotrici Alstom Citadis matricole2003-2006-2011-2013-202nell’anno 2008 sono state prima noleggiate e poi cedute niente meno che alle tranvie di Melbourne in Australia! Merita anche un cenno il fatto che due unità (matr. 2004-2005) sono state noleggiate dal 2006 al 2008 alla rete tranviaria di Buenos Aires in Argentina (!) mentre l’unità 2008 ha circolato ad Utrecht in Olanda. Certo potremmo definire questi particolari Citadis come “tricontinentali” avendo avuto modo di circolare sia nell’America del Sud che in Oceania! Ultimo dettaglio, un’usanza molto teutonica o svizzera applicata in Francia ovvero l’aver battezzato ogni singolo convoglio Alstom Citadis con un nome scelto tra i Comuni dell’Agglomeration di Mulhouse, il caso vuole che hanno ricevuto un nome di battesimo persino le unità in seguito cedute in Australia (nome di conseguenza poi perso...) ma non curiosamente l’elettromotrice 2018, unica tra 27 a non aver ricevuto un nome semplicemente in quanto interamente gialla, senza adesivi in quanto atta a quanto pare a ricevere pellicolature pubblicitarie (forse solo inizialmente in quanto rileveremo che non sarà l'unica ad averne ricevute!). Da ricordare che le elettromotrici Siemens Avanto di SOLEA Mulhouse, circolando su rete RFF sono state classificate di seguito a quelle in circolazione sulla linea T4 nell’Ile de France a Parigi gestita sempre da SNCF, motivo per cui i convogli di Mulhouse partono dalla matricola TT16 a salire. E non solo: pur essendo un prodotto Siemens dovrebbero esser state realizzate da Lohr presso Duppigheim, poco fuori Strasburgo, per intenderci la "mamma" del noto Translohr (vedi Padova, Venezia...)
Da ricordare inoltre che tutte le vetture sono bidirezionali e che tutte vengono ricoverate presso il deposito aziendale di Mertzau situato presso la fermata Musée de l’Auto, sede aziendale SOLEA presso la quale vengono ricoverati anche i veicoli su gomma, ove risulta essere presente un capannone per il ricovero vetture al coperto ed anche un “pettine” di binari tronchi allo scoperto ove vengono ricoverate anche le vetture Siemens Avanto della linea TT che per l’appunto onde rientrare in deposito percorrono fuori servizio un tratto della linea 1 tra la fermata citata e lo snodo strategico di Porte Jeune. Altrettanto interessante il fatto che non esistono comunicazioni dirette qualora ci si voglia dirigere dalla Gare Centrale a Nouveau Bassin e dalla zona ovest verso il deposito, tuttavia la presenza di un paio di comunicazioni tra i due binari potrebbero essere utilizzate per semplificare le manovre di uscita e rientro dal deposito, visto e considerato che in Francia vi è una tendenza molto ma molto inferiore a fasciarsi la testa rispetto alla burocrazia italiana ove senza buon senso ci si affida ridicolmente a delibere. Un cenno infine alla infrastruttura: tutta la rete risulta essere a doppio binario, ad eccezione del tratto a binario unico percorso dalle linee 3 e TT tra Dornach e Lutterbach con la fermata intermedia Musees dotata di raddoppio, binario unico che corre in questo tratto a fianco della rete ferroviaria (linea per Colmar e Strasburgo), giusto prima di confluire sulla rete RFF sulla linea locale per Kruth su cui la linea TT corre sino a Thann, venendo persino intersecata dal raccordo tra la rete RFF ed il Museo ferroviario Cite’ du Train di SNCF!.
Iniziamo dunque a fare una passeggiata fotografica esaminando per iniziare gli Alstom Citadis serie 2000, soprannominati scherzosamente "minions"...
FOTO (del 24 e 25 Aprile 2022)

2001-porte jeune
La fermata principale di Porte Jeune nei pressi del centro storico è ovviamente pedonale, il traffico privato è minimo e contenuto ai margini; i pedoni vengono messi al centro della priorità così come dovrebbe essere in un paese civile. L'elettromotrice 2001 ha appena effettuato la fermata e sta svoltando a sinistra per dirigersi a Nouveau Bassin come linea 2, tenete a mente la decorazione laterale dell'elettromotrice "con figure geometriche" dato che come osserveremo spesso cambierà tra le varie elettromotrici. Le vetture sono dotate di 5 casse di cui una corta centrale con pantografo, due con doppia porta da entrambe i lati ed infine sono presenti le due casse di estremità con cabina ed una porta singola, nel più classico dello stile degli Alstom Citadis francesi.

2002-nouveau bassin
La matricola 2002 è ritratta al capolinea Nouveau Bassin come linea 2, la vettura è ritratta alla banchina di arrivo e si sta apprestando a procedere sull'asta di manovra ove avverrà l'inversione di marcia, l'indicatore elettronico dovremmo averlo colto mentre stava cambiando indicazione passando ad indicare "Les Coteaux", capolinea opposto. Da notare la particolare "foresta" presente sullo sfondo in direzione centro, decisamente non male e con una vasta chioma, sulla linea 2 le fermate sono contraddistinte da archi circolari colorati (sullo sfondo si scorge anche quello della fermata Lefebvre) secondo un progetto di Daniel Buren pittore e scultore francese le cui opere sono presenti anche in Italia tra cui ad esempio la riqualificazione di Piazza Verdi a La Spezia od altre strutture presenti in Toscana a Quarrata (Pistoia) e Colle Val d'Elsa.

2004-daguerre
Risulta essere rosa invece l'arco presso la fermata Daguerre (da notare che hanno anche una funzione tecnica essendovi agganciata la linea aerea), l'ultima prima che la linea 2 si separi dalla 3 e dal TT, punto di separazione individuabile più o meno oltre il secondo cavalcavia sullo sfondo. L'elettromotrice 2004 è in arrivo mentre si dirige verso Nouveau Bassin, sulle reti francesi è un minimo segno di civiltà indicare come minimo anche i tempi di attesa in fermata anche del secondo passaggio per ogni linea, impresa a quanto pare impossibile a Milano. Da notare la decorazione dell'elettromotrice che risulta essere differente ad esempio rispetto alle due precedenti unità sinora osservate, anche in questo caso è impressionante e logico l'interscambio con le linee su gomma, essendo la fermata dell'autobus sullo stesso marciapiede di quella tranviaria, una soluzione logica che a Milano spesso sembra esser ritenuta poco logica...

2005-avenue de colmar
L'elettromotrice 2005 insieme alla precedente 2004 per quasi due anni tra il 2006 ed il 2008 (non essendo al tempo ancora completa la rete di Mulhouse) ha circolato niente meno che a Buenos Aires in Argentina probabilmente su quella che è nota come "Tranvía del Este", conosciuta anche come Tranvía de Puerto Madero, impianto che ha avuto scarsa fortuna essendo stato chiuso nel 2012 e che ha visto circolare anche l'elettromotrice 153 di Madrid, sempre un Alstom Citadis della rete tranviaria moderna madrilena di cui ci siamo occupati nel 2011 (vedi precedenti mail). L'alsaziana 2005, rientrata a casa presumibilmente entro il 2008, è rimasta in attività in città ove la incontriamo sulla linea 1 diretta a Chataignier, sulla sinistra si intuisce la guglia del "Tempio di Saint Etienne" ovvero Santo Stefano, il quale sarebbe "sulla carta" una cattedrale per i cattolici in tutta la Francia, tuttavia risulta essere un tempio essendo di rito protestante.

2009-lefebvre
L'elettromotrice 2009 sta giungendo alla fermata di Lefebvre, l'ultima della linea 2 prima di arrivare al capolinea di Nouveau Bassin, dotata dei classici archi che contraddistinguono le fermate di tale linea. Possiamo così osservare la strutture presenti presso le fermate tranviarie ovvero un parallelepipedo che ingloba l'emettitrice di biglietti ed è raccordato con la copertura, non mancano le sedute monoposto lungo la banchina. Osservando qualche piccolo dettaglio si ha la sensazione che a Mulhouse sia passata un pochino la "voglia di tram" come ad esempio alcuni piccole dettagli trascurati del parallelepipedo; notevole invece il manto erboso che sicuramente alle nostre latitudini non si riesce a tenere nelle stesse condizioni e non solo per motivi atmosferici.

2009-porte jeune
La stessa elettromotrice il giorno prima rispetto alla precedente immagine la ritroviamo a Porte Jeune ove però tuttavia risultava essere impegnata sulla linea 1 diretta a Chataignier, è in arrivo dalla Gare Centrale ed i binari che tendono a sinistra risultano essere quelli della linea 2 diretta a Nouveau Bassin. Sullo sfondo il Conservatorio di Mulhouse ove curiosamente all'interno le sedute per gli spettatori sono state fornite da un'azienda italiana, più sullo sfondo un Liceo Tecnico non indifferente che ha cambiato più volte la destinazione d'uso tanto che è stato reso accessibile ai maschietti solo dal 1971!

2010-rue de la somme-1
Particolarmente apprezzabile anche se un poco "arzigogolato" l'itinerario di avvicinamento delle linee 1-3 e TT alla Gare Centrale con un percorso alquanto contorto ma di buon senso, tra cui ad esempio il passaggio nella qui ritratta Rue de la Somme, risultante essere a senso unico per il traffico privato, tanto è vero che se osservate per bene l'elettromotrice 2010 diretta in Stazione sta transitando in un'area con cubetti di porfido interdetta agli altri veicoli. La sede tranviaria è stata dunque perfettamente inserita senza dover subire pianti in cinese, lamentele del gomito del tennista, palazzi rovinati dalla linea aerea con installazione di complicati impianti alternativi. Un progetto presentato, condiviso, approvato ed infine realizzato, senza tanto dover cercare scuse nel "non si può fare". Tanto più che nella stessa strada passano anche convogli a tutti gli effetti "ferroviari"!


2012-nouveau bassin
2012-nouveau bassin-1
Cogliamo in due momenti distinti l'elettromotrice 2012 sempre al capolinea di Nouveau Bassin sulla linea 2, nella prima immagine (quella senza il suffisso "-1") l'elettromotrice si è spostata sull'asta di manovra, dopo qualche minuto, solo a tempo debito, l'elettromotrice si sposterà sulla banchina di partenza caricando i passeggeri. Alcuni piccoli dettagli, di cui non si capisce come non ci si possa arrivare in taluni casi anche a Milano: nella seconda immagine troviamo sulla sinistra un cartello che invoglia gli automobilisti a lasciare la macchina nel parcheggio di corrispondenza indicando persino la convenienza economica dell'offerta (2 euro parcheggio+tram sino a 7 persone!) e secondo aspetto, la linea tranviaria perfettamente integrata con il vicino parcheggio tanto che i passeggeri possono rimanere ad attendere al coperto senza bagnarsi in caso di pioggia.

2017-porte jeune-2
Una curiosità sulle pellicolature: abbiamo citato il fatto che l'elettromotrice 2018 sembrava esser l'unica a non aver ricevuto "ornamenti geometrici" sulle fiancate in quanto destinata a pellicolature pubblicitarie, in realtà come abbiamo visto anche altre elettromotrici pur con i disegni geometrici sulla fiancata hanno ricevuto pellicolature come ad esempio la matricola 2012 con l'Agglomeration di Mulhouse oppure la qui ritratta matricola 2017 impegnata sulla linea 1 con una pellicolatura anche in questo caso "auto-promozionale" in quanto SOLEA, come tante altre aziende di trasporto, cerca collaboratori! L'elettromotrice ha appena abbandonato il nodo nevralgico di Porte Jeune essendo diretta come linea 1 a Chataignier, si noti il curioso contrasto sullo sfondo, a sinistra un giovane centro commerciale (il quale ha il nome da cui prender la fermata ovvero "Porte Jeune"), a destra un palazzo d'epoca...
2018-leclerc-de gaulle-gare
L'elettromotrice 2018 (quasi più interessante fuori che dentro...) ci consente di dare un'occhiata al suo interno, tipico di un Alstom Citadis con i classici "poggiachiappe" per coloro che non hanno voglia di sedersi dato il breve tragitto e le sedute ben evidenziate in un pulito e lineare color giallo che diventa rosso per richiamare le porte. Ben distribuito il numero di convalidatrici in modo tale che nessuno debba fare la danza dei berberi per arrivare a convalidare il titolo di viaggio, come nel nostro paese, fattore che spesso, abbinato ad una scarsa frequenza dei passaggi, porta al riempimento della vettura con conseguente italico pensiero "oh non arrivo a timbrare, se arrivano i controllori spingo, se non arrivano non timbro".
2019-avenue de colmar
L'elettromotrice 2019 transita nella tranquilla e commerciale Avenue de Colmar, guarda caso disposta in direzione della cittadina omonima situata bene o male a metà strada tra Strasburgo e Mulhouse. La sede tranviaria per la linea 1 (e per tutte le vetture che escono rientrano dall'unico deposito di Mertzau) è ben presente ma non è necessario che sia protetta, la nostra sta transitando in direzione Stazione mentre una collega è appena transitata in direzione opposta. Una sede tranviaria del genere a Milano sarebbe invasa nell'ordine dal camioncino che "solo un attimo consegno e vado", dal furbo di turno che "vado via subito" e non ci stupirebbe dalla Polizia locale che va a bere il caffè per non incorrere nella responsabilità di andare a sanzionare i precedenti casi...

2024-porte jeune-1
2024-rue de metz-porte jeune
L'elettromotrice 2024 è ritratta in due giorni differenti su due linee differenti, caso che ci dimostra che fatto salvo il servizio TT Tram-Treno, sulle restanti linee SOLEA utilizza promiscuamente gli Alstom Citadis serie 2000 su tutte e tre le linee senza particolari problemi o fissazioni di sorta. Merita interesse in particolare l'immagine di Rue de Metz ove la nostra 2024 è ritratta in servizio sulla linea 3 in direzione Lutterbach e si approssima allo snodo di Porte Jeune. Desta decisamente interesse, se ci fate caso, il fatto che la sede tranviaria passa a poco più di un metro da una "torre tagliata a metà" che risulta essere uno dei simboli di Mulhouse ovvero la "Torre di Bollwerk" nome da cui, a quanto si narra, sembra esser nata la parola francese "Boulevard" ben più famosa. La torre ha ricevuto più nomi nel corso della sua storia ("Neuensteinerturm" per i tedeschi, sempre simpatici in queste cose...) ed è stata più volte ricostruita anche se effettivamente è presente una torre in tal punto sin dal XIV° secolo ovvero dal 1300. Pur essendo uno dei monumenti ed edifici storici più importanti della città il tram vi transita davanti a poco più di un metro senza particolari problemi, chissà forse fischieranno le orecchie a qualcuno, ovvia...
2025-porte jeune
Osservando dal marciapiede di Porte Jeune in direzione ovest, da sinistra a destra possiamo osservare i seguenti binari: l'elettromotrice 2025 sulla linea 2 diretta a Nouveau Bassin (ma anche le linee 3 e TT da Lutterbach e Thann in direzione Gare Centrale) sono costrette gioco forza ad arrivare al primo binario adiacente al centro storico (ed aprirà le porte alla sua sinistra) senza interferire con il binario 2 impegnato invece dalla linea 1 in arrivo da Chataignier (da destra) attraversando i binari davanti a noi e si approssima alla stessa banchina presso la quale invece aprirà le porte alla propria destra. A sinistra dell'albero in primo piano possiamo osservare il binario di partenza delle linee 3 e TT che proseguiranno diritto verso Lutterbach e Thann mentre la linea 1 si dirigerà a Chataignier svoltando a destra subito dopo il suddetto albero, tutte le elettromotrici di queste tre linee partono da Porte Jeune osservando l'apertura delle porte a destra. Infine alla nostra destra la linea 2 dopo aver osservato la fermata avendo aperto le porte a sinistra, proseguirà diritto in direzione di Les Coteaux mentre la svolta a destra non è utilizzata da vetture in servizio ma molto probabilmente dalle sole vetture della linea 2 che terminano il servizio in fermata per poi rientrare al deposito di Mertzau, situato a nord del centro, proseguendo una manciata di minuti alla nostra destra.

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo di SOLEA Mulhouse con una 2° parte dedicata sempre alla rete tranviaria, avvicinandoci sempre di più al "Tram-Treno"...
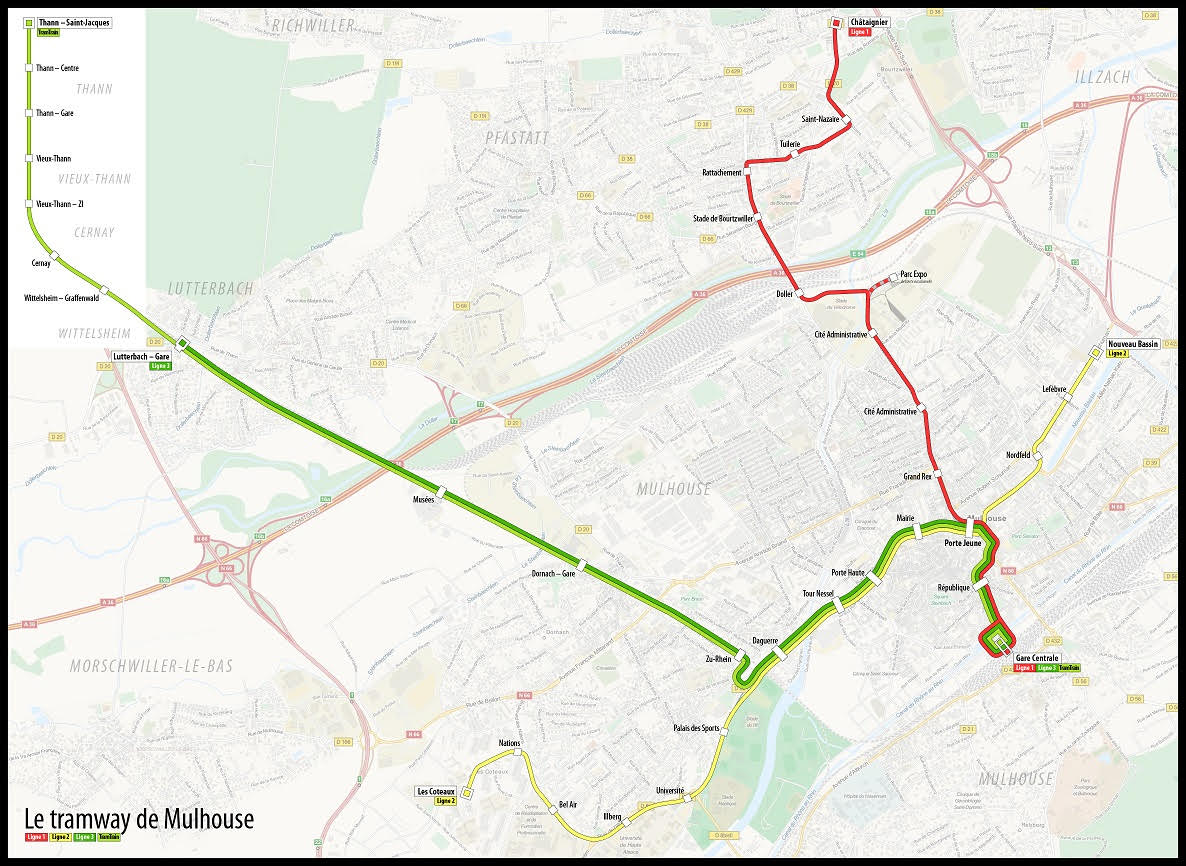
FOTO (del 24 e 25 Aprile 2022)

2026-musee
Spostiamoci in periferia nella zona nord-occidentale della città ove per un tratto non indifferente le linee tranviarie 3 e TT corrono in parallelo alla linea ferroviaria RFF sino a Lutterbach punto nel quale poi si divide in direzione di Thann e Kruth da un lato e Colmar e Strasburgo dall'altro. In particolare l'elettromotrice 2026 si sta avviando come linea 3 verso Lutterbach (ne stiamo osservando la coda in questo caso...) dalla fermata Musees, "al plurale" facendo riferimento al fatto che nei suoi pressi troviamo non solo il Museo Cite' du Train di SNCF ma anche il Museo Electropole sulla elettricità. La sede tranviaria per ora è ben separata da quella ferroviaria, la fermata è disposta ad isola e vi si accede solo con un attraversamento pedonale intuibile a sinistra che obbliga i pedoni ad avere attenzione perlopiù alle vetture in arrivo da Lutterbach e Thann, senza dunque facendo aumentare a sproporzione i costi di realizzazione, con scale, sottopassi ed ascensori che poi in Italia vengono vandalizzati, non mantenuti e diventano ricettacolo di cattivi odori e comportamenti da inetti. Ovvero spendiamo di più, creiamo maggiore manutenzione, con conseguente disagio e mancanza di buon senso, cercando di rispettare delle leggi in un paese ove esiste una legge per ogni cosa ma che non viene minimamente rispettata. Due dettagli per i più interessati: il binario in curva osservabile sull'estrema destra è il raccordo che consente ai convogli ferroviari in arrivo dalla Gare Centrale e da Belfort di procedere sulla cintura merci nord verso lo scalo merci noto come Gare du Nord; all'estrema sinistra invece il binario non elettrificato risulta essere il raccordo tra il Museo ferroviario Citè du Train e la rete RFF che proprio appena poco a sud della fermata Musees incrocia il binario unico della rete tranviaria.

2026-porte jeune
Ancora la torre di Bollwerk funge da sfondo all'elettromotrice 2026 appena partita da Porte Jeune e diretta alla Gare Centrale come linea 3, tra qualche secondo transiterà ai piedi della torre simbolo della città, senza creare particolari stravolgimenti da far strappare i capelli. Da notare anche in questo caso la "pulizia visiva" della fermata più importante della città, niente catenelle o pesanti limitazioni a pedoni, limitazioni invece imposte al traffico privato sostanzialmente scacciato. Il primo carrello dell'elettromotrice sta impegnando lo scambio che consente di far confluire nell'unico binario verso la Gare Centrale sia la linea 3 e TT (da cui sta arrivando la nostra 2026) che la linea 1 da Chataignier, consentendo l'arrivo in parallelo in fermata a Porte Jeune di queste tre linee, situazione analoga succede sull'altra banchina in cui le elettromotrici delle linee 1-3-TT possono entrare in fermata contemporaneamente alle vetture della linea 2. Come andremo a vedere...

2027-2017-2009-porte jeune
...a vedere nella presente immagine, in cui stiamo osservando la fermata di Porte Jeune da oriente: l'elettromotrice 2027 come linea 1 sta procedendo verso di noi e svolterà alla sua destra verso Gare Centrale per passare nello stesso punto dell'immagine precedente; davanti a noi l'elettromotrice 2017 è appena giunta in fermata come linea 1 aprendo le porte alla sua destra mentre l'elettromotrice 2009 è nel contempo giunta in fermata aprendo le porte alla propria sinistra come linea 2 diretta a Les Coteaux e dovrà attendere il transito della collega della linea 1 che a breve le taglierà la strada.

2027-porte jeune-1
E proprio l'elettromotrice 2027 si avvia come linea 1 diretta a Gare Centrale, ha superato da poco un deviatoio la cui svolta a sinistra probabilmente non viene utilizzata in servizio di linea in quanto a destra svolta la linea 1 mentre la linea 2 diretta a Nouveau Bassin transita sull'altro binario dal quale svolta sempre a sinistra (oltre al pedone ritratto nell'immagine sull'estrema sinistra) pertanto si presume lo scambio sia utilizzato al mattino per le vetture in uscita dal deposito di Mertzau dirette sulla linea 2 in direzione di Nouveau Bassin. Da notare sulle porte la presenza delle indicazioni di accesso alle vetture in un periodo considerato ancora importante contro il Covid, era l'Aprile 2022.
UN PICCOLO CAMEO PER SCOPRIRE MEGLIO COSA E' IL TRAM-TRENO DIMULHOUSE...
Prima di esaminare "visivamente" il servizio offerto sulla linea TT, è doveroso ricordare come è strutturata lalinea di Tram-Train: da Mulhouse Gare Centrale sino alla fermata di Daguerre le elettromotrici corrono su una normale rete tranviaria, poco oltre tale fermata e dal bivio con il quale si distaccano dalla linea 2, le linee 3 e TT passano ad un tratto in affiancamento alla sede ferroviaria RFF (linea per Kruth e Colmar) pur rimanendo ancora su una sede nettamente indipendente (con tanto di recinzione di separazione tra le due sedi!) seppur a doppio binario solo fino a Dornach Gare mentre nel successivo tratto sino a Musees e Lutterbach il binario diventa singolo con possibilità di incrocio presso le tre fermate di Lutterbach, Musees e Dornach. Oltre la fermata di Lutterbach avviene il cambio di tensione di alimentazione, si passa al segnalamento ferroviario e si ricade sotto la giurisdizione ferroviaria di RFF, vincoli non indifferenti e che per ovvi motivi oltre Lutterbach consentono la circolazione alle sole elettromotrici Siemens Avanto serie TT, la sola tra le due serie "alsaziane" a poter circolare su rete RFF. In condizioni normali (potremmo dire un classico giorno feriale invernale) il servizio sulla linea TT viene garantito ogni 30 minuti traMulhouseGare Centrale e Lutterbach, tratto nel quale grazie alla linea 3 "urbana in parallelo" la frequenza aumenta ad una corsa ogni 14/16 minuti. Una volta entrati in sede ferroviaria in realtà la relazione TT prosegue sino alla fermata di Thann Saint Jacques (a monte del paese di Thann), la quale viene servita "quasi da tutte le corse" nei giorni Feriali, da tutte le corse al Sabato mentre nei festivi i servizi si attestano alla fermata di Thann Gare, situata a centro del paese, presso la quale limitano anche poche corse feriali.
Resta da citare il fatto che oltre Thann Saint Jacques la linea RFF comunque prosegue e giunge sino a Kruth (grazioso villaggio alsaziano, a differenza del terribile nome...impronunciabile o quasi per un francese!) anche se non risulta essere più elettrificata e rimane garantito un servizio TER di SNCF con automotrici ed una corsa ogni due ore circa che raggiunge il capoluogo in 75 minuti circa, terminando a Mulhouse Gare Centrale sebbene effettuando un percorso ben differente intono alla città. E' doveroso ricordare che secondo i piani originali la linea TT avrebbe dovuto raggiungere Kruth, prolungamento rinviato a data da destinarsi sebbene fosse stato previsto un budget senza però una data di prevista realizzazione, prolungamento inoltre in seguito osteggiato anche da diversi Comuni a causa della presenza di un passaggio a livello sulla importante strada principale locale della valle. Due curiosità finali: la prima è che nel momento in cui scriviamo (ma non nel momento in cui leggerete...) dal 17 Luglio al 27 Agosto 2023 le linee tranviarie 2, 3 e TT risultavano essere sospese causa lavori di manutenzione tra Lutterbach Gare e Tour Nessel (Ponte Stoessel) e pertanto le linee 2 e 3 erano gestite con autobus mentre la linea Tram-Treno risultava essere temporaneamente soppressa con contestuale rinforzo delle corse ferroviarie TER tra Mulhouse Gare Centrale e Thann. Il secondo aspetto è più simpatico e curioso ma trovo che sia comunque interessante e meritevole ricordare che nel 2011 è stato realizzato un francobollo celebrativo avente per oggetto il tram-treno!


TT16-mertzau-lefebvre-dep solea
TT16-mertzau-lefebvre-dep solea-1
I convogli Siemens Avanto (meno noti anche con la sigla S70) utilizzati sulla linea TT altro non sono che parenti molto simili a quelli utilizzati sulla linea T4 di Parigi (vedi precedenti mail), tanto che la numerazione dei convogli alsaziani per SNCF prosegue al seguito dei convogli della capitale, giusto per rammento ricordiamo che si tratta di 15 convogli a Parigi (serie TT01/TT15, classe U25500 per SNCF) del 2006/07 contro i 12 convogli diMulhouse(serie TT16/TT27) indicativamente del Dicembre 2010. Possiamo osservare il primo convoglio TT16 in sosta insieme ad un collega presso il deposito di Mertzau in un "pettine" tranviario alquanto curioso ovvero una serie di 8 binari tronchi scoperti disposti trasversalmente rispetto al corpo principale coperto del deposito e presso la quale possono essere ricoverate "comunque all'aperto" come minimo 24 vetture, di entrambe i tipi, sia Avanto che Citadis. L'aspetto curioso, osservabile anche su Google Maps, è che non risulta "bypassabile" dalle vetture, ma ci si deve per forza infilare, probabilmente da un lato le vetture arrivano dopo esser state lavate ed al mattino ripartono direttamente verso l'altro lato ripartendo verso la linea. Per i più curiosi:https://goo.gl/maps/JYWNdFWTdMk2Lb9j7

TT21-lutterbach
Presso la fermata di Lutterbach, una semplice banchina ad isola tra i due binari "ancora tranviari" (in questo caso con un sottopasso collegato alla parallela stazione RFF) vediamo giungere dalla città il Siemens Avanto TT21 diretto come linea TT Tram-Train con una corsa limitata a Thann Gare essendo il 24 Aprile 2022 una Domenica ovvero giornatestiva in cui tutte le corse TT limitano al centro del paese di Thann, un paese a nord-ovest diMulhousesu una linea RFF che poi prosegue oltre verso Kruth ma senza elettrificazione e dunque esclusivamente con automotrici TER di SNCF. A sinistra la parallela linea ferroviaria alla quale il nostro Avanto non ha ancora avuto accesso, sullo sfondo il binario singolo tranviario in direzione diMulhousepercorso sia dai servizi TT che dalla linea 3 attestata proprio in tale stazione. Da notare il curioso profilo dell'Avanto, tanto "cartone animato giapponese" come muso quanto abbastanza curioso come sagoma, data la rastrematura della cassa nella parte inferiore, al che ci fa tornare in mente l'ippopotamo che balla a suon di musica nel colossal animato "Fantasia" di Walt Disney...

TT21-lutterbach-3
Uno scorcio decisamente interessante, in questo caso ci rivolgiamo verso nord ovvero verso Thann e Kruth: il convoglio Siemens Avanto si è appena avviato dalla fermata di Lutterbach in direzione di Thann Gare, qualche secondo e transiterà nel punto ove diverse eloquenti indicazioni ricordano al conducente che si sta per passare sotto giurisdizione ferroviaria RFF con cambio di tensione passando dai 750v c.c. ai 25 kV c.a. "ferroviari", si intuisce anche il binario in curva che entra sulla sede ferroviaria parallelo in arrivo dalla stazione ed è impegnato dai convogli TER diretti a Thann ed oltre a Kruth in arrivo daMulhouseGare Centrale, iniziando così il vero e proprio tratto di "tram-treno". Al contrario la linea tranviaria 3 tramite il deviatoio in primo piano si sposta verso sinistra su un binario tronco che diventa asta di manovra rimanendo elettrificato a 750v. c.c., lo stesso deviatoio consente ai Siemens Avanto in arrivo da Thann di entrare sulla al binario "voie E" nominato "con lettera" per semplificazione secondo lo stile RFF-SNCF ed al seguito dei veri binari ferroviari A-B-C di Lutterbach Gare RFF, sebbene si trovino in un'area ancora sotto giurisdizione SOLEA. Una curiosità per i più interessati: il binario sullo sfondo che si vede svoltare a destra è la linea RFF a doppio binario per Colmar, Selestat e Strasburgo, percorsa non di meno anche da servizi TGV, lambita ma non impegnata dal servizio TT dato che si inserisce solamente dopo il bivio sulla linea locale RFF per Kruth.

TT21-porte jeune-mulhouse-2
Certo lascia abbastanza disorientati vedere lo stesso convoglio in pieno centro città alla centralissima fermata di Porte Jeune presso la quale finora avevamo incontrato i soli e semplici Alstom Citadis serie 2000 per gli amici "chenille de pomme" o "minions" che dir si voglia. L'elettromotrice TT21 sta osservando l'importante fermata in direzione di Thann St Jacques, località che verrà raggiunta dopo oltre 14 fermate in poco più di mezz'ora da Porte Jeune. In primo piano il binario utilizzato dalla sola linea 1 in arrivo da Chataignier e diretta a Gare Centrale, mentre il nostro corrispettivo TT diretto in Gare Centrale effettuerà fermata sull'estrema destra aprendo le porte a sinistra.
TT21-rue du sauvage-republique-mulhouse-1
La stessa elettromotrice TT21 il giorno precedente rispetto alla precedente immagine risultava essere impegnata sulla linea "urbana" 3 ovvero il servizio tranviario puro limitato a Lutterbach Gare, caso interessante in quanto proprio la linea 3 risulta essere l'unica linea in cui effettuano servizio promiscuamente sia gli Alstom Citadis che i Siemens Avanto, quest'ultimi probabilmente in soprannumero rispetto a quelli effettivamente necessari per il puro servizio "tram treno" TT. Incontriamo l'elettromotrice presso l'unica fermata intermedia presente tra Porte Jeune e Gare Centrale ovvero Republique. Sullo sfondo tra gli alberi si apre la "Square de la Bourse" toccata solo da un lato dalla sede tranviaria, ovvero una curiosa e graziosa piazza triangolare con palazzi dotati di portici che tanto ricordano le numerose piazze con portici di diverse cittadine piemontesi ovviamente a partire da Torino.
TT27-2018-leclerc-de gaulle-gare-mulhouse-1
Sotto un bel nubifragio (l'unico nella prima scampagnata dell'Aprile 2022) presso la Gare Centrale RFF SNCF diMulhousealle nostre spalle abbiamo modo di scorgere e catturare due aspetti interessanti: il primo è l'anello tranviario presso la quale effettuano capolinea tuttavia tre linee (1-3-TT) ove si possono osservare in sosta fianco a fianco Siemens Avanto ed Alstom Citadis, in questo caso lo scatto dovrebbe essere impreziosito dal Citadis matricola 2018 ovvero l'unico che "sulla carta" completamente giallo e che non dovrebbe presentare disegni geometrici sulla fiancata in quanto preposto a ricevere le pellicolature pubblicitarie, poi applicate però anche ad altre elettromotrici della serie!. Le indicazioni sono molto chiare: i servizi TT e linea 3 effettuano capolinea sull'anello più vicino al fabbricato RFF, la linea 1 invece sull'anello interno per così dire, complice anche il fatto che le linee 3 e TT formalmente forniscono lo stesso servizio, stesse fermate garantendo una corsa ogni 14/16 minuti nel tratto in comune tra la Gare Centrale e Lutterbach.

TT27-leclerc-de gaulle-gare-mulhouse-profilo
I convogli Siemens Avanto serie TT anche se abbastanza in maniera nascosta, sulla fiancata presentano anch'essi forme geometriche (quadrati oppure rettangoli oppure cerchi..) mentre decisamente si nota di più la presenza di una delle due casse di estremità dotate di una fascia colorata formata da diversi colori e dalla presentazione del percorso della linea TT in formato lineare con tutte le fermate. La posizione di tale cassa colorata non sembra essere rilevante, talvolta la incontriamo disposta per prima in direzione di Thann, talvolta per ultima, logica conseguenza anche del fatto che, essendo il capolinea alla Gare Centrale ad anello, diventa dunque abbastanza scontato veder passare un convoglio da Thann con la fascia colorata in testa latoMulhousepoi poi ritrovarla in testa anche verso Thann non avendo invertito la marcia alla Gare Centrale.
TT27-musee-mulhouse
E' interessante ricordare che proprio l'elettromotrice TT27 risulta essere l'ultima ad esser stata consegnata aMulhouse, tanto che risulta essere l'unica consegnata a Gennaio 2011, la incontriamo alla fermata Musees in direzione del centro città dopo aver appena incrociato un Citadis diretto a Lutterbach come linea 3 (si intuisce a sinistra). E' interessante ricordare due aspetti dei convogli Siemens Avanto: il primo è che pur essendo Siemens sono stati realizzati presso lo stabilimento Lohr Industries alle porte di Strasburgo (dunque su suolo nazionale francese probabilmente per superare qualche gabola protezionista francese...) e la seconda riguarda invece la recente notizia che SNCF sembra aver messo in vendita tutti o una parte dei convogli gemelli circolanti a Parigi sulla linea T4 in quanto sostituiti o integrati dai più giovani Alstom Dualis. E non credoMulhousene voglia approfittare ma potrebbe essere interessante, anche se probabilmente già 12 convogli per il servizio TT attualmente offerto, risultano essere abbondanti, tanto che come abbiamo visto li abbiamo incontrati in servizio anche sulla linea 3.
nd-lutterbach-fermata-24-04-2022-vista1
La fermata di Lutterbach Gare vista guardando verso la periferia ovvero verso Thann: la banchina è disposta ad isola, a destra giungono dalle nostre spalle le vetture delle linee 3 e TT, la prima scarica i passeggeri, impegna l'incrocio e si sposta su un'asta di manovra senza occupare binari utili al servizio TT il quale invece prosegue diritto e dopo qualche decina di metri entra nella competenza RFF/SNCF di cui è osservabile la stazione di Lutterbach a destra con i binari B e C su cui corrono sia i servizi TER diretti a Kruth che i servizi più importanti della linea a doppio binario per Colmar, Selestat e Strasburgo, linea impegnata anche da servizi TGV. A sinistra il binario di carico passeggeri in direzione centro città, da notare come i due binari, pur essendo nettamente separati da una rete rispetto all'area RFF siano stati nominati in sequenza ai binari RFF ovvero "Voie D" verso fuori città e "Voie E" verso il centro città.
nd-musees-mulhouse-fermata-25-04-2022-vista1
Analoga visione della fermata Musees al servizio dei Musei Citè du Train SNCF ed Electropole, questa volta però volgiamo il nostro sguardo verso il centro città, dunque abbiamo a sinistra la sede ferroviaria RFF a doppio binario nettamente separata dai due binari di incrocio della fermata tranviaria, i quali tuttavia hanno ricevuto i nomi "Voie A" e Voie B" in perfetto stile ferroviario. A destra il binario non elettrificato risulta essere il raccordo tra il Museo Citè du Train SNCF e la rete RFF, binario che consente al Museo di essere sempre collegato alla rete ferroviaria nazionale e che per di più incrocia il binario tranviarioa valle di questa fermata,senza alcuna comunicazione diretta, quasi un'eresia in un paese come l'Italia ove si sarebbero spesi milioni di euro inutilmente per poi non utilizzare il raccordo oppure sarebbe stato semplicemente tagliato. Da notare un piccolo ma agevole marciapiede sul raccordo per il Museo, probabilmente previsto per essere utilizzato occasionalmente con qualche "corsetta interna al Museo", visto e considerato che la struttura museale è comodamente raggiungibile a piedi seppur in qualche minuto.
nd-zona nord-mertzau-lefebvre-dep solea-25-04-2022-vista1
Il deposito tranviario di Mertzau è un'area di interessanti dimensioni in cui SOLEA ricovera sia tram che autobus, dal punto di vista tranviario è costituito da due accessi, dalla nota area "a pettine scoperto" già intravista nelle precedenti immagini e da un capannone coperto con un solo binario passante, Inoltre, grazie ad una comunicazione tra i binari della linea 1 poco oltre, la struttura risulta essere collegata in entrambe le direzioni visto che un raccordo consente alle vetture di uscire in linea 1 anche in direzione del capolinea esterno di Chataignier. Esiste inoltre una fermata "fantasma" nota come "Parc des Espositions" (l'edificio bianco sullo sfondo) intuibile nell'immagine sull'anello esterno, posizionata poco fuori i cancelli aziendali anche se probabilmente poco o per nulla utilizzata, in primo piano l'uscita del deposito in direzione centro città. All'interno del capannone è presente una sagoma interessante e curiosa, dovrebbe e potrebbe essere lo stesso autobus storico Chausson che SOLEA utilizza come ufficio ambulante per il rinnovo abbonamenti, pubblicizzato periodicamente sul sito e pagina Facebook. Bisogna tener conto tuttavia che SOLEA (dunque Transdev, ricordiamolo) ha preservato e sta preservando veicoli della propria storia tra cui anche autobus relativamente recenti.

IL TRASPORTO MERCI TRANVIARIO - PARTE PRIMA
di Roberto Cambursano
Oggi si dà per scontato che il tram sia esclusivamente un mezzo di trasporto di persone: non si può tuttavia dimenticare che in passato era piuttosto diffuso anche il suo impiego nel trasporto delle merci in città. Attualmente a Torino questo compito è affidato totalmente ai veicoli su gomma, in massima parte alimentati a gasolio e solo in minima parte elettrici (e comunque anche i veicoli elettrici contribuiscono ad aumentare il volume di traffico); inoltre, i vari vettori (corrieri, aziende, privati, ecc.) operano in modo indipendente e non coordinato. Tutto questo contribuisce all’aumento della congestione del traffico e al peggioramento della qualità dell’aria. Alcune recenti esperienze attuate in città estere dimostrano che è possibile, laddove una rete tranviaria abbia i requisiti di base necessari, attivare servizi di trasporto merci in chiave moderna che risultino ambientalmente ed economicamente sostenibili. Questi requisiti sono: la capillarità della rete tranviaria sul territorio, l’interconnessione tra le varie linee, la presenza di binari di servizio e raccordi, la possibilità di creare siti logistici attrezzati per il carico, scarico e distribuzione delle merci (ovvero i “centri di distribuzione urbana”), la possibilità di riutilizzare veicoli dismessi dal normale servizio di linea ma ancora efficienti e di attrezzarli per il trasporto delle merci con una spesa modesta. Poiché Torino è oggi una delle poche città al mondo a possedere tutti i predetti requisiti, questo articolo intende avanzare una proposta di sperimentazione di trasporto tranviario merci in città, attuabile in tempi relativamente brevi e a costi contenuti.
CENNI STORICI
Il concetto di tram deriva dall’evoluzione di un antico sistema di trasporto di materiali: fin dal XVIII secolo il termine “tramway” fu infatti usato per indicare il trasporto su rotaia all’interno delle miniere inglesi.
.
Trasporto di materiali su rotaia all'interno di una miniera in Inghilterra nel Settecento
Con l’affermarsi del tram come mezzo di trasporto di persone a partire dalla metà dell’Ottocento, si andarono diffondendo anche numerosi servizi speciali di trasporto merci. Fino a metà del XX Secolo è esistita un’ampia gamma di veicoli urbani appositamente modificati e dedicati al trasporto di materiali industriali e militari, di generi alimentari, di rifiuti, di posta e di pacchi all’interno delle città. Con la crisi del tram iniziata a metà del XX secolo, questo tipo di trasporto integrativo finì per scomparire totalmente, a vantaggio dei mezzi stradali su gomma.

Tram per trasporto latte a Filadelfia (USA). Archivio Free Library of Philadelphia, 1908.
Il trasporto merci su rotaia era un tempo molto rilevante: non bisogna dimenticare che, oltre alle estesissime reti tranviarie interurbane che effettuavano un servizio di trasporto merci con carri simili a quelli ferroviari, le reti tranviarie urbane erano collegate con quelle ferroviarie e in città esistevano numerosi binari di raccordo con stabilimenti, magazzini, caserme e mercati, con interscambio di carri merci fra treni e tram ove lo scartamento dei binari lo permetteva. Una categoria molto importante era il trasporto di generi alimentari, utilizzato per collegare stabilimenti, scali ferroviari e mercati; oltre al trasporto di cibi (in particolare di prodotti ortofrutticoli) e di bevande, veniva effettuato anche il trasporto di animali vivi.
A Torino funzionò, a partire dal 1935 per una ventina d’anni, un servizio di trasporto di frutta e verdura dai Mercati Generali di Via Giordano Bruno ai mercati rionali principali, effettuato dall’ATM con convogli di veicoli a due assi (motrice + rimorchio) dismessi dal servizio di linea.

Trasporto di prodotti ortofrutticoli in partenza dai Mercati Generali di Torino. Archivo GTT, 1940.
Un particolare tipo di merce è la posta: anche in questo caso il tram ha svolto in passato un’importante funzione per il recapito della corrispondenza e dei pacchi. Mentre sulle linee interurbane il servizio veniva svolto con modalità del tutto identiche a quelle ferroviarie (con compartimenti o carrozze dedicate), in ambito urbano e suburbano ci si poteva avvalere talvolta di tram in normale servizio passeggeri per trasportare la posta; in alcune città, tra cui Torino, la raccolta della corrispondenza avveniva tramite una cassetta delle lettere installata su una fiancata del veicolo, che veniva svuotata quando il tram transitava presso un punto strategico quale una stazione ferroviaria.

Tram postale negli U.S.A. Archivio National Postal Museum, 1898.
ESPERIENZE RECENTI NEL MONDO
Solo in tempi piuttosto recenti sono ricomparsi dei servizi di trasporto merci in tram, che possiamo sintetizzare nella tabella che segue. Altri sono allo studio.
Il primo, nonché il più rilevante caso moderno di tram-merci è stato il “Car.go Tram” della città tedesca di Dresda, dove dal 2001 al 2020 hanno circolato due convogli tranviari appositamente costruiti per il trasporto di componenti automobilistici dalla stazione ferroviaria di Fiedrichstadt allo stabilimento Volkswagen, utilizzando la normale rete tranviaria in pieno centro su un percorso di 4,5 km. I convogli, fabbricati dalla Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik utilizzando carrelli revisionati di vecchi tram Tatra, erano gestiti dall’azienda di trasporto pubblico locale DVB. Erano normalmente composti da due unità pilota alle estremità e da tre unità intermedie (tutti gli assi erano motori), per un totale di cinque casse, con una lunghezza totale di 59,4 m e con una portata di 60 t. Il parco veicoli era costituito da 5 unità pilota e da 7 unità intermedie. Il servizio, pur essendosi dimostrato estremamente soddisfacente, si è concluso a causa dei cambiamenti logistici derivanti dalle mutate esigenze produttive della fabbrica.

Il "CargoTram" di Dresda (Germania). Foto Kaffeeinstein-Lic.CC.BY-SA 2.0, 2005.

Il "City Cargo" di Amsterdam (Paesi Bassi). Immagine da www.researchgate.net
Riguardo al trasporto di pacchi, un caso di ampia portata è stato il “City Cargo” di Amsterdam nei Paesi Bassi. In questa città era stato lanciato nel 2007 un ambizioso progetto di trasporto tranviario di merci da un autoporto periferico, situato presso uno svincolo autostradale, a una piattaforma di interscambio situata a ridosso del centro cittadino: da qui i colli di varie dimensioni venivano caricati su furgoni elettrici che si occupavano della piccola distribuzione in città. La sperimentazione era partita con due tram articolati forniti dall’azienda di trasporto pubblico locale GVB e appositamente adattati; gli obbiettivi dichiarati dalla Società privata “City Cargo” che gestiva il servizio, erano di arrivare a disporre di una flotta di ben 50 tram merci articolati e di 600 furgoni elettrici, con varie piattaforme logistiche periferiche. Pur essendo i risultati promettenti, alla fine del 2008 la sperimentazione è stata però sospesa a causa del fallimento di City Cargo, in conseguenza di controversie insorte tra i partner, nella vana attesa dello stanziamento di opportuni finanziamenti pubblici per l’avviamento dell’esercizio a regime.
E’ da segnalare anche un’applicazione svoltasi a Vienna tra il 2005 e il 2007 (“GüterBim”), con carri-container trainati da vecchie motrici di linea appositamente convertite che trasportavano materiali e pezzi di ricambio fra uno scalo ferroviario e tre comprensori logistici della locale azienda di trasporto pubblico.
Una sperimentazione più recente, su piccola scala, è quella in corso in Germania a Schwerin dalla fine del 2022, denominata “Packetbahn”. Due tram articolati distolti dal servizio di linea percorrono un itinerario fisso, caricando pacchi e posta a tutte le fermate e scaricandoli in centro in tre punti di raccolta. Il servizio è gestito in collaborazione con le Poste tedesche e il corriere privato DHL.

Il "Packetbahn" a Schwerin (Germania). Brochure DHL-Deutsche Post, 2022.
Alcune altre applicazioni sono allo studio in giro per il mondo: fra di esse citiamo in Francia il “Tramfret” a Saint-Etienne (ispirato al modello di Amsterdam) e in Germania il “RegioKargo” a Karlsruhe, che prevede una forma di trasporto misto (pacchi e passeggeri) su scala interurbana avvalendosi dei normali tram di linea.

Progetto di trasformazione per il trasporto merci di un tram PCC di Saint-Etienne (Francia). Immagine da "Tramfret.com", 2017.
Una categoria a sé stante riguarda il trasporto dei rifiuti ed è una applicazione relativamente recente, oltre che affascinante in termini di sostenibilità ambientale. Il caso-scuola in questo campo è il “Cargo tram” svizzero di Zurigo, dove le aziende municipali VBZ (trasporti) e ERZ (igiene urbana) gestiscono congiuntamente fin dal 2003 un servizio di trasporto rifiuti ingombranti e di rifiuti elettronici tra 11 punti di raccolta (tutti situati presso capilinea o depositi tranviari) e l’inceneritore cittadino. Il servizio è molto apprezzato ed è utilizzato da quasi il 12 % della popolazione di Zurigo, riuscendo a smaltire poco più del 3% dei rifiuti della città. Una motrice tranviaria di vecchio tipo (la prima “standard svizzera” del 1940 adattata per questo scopo) traina due rimorchi su cui vengono caricati i container con i materiali da smaltire. In ognuna delle 11 località di raccolta il servizio è attivo due volte al mese e la sosta a disposizione dei cittadini dura dalle ore 15 alle ore 19; il convoglio si porta successivamente al capolinea Werdhölzli (linea 17), dove i contenitori sono caricati su camion che partono verso l’inceneritore e i siti di riciclaggio.
Il "Cargo-tram" di Zurigo (svizzera). Foto Martin Gut, 2021.
.....a seguire nella seconda parte: una proposta sostenibile per Torino
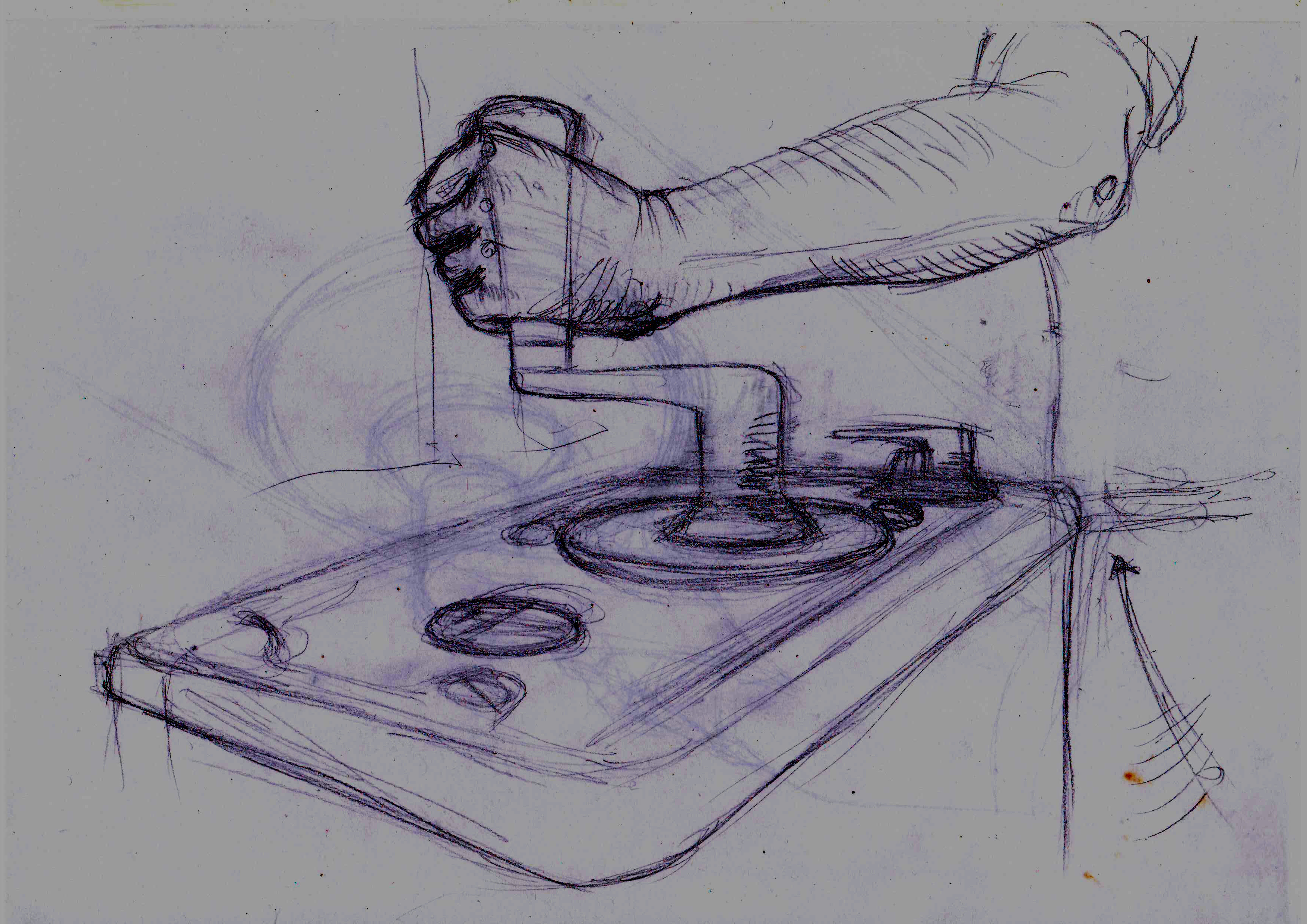
Un po’ tutti noi da piccoli, osservando il manovratore guidare il tram, ci siamo chiesti come funzionasse quella manetta che permette al tram di accelerare. Lo strumento utilizzato per l’accelerazione del tram ha diversi nomi: “controller”, “inseritore” o “combinatore di marcia”. È utilizzato sui tram più vecchi, quelli antecedenti all’epoca dell’elettronica ovvero i tram dotati di reostati. Funziona attraverso l'inserimento e il disinserimento di resistenze, combinando i circuiti di trazione “in serie” e “in parallelo”. In questo modo viene “aumentata” l’intensità di corrente che, arrivando ai motori, provoca l’aumento della velocità. Il controller “PN-15” è il più diffuso sulle vetture torinesi, dalla storica vettura 116 del 1911 ai tram arancioni serie 2800, con alcune piccole modifiche di cui parleremo in seguito.
Per impostare il senso di rotazione dei motori e di conseguenza la marcia avanti e/o la marcia indietro, c'è, visibile nella foto 1. La maniglia più piccola. Impostando la maniglia piccola, si abilita la rotazione di quella grande, la principale. (foto 1) La maniglia principale è caratterizzata da un numero di posizioni prestabilite, dette tacche. Inserendo la prima tacca, si chiude un circuito che invia tensione a una bobina dell'interruttore di linea (foto 2) che, eccitandosi, chiude a sua volta il circuito di trazione e permette al tram di muoversi. Avviato il tram è quindi possibile inserire le tacche "di mezzeria" arrivando fino all'ultima tacca, chiamata "fondo serie". Per aumentare ulteriormente la velocità si passa alle successive tacche fino ad arrivare al fondo parallelo, che utilizza la combinazione del circuito in parallelo. Alcuni motori alla massima potenza funzionano a 600 VCC, mentre altri motori necessitano di un voltaggio inferiore.

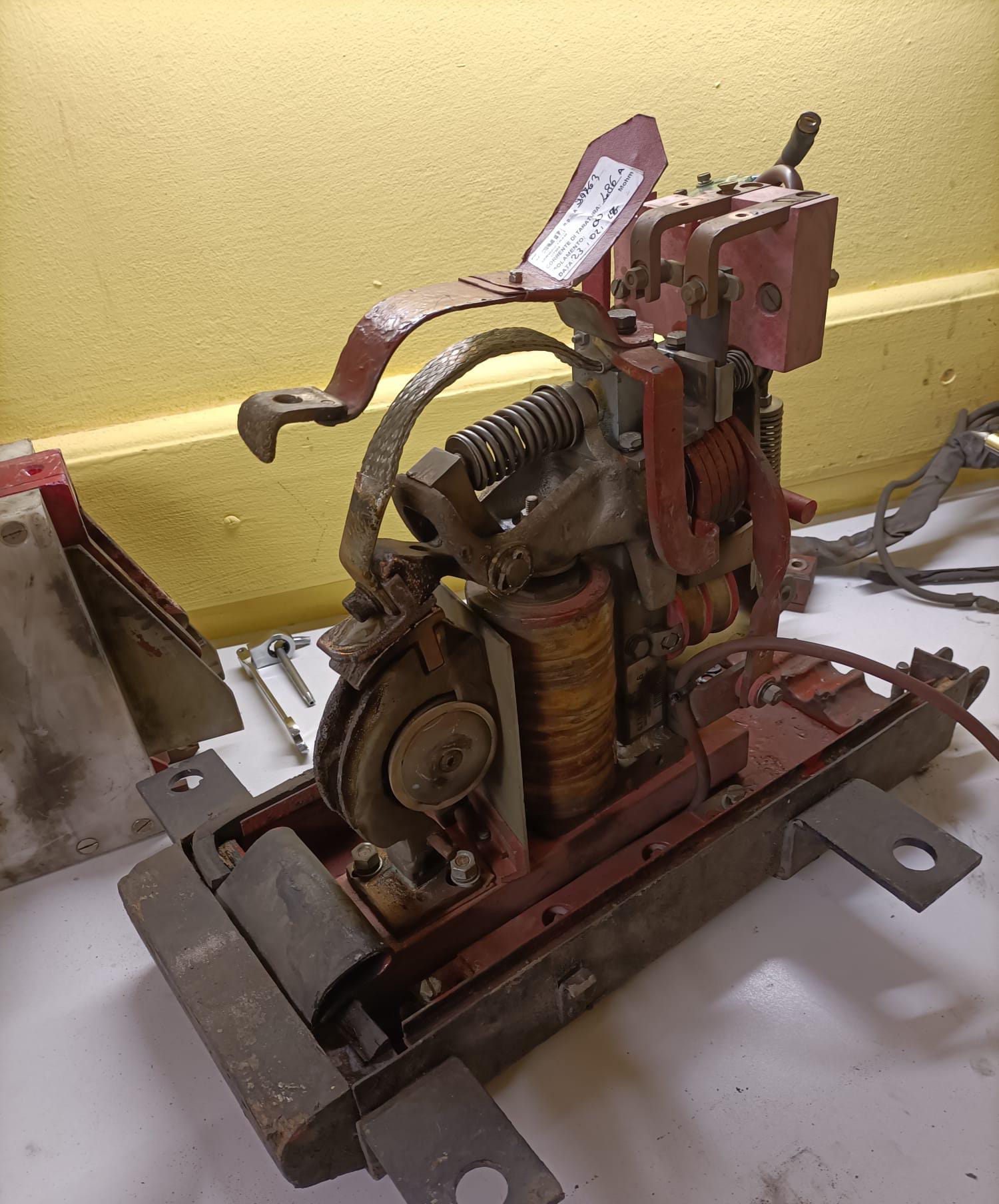
foto 1 foto 2
Attraverso il controller è possibile anche frenare, grazie all'ausilio del freno elettrico, che utilizza i motori come generatori e disperde l'energia prodotta, in calore attraverso le resistenze. In caso di anomalie è possibile anche decidere quali motori utilizzare. Sulle vetture storiche troveremo sul controller anche il freno elettrico. Come per la marcia, anch’esso è utilizzato in maniera graduale. L’ultima tacca serve per la frenatura elettrica di emergenza e va usata con attenzione poiché mette sotto sforzo resistenze, motori e il controller stesso. In questo modo tutte le resistenze saranno inserite e applicheranno sul tram il massimo freno elettrico possibile, così potente da poter fermare il tram anche senza l'ausilio del freno pneumatico. (foto 3)
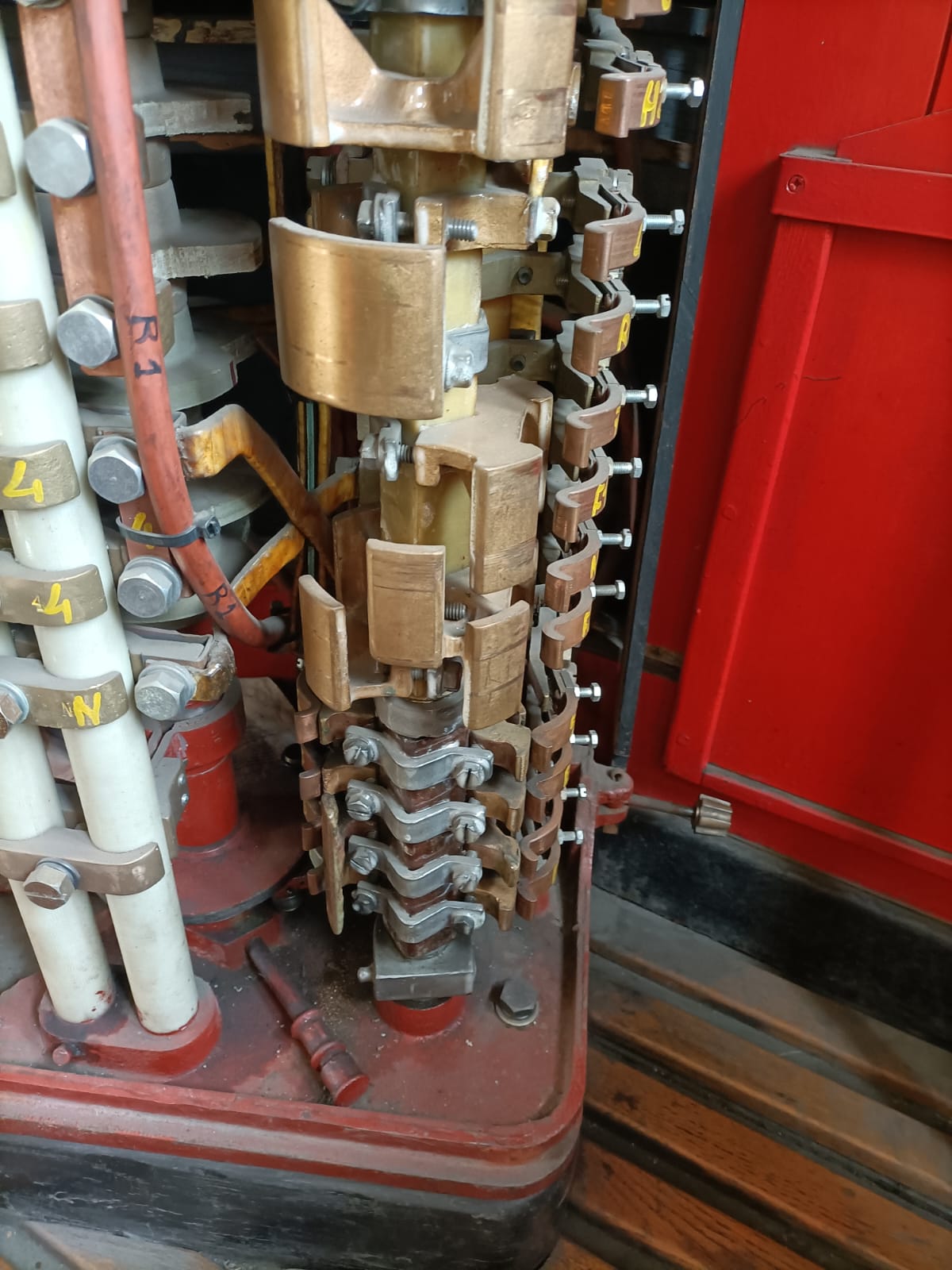
foto 3
Quando vennero creati i tram della serie 2800 dall’unione di due tram tipo 2100/2200 o 2500 il controller venne modificato da un lato per azionare 6 motori invece di 4, dall’altro per essere più comodo e facile da usare dai manovratori. (foto 4). Tra le modifiche più evidenti si ha quella del freno elettrico di servizio: tolto dall’inseritore e integrato direttamente nel freno pneumatico. Altre modifiche videro l’aggiunta della “palmola” e di un temporizzatore con solenoide sul freno elettrico di emergenza. Il temporizzatore con solenoide viene utilizzato in situazioni di frenata elettrica di emergenza e blocca meccanicamente la maniglia principale dell’inseritore per 25/30 secondi, in modo da non creare un arco voltaico. Anche lo scopo della palmola è quello di non creare archi voltaici ma agisce sul controller durante il normale utilizzo: toglie la corrente ai motori attraverso l'apertura dell’interruttore di linea, quando si riporta la manetta sulla tacca zero.
I tram sono molti diversi tra loro, ognuno ha il suo tipo di controller legato al tipo di resistenze e motori. Speriamo di avervi sufficientemente incuriosito e svelato il funzionamento di tutte le apparecchiature collegate a quella manetta che ricorda un vecchio macinacaffè funzionante.
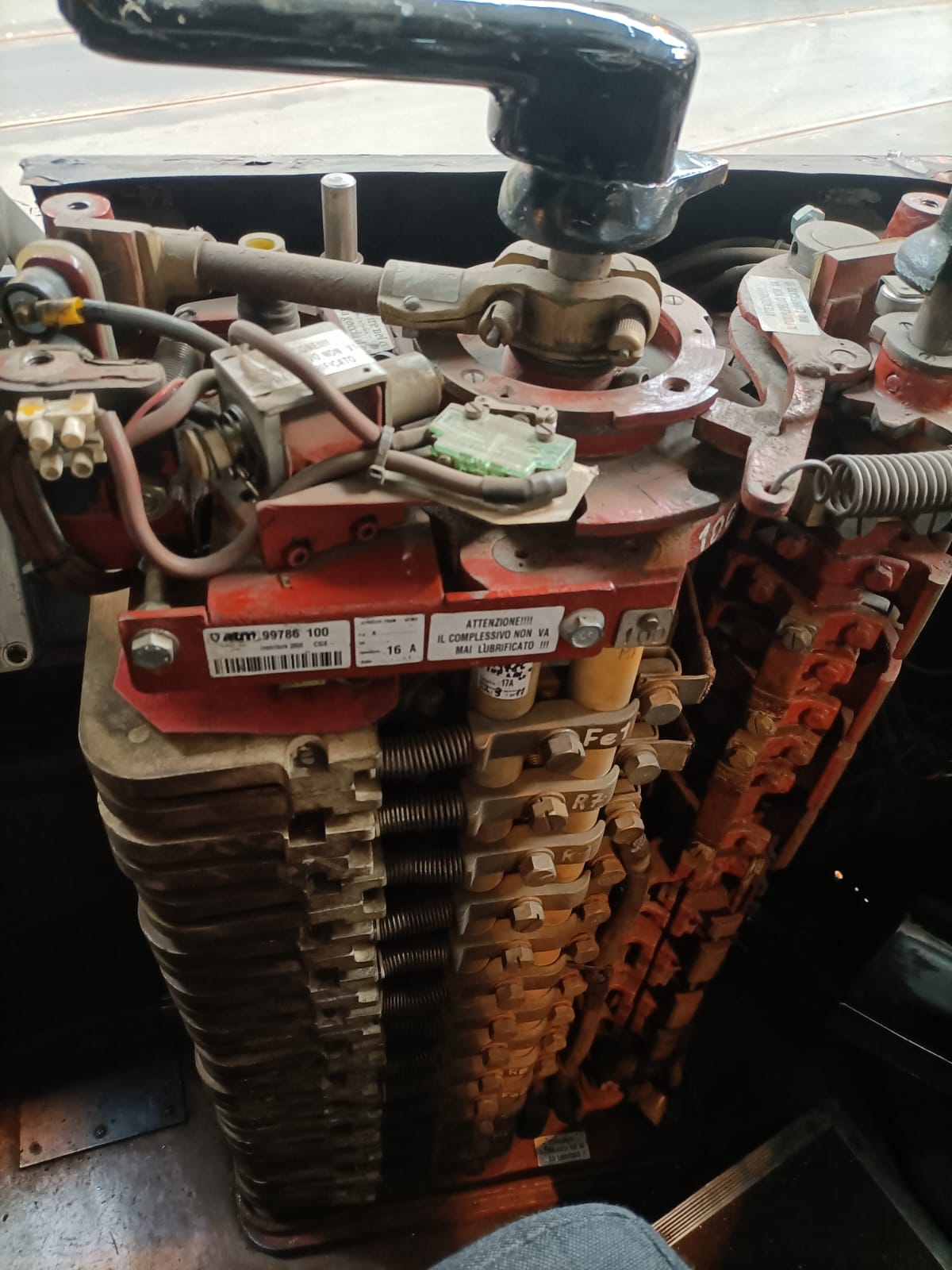
foto 4

GUIDARE IL TRAM 116
di Elio Bogiatto
…è fatica: si guida in piedi e rispetto ai tram moderni, i vari sistemi di frenatura, tra cui elettrico e pneumatico non sono integrati. Non avendo il carrello, ma il truck a due assi è particolarmente rigida, caratteristica che inevitabilmente si ripercuote sul confort di marcia. Ma...è un onore poterla "portare", “avere tra le mani” un pezzo di storia di Torino del 1911, ancor prima della Prima Guerra Mondiale!Il sentirla, percepire la vettura, dare "tacche" di corrente per raggiungere il fondo serie, per poi continuare sino al fondo parallelo…massima velocità ben 35 km/h ma con la sensazione del tipo "Frecciarossa scansati". Lasciarla poi andare per inerzia…
La 116 sembra quasi come una cosa viva (cit. Guccini).
Osservare la città immaginando come doveva essere nel 1911, percepire i cambi di temperatura. Oltre a guidare in piedi, si è esposti al clima esterno, agli effluvi cittadini.
È amore, passione per i tram e per le persone e queste son due cose indissolubili.
Prima di iniziare ogni giro, racconto sempre ai passeggeri che mi piace pensare che noi non trasportiamo solo persone ma "emozioni". Pensateci bene: ognuno di noi su un mezzo di trasporto oltre il fisico porta con sé quello che sta provando in quel momento: da questa prospettiva, la trovo una cosa potentissima ed emozionante. Ecco a noi volontari di ATTS, oltre ai tram ci appassionano le emozioni, le vostre emozioni. Ogni volta che usciamo con i nostri mezzi storici, lo facciamo con la speranza che ogni passeggero lasci un'emozione positiva…siamo un po’ "cacciatori di emozioni”!Dietro ogni evento c'è lavoro, tanto lavoro: il restauro, la manutenzione dei rotabili, la programmazione del percorso, la decisione su quali argomenti trattare durante il tragitto, il coinvolgimento dei volontari disponibili. Ognuno di noi fa tutto ciò gratuitamente, non solo per passione verso i tram ma anche per "spirito di servizio" verso la cittadinanza, i turisti e per riconoscenza a questa nostra meravigliosa Torino.
Un grazie va a tutti coloro che sui nostri tram hanno lasciato le proprie emozioni, a chi le lascerà in futuro e a tutti i volontari che periodicamente, a vario titolo, dedicano il loro tempo, le proprie competenze per rendere fruibile a tutti una parte così importante e "magica" della nostra storia.
Foto di Dino Buon Spirito





IL TRASPORTO MERCI TRANVIARIO - PARTE SECONDA
di Roberto Cambursano
UNA PROPOSTA SOSTENIBILE PER TORINO
Quella di Torino è una delle poche grandi reti tranviarie al mondo che possiedono ancora oggi tutte le caratteristiche ideali per la gestione di un servizio di trasporto merci su larga scala. I suoi punti di forza possono essere così riassunti:
1. capillarità sul territorio: i binari tranviari raggiungono quasi tutti i quartieri della città;
2. interconnessione tra le varie linee: i binari incrocianti sono generosamente raccordati da scambi che permettono l’effettuazione di una ampia varietà di itinerari differenti;
3. abbondanza di binari di servizio: sono stati mantenuti in efficienza numerosi binari non più utilizzati in regolare servizio commerciale, sia tratti che appartenevano a linee dismesse, sia binari di raddoppio che permettono la sosta di tram senza interferenze con il servizio di linea;
4. possibilità di organizzazione logistica di carico, scarico e distribuzione delle merci senza apportare nessuna modifica all’attuale giacitura dei binari;
5. possibilità di riutilizzo e trasformazione dei tram della serie 2800 in fase di alienazione.
La grande potenzialità della rete torinese permette dunque di formulare ipotesi pienamente sostenibili sotto diversi aspetti:
• tecnici: semplicità di realizzazione di impianti e di veicoli, con utilizzo di binari già esistenti (salvo eccezioni in un secondo tempo) e trasformazione di tram funzionanti;
• economici: bassi costi di realizzazione;
• ambientali: riduzione della circolazione di camion e furgoni in città e promozione del trasporto full-electric;
• gestionali: semplicità e bassi costi di gestione;
• sistemici: integrazione nel sistema complessivo della mobilità cittadina, senza conflitti col trasporto pubblico di persone e coi residenti.

Alla luce delle esperienze estere citate nella prima parte dell'articolo, si ipotizzano due tipi di servizio: il trasporto di pacchi e colli da un centro logistico unificato periferico verso la zona centrale della città e il trasporto di rifiuti speciali da tutti i quartieri della città verso lo stesso centro logistico. Per rendere la gestione più efficiente, i due servizi potrebbero essere espletati con gli stessi veicoli in fasce orarie differenti (ma comunque fuori dagli orari di punta, allo scopo di interferire il meno possibile con il normale servizio passeggeri).
“MERCINTRAM” potrebbe essere la denominazione commerciale del sistema nel suo complesso.
I VEICOLI
L’immissione in servizio attualmente in corso da parte di GTT dei 70 nuovi tram Hitachi della serie 8000 e la corrispondente progressiva alienazione dei tram della Serie 2800 rappresentano un’occasione ideale e irripetibile. I tram 2800 sono ormai certamente inadatti a un moderno servizio di trasporto passeggeri di qualità, sia per il pianale alto e inaccessibile ai disabili sia per le scarse prestazioni e il ridotto confort di marcia. Sono però dei veicoli robustissimi e ancora efficienti dal punto di vista elettro-meccanico: dell’originario parco di 102 vetture sono sopravvissute quelle in miglior stato e una ulteriore selezione finale potrebbe portare a individuare una ventina di esemplari da trasformare in dieci vetture bidirezionali, articolate a tre casse e riadattate per il trasporto merci. Al fine di permettere la loro circolazione sulla totalità della rete tranviaria e la movimentazione in sicurezza sui raccordi di servizio in entrambe le direzioni di marcia, la soluzione ideale è rappresentata da un veicolo bidirezionale, lungo 27 metri e articolato su tre casse e quattro carrelli (con interperno invariato e altezza del pavimento invariata rispetto alla Serie 2800 a due casse e tre carrelli). I costi della trasformazione sarebbero estremamente contenuti, in quanto verrebbero riutilizzati senza modifiche i carrelli, i pavimenti e i tetti delle casse, le articolazioni (giostre), le parti frontali e le cabine di guida, oltre alle componenti elettriche, meccaniche e pneumatiche. Le uniche modifiche di rilievo sarebbero quelle da apportare alle fiancate, da attrezzare con portelloni su entrambi i lati: il carico/scarico delle merci avverrebbe mediante movimentazione dei carichi dall’esterno allo stesso livello del pavimento, oltre che eventualmente mediante argani montati a bordo. Dal punto di vista gestionale, questi veicoli beneficerebbero della proverbiale affidabilità e facilità di manutenzione della Serie 2800, oltre a disporre di pezzi di ricambio a profusione ricavati dalla cannibalizzazione delle motrici rottamate che garantirebbero loro un prolungamento di vita di almeno altri trent’anni.

In sintesi, le caratteristiche dei veicoli risulterebbero le seguenti:
Numerazione: T481 - T490
Lunghezza fuori tutto: 26.920 mm
Interperno: 6.600 mm
Larghezza: 2.250 mm
Altezza del pavimento: 995 mm
Altezza. 3.216 mm
Scartamento: 1.445 mm
Raggio minimo curvatura: 13.760 mm
Posti di servizio: 5 (2 guidatori + 3)
Tara: 34 t circa
Massa Trasportabile max: 38 t circa
Massa complessiva: 72 t circa
Alimentazione: 600 Vcc
Velocità max. 40 Km/h
Motori n.: 8 Potenza continuativa: 8 x 24 = 192 kW
Rodiggio: Bo’ –Bo’ -Bo’ -Bo’
IL SERVIZIO DI TRASPORTO PACCHI E COLLI
Le applicazioni di riferimento sono il “City Cargo” di Amsterdam e il “Packetbahn” di Schwerin (vedi parte prima). La proposta consiste in un servizio di trasporto di pacchi e colli destinati ad aziende (negozi, uffici, imprese) e a privati situati all’interno della Z.T.L. fra un centro logistico esterno unificato di carico e una piattaforma di interscambio centrale: la distribuzione capillare finale all’interno della Z.T.L. sarebbe affidata a dei piccoli furgoni elettrici.
Il centro logistico esterno ottimale può essere realizzato presso l’impianto tranviario dell’Allianz Stadium, che è dotato di cinque lunghi binari ad anello con possibilità di movimentazione di un gran numero di mezzi tranviari e di ampi spazi liberi che potrebbero ospitare le attrezzature logistiche e i parcheggi per camion e furgoni. Questo impianto, che fu realizzato per i Campionati mondiali di calcio del 1990, è oggi sottoutilizzato e usato solo in occasione delle partite di calcio e di altri sporadici eventi; è collegato tramite un sottopasso tranviario lungo Corso Molise alla linea tranviaria 3 in Corso Toscana e inoltre il progetto della linea 12 prevede un secondo collegamento tranviario lungo Via Druento; infine, è comodamente accessibile dalla rete autostradale essendo situato in prossimità dello svincolo di Venaria Reale della tangenziale di Torino.
Anche per la piattaforma di interscambio centrale esiste una località ideale, situata nel cuore della Z.T.L: il tratto di Via Bertola compreso fra Via San Tommaso e Via XX Settembre, che è dotato di un binario tranviario (non percorso dal servizio di linea tranne che nei giorni festivi dalla linea storica 7) e ha una larghezza abbastanza grande da permettere la trasformazione. Sul binario potrebbero infatti sostare due tram-merci accodati e la piattaforma centrale potrebbe ospitare contemporaneamente sei furgoni (tre per ogni tram) che movimenterebbero le merci posizionandosi ortogonalmente ad essi, con i pianali allo stesso livello di quello dei tram. La sistemazione viabile evidenziata in figura implica la ricollocazione dei due capilinea bus di GTT attualmente posizionati in loco, che potrebbero essere spostati senza maggiori oneri di esercizio nel tratto di Via XX Settembre compreso fra Via Santa Teresa e Via Bertola.

Si propone un servizio tranviario da effettuarsi nei giorni feriali su un percorso fisso (vedi mappa) con partenze dallo Stadio ogni 30’ dalle 9,00 alle 15,00. Il tempo di ciclo (carico +andata +scarico +ritorno) sarebbe pari a 120’, rendendo necessario un impegno di base di 4 tram e di 4 corrispondenti turni di carico/guida (durata di ciascun turno: 6h30’). Le consegne da parte dei furgoni ai destinatari avverrebbero dalle 9,30 alle 15,30. Allo scopo di sincronizzarsi con la cadenza dei tram, per questo servizio il tempo di ciclo potrebbe essere stabilito in 60’ (un gruppo di 3 furgoni elettrici scarica un tram in 15’ e fa un giro di consegne in 45’), rendendo necessario un impegno di base di 6 furgoni e di 6 corrispondenti turni di carico/guida/scarico (durata di ciascun turno: 6h30’). I veicoli necessari per la gestione di base ammonterebbero a 5 tram e 7 furgoni, mentre l’organico sarebbe composto da 10 agenti. Il servizio è raddoppiabile senza problemi tecnici, mantenendo invariati orari e frequenze e prevedendo 8 tram che procedono a coppie e 12 furgoni: tale configurazione finale potrebbe essere adottata nelle sole giornate dal lunedì al venerdì, mentre l’impegno del sabato rimarrebbe limitato a 4 tram e 6 furgoni. Il parco veicoli necessaro per la gestione a pieno regime ammonterebbe a 10 tram e 14 furgoni, mentre l’organico di personale sarebbe composto da 20 agenti. Gli oggetti trasportabili sarebbero: posta, pacchi e colli con dimensione massima di 2 metri per ogni lato.
La sperimentazione iniziale potrebbe essere fatta con soli 2 tram e 3 furgoni in servizio, con passaggio alla gestione di base qualora l’esito fosse positivo e un eventuale successivo raddoppio del servizio nel caso in cui le richieste lo giustificassero. Un tale livello di servizio a regime potrebbe essere collegato all’adozione di drastici provvedimenti come il totale divieto di circolazione all’interno della Z.T.L. a particolari categorie di camion e furgoni.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
In questo caso, l’applicazione di riferimento è il “Cargo tram” di Zurigo (vedi parte prima). Si propone un servizio tranviario da effettuarsi dal lunedì al venerdì con percorsi e orari variabili (notturno oppure pomeridiano/serale), fra 30 punti di raccolta distribuiti omogeneamente sul territorio (non immediatamente attigui a case di abitazione per evitare problemi di rumore) e un punto unificato di conferimento (Allianz Stadium) dal quale avverrebbe il trasferimento finale alle discariche su autocarri. Gli articoli trasportati (in contenitori separati) potrebbero essere: a) radio-tv-elettronici- b) farmaci scaduti– c) pile e batterie esauste– d) legno, mobili e grandi imballaggi – e) altri rifiuti speciali a giudizio dell’AMIAT. Tutti i contenitori, che sarebbero posizionati a fianco dei tratti di binario individuati come punti di sosta dei tram-merci in appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale, resterebbero permanentemente a disposizione dei cittadini per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti speciali e verrebbero svuotati due volte alla settimana secondo un calendario prefissato. Il servizio potrebbe essere svolto dagli stessi veicoli tranviari utilizzati per il servizio di trasporto pacchi e colli, ma in una fascia oraria diversa: in continuità al precedente tra le 15,30 e le 22,00 oppure, in alternativa, di notte tra le 22,00 e le 4,30. Il carico dei contenitori pieni, come pure il loro scarico, potrebbe avvenire meccanicamente con il solo impiego di appositi argani montati a bordo dei tram, quindi senza necessità di realizzare impianti a terra. I punti di raccolta individuati (vedi mappa) coprono abbastanza uniformemente il territorio comunale e sono situati in prossimità di binari tranviari esistenti, non immediatamente a ridosso di abitazioni. Solo nell’ipotesi di servizio pomeridiano, allo scopo di non intralciare il servizio di linea, sarebbe necessario realizzare 3 nuovi brevi binari tronchi di servizio (Via Monginevro, Piazza Campanella e Corso Vercelli ex ferrovia TO-Ceres). Nessun problema si porrebbe invece per gli altri 27 punti e, nell’ipotesi di servizio notturno, per nessuno dei 30 punti. Si ipotizza un impegno giornaliero di due tram e di 2 corrispondenti turni di carico/guida/scarico (durata di ciascun turno: 7h15’): per ogni turno, ogni tram potrebbe effettuare due cicli completi aventi una durata media di 3 h00’ (andata +raccolta +ritorno +scarico), fermandosi a 3 punti di raccolta per ogni ciclo, con una potenzialità di 6 svuotamenti al giorno. In totale sarebbero quindi possibili, con due tram, 60 svuotamenti alla settimana.


La parata del 17° Trolley Festival si è spostata allo Stadio
di Alessio Pedretti
















Il deposito-scuderia
Tram a cavalli: la fine dell’impero
Fonti:
- Luigi Rocca, Viaggio sul Tramway da Torino a Moncalieri, 1876.
- Rivista ATM (Azienda Tranvie Municipali), La prima centrale… elettrica dei Tramways di Torino, Anno III, numero 1, Gennaio-Febbraio 1928.
- Museo Torino, Ex Stabilimento Diatto, https://www.museotorino.it/view/s/18952c2b4d444a19b1822bb1db6c57d0Museo Torino, pianta di Torino, 1870 circa, Biblioteca Civica Centrale, Cartografico 8/10.7
- Gazzetta Piemontese, Tramway alla Barriera di Milano, 30 dicembre 1871, pag.1 e 2.
- La Stampa – Gazzetta Piemontese, 12 aprile 1898, rubrica La Vita che si Vive
- Torino: reti e trasporti, a cura di Paola Sereno, Archivio Storico della Città di Torino, 2009.
- Tram di Torino, L’ultimo cavallo, https://www.tramditorino.it/
Didascalie:

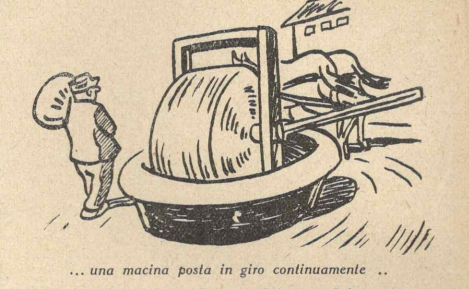
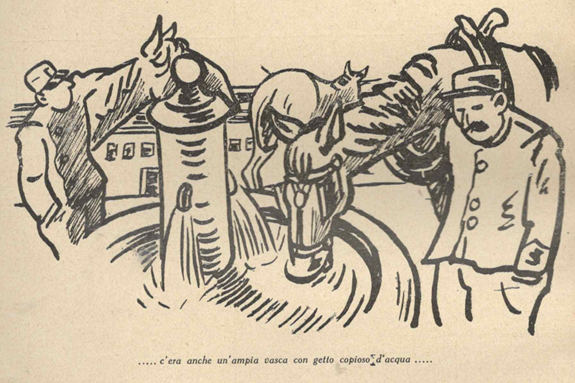
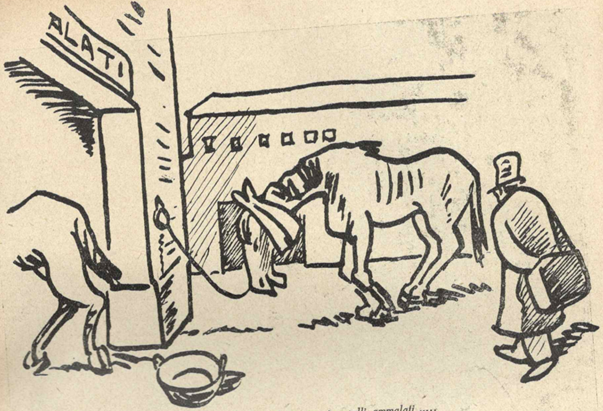

Nel 2024 ricorre il 140° anniversario della linea Sassi-Superga e l'occasione è ghiotta per rendere omaggio al suo rango di autentica linea storica con una volume che va ad inserirsi nella collana dei libri ATTS “storia e tecnica” espressamente dedicata ai mezzi e ai sistemi di trasporto di Torino. Grazie al materiale storico raccolto nel tempo, il nuovo libro si prospetta ricco di informazioni e la sua pubblicazione è prevista per maggio 2024, in tempo per l'evento del 25-26 maggio che celebrerà l'anniversario presso la stazione Sassi. Ma la storia non è fatta solo di grandi nomi e il racconto che seguirà nasce da piccoli dettagli scovati tra i polverosi faldoni, ripieni di carte bollate, disegni tecnici e bilanci aziendali.
Questa è la storia di Giuseppa, la guardiana del ponte levatoio.

I documenti sono pochissimi, le informazioni ivi contenute addirittura in parziale contraddizione (segno di errori commessi nelle trascrizioni) e la protagonista riveste letteralmente il ruolo di Cenerentola. Il più antico carteggio in cui la incontriamo è del 1898 ed è anche l'unico documento che la cita per intero: si tratta dell'elenco del personale di servizio al 1° gennaio 1898 e alla 14a posizione della lista troviamo ROCCO GIUSEPPA con la mansione di "guardiana del ponte". Il "ponte" fa riferimento al ponte levatoio presente in prossimità della stazione di monte, a Superga, che permetteva di attraversare la linea praticamente in corrispondenza dell'attuale passaggio a livello, costruito nel 1934 in sua sostituzione. Perché era necessario un simile manufatto? Perché era l'unico modo per scavalcare la fune bassa della funicolare. Qui di seguito il documento del 1898 con evidenziata la riga 14. Non è l'unica persona a chiamarsi Rocco, ne scorgiamo altre 3: Rocco Francesco (30, cantoniere), Rocco Angelo (43, aiuto macchinista) e Rocco Giovanni (28, fuochista). Rocco Giuseppa ha 29 anni ed è indicata come assunta in pianta stabile (a differenza di altri "avventizi", oggi diremmo "precari") dal 1884 (quindi dall'età di 15 anni... età comune al tempo). La sua mansione è "guardiana del ponte" e percepisce una paga giornaliera di 50 centesimi (15 Lire al mese), una delle più basse dell'azienda al pari del manovale avventizio. Da notare come il personale sia indicato come "borghese" o "ex militare", eccetto la guardiana del ponte che è semplicemente "donna".
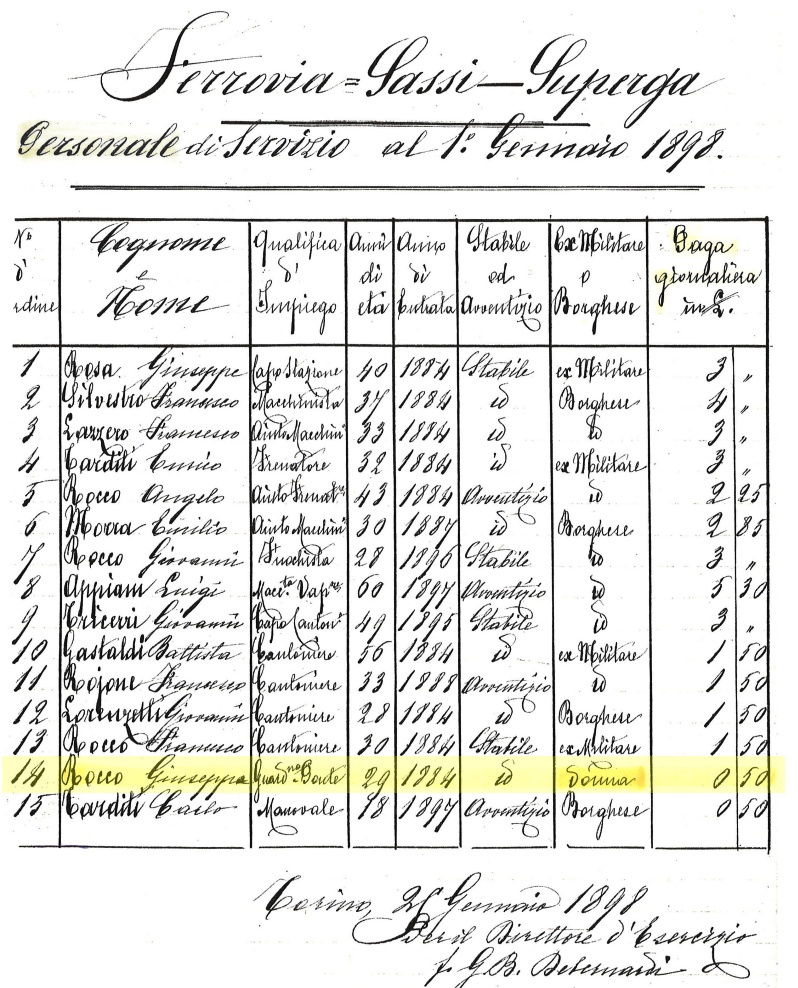
La curiosità di scoprire di più riguardo questa ragazza porta a scavare in modo più approfondito tra le carte giunte a noi. Il successivo documento è del 1900 e il suo nome è abbreviato in "Gius.": non fosse stato per il documento del 1898, nulla ci avrebbe potuto permettere di capire che era una donna. Si tratta di un ordine di servizio riguardante gli orari di lavoro, in accordo con il regio Decreto del 10 giugno 1900, del periodo invernale dal dicembre 1900 al maggio 1901. La mansione è guardiana a Superga e il suo orario prevede dalle ore 7 alle ore 18 con un'ora di pausa dalle 12 alle 13. L'orario invernale 1900/1901 prevedeva la prima corsa da Sassi in partenza alle ore 9.20 mentre l'ultima da Superga alle ore 17.55 con un totale di 4 coppie di convogli nell'arco della giornata.

Proseguiamo quindi nella ricerce a troviamo un ultimo documento datato 1902:
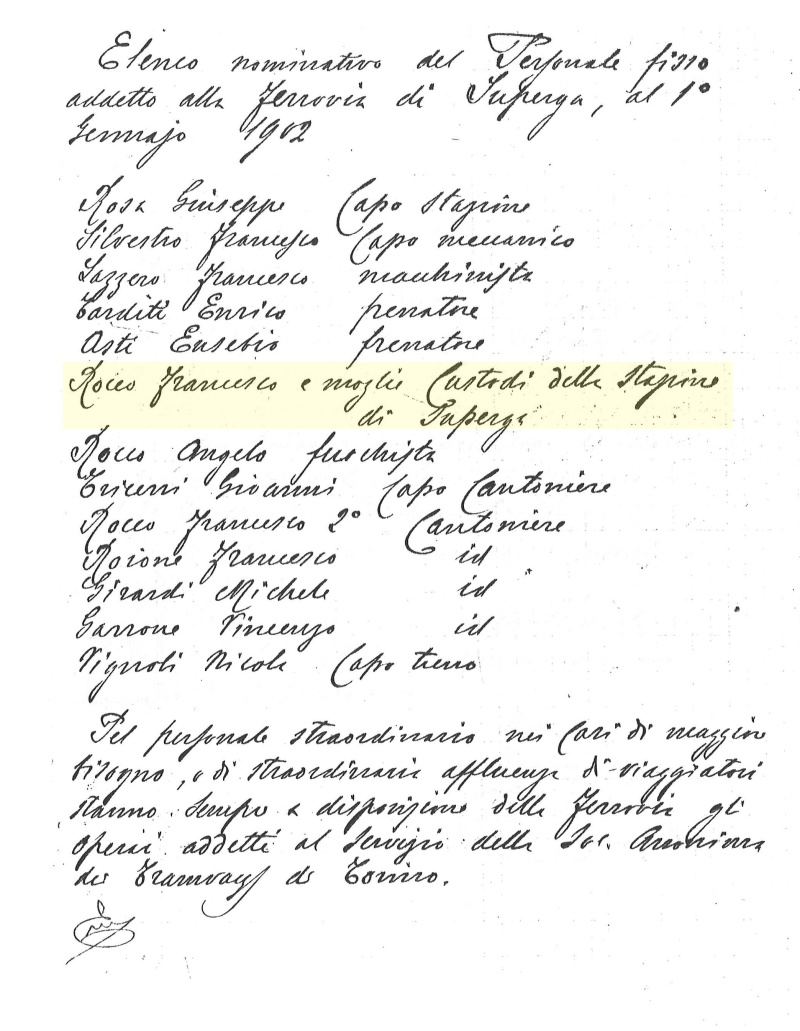
Qui appare ma il suo nome non è neppure citato, è indicata con la formula "e moglie". Qualcuno potrebbe oggi gridare alla mancanza di rispetto, alla scarsa importanza della donna, al patriarcato... tuttavia questa forma di citazione ci permette di delineare la figura di questa ragazza e del ruolo che ebbe all'interno dell'azienda per cui lavorava: era la moglie di un altro dipendente, Rocco Francesco, cantoniere di Superga. Il fatto di essere coniugata (l'articolo 131 del Codice Civile del Regno d'Italia ci ricorda: "Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza") ci permette di capire che "Rocco" non è il suo cognome. Dopo la visione del documento del 1898 una delle ipotesi prevedeva una parentela tra i quattro dipendenti Rocco, le cui età comprese tra 43 e 29 anni facevano immaginare un rapporto di fratellanza. Invece il documento del 1902 racconta una storia diversa: Giuseppa è moglie di Francesco. Riguardo Angelo e Giovanni possiamo solo ipotizzare una fratellanza con Francesco anche se l'ordine di servizio del 1901 riporta ben due Angelo (Angelo I e Angelo II, tipico modo del tempo di distinguere gli omonimi).
Dal documento del 1898 si leggeva che sia Francesco che Giuseppa erano stati assunti nel 1884, ma un documento del 1899 cita i tre Rocco (Angelo, Giovanni e Francesco) ma fornisce informazioni discordanti sia sull'età che sulla data di assunzione. Secondo questo foglio di 1 anno più vecchio del precedente, Francesco risulta assunto dal 1888 e con un'età di 35 anni. Giovanni ne avrebbe 29 e Angelo 44... se queste due età sono coerenti con il documento del 1898 dove hanno rispettivamente 28 e 43 anni, non si spiegano i 35 di Francesco. Anche le date di assuzione di Giovanni e Angelo sono concordi tra i due documenti ma quella di Francesco no. E di Giuseppa neppure l'ombra...
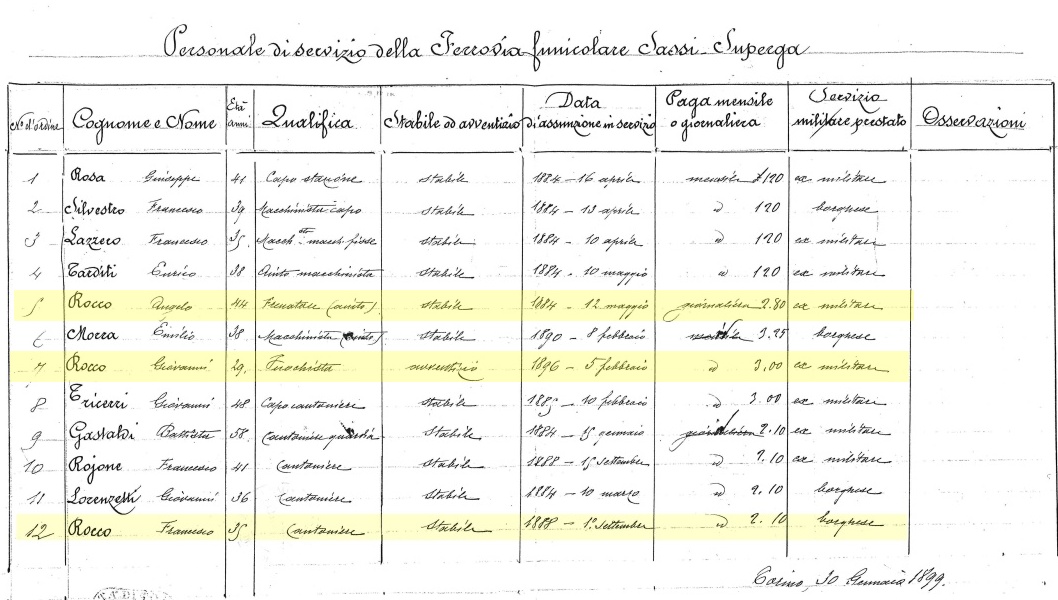
Tornando indietro nel tempo, cercando specificatamente qualcosa su Francesco, ci imbattiamo un un altro documento del 1894:
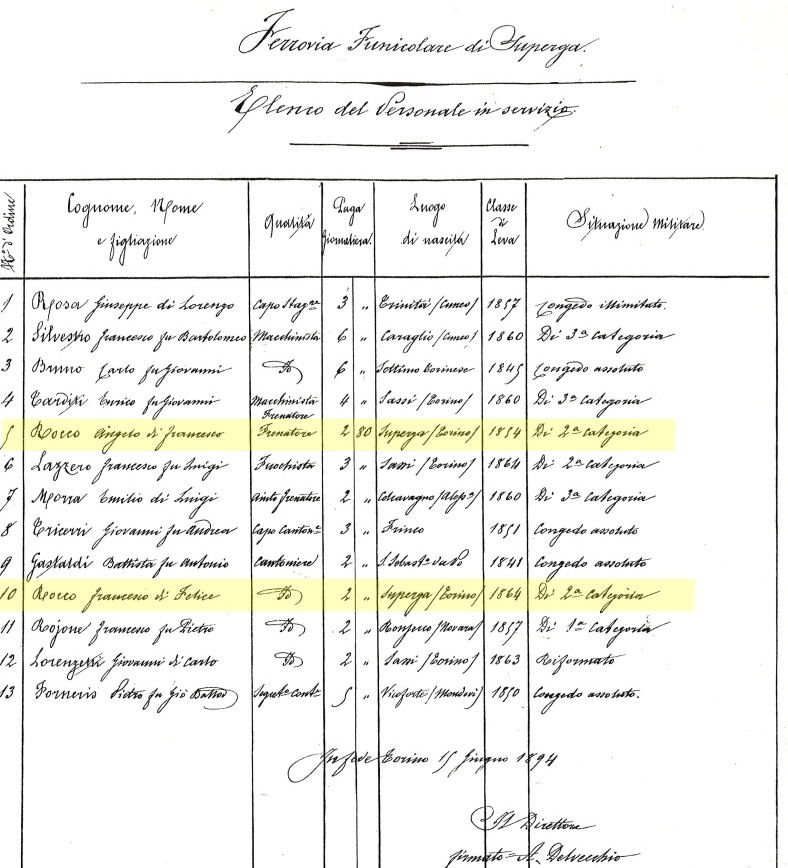
Rocco Francesco risulta classe 1864, quindi nel 1898 (documento iniziale) ha 34 anni mentre Angelo è classe 1854 e nel 1898, alla data del documento, potrebbe avere ancora 43 anni. Giovanni invece non è presente in elenco perché assunto solo nel 1896. Anche qui di Giuseppa neppure ombra... Tuttavia il documento del 1898 ha mostrato un errore e nulla può escludere che ve ne siano altri.
L'elenco del 1894 aiuta a comprendere che Francesco e Angelo non sono fratelli: il primo è figlio di Felice mentre il secondo di un altro Francesco.
Purtroppo non abbiamo trovato null'altro su Giuseppa. Non sapremo mai il suo cognome originario salvo che qualche erede, leggendo questo articolo, possa riconoscere in lei una sua prozia o trisavola e con qualche ricordo di famiglia ci possa aiutare a dare un volto alla prima (e forse una delle pochissime) donna della funicolare.
Immagini

Maggio del 1916. l’Italia era entrata in guerra da circa un anno. A Torino i quotidiani annunciavano la stagione lirica al Teatro Torinese mentre Il bagno di Venere, un’operetta in scena al Politeama Chiarelli, riscuoteva un discreto successo. Intanto, l’Officina Metallurgica Elettrica di via Vanchiglia 22 cercava calibristi, aggiustatori, tornitori e limatori “ben retribuiti” e la ditta Michele Franco presentava fallimento e offriva in vendita perle e brillanti presso lo studio del curatore in via Perrone,5. I quotidiani torinesi annunciavano i funerali di Clara Rodellono Vedova Salvagno per i quali non sarebbero state inviate partecipazioni personali e nemmeno sarebbero stati accettati dei fiori. Sempre in quei giorni, il pregiudicato Pietro Sconfienza, già condannato in contumacia a cinque anni di reclusione più tre di vigilanza sociale dopo il furto al Calzaturificio Italiano, fu finalmente intercettato dagli agenti della Squadra Mobile al n. 35 di corso Tortona.
In questo contesto così movimentato, a fatica, si scorge un piccolo articolo tra le pagine ingiallite dei giornali della Torino di allora. L’articolo racconta di un esperimento… quello delle donne-fattorino. «La Direzione della Belga-Torinese ha voluto per la prima iniziare la prova e ieri mattina -riporta il quotidiano La Stampa-, coloro che percorsero la linea dei Viali ebbero la sorpresa di trovare su qualche vettura le donne-fattorino. L’innovazione è veramente simpatica ed ha trovato il più cordiale consenso del pubblico».
L’entrata in scena
Dall’inizio della Grande Guerra un gran numero di tranvieri dell’Azienda Municipale e della Società Belga-Torinese era già stato chiamato alle armi perciò le aziende tranviarie decisero di reclutare dei giovani ragazzi per svolgere le mansioni di fattorino. In quanto minorenni, non vi era su di essi l’obbligo di leva. Tuttavia, verso il 1916 la chiamata di nuve classi fece sì che un gran numero di giovani fattorini venissero sottratti al servizio tranviario. Gran parte di quelli rimasti assunsero la mansioni di conduttore creando un notevole vuoto tra i fattorini: vi erano, quindi, numerosi posti ancora da ricoprire all’interno delle aziende tranviarie torinesi. Ed ecco l’entrata in scena delle donne! Per quanto Torino fosse stata la prima città a contare con un servizio tranviario a cavalli, in fatto di donne si decise a tentare una simile innovazione solo dopo gli ottimi risultati ottenuti in altre città italiane, quali Roma, Napoli, Firenze e Brescia.
Le tranviere di Torino iniziarono il loro servizio nelle linee dell'azienda Belga-Torinese il giorno 16 maggio 1916. Si trattava di un gruppo di circa venti donne, quasi tutte mogli o congiunte di tranvieri richiamati sotto le armi. Percepivano la stessa paga dei colleghi maschi: L. 3,25 al giorno. Inoltre, quelle che avevano il marito al fronte, mantenevano il sussidio concesso in parte dallo stato nazionale, in parte dal municipio.La loro divisa consisteva in una lunga blouse-spolverino di tela grigio scura e indossavano un cappello floscio di tela azzurra sui capelli regolarmente legati, come imponeva la moda dell’epoca. Portavano anche un distintivo di metallo bianco sulla sinistra del cappello che veniva anche ripetuto sul bavero della blouse. Avevano inoltre un portamonete di pelle e dai loro colli pendeva un fischietto che avrebbe recato, nei mesi successivi, non poche lamentele da parte dei passeggeri. Qualche tempo dopo, questa divisa fu copiata dalle donne-spazzino (anch’esse una novità nella Torino di allora) che cambiarono il cappello azzurro per uno di paglia e sostituirono portamonete e fischietto con scopa e pattumiera. Queste prime lavoratrici tranviarie furono istruite dai fattorini anziani. Erano particolarmente addette alla distribuzione dei biglietti nei rimorchi, così che non dovessero scendere ai crocevia. Dai quotidiani di allora, si apprende che il pubblico vide con grande compiacimento queste donne-tranviere, le quali dimostravano un grande senso pratico della vita, non del tutto scontato nella comunità femminile di allora.
«Questo primo esperimento tentato sulla linea dei Viali della Belga-Torinese darà senza dubbio un eccellente risultato -presagivano i giornali- e, poiché le domande sono numerosissime, vedremo presto, anche sulla rete dell’Azienda Municipale, un largo aiuolo di donne tranviere. Come si vede la guerra ha segnato una prima vittoria pratica per il femminismo».
In seguito a quel primo esperimento sulle linee della S.B.T. (Società Belga Torinese), la mattina del 22 maggio si videro le donne-fattorino anche a bordo dei tram dell’Azienda Municipale, nello specifico su quella del Cavalcavia. Anche in questo caso l’esperimento riuscì egregiamente. Da quel momento, molte donne tranviere furono presto assunte in servizio. Intanto a Roma, la notte del 28 di quello stesso mese veniva autorizzata dal Ministero del LL. PP. (Ministero dei Lavori Pubblici) «l’utilizzazione delle donne nel servizio tranviario urbano anche in qualità di conducenti». L’assunzione in servizio era, naturalmente, subordinata all’accertamento delle capacità tecniche e fisiche delle candidate.Finalmente le donne approdarono sui tram, in una veste diversa da quella di passeggere, e la Guerra fece che vi rimanessero ancora per un po’. Ma la corsa non fu affatto priva da ostacoli.
La corsa ad ostacoli
Appena assunte, queste prime donnette, che fino a qualche mese prima restavano a casa a cercare l’acqua e la legna, a rattoppare i vestiti e a fare da mangiare, dovettero fronteggiare altre afflizioni; spesso assai diverse da quelle della vita domestica. Si videro catapultate in un nuovo mondo: quello del lavoro, dei diritti e delle tutele mancate, delle agitazioni, delle manifestazioni e delle innumerevoli proteste dei lavoratori. Per quanto le donne-fattorino fossero retribuite alla pari dei colleghi maschi, solo due mesi dopo la loro assunzione, il Municipio ebbe l’intenzione di sopprimere il sussidio che esse percepivano. Questo sussidio, veniva corrisposto a quelle donne che avevano i mariti al fronte ed era in parte erogato dal governo centrale e in parte da quello municipale. Perciò nel luglio del 1916 il Sindacato dei Tranvieri si riunì nei locali della Camera del Lavoro e fu votata il seguente ordine del giorno: “Le tramviere mogli di richiamati, assistite dalla solidarietà dei propri compagni di lavoro, mentre affermano di essersi sobbarcate il duro lavoro di fattorine tramviarie solo perché lo scarso sussidio governativo unito a quello municipale non bastava ai bisogni dell’esistenza, protestano contro il minacciato, ingiustificato provvedimento di sospensione di quel sussidio municipale che è pur sempre loro necessario, provvedimento che sarebbe una ben cattiva ricompensa di quello spirito di sacrificio per cui si sono sobbarcate e, si sobbarcano alla nuova fatica”.
A questo si aggiunse l’agitazione tra gli operai delle officine tranviarie dell'Azienda Municipale per via di un mancato aumento di salario che era stato promesso dall’amministrazione e mai concesso. Di conseguenza, il personale delle officine proclamò uno sciopero il quale sarebbe passato probabilmente inosservato alla cittadinanza, se non fosse sopraggiunta la dichiarazione di sciopero -per solidarietà- del personale tranviario della società Belga-Torinese. Anche loro erano scontenti per gli stessi motivi dei colleghi dell’Azienda Municipale. La sera del 23 agosto, un esercito de tranvieri, manovratori, fattorini e fattorine si diedero appuntamento negli uffici della Camera del Lavoro, al numero 12 del Corso Siccardi (che corrisponde all’attuale Corso Galileo Ferraris, 2). Nel fabbricato dell’ex-teatro Politeama che era stato trasformato alcuni anni prima dall’ingegnere Riccardo Brayda, i lavoratori tranviari si radunarono per decidere il da farsi. Quella fu probabilmente la prima assemblea a contare con la presenza delle donne-fattorino.

Nella prima forto via Meucci angolo Corso Siccardi, nella seconda il palazzo di Corso Siccardi. I binari che girano, arrivano da via Meucci. In fondo a sinistra Piazza Arbarello. (Archivio storico Gtt)
Finalmente alla guida
Intanto la Grande Guerra, come un marchingegno fuori controllo, continuava ad inghiottire le vite dei lavoratori italiani. E sembrava che non sarebbe mai finita. Nuove classi furoni chiamate alle armi creando più vuoti nella mano d’opera maschile che, purtroppo l’esperimento delle donne-fattorino, tramutato oramai in quotidianità, non riusciva a colmare. La Società Belga, nel luglio del 1917, emulando ancora una volta quanto sperimentato in altre città italiane, decise di adoperare la mano d’opera femminile anche per guidare le motrici dei tram metropolitani.
Come accadde un anno prima con le donne-fattorino, anche questa volta, le donne alla guida dei tram furono accolte con il consenso della cittadinanza. Tuttavia, l’innovazione non fu facile da mandar giù per il personale maschile della società. I lavoratori tranviari si mostrarono da subito preoccupati della cattiva prova che l’elemento femminile, a loro parere, avrebbe potuto fare in questo speciale servizio. «I tranvieri -riassume La Stampa- si sono espressi in senso molto antifemminista: affermano nella donna minore capacità, minore resistenza e soprattutto deficienza di cognizioni tecniche per servirsi di un materiale vecchio e molte volte avariato».
La Direzione della Società Belga-Torinese rispose a questo severo giudizio sottolineando che «l’elemento femminile dà tanto affidamento quanto può darne un personale maschile raccogliticcio, avventizio, che in questi momenti non può essere reclutato che con criteri molto larghi e…misericordiosi». Un modo pacato ed elegante per dire che, viste le circostanze, mettere le donne alla guida dei tram era l’ultimo dei problemi.
Il primo tram guidato da una donna fece la sua prima corsa il mercoledì 31 luglio 1917 dando luogo a una clamorosa scenata accaduta nei pressi della Barriera di Nizza. Una quindicina di donne, mogli e parenti di tranvieri, cominciò a radunarsi intorno alla vettura attraendo intorno a sé una cinquantina di curiosi che impediva il normale transito della vettura. Da lì a poco, la situazione andò fuori controllo: «ad un certo punto -raccontano i quotidiani- la moglie di un tranviere una certa Crippi, raccattò da terra una manata di fango (anzi peggio) e la gettò contro la malcapitata guidatrice lordando anche alcuni passeggieri». Vi fu bisogno dell’intervento delle guardie municipali per far si che il tram potesse proseguire la marcia e la signora Crippi fu, naturalmente, tratta in arresto. Mentre la detenuta era trasferita dal Commissariato di via Nizza fino alla Questura Centrale (allora Piazza San Carlo all’angolo con via Giolitti) vi fu una nuova dimostrazione di simpatizzanti ma per fortuna la cosa non ebbe seguito malgrado gli animi fossero ancora esasperati.
Proprio in quell’estate, i problemi economici e le difficili condizioni di lavoro che affliggevano la maggior parte dei proletari torinesi sfociarono in una serie di rivolte più conosciute come I moti di agosto oppure I moti di Torino. Difatti il mancato rifornimento di farina -malgrado si fosse trattato di un ritardo di alcune ore-diede luogo a una serie di manifestazioni e proteste tramutate in dimostrazioni antimilitaristi contro la guerra e che si protrassero per un’intera settimana. Dal 22 di agosto, vi furono degli scontri violenti in vari punti della città: Borgo San Paolo, Barriera di Nizza e Barriera di Milano, quartiere in cui vi era una forte presenza di anarchici. I rivoltosi si fronteggiarono con le forze di polizia e dell'esercito. Le rotaie dei tram vennero sradicate, furono erette barricate e molti negozi vennero saccheggiati. Si dovette attendere il martedì per vedere sedare le rivolte e sentire alle autorità confermare che «l'ordine regnava a Torino». Il bilancio finale fu di circa sessanta morti, duecento feriti e un migliaio di arrestati.
Tra i mesi di giugno ed agosto del 1918 ebbe luogo, al Tribunale Militare di Torino, un processo che vide imputati dodici dirigenti socialisti e un anarchico. Il Prefetto Verdinois, testimone a questo processo spiegò che il 22 agosto 1917 «i tumulti all’inizio furono diretti specialmente controi trams perché vi era da tempo una irreducibile agitazione contro le donne manovratrici tramviere». Quando seppe che anche gli operai delle ferrovie si sarebbero aggregati allo sciopero, il Prefetto non ebbe più alcun dubbio della gravità della situazione.
Una giovane operaia ricordava un episodio che ne dà conto del protagonismo delle donne durante l’insurrezione: «...un migliaio di donne sbucarono dai portoni di tutte le case, ruppero i cordoni e tagliarono la strada ai carri blindati. Questi si fermarono un momento. Ma l’ordine era andare ad ogni costo, azionando anche le mitragliatrici. I carri si misero in moto: allora le donne si slanciarono, disarmate, all’assalto, si aggrapparono alle pesanti ruote, tentarono di arrampicarsi alle mitragliatrici, supplicando i soldati di buttare le armi. I soldati non spararono, i loro volti erano rigati di sudore e lacrime. Le tanks avanzavano lentamente. Le donne non le abbandonavano. Le tanks dovettero arrestarsi».
Impossibile parlare dei Moti di Agosto senza fare il nome di Maria Giudice, in più occasioni aveva preso le difese delle lavoratrici tranviarie quando ancora destavano stupore e scomodità tra i lavoratori, nei primi mesi del 1916. Anche durante I Moti di Torino, sostenne l’assunzione di donne in qualità di manovratrici adducendo che ciò consentiva che uomini validi andassero negli stabilimenti ausiliari ad aumentare la produzione bellica, oppure andassero al fronte.
Fonti
- Il primo esperimento delle donne tranviere, La Stampa, 17 maggio 1916
- Le donne tranviere, La Stampa, 22 maggio 1916
- Le donne conducenti dei tramway, La Stampa, 29 maggio 1916
- Le “spazzine”, La Stampa, 4 luglio 1916
- Un ordine del giorno delle tranviere, La Stampa, 27 luglio 1916
- Lo sciopero dei tranvieri dell’Azienda Municipale, La Stampa, 23 agosto 1916
- Il borsaiuolo delle fattorine tramviarie, La Stampa, 14 gennaio 1917
- Una tranviera sotto una vettura rimorchio, La Stampa, 5 gennaio 1917
- La morte della tranviera caduta sotto una vettura, Ultime di Cronaca, La Stampa, 6 gennaio 1917
- Il portamonete della fattorina, La Stampa, 8 aprile 1917
- Un inconveniente tranviario, La Stampa, 15 giugno 1917
- Una scena contro una tranviera: un arresto, La Stampa, 31 luglio 1917
- Pubblicazioni di matrimonio, La Stampa, 5 maggio 1918
- Tramviera accoltellata da una donna, La Stampa, 22 maggio 1918
- L’on. Orlando inaugura un posto di ristoro per le tranviere, La Stampa, 11 giugno 1918
- Bimbo schiacciato dal tram, La Stampa, 15 giugno 1918
- All’Ospedale, La Stampa, 18 luglio 1918
- Il processo per i fatti d’agosto, La Stampa, 18 e 19 luglio 1918
- M.P., Sciopero delle Tramviere a Londra, La Stampa, 20 agosto 1918
- All’Ospedale, La Stampa, 6 dicembre 1918
- La caccia allo squartatore, La Stampa, 13 aprile 1919
- I funerali di Trossi, La Stampa, 13 aprile 1919
- Movimentata assemblea di postelegrafonici – La dibattuta questione del personale femminile, La Stampa, 4 luglio 1920
- Le competenze arretrate alle ex-tramviere, La Stampa, 17 novembre 1920
- Museo Torino www.museotorino.it
- Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna: La prima guerra mondiale, il dopoguerra, l'avvento del fascismo, Feltrinelli, Milano 1996.
- Chiara Devoti, Gli Spazi dei militari e l’urbanistica della città: 1815-1918
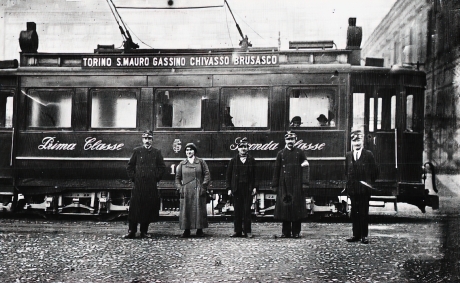
Il fischio del rimorchio
Gli inconvenienti ai quali le tranviere di Torino dovettero abituarsi furono tanti e molto variegati. Alcuni di essi persino divertenti. Vi fu un alterco a bordo di un tram nel quale una tranviera fu colpita con una bottiglia alla testa da parte di un passeggero andato in escandescenza. Da molto tempo giungevano alla redazione dei giornali diversi reclami dei cittadini contro gli acuti…sibili usati dai tranvieri e tranviere nelle vetture rimorchio. Si trattava di un fischietto portatile che veniva utilizzato dal personale adibito ai rimorchi per indicare la partenza ai manovratori. Persino una Commissione di medici specialisti si era costituita a Milano e aveva analizzato la situazione ed enumerato i danni che il fischio può produrre nei timpani dei passeggeri. Suggerivano inoltre la sostituzione del fischio con l’adozione di una speciale trombetta. A Torino invece, l’inconveniente persisteva e il lamento giungeva persino dagli operai delle fabbriche i quali, pure essendo avvezzi ai rumori dell’officina, non riuscivano a tollerare il rumore del fischietto delrimorchio il quale pare fosse particolarmente sibilante se il fischio usciva dalle labbra femminili. Ecco quanto scriveva un gruppo di operai della Fiat San Giorgio in una lettera pubblicata dal quotidiano La Stampa: «La preghiamo di voler pubblicare una viva protesta da parte di molti cittadini per far cessare oppure moderare gli acuti trilli che certe tramviere lanciano negli orecchi dei passeggeri. Se qualcuno osa pregarle di sporgersi fuori, oppure di non spolmonarsi a fischiare, si è mortificati dalla risposta». Sembra che uno di questi passeggeri osò richiamare l’attenzione della fattorina e questa rispose «Fischio quanto mi pare e piace!». E allora dalle parole si arriva ai fatti e cosí si è andati a finire con uno schiaffo e un calcio per il passeggero e una bottiglia in testa per la tranviera.
Certo che il torto non era sempre delle donne. Anche le fattorine del tram, queste brave donnette che si sobbarcavano al pesante lavoro che sembrava riservato solo agli uomini, erano spesso vittima di reati perpetrati proprio sul posto di lavoro. Come accadde alla fattorina Lina Barberis una sera del 1916, mentre era in servizio. Essendo vicina ad una vettura tramviaria, Lina si senti a frugare una tasca da una mano che non era la sua. Se ne accorse subito che le era stato sottratto il portafoglio che conteneva quattro lire. Riconobbe l’autore del furto fra la folla e lo rimproverò con tale durezza che il ladro -pur di scampare all’imbarazzo di vedersi scoperto- gli restituì il portafoglio. Alcune persone che presenziavano la scena, vedendo passare un soldato, lo chiamarono e gli raccontarono l’accaduto. Adamo Piccinini, venditore ambulante che vantava ben diciotto condanne, dovette rispondere davanti al tribunale per il suo diciannovesimo reato e fu condannato a un anno di reclusioneEpisodi del genere facevano parte della quotidianità di queste donne che spesso si recavano, oppure scrivevano alla redazione dei giornali per renderli noti. Maria Ferraris, fattorina dell’Azienda Municipale, che aveva perso sul posto di lavoro il portamonete che conteneva 30 lire insieme al suo orologio, si rivolse a un noto quotidiano torinese per chiedere a chi li avesse trovati di farli recapitare agli uffici dell’azienda. Rischi del mestiere a parte, sembra che il lavoro nelle società tranviarie durante la Prima Guerra abbia anche contribuito a quello che era il massimo traguardo delle donne di un tempo: il matrimonio. Così, tra un vasto numero di pubblicazioni di matrimonio di medici, meccanici, sarte e operai vi è anche quello di Giovanni Bocca che nel maggio del 1918 prese per moglie Luigia Melano, anche lei di professione tranviera.
L’Ospedale Maggiore
Nell’oggi Museo Regionale di Scienze Naturali (in via Cavour, 31) tra ritratti, busti e statue che tuttora adornano l’atrio e le scale, furono curate e assistite un numero importante di donne che lavoravano in entrambe le società tranviarie della città. Infatti, l’Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista fu un luogo altamente frequentato dalle lavoratrici tranviarie. Non mancavano di certo gli incidenti sul lavoro come accadde a Maria Rosetti, fattorina tranviaria di 28 anni che girando il trolley del tram in piazza Vittorio Emanuele fu colpita al naso dalla rotella dell’asta caduta accidentalmente. Maria fu subito portata al San Giovanni ricevendo una prognosi di qualche settimana. Vi erano però, anche altre tipologia di incidenti con protagoniste le tramviere torinesi di indole molto più curiosa. La fattorina Adelina Broca, ad esempio, che nel 1918 abitava in corso Valentino al numero 33, dovette essere ricoverata all’Ospedale Maggiore per ferite lacero contuse alla testa riportate durante una rissa con altre donne. L’episodio non ebbe particolari ripercussioni per Adelina, che aveva all’epoca 32 anni, in quanto le sue ferite, una volta medicate dal Dott. Volante, furono giudicate guaribili in otto giorni. E’ invece il caso della tranviera Luisa Costamagna, di Cherasco, che presenta una sfumatura alquanto particolare. Di solito sono le mogli tradite dai mariti che si vendicano della rivale, ma la vita ha molte stravaganze, e questa volta fu proprio il caso inverso. Fra la tranviera Luisa Costamagna e la signora Luigia Vigna -di Orbassano- esisteva una vecchia ruggine, per il fatto che la tranviera accusava l’altra donna di averle insidiata la pace coniugale, rubandole il marito. Quindi la Vigna non potendo più tollerare le accuse di essere l’amante del marito della Costamagna, andò a cercare la tranviera nella sua casa. Le due donne ebbero un acceso diverbio durante il quale la Vigna aggredì Costamagna con un coltello. La colpì ripetutamente procurandole diverse ferite da taglio alla testa, alla spalla sinistra, al petto e alle braccia in una lotta che fu tanto breve quanto violenta e sanguinosa. Alle grida della tranviera aggredita, accorsero i vicini che chiamarono gli agenti della Squadra Mobile. La signora Vigna fu tratta in arresto e condotta al carcere giudiziario. In quanto alla tranviera Luisa Costamagna, fu subito trasportata all’Ospedale Maggiore dove fu giudicata guaribile in una quindicina di giorni.

Via Cavour, davanti alla vecchia sede del Regio Politecnico, attuale Valdo Fusi. L’edificio chiaro in fondo è l’Ospedale San Giovanni Vecchio (foto Archivio privato Antonio Accattatis)
Tramviera accusata di omicidio
Nel 1919 gli animi dei torinesi furono scossi da una serie di ritrovamenti senza precedenti. Si trattava particolarmente di alcuni involti fatti con sacchi da cemento e gettati nella Dora -dal Ponte della strada di Circonvallazione- e nel canale della Pellerina. All’interno dei sacchi vi erano i resti del povero signor Pietro Trossi. Non essendoci nessun inidizio o movente che facesse chiarezza sull’accaduto, le autorità procedevano a tentoni in cerca della via buona per riuscire a svelare il mistero dell’assassinio. Una delle ipotesi era quella legata a un’atroce vendetta provocata da una regolare relazione d’amore. Il quadro pareva indicare che il Trossi, nonostante la sua età matura, «si compiacesse sovente di qualche avventura extra-coniugale». Perciò le autorità temevano che fosse stato sorpreso e avesse «pagato con la vita il capriccio di un’ora». In quel caso l’assassinio non sarebbe stato premeditato, ma occasionale ed il colpevole avrebbe poi squartato il cadevere per occulatare il delitto. Supportava questa idea il fatto che tra le carte di Pietro Tozzi erano stati trovati diversi indirizzi di donne tra cui quello di una fattorina tranviaria che fu subito rintracciata dalla polizia e portata in commissariato. Notevolmente spaventata la fattorina raccontò che un giorno, sulla tramvia fece conoscenza del Trossi, il quale si mostrò con lei molto galante e finì per richiederla del suo indirizzo. La tranviera, non seppe resistere alle insistenze del Trossi e gli fornì il proprio nome ed indirizzo di casa. Dopo di che non lo rivide più. La fattorina, dopo la sua deposizione fu rimessa in libertà, un po’ commossa e soprattutto impaurita.
Un pensiero per Felice e per Caterina
Fare la tranviera comportava un lavoro gravoso: ben dodici ore di lavoro quasi tutte passate in piedi a dondolare e ondeggiare delle andirivieni del rimorchio per non parlare dei passeggeri incauti e spesso maleducati oltre al fatto di sfidare quotidianamente i diversi rischi di un mestiere alquanto pericoloso. Tuttavia, tutto ciò viene ridotto a zero se si pensa al più straziante rischio che i tranvieri devono abbordare: quello di perdere la vita oppure -forse peggio ancora- di stroncarne una. Toccò a due donne, una manovratrice e una fattorina fare i conti con tragedie di questo tipo. La manovratrice Crosta guidava la motrice della società Belga in un sereno pomeriggio d’estate quando in corso Ponte Mosca, Felice Penazzi di soli quattro anni, attraversò la strada con la spensieratezza tipica della sua età. Proprio la stessa strada che percorreva il tram della società Belga guidato dalla Crosta. La manovratrice arrestò la motrice di botto nel vedere Felice, ma lui era già stato travolto dalle ruote anteriori del tram e morì istantaneamente quel pomeriggio di giugno del 1918.
Corso Ponte Mosca, sulla sinistra la stazione della Torino-Lanzo, sulla destra la chiesa di San Gioachino (foto Archivio storico Gtt)
Un anno e mezzo prima di quel fatidico giorno, il 15 gennaio del 1917, Caterina Ottino aveva da poco iniziato la sua giornata di lavoro. Era addetta alla vettura motrice della linea 5 - Barriera San Paolo, linea appartenuta alla Società Elettricità Alta Italia e prelevata dall’Azienda Tranvie Municipali (ATM) nell’ottobre del 1907. Caterina aveva 25 anni, era mamma di un piccolo figlio e suo marito era al fronte. Il tram percorreva il corso Vittorio Emanuele, dove fino a qualche decennio prima si trovava la vecchia Piazza d’Armi, quella costruita nel 1817 nei terreni appartenuta alla Cittadella. La stessa piazza dove nel marzo del 1900 si disputò il primo derby, quella che serviva a giovani e adulti per giocare al «giuoco del pallone palla, un giuoco tanto valevole per isviluppare le forze fisiche e la destrezza della persona». Quello spazio che sopravvisse fino agli anni venti del Novecento e dove vi è eretto, all’angolo di corso Galileo Ferraris, il monumento a Vittorio Emanuele II inaugurato nel 1899 tra solenni festeggiamenti e dopo una travagliata vicenda. Proprio lì, di fronte a quel monumento, Caterina notò un giovane ragazzo che, aggrappato sul predellino, costituiva un pericolo per se stesso e impediva ai passeggeri la salita e la discesa del tram. Si sporse della vettura per richiamarlo e nel farlo, perse l’equilibrio e precipitò a terra. Caterina rimase con le due gambe schiacciate dal rimorchio, erano circa le sette di sera. Due soldati, Magneti e Giani, la adagiarono su una carrozza e la trasportarono d’urgenza all’Ospedale San Giovanni. Le gambe erano state quasi troncate e aveva perso sangue in abbondanza, il dottor Jachia nel vedere il quadro generale della fattorina non ebbe nessun dubbio: bisognava amputare. Caterina passò la notte in ospedale con la vita appesa a un filo. Il caso suscitò la pietà dei colleghi e molti di essi fecero visita all’ospedale insieme ai parenti della fattorina. Altrettanto fecero le autorità ma, dato il suo stato, Caterina non poté essere interrogata. Caterina Ottino, fattorina dell’Azienda Tranvie Municipale, moriva in ospedale dopo l’incidente: la mattina del 16 gennaio 1917. Oltre alla commiserazione della comunità tranviaria vi fu quella della stampa locale; nel giorno della sua morte i quotidiani protestarono: «alla monelleria troppo abituale di ragazzacci scriteriati sovente causa di guai a se stessi ed agli altri dovrebbero provvedere le guardie municipali e il buon senso dei cittadini. Ieri sera l’Ottino era stata lasciata sola contro l’ostinatezza provocante d’un ragazzo, sino a che non sufficientemente in forze, perdette l’equilibrio e precipitò al suolo».


Alcune vedute dell'incrocio fra corso Vittorio Emanuele II e corso Galileo Ferraris negli anni Venti (foto Archivio storico Gtt)
Verso la fine del percorso
Quelle tranviere che avevano causato tanto stupore e scandalo, paragonabile a quello creato dal primo tram a cavalli che percorse le strade del centro di Torino, occupavano già un ruolo consolidato nella società torinese del 1918. Intanto, i venti di guerra iniziavano a dissiparsi e avanzavano quelli del fascismo: «Ad iniziativa del Fascio nazionale femminile è sorto a Roma, in piazza San Marco, un punto di ristoro per le tranviere. L’inaugurazione ha avuto luogo stamane. Sono intervenuti il presidente del Consiglio on. Orlando, l’on. Galienga, la signora Orlando, il direttore della Banca Commerciale, le signore del Fascio nazionale femminile con la loro presidentessa baronessa Bianc e la altre Autorità». La notizia è riportata dal quotidiano torinese La Stampa del giorno 11 giugno del 1918 e dà conto della presenza del Presidente del Consiglio, On. Vittorio Emanuele Orlando che ebbe «espressioni elevate per esaltare la virtù delle donne italiane ed ha detto che la sua presenza nei locali destinati ad accogliere le tramviere, sta a significare quanto il Governo apprezzi l’opera della donna». A seguito del discorso di ringraziamento pronunciato dalla tranviera Sabatini, il Presidente del Consiglio fece la proposta di offrire a ciascuna lavoratrice un buono stato da 25 lire; e come prima offerta l’On. Orlando consegnò alla presidenza del Fascio 199 buoni da costituire il primo nucleo della raccolta. In effetti l’avvenire si presentava ancora incerto per le tranviere italiane in generale. Si attendeva da un momento all’altro la fine della guerra e gli italiani accarezzavano l’illusione che tutto sarebbe tornato al punto dove si era interrotto. Difficile però -se non impossibile- far tornare il passato: la guerra aveva modificato l’ordine delle cose introducendo un drastico mutamento delle dinamiche, nello specifico, quelle relative al lavoro: «Una delle più formidabili questioni per dopoguerra sarà quella delle paghe industriali per le donne.» Inizia cosí l’articolo riportato da un giornale torinese nel mese di agosto del 1918 riflettendo sul recente sciopero delle tranviere a Londra e sulla conferenza che sarebbe stata tenuta nella capitale inglese quella stessa sera. Le conduttrici di omnibus e tram di Londra sostenevano di avere il diritto di ricevere l’identico salario dei colleghi maschi di fronte a una identica prestazione. Le società tranviarie si erano negate e le conduttrici, sostenute dai colleghi maschi, avevano organizzato uno sciopero. «Gran parte dei servizi di locomozione stradale nella metropoli sono quindi sospesi ed il movimento tende ad allargarsi». Intanto a Torino, col finire della Grande Guerra si aprì il dibattito sulla questione del personale femminile. I sindacati avevano preso l’impegno di tutelare le lavoratrici femminili, quindi la loro permanenza sui posti di lavoro che avevano occupato fino a quel momento. Ma il fatto che avessero pari diritti al personale maschile era una cosa che ancora era vista con obiezione da parte di molti. E furono questi ultimi a vincere la battaglia. Le tramviere di Torino, quelle donne-fattorino protagoniste del primo esperimento, furono licenziate nell’estate del 1919. Di loro si parlò ancora una volta, nel mese di novembre del 1920.«Un gruppo di ex-fattorine tramviarie ci scrive per deplorare che ancora non siano state loro pagate le competenze ad esse spettanti ed in conto delle quali avevano ricevuto un anticipo di lire 4 mensili. La liquidazione finale non è ancora avvenuta, quantunque siano trascorsi ben 15 mesi dal licenziamento. Le ex-tramviere protestano vivamente contro questa ingiustificata trascuranza e ricordano che, quando gli uomini erano al fronte esse dovevano provvedere alla famiglia, e si sobbarcarono al gravoso lavoro con sole lire 3,25 al giorno. Ora chiedono che le somme loro dovute vengano pagate senza altri indugi e perciò si sono rivolte -inutilmente, scrivono- alle Autorità che finora non hanno provveduto. Perciò rivolgono pubblica istanza perché le Amministrazioni tramviarie procedano alla corresponsione delle competenze arretrate loro dovute».
Nel 1920, quelle stesse donne che una volta vendevano biglietti a bordo dei rimorchi e che guidavano le motrici, che partecipavano ad assemblee sindacali e manifestazioni popolari; continuarono a salire sui tram di Torino come fantasmi che si aggirano in quella casa che una volta fu la loro. Fantasmi nella veste di passeggere.
Fonti
- Il primo esperimento delle donne tranviere, La Stampa, 17 maggio 1916
- Le donne tranviere, La Stampa, 22 maggio 1916
- Le donne conducenti dei tramway, La Stampa, 29 maggio 1916
- Le “spazzine”, La Stampa, 4 luglio 1916
- Un ordine del giorno delle tranviere, La Stampa, 27 luglio 1916
- Lo sciopero dei tranvieri dell’Azienda Municipale, La Stampa, 23 agosto 1916
- Il borsaiuolo delle fattorine tramviarie, La Stampa, 14 gennaio 1917
- Una tranviera sotto una vettura rimorchio, La Stampa, 5 gennaio 1917
- La morte della tranviera caduta sotto una vettura, Ultime di Cronaca, La Stampa, 6 gennaio 1917
- Il portamonete della fattorina, La Stampa, 8 aprile 1917
- Un inconveniente tranviario, La Stampa, 15 giugno 1917
- Una scena contro una tranviera: un arresto, La Stampa, 31 luglio 1917
- Pubblicazioni di matrimonio, La Stampa, 5 maggio 1918
- Tramviera accoltellata da una donna, La Stampa, 22 maggio 1918
- L’on. Orlando inaugura un posto di ristoro per le tranviere, La Stampa, 11 giugno 1918
- Bimbo schiacciato dal tram, La Stampa, 15 giugno 1918
- All’Ospedale, La Stampa, 18 luglio 1918
- Il processo per i fatti d’agosto, La Stampa, 18 e 19 luglio 1918
- M.P., Sciopero delle Tramviere a Londra, La Stampa, 20 agosto 1918
- All’Ospedale, La Stampa, 6 dicembre 1918
- La caccia allo squartatore, La Stampa, 13 aprile 1919
- I funerali di Trossi, La Stampa, 13 aprile 1919
- Movimentata assemblea di postelegrafonici – La dibattuta questione del personale femminile, La Stampa, 4 luglio 1920
- Le competenze arretrate alle ex-tramviere, La Stampa, 17 novembre 1920
- Museo Torino www.museotorino.it
- Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna: La prima guerra mondiale, il dopoguerra, l'avvento del fascismo, Feltrinelli, Milano 1996.
- Chiara Devoti, Gli Spazi dei militari e l’urbanistica della città: 1815-1918