Tranvài 2.0 è la nuova versione, più snella e moderna, del primo giornalino dell'Atts.
In ogni numero una selezione di alcuni articoli facenti parte queste categorie: Vita dell’Atts, Progetti significativi dell’Atts, Rapporti con altre associazioni, Restauro veicoli storici, Cronache tranviarie torinesi dai giornali d’epoca, Storia dei trasporti di Torino e dintorni, Aneddoti e fatti di costume, Curiosità dai libri dell’Atts, Tecnica tranviaria, Modellismo, I tram di… e Novità tranviarie dal mondo.

Come è noto, il mattino del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, l’aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica Little boy sulla città di Hiroshima, radendo al suolo e bruciando il 70% degli edifici nel raggio di 7 km dall’esplosione. Circa 70.000 persone morirono sul colpo e più di 70.000 morirono nei mesi successivi, a causa di malattie da radiazioni, ustioni e altre lesioni direttamente correlate all'esplosione.
Secondo il “Registro del disastro bellico della bomba atomica di Hiroshima”, 185 tranvieri e addetti in servizio a vario titolo persero la vita sotto il bombardamento e 266 rimasero gravemente feriti, su un totale di 950 dipendenti in servizio quel giorno.
Quel 6 agosto vennero distrutti 108 dei 122 tram della Hiroden (Hiroshima Dentetsu Kabushiki Gaisha), abbreviazione con cui ancora oggi viene denominata la Hiroshima Electric Railway Co. Ltd, l’azienda che intraprese a gestire la rete tranviaria di Hiroshima il 23 novembre 1912, subentrando alla Hiroshima Electric Tramway Co. Ltd.
Nella città nipponica la situazione del trasporto tranviario iniziò a complicarsi già da prima di quel fatidico anno, ossia a partire dal dicembre 1941, quando con il sopraggiungere della Guerra del Pacifico, gran parte dei dipendenti della Hiroden furono mandati a combattere, creando una grave carenza di manodopera.
Per garantire le capacità di trasporto in città, nell'aprile del 1943 fu fondata la “Hiroshima Electric Railway Kasei - Scuola Tranviaria per Fanciulle”, una scuola professionale per ragazze dai 14 anni in su, già in possesso di licenza di scuola elementare superiore. In detta scuola, le ragazze avrebbero dovuto trascorrervi tre anni studiando e lavorando. Il primo anno avrebbero dovuto frequentare le lezioni il mattino o il pomeriggio e impiegare la metà della giornata libera lavorando sui tram come bigliettaie. Il secondo anno sarebbero passate alla formazione per diventare manovratrici di tram e il terzo anno avrebbero dovuto completare il percorso didattico e conseguire il diploma.
Per capire come la storia delle allieve delle Scuola Kasei s’intrecciò con quell’indicibile momento della storia, sul finire della Seconda guerra mondiale, facciamo un passo indietro.
A partire dalla metà del 1943, un buon numero di “giovinette” provenienti dalle zone rurali delle prefetture settentrionali di Hiroshima, Shimane e Tottori iniziarono ad essere attirate dalla nuova scuola e da una nuova visione e speranza per il futuro. “Se aiuti sui nostri veicoli e a guidare, ti insegneremo ad usare la macchina da cucire e la macchina da scrivere” era lo slogan del reclutamento. Venivano inoltre promessi vestiti, cibo e alloggio. La prima classe (anno 1944-1945), arrivò a contare 72 studentesse. E a primavera 1945 risultarono altre 309 nuove iscritte all’anno successivo.
Affascinata dai racconti dalla sorella maggiore Kikuko, già arrivata in città da qualche mese, a quella prima classe si iscrisse Satoko Sasaguchi (cognome da nubile Oka). Una ragazza di non ancora 14 anni compiuti, nata e cresciuta in quella che oggi è la città di Ota, il cui più fervido desiderio era lasciare la campagna per "la città", alla ricerca di istruzione scolastica e di un futuro migliore. I primi mesi di scuola trascorsero come previsto, con l’alternanza mezza giornata di studio per la qualificazione professionale e mezza giornata a svolgere alcuni primi compiti, come fare scorrere i passeggeri sui tram di linea per velocizzare i tempi di salita e discesa, istruirsi sui regolamenti o semplicemente osservare per imparare dal personale esperto a bordo.


Foto 1 - Satoko Sasaguchi posa per una foto commemorativa con l’insegnante addetta alla sorveglianza del dormitorio scolastico, prima di andare a lavoro sui tram https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399
Foto 2 - Una foto di gruppo della classe 1° della Scuola tranviaria di Hiroshima, scattata nell’aprile 1945. Satoko Sasaguchi è tutta a destra nella terza fila in alto(foto fornita da Satoko Sasaguchi all’intervistatore). Da https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399
All’inizio del 1945, però, a causa dell’intensificarsi della guerra, la carenza di manodopera divenne ancora più manifesta. Le lezioni iniziarono a tenersi raramente e le ragazze finirono con il trascorrere le intere giornate lavorando. Il mese di agosto arrivò in fretta, la preparazione delle alunne più giovani era poca e in quel fatale 6 agosto la scuola Kasei, situata a circa 2.1 chilometri dall’ipocentro, venne distrutta.
Poiché l’esplosione avvenne all’ora della colazione, il dormitorio studentesco era affollato e molte ragazze furono colte dall’esplosione nella sala della mensa. Un’insegnante e 30 allieve persero la vita sul colpo. Venne inoltre confermato che alcune studentesse morirono, quel mattino, mentre erano in servizio a bordo dei tram.
Le allieve sopravvissute furono evacuate presso la scuola professionale femminile Hiroshima Jitsutsu (una sorta di scuola gemella). Tutte subirono lesioni e un forte shock. Satoko Sasaguchi restò intrappolata sotto le macerie e svenne. Al risveglio riuscì, tuttavia, a liberarsi da sola, accorgendosi che, a differenza di molte sue compagne, non aveva ferite gravi. In un’intervista Satoko raccontò di avere perso i sensi dopo aver visto una luce azzurra difficile da descrivere e di aver provato terrore e convulsioni nel vedere i corpi di due sue compagne decedute in poche ore. Con tutto ciò, già il giorno successivo (7 agosto) si prodigò nell’assistenza delle ragazze superstiti, che riportavano profonde ustioni, iniziando a rendersi protagonista di quei giorni drammatici.
L’operosità e l’inflessibile disciplina del popolo giapponese, in ambito tranviario, si manifestarono in pochi giorni. A sole 72 ore dall’esplosione, ovvero il 9 agosto 1945 (giorno in cui ad essere colpita fu Nagasaki), la Hiroden aveva già provveduto a rimettere in servizio tre fermate di tram vicino all’ipocentro e riparato dai danni del bombardamento prima il tram n° 653 e poco dopo il tram n° 652.
Il tram n° 653 fu il primo ad uscire in servizio, ma a distanza di poche ore i tram n° 652 e n° 653 ripresero a circolare agganciati l’un l’altro. La linea principale tra Koi (attualmente Hiroden Nishihiroshima) e Nishitemmacho (attualmente Tenmacho) riprese il funzionamento a binario unico.
Quel convoglio di tram che attraversò Hiroshima il 9 agosto venne chiamato "Ichiban Densha" (“Tram dell’uscita numero 1” o “Primo Tram”), fu un importante simbolo di ripresa, poi diventato una vera leggenda. La città, paralizzata dalla distruzione, grazie al tram tornò lentamente a muoversi. Come bigliettaia, a bordo del “Primo Tram”, quel giorno vi prese servizio proprio Satoko Sasaguchi.
Nell’ultima intervista che rilasciò circa quattro anni fa, Satoko raccontò «In mezzo al caos, a campi bruciati e a quell’orrore di fronte a me, ho cercato di lavorare diligentemente tutto il giorno».
Era solo dalla settimana precedente che aveva iniziato a studiare i nomi delle fermate e ad imparare le domande come “Avete già fatto tutti il biglietto? Chi deve ancora fare il biglietto? Biglietto per favore, devo controllare.” Eppure, seguendo le ultime indicazioni della sua insegnante, quel mattino del 9 agosto salì sul tram.
Ancora Satoko: «Ricordo di aver sentito la notizia della ripresa del servizio la sera dell'8 agosto. Il tram comincerà a circolare domani. Così, ascoltate le ultime raccomandazioni e istruzioni della mia insegnante, il mattino dopo ho iniziato a lavorare come bigliettaia tra Koi e Nishitemmacho. Sul tram saltavano, una dopo l'altra, persone in cerca di parenti e soldati. Ai passeggeri che salendo mi avvicinavano per il biglietto, dicevo “oggi non chiedo soldi”. Non posso dimenticare quei loro “grazie” con cui mi rispondevano. La bomba ha distrutto tutto, ma non i miei ricordi. La Hiroden era ed è ancora oggi parte della vita di Hiroshima».
Satoko rimase in servizio come bigliettaia sui tram fino al giorno prima della fine della guerra. Tornò a Ota, sua città natale, il 17 settembre 1945.
Nessuna allieva arrivò al terzo anno di scuola, in quanto, dopo la fine della guerra, oltre alla ricostruzione post bombardamento atomico, l’Azienda tranviaria dovette partecipare alla ricostruzione dell’indispensabile ponte Hiroden Tenmabashi, che crollò a causa dei danni provocati dal tifone Makurazaki a fine 1945. I costi per ripristinare la rete sembrarono moltiplicarsi, escludendo quindi qualsiasi prospettiva di investimento sulla riapertura dell'edificio scolastico femminile.
Attualmente il tram storico n° 652 in livrea verde e crema (insieme al n° 651, anch’esso colpito dalla bomba atomica) circola sulle linee 1,3,5,7 nelle ore di punta del mattino dei giorni feriali. Il tram n° 653, dopo essere stato messo fuori servizio nel 2006, a grande richiesta della cittadinanza è stato restaurato nel 2015 e riportato alla sua livrea bianca e blu del giorno del bombardamento. Viene utilizzato per eventi di educazione alla pace, per servizi turistici in estate, il 10 giugno (giorno del Tram Festival di Hiroshima) e nelle commemorazioni dedicate a non dimenticare il disastro atomico.
Questi tre tram, il cui anno di fabbricazione è il 1942, godono di cure quasi giornaliere, tanto è il riguardo loro riservato. Continuano ad essere considerati emblema del coraggio di una giovane ragazza e degli abitanti della città.

Foto 3 – Satoko Sasaguchi durante un’intervista sul tram 652. Da https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399


Foto 4 e 5 – Tram 652 e 653 (Anno 2024). Si ringrazia Gianni Droetto.
Fonti:
『1945原爆と中国新聞』(年、中国新聞社)= (La bomba atomica del 1945, The Chugoku Shimbun Journal)
「廣島特報」= (Hiroshima Tokuho - Periodico “Notizie speciali su Hiroshima”
https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/263399
https://www.hiroden.co.jp/company/outline/history03.html
https://washira.jp/onsen/posts/128841
https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=111341
https://rcc.jp/tram/history/history1.php
https://www.hiroden.co.jp/train/train-list/index.html
https://www.itej.or.jp/cp/wp-content/uploads/katsudou/2020-03.pdf
https://ameblo.jp/miyashima/entry-12757490332.html
http://j-tetsu.net/HP1/chinsya-htm/hiroden_652/hiroden_652.htm
https://www.nishiki-p.co.jp/2014/03/26/tram02-yon/
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2108/05/news136.html
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2208/05/news033.html
https://www.kipio.net/hd-650.html
https://tetsudo-ch.com/12935194.html
https://www.hiroden.co.jp/company/outline/history01.html

Una relazione della Columbia Britannica (la provincia di British Columbia, Canada) eseguita tra il 1911 e il 1915 e relativa agli incidenti di transito nell’ambito dei trasporti pubblici, si dà conto che le donne avevano il primato in materia di incidenti. Forse per via del loro “comportamento ansioso, talvolta testardo, di ostinarsi nel salire e scendere mentre i veicoli erano ancora in movimento”, è una delle possibili motivazioni considerate nella relazione.
In effetti, gran parte delle donne, dopo aver preso il tram, accusavano sgradevoli conseguenze quali capi d’abbigliamento rovinati e persino esaurimenti nervosi. Talvolta, recavano dei segni degli infortuni subiti durante la corsa quali tagli, graffi e ferite di diversa tipologia. Qualche passeggera è anche finita con le costole fratturate e qualcun’altra addirittura inconscia dopo la caduta del tram.
Quelle fortunate che ne erano uscite illese, a fine corsa, riportavano delle conseguenze legate agli accessori che, secondo la moda dell’epoca, dovevano trasportare insieme a sé. Dopo una collisione tra due tram interurbani nella città di Vancouver, nel 1911, una passeggera denunciò la perdita della borsa e degli orecchini ed un'altra ne uscì illesa ma notevolmente scossa e con il proprio parasole completamente distrutto.
Di tutte queste esperienze altrui, Marion Harland ne fece tesoro e nel suo libro Complete Etiquette, 1914 consigliava “Una delle cose che la maggior parte delle donne deve imparare è il modo corretto di scendere dal tram, cioè scendere con il piede destro, guardando in avanti, il che evita imbarazzi in ogni caso e talvolta, se le vetture parte troppo presto, un incidente.”
Tra gli atti encomiabili femminili invece, vi è quello accaduto nel 1913, sempre nella British Columbia: una donna salvò la giornata con una forcina. Successe durante una corsa della linea Oak Street nella quale vi era solo una donna tra tutti i passeggeri. Quando il veicolo rimase senza elettricità e dovette fermarsi, la signora non ebbe nessuna remora e“sottostando alla richiesta del motorman e in modo molto grazioso, lei consegnò la propria forcina e fu grazie a questo suo aiuto che la vettura potè riacquistare la scintilla e proseguire la corsa fino al capolinea senza altri incidenti.”
Non ci è giunta voce che in Italia sia stata fatta un’indagine del genere, tuttavia qualche accenno al fatto che le donne avessero delle cattive abitudini in salita e in discesa dei tram si evince in un articolo del house organ dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino del 1927. Ma non per questo, le corse tranviarie nostrane erano meno prive di incidenti.
Un articolo del quotidiano La Stampa del 1935, dà conto di quanto accaduto su un tram della linea 10 della città di Torino nell'articolo Un tranviere, una scimmia, due donne. Verso le nove di mattina, all’ angolo tra corso Vinzaglio e via Cernaia, nel centro di Torino “sale una donna sulla trentina…ella tiene, avvolto in una scialle grigio, un fagotto”. Non essendoci sulla vettura più di una decina di passeggeri il che consentiva una ampia libertà di movimento, il bigliettaio si adoperò con comodità al controllo dei biglietti. Ad un tratto, sentì un sussulto venire dal fagottino tenuto in braccio dalla donna e vide una mano scappare fuori di esso. “Una mano inverosimilmente piccola ma irrequieta, nervosa…e pelosa,” il bigliettaio quindi scosse lo scialle e vide uscire dalle pieghe della stoffa la testina di una scimmietta. Una passeggera, nel vedere l’animaletto spuntare fuori, ricordò al fattorino che le scimmie erano delle “sporche bestiacce" e che il regolamento vietava il trasporto di animali sulle vetture tranviarie. La padrona della scimmia obiettò, a sua volta, sostenendo che aveva sempre portato con sé la scimmietta in tram e nessuno aveva mai fatto opposizioni. Si crearono a questo punto “due fazioni di passeggeri: pro-scimmia e contro scimmia, con il bel risultato di mettere il fattorino fra incudine e martello”. All’incrocio di via Garibaldi e via S.Francesco d’Assisi dove vi era un vigile urbano “i contendenti scendono, si spiegano e rimane nella vettura soltanto il tranviere.”
Purtroppo l’articolo non riporta la fine della storia né specifica quale delle due fazioni abbia vinto la battaglia. Comunque sia che la scimmietta fosse arrivata a destinazione a piedi o proseguendo sul tram, anche da questo lato dell’oceano i trasporti tranviari erano spesso una sorgente di divertimento per il modico prezzo del biglietto.
FONTI
Women, men and urban public transport in Germany. Barbara Schmucki, The Journal of Transport History, Institute of Railway Studies, York Technical University, Darmstadt, march 2002.
Ladies Riding Cars, 30 agosto 2014, www. https://isabellaalden.com/
Un tranviere, una scimmia, due donne. La Stampa, 3 ottobre 1935.
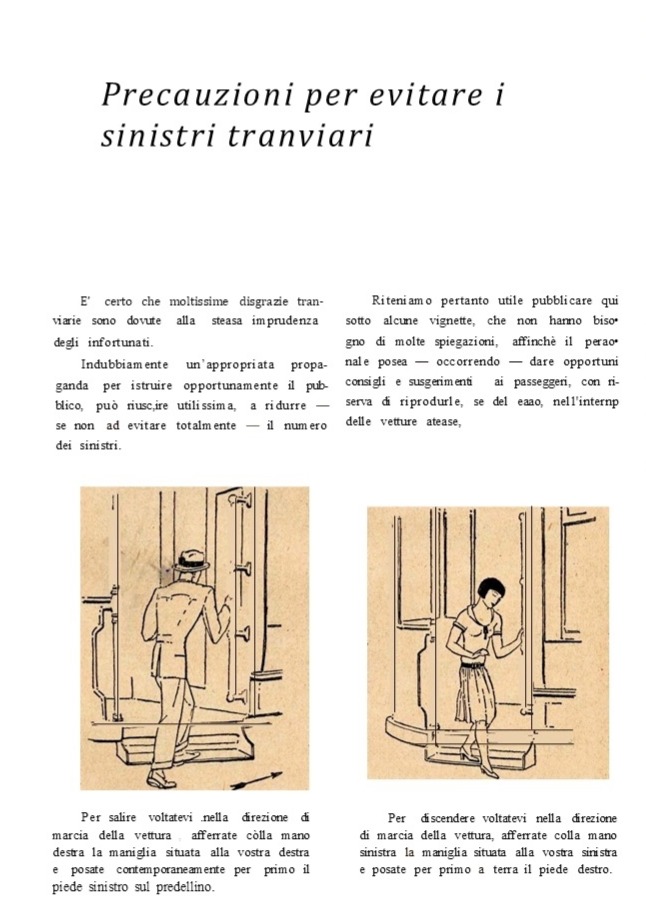
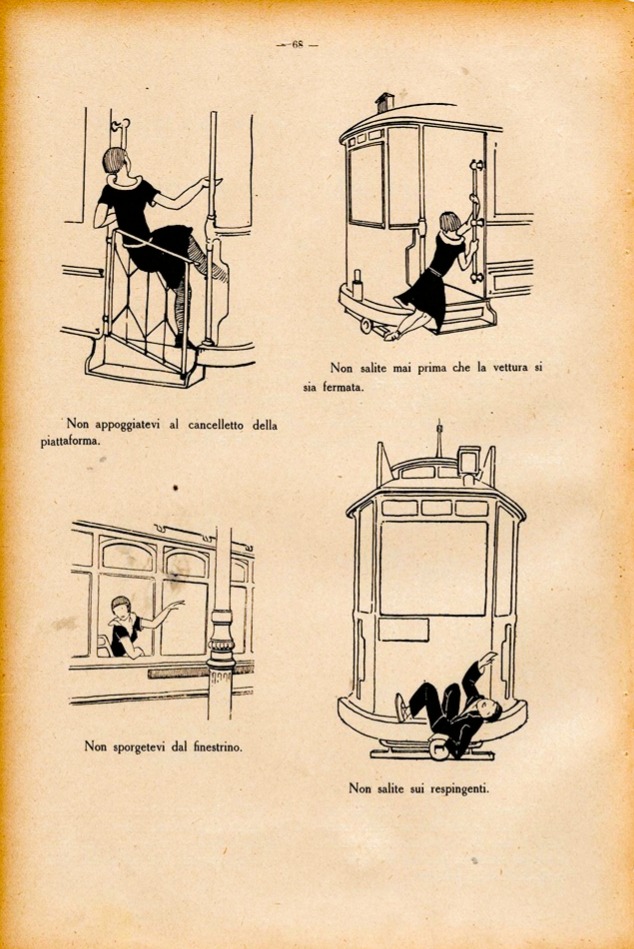
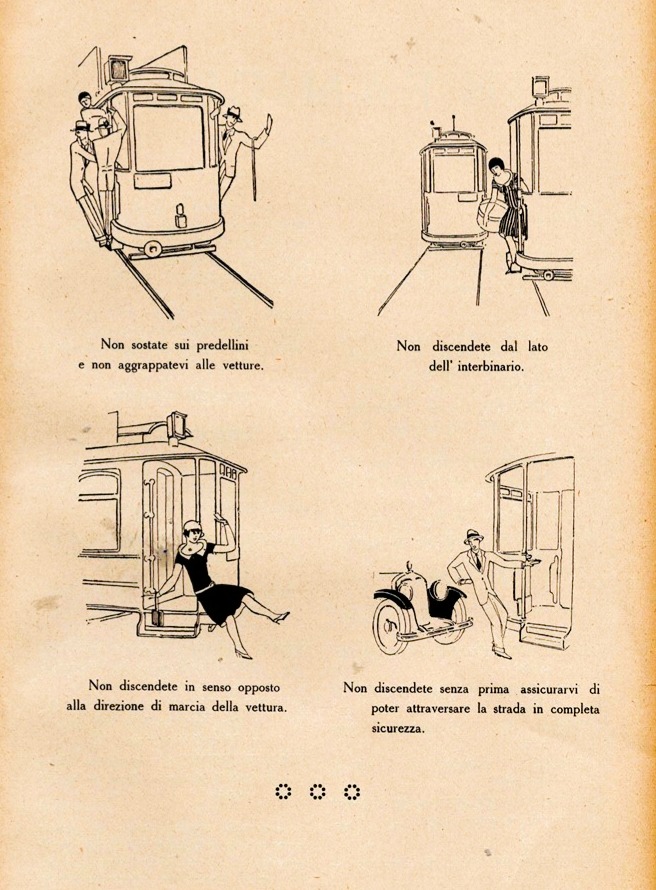
Il problema delle cattive abitudini in salita e in discesa delle vetture tranviarie viene represso dalla Rivista dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino, nel suo secondo numero nel mese di marzo 1927.

“Eppure dicono che le donne stanno facendo passi da gigante”. New York Times, 12 giugno 1910. https://isabellaalden.com/
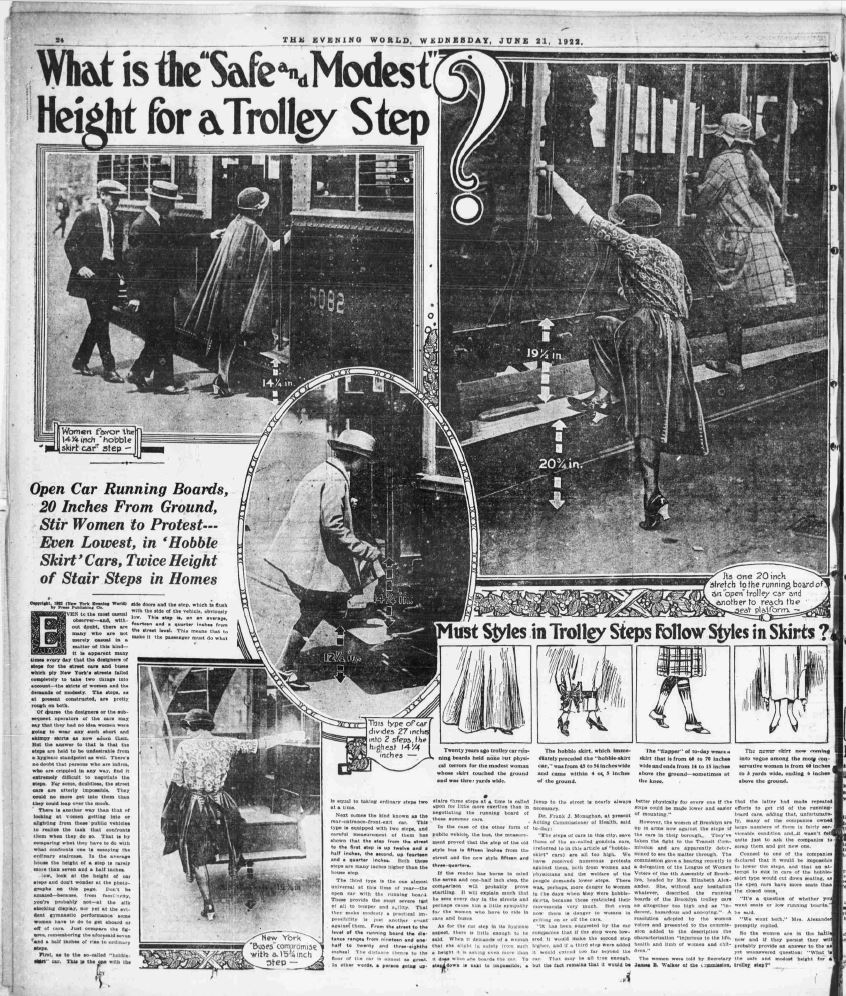
The Evening Work di New York ripropone l’argomento dell’altezza dei gradini del tram in questo articolo del 21 giugno 1922 .
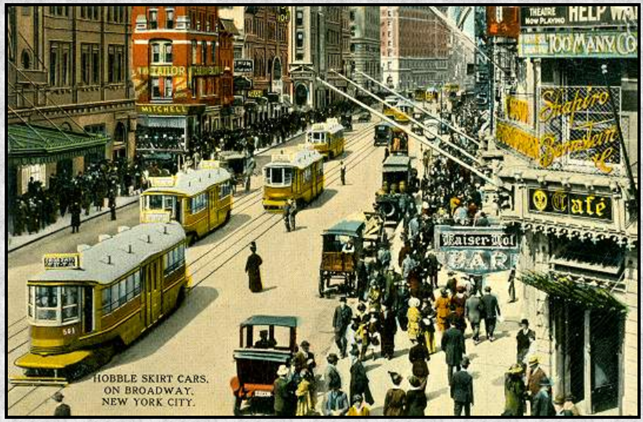
Il tram al femminile. I tram a pianale ribassato: tecnologia su richiesta femminile di Marcela Luque
Tra tutte le situazioni di pericolo, anzi, di estremo pericolo, che le passeggere di sesso femminile dovevano affrontare durante la salita e la discesa dei primi tram elettrici, la più seria era indubbiamente rappresentata dalle gonne che erano costrette ad indossare.
Ai tempi dei primi tram a cavalli, gli ampi volumi delle gonne spesso bloccavano la vista di gradini e altri pericoli, facendo sì che gli incidenti nel contesto dei trasporti pubblici riguardassero maggiormente le donne. Durante la prima decada del ventesimo secolo, la moda femminile cambiò radicalmente: fu la fine dell’impero delle gonne voluminose che mutarono in capi più aderenti, dello stile comunemente chiamato tubino, sinonimo di eleganza ancora nei nostri giorni. Verso il 1910, ci fu una variante di queste gonne meglio conosciuta come "hooble-skirts" e che prese piede nei paesi del Nord America.
Si trattava di una gonna, non particolarmente aderente, ma stretta alle caviglie e spesso anche alle ginocchia e che limitava drasticamente le capacità di movimento della donna che l’indossava. Queste gonne, di moda tra il 1908 e il 1914, furono spesso ridicolizzate nei quotidiani americani come le “speed limit skirts” (gonne per il limite di velocità). Dal punto di vista estetico invece, sembravano disegnate unicamente per quelle donne con una corporatura simile al manico di una scopa, visto che accorciavano e allargavano la figura esageratamente. L'editore del Monroe City Democrat nel Missouri dichiarò che "indossare una hobble skirt farà sì che la ragazza più dolce assomigli al tappo di un'ampolla di aceto."
Curiosamente le hooble skirts, presero popolarità proprio nel momento in cui le donne diventavano più attive dal punto di vista fisico. Il 12 giugno 1910, un editorialista del New York Times osservava una contrarietà tra “queste donne che lottano con tanto entusiasmo per essere legalmente libere, come possono poi accettare di essere incatenate sartorialmente?”. E, in modo provocatorio, sosteneva che “se una donna ambisce a correre per la carica di governatore, dovrebbe quantomeno essere in grado di correre anche dietro al tram”.
Difatti non passò molto tempo prima che l’introduzione delle hobble skirts avessero un impatto disastroso sul sistema tranviario delle più importanti città americane. Le donne impiegavano troppo tempo nella salita e nella discesa ritardando notevolmente gli orari delle corse programmati. Era anche molto comune che, le donne che indossavano gonne aderenti, bloccassero le portiere mentre cercavano di alzare le gonne quanto bastava per consentire loro di salire sulle vetture.
Purtroppo, le hobble skirts si tramutarono in fatalità in alcuni casi: nel settembre 1910, all’ippodromo di Chantilly, una donna muore travolta da un cavallo scosso senza che la gonna le consentisse di avere il tempo necessario per sfuggire all’impatto. In Canada, la giovane Ida Goyette, perse la vita a soli 18 anni per colpa di una hobble skirt: “la hobble skirt che indossava fu la responsabile della morte de Miss Ida Goyette, residente a Cohoes, lo scorso giovedì a soli 18 anni…” riportava il quotidiano Unadilla Times dell’8 settembre 1911, “… mentre attraversava il ponte sopra il Canale Erie e cercando di scavalcare la ringhiera chiusa, la gonna la fece inciampare e subito precipitare cadendo nelle acque del canale.”
Incoraggiate dalle notizie fatali che riportano i quotidiani in merito alle hobble-skirts, le passeggere dei tram di diverse città americane, iniziarono a inviare numerose lamentele alle aziende. Lo scopo era quello di rendere le aziende tranviarie consapevoli dell’impresa che rappresentava salire su un tram, cioè arrampicarsi a dei gradini di all’incirca 40 o 50 cm di altezza dal pavimento, il tutto indossando una hobble skirt.
Seppellite sotto pile di lettere di reclamo delle signore passeggere, le aziende di trasporti accettarono che, per quanto temporanea potesse essere una moda, comunque bisognava prendere sul serio la questione e fornire una soluzione tempestiva. La prima a capire come farlo fu la Interborough Rapid Transit Company della città di New York.
Un tram con nome di gonna
L’Interborough Rapid Transit Company di New York rispose al problema creato dalle hobble skirts esattamente con le stesse parole: i Hobble-Skirt… Cars.
Già nel 1904 l’Ing. Frank Hedley, Direttore Generale, e James S.Doyle, sovrintendente delle attrezzature e alle vetture; avevano progettato una tipologia di tram che prevedeva il pianale ribassato e che fu ritenuto la risposta alle problematiche create dalle hobble skirts.
Il 4 aprile 1912, 11 giorni prima dell’affondamento del transatlantico Titanic, il quotidiano The World di New York City descrisse la corsa inaugurale di questa nuova vettura: “È il primo tram senza gradini, igienico e con porta laterale di pubblica sicurezza…”. E prosegue: “Il primo passeggero a salire sul vagone a South Ferry è stata una donna, la signora A. L. Un’ altra passeggera, Ackerman di Bayonne, N.J., ha dichiarato di non essersi mai sentita così libera dalla confusione e a suo agio su un tram prima d’ora…”. La descrizione del quotidiano ci offre altresì alcuni dati sulle caratteristiche della carrozza: “l'ingresso alla vettura avviene attraverso un'ampia porta laterale. Ci sono solo dieci pollici (25 cm.) di gradino fino al pavimento della vettura, che è basso e solido, come quello di una vettura da corsa”. Le Hobble-Skirt Cars si rivelarono un vero successo per la New York Railways Company e nel giro di pochi anni ne furono costruiti 176 unità solo per la città di New York.
Oltre a risolvere il problema alle indossatrici delle hobble skirts, questa tipologia di vettura agevolava la salita e la discesa per chiunque avesse difficoltà motorie. L'accoglienza da parte delle passeggere fu talmente festosa che convinsero anche le autorità della città di Washington D.C. a ordinare le nuove vetture a pianale ribassato.
“Le donne di Washington vincono la battaglia per i tram a pianale ribassato. Vittoria per la hobble skirt a Washington" fu il titolo dell’articolo del New York Times del 21 marzo 1912, “La Washington Railway & Electric Company ha ordinato 50 nuove vetture tranviarie e sul contratto è stabilito che i gradini devono essere costruiti di modo che le donne indossanti una hobble skirt, possano salirci sopra senza bisogno di essere accudite da una folla”. Con queste parole semplici uno dei quotidiani più importanti degli Stati Uniti, il New York Times, dava conto della recente affermazione femminile.
Taglia e Misura
Gli Hobble Skirt Cars presentavano un'ampia porta scorrevole posta al centro della carrozza, dalla quale i passeggeri, e soprattutto le passeggere, salivano a bordo per via di un unico gradino che rimaneva a circa 25 cm dal piano del ferro. Una volta all'interno, il pavimento si inclinava verso l'alto per dare spazio sufficiente ai carrelli.
Prodotto dalla J. G. Brill Company nella città di Philadelphia, fu anche conosciuto con il nome di one-step-car, drago in California e come vettura del benessere pubblico a New York. Ma in realtà, il progetto porta il nome dei suoi creatori: Hedley-Doyle Cars. Nel 1912 furono prodotti tre prototipi sulla base del progetto di Hedley & Doyle: le 5000 ovvero i rinomati Hobble Skirt Cars, le 6000 a due piani e le 7000 a batteria a 4 ruote.
Numerati da 5001 a 5175 i Hobble Skirt Cars della città di New York erano montati su truck 62E della J. G. Brill Company. Tuttavia, la Brill subito capì di non potere tener testa a una tale quantità di ordinazioni perciò incaricò il lotto di produzione alla St. Louis Car Company.
Oltre alla particolarità del pianale ribassato, gli Hobble Skirt Cars avevano un enorme paraurti (o parafango) a becco d'anatra il quale era montato sui truck anziché sulla carrozzeria delle vetture come era normale all’epoca. I truck, a loro volta, erano racchiusi da protezioni in lamiera d'acciaio. Le vetture utilizzavano la raccolta della corrente tramite condotto ed erano controllate dai controller Westinghouse 1PK. Le casse erano bidirezionali, lunghe 11 metri e larghe due e mezzo; potevano ospitare fino 51 passeggeri.
Un lotto di 36 vagoni Hobble-Skirt, fu fornito dalla J. G. Brill Co. alla Southern Pacific Company destinati ai servizi locali della Pacific Electric Railway e sui sistemi urbani di Stockton, San Jose e Fresno, tutte città della California. Altre vetture Hobble Skirts sono state acquistate anche da altre città quali Vancouver in Canada, Perth e Brisbane in Australia.
Il fallimento di Vancouver
La città canadese di Vancouver presentò la sua prima vettura il 18 marzo 1913 e nell’edizione del giorno dopo, il Vancouver Sun affermava che le donne potevano salire a bordo "senza trepidazione e senza il timore di sentire addosso cento occhi curiosi".
Per quanto i più critici, essi sostenevano che gli Hobble Skirt Cars fossero tutto stile e niente sostanza, tuttavia questo tipo di tecnologia si dimostrava veramente alla moda: “La vettura 500 ha effettuato il suo divertente viaggio di prova ieri. Più di due dozzine di donne importanti, in pellicce e abiti eleganti, si unirono a dignitari come B.C., il direttore generale dell'elettricità RH Sperling, e sua moglie,” riporta il Vancouver Sun nella edizione del 19 di marzo 1913. E continua: “Il ‘tram delle signore’ parti dalla stazione interurbana di Carrall Street per una gita pomeridiana percorrendo la linea Fairview fino a English Bay. I passeggeri furono trattati con delicatezza e gli fu offerto del tè e dei gelati durante il viaggio di ritorno”.
Secondo il quotidiano "l’opinione unanime di tutti coloro che erano a bordo, era che la vettura è qui per restare e che si rivelerà uno dei più grandi nemici della limousine e del taxi, che divennero così di moda per via delle Hobble Skirts". Poche profezie si sarebbero ribellate così sbagliate.
Purtroppo, gli Hobble Skirt Cars non furono molto popolari a Vancouver operando solo per pochi mesi principalmente sulla linea di cintura di Fairview, con il capo macchinista Sam Wilcockson spesso ai comandi. L’esistenza della porta centrale creava confusione tra i passeggeri che erano abituati alla comodità di un ingresso anteriore a porta singola e di un'uscita posteriore a doppia porta.
Spesso, il tram sbandava a causa della sua costruzione centrale bassa. Inoltre, si rivelò inadatto alle colline della città perché il design a pianale ribassato riduceva il numero di motori del veicolo. "Si è rivelato un vero fiasco", spiegava il riparatore tranviario Ted Gardner nel 2002. "Era sottodimensionato e inutile. Aveva solo due motori e quattro assi con ruote piccole. Gli altri tram avevano quattro motori con otto ruote grandi!"
In aggiunta il veicolo costruito da J.G. Brill di Filadelfia, non condivideva parti intercambiabili con il resto della flotta rendendolo più difficile da riparare. In aggiunta a questi svantaggi vi era anche quello legato al prezzo: in un periodo in cui il tram medio costava 8.000 dollari, un Hobble Skirt Car veniva a costare ben 15.700 dollari. In poche parole, per la città di Vancouver, il Hobble Street Car diventava troppo costoso e scomodo da mantenere.
Fuori moda
Verso il 1914, non per via del buonsenso ma della Grande Guerra, le hobble skirts sparirono improvvisamente con la stessa rapidità con cui erano arrivate. Finita la tendenza delle hobble skirt, le donne poterono nuovamente salire i gradini con relativa facilità.
L’impero dei Hobble Skirt Cars si estinse insieme a quello delle gonne che li avevano dato vita diventando, in meno di un decennio, completamente fuori moda. E i tram che portano il loro nome seguirono lo stesso destino.
La durata delle vetture di New York non fu molto lunga. Nel 1919 l'azienda era in difficoltà finanziarie e furono istituiti tagli. Le vetture Hedley-Doyle furono ritenute non adatte a questo nuovo contesto e furono progressivamente ritirate: l’ultima rimase in funzione fino al 1925.
Le vetture Pacific Electric andarono un po' meglio e resistettero fino al 1934. Una delle carrozze di Fresno e il telaio in acciaio di un'altra si trovano all'Orange Empire Railway Museum di California. L’ultima delle di Vancouver, fu demolita nel 1939 e quella di Brisbane nel 1933. Tuttavia, a Perth servirono fino al 1950 e la carrozza esiste ancora nel museo della Perth Electric Tramway Society a Perth in Australia.
Anche se per poco tempo, questa tipologia di tram è stato un primo segnale dell’importanza che la clientela femminile riscuoteva nelle aziende di trasporti. Importanza che sarebbe aumentata verso gli anni ’50 in cui, preferendo gli uomini guidare la propria auto, furono le donne – insieme e tutte le altre categorie che non avevano un auto a disposizione- a rappresentare la percentuale di utenti più alta di trasporti pubblici e costringendo ai progettisti a concepire delle vetture nell’ottica di una maggiore accessibilità per tutti.
Per quanto riguarda le altre persone con mobilità ridotta, dovettero attendere altri decenni prima che la progettazione dei tram tenesse in considerazione le loro esigenze. L’Italia attese fino al 1984 per vedere i tram della serie 4500 dell'ATM di Milano, i primi tram a pianale ribassato a circolare nel nostro paese.
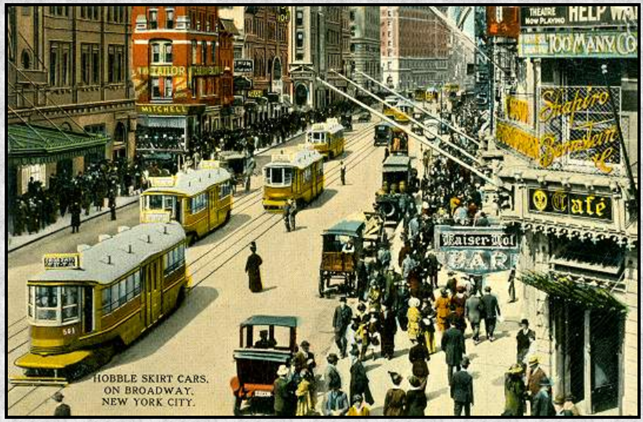
Cartolina dell’American Art Publishing Company di New York City che mostra le vetture hobble-skirt a Broadway St nel 1914. https://www.tramwayinfo.com/
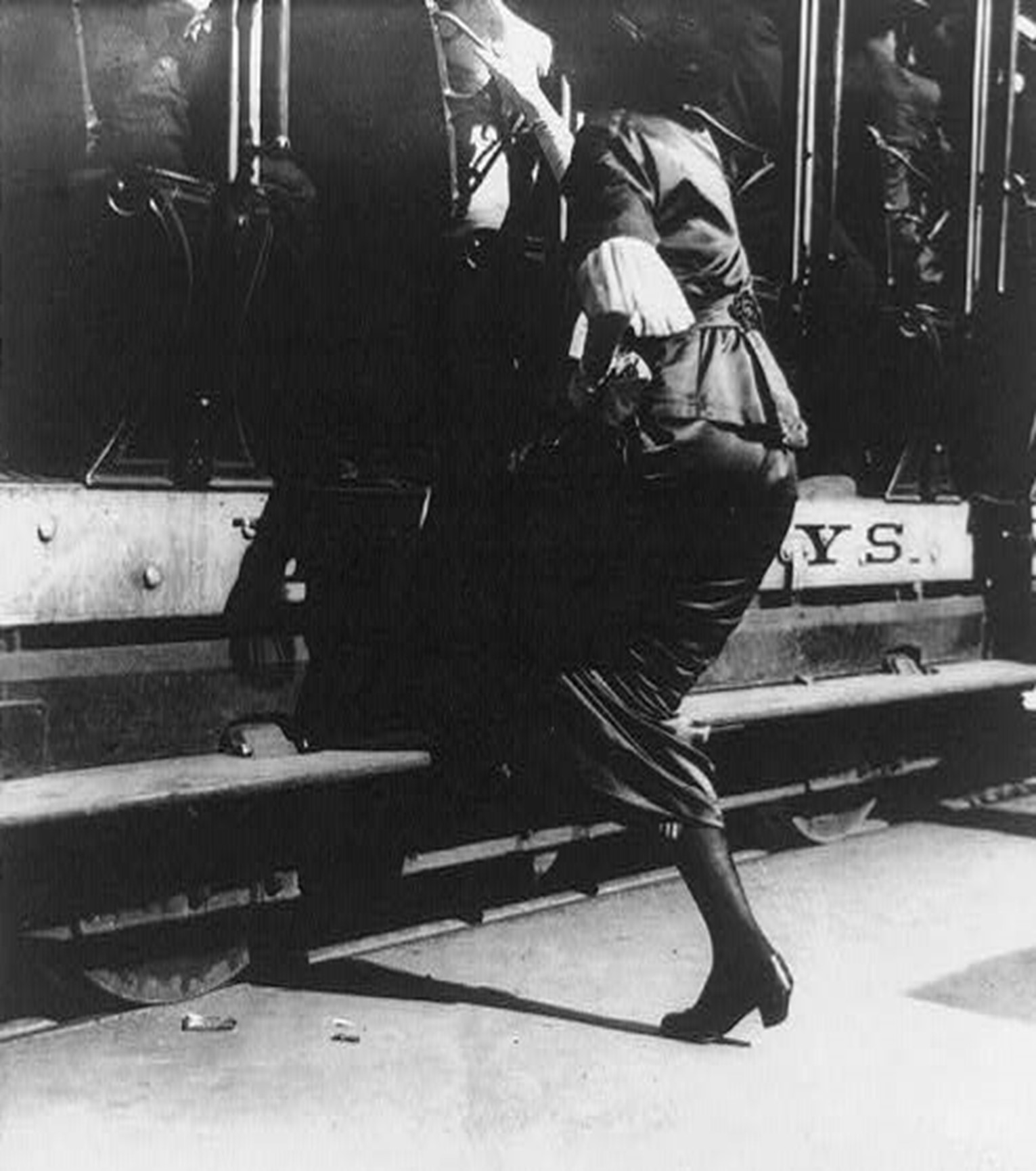
La fatica di salire su un tram elettrico indossando una hobble skirt. Broadway, New York City, 1913. https://www.tramwayinfo.com/

4 aprile 1912: l’edizione pomeridiana de The World riporta il primo giro degli hobble-skirt trams.
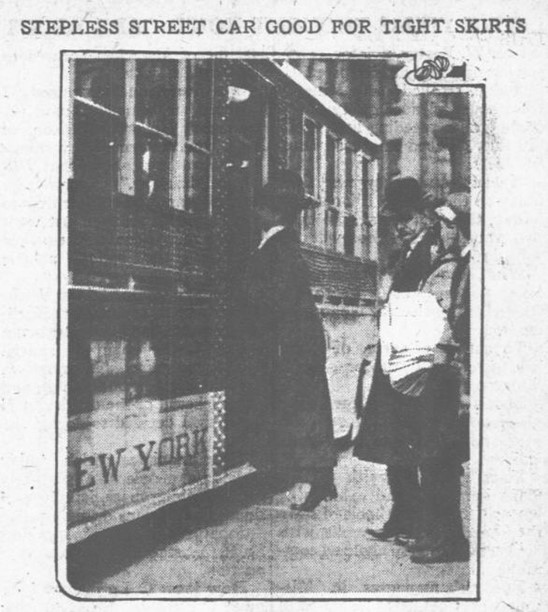
Le gioie del tram a pianale ribassato immortalate dal quotidiano The Day Book del 10 aprile 1912.
FONTI
New York Step High, The Evening World, New Your, 21 giugno 1922
Tramway Information, https://www.tramwayinfo.com/
Spacing https://spacing.ca/toronto/2016/04/22/curious-origin-original-low-floor-streetcar/
Un mondo di tram, Roberto Cambursano, 2017

Dopo la dismissione della rete di Arkhangelsk in Russia nel 2004, la linea tranviaria più settentrionale del mondo è quella di Trondheim, vivace cittadina universitaria di oltre 200.000 abitanti nella Norvegia centrale.
L’unica linea sopravvissuta della vasta rete cittadina collega il centro storico con la località di Lian, raggiunta dopo 8,8 km e 21 fermate. Lo scartamento è metrico e la linea si sviluppa in gran parte a binario unico. Inizialmente numerata linea 1, ora è la 9 “Gråkallbanen” e parte da St. Olavs Gate, non lontano dalla famosa cattedrale di Nidaros. Attraversa i caratteristici quartieri di case in legno del centro e si immerge presto nella natura della periferia cittadina fino ad arrivare ai circa 300 metri slm del capolinea, dal quale è possibile accedere ad alcuni laghetti immersi nei boschi e ad una fitta rete di sentieri con itinerari per escursionismo e sci di fondo. A circa metà percorso (fermata Munkvoll) si trovano il moderno deposito ed il Museo del tram, ricavato dalla vecchia rimessa. La Gråkallbanen è gestita dalla società privata Boreal AS che possiede sette tram articolati costruiti nel 1984 in Germania da Linke-Hofmann-Busch con apparecchiature elettriche Siemens. I veicoli appartenenti a questa serie in origine erano 11, ma 4 sono stati demoliti. La frequenza nei giorni feriali è di un tram ogni 15 minuti con 4 veicoli in servizio e si riduce a 30 la sera e nei giorni festivi con due veicoli.




Percorriamo la travagliata storia cittadina per scoprire come è rinata la Gråkallbanen. La prima linea tranviaria aprì nel 1901 - gli omnibus erano in servizio solo dal 1893 - su un percorso che collegava la città da ovest ad est. La rete all’inizio del secolo scorso si è espansa molto velocemente ed è arrivata ad avere 5 linee, ognun identificata con un nome. Tutte le zone allora popolate erano capillarmente servite da rotaie. Il primo tratto dell’attuale linea 9 è stato costruito nel 1924 e la linea è stata completata solo nel 1933. Durante la Seconda Guerra Mondiale i tram furono l’unico mezzo regolarmente in servizio e dal 1941 fu assunto un consistente numero di bigliettaie in sostituzione degli uomini chiamati a combattere (maggiori dettagli nella pagina il Tram al femminile). In questo periodo lavorarono sui tram anche ragazzi minorenni. Alcuni tram furono confiscati dagli occupanti tedeschi ed inviati a Mannheim in Germania.
Nella notte del 10 ottobre 1956, il deposito di Dalsenget prese fuoco, distruggendo quasi completamente la moderna flotta di tram da poco acquistata (26 tram e 16 rimorchi). Fortunatamente i vecchi tram erano stati conservati nel deposito di Voldsminde e tornarono presto in servizio. Inizialmente si pensò di sostituire con filobus il servizio tranviario, ma furono costruiti nuovi tram con truck e componenti meccaniche recuperati dall'incendio. Nel 1968 una prima linea fu chiusa e sostituita da bus. Nel 1972, le due compagnie presenti, Gråkallbanen e Trondheim Sporvei, furono fuse con la compagnia di autobus municipale Trondheim Trafikkselskap. Da quel momento in poi, ci furono molte pressioni politiche per lo smantellamento della rete tranviaria a favore degli autobus, considerati economicamente più convenienti perché il conducente poteva svolgere anche le mansioni del bigliettaio. Dopo diversi anni di acceso dibattito, il comune decise di interrompere completamente il servizio tranviario nel 1988. Pochi anni prima erano stati acquistato 11 nuovi tram. Gran parte della rete, dopo pochissimo tempo fu coperta dall’asfalto per cancellare ogni traccia del passato. Sopravvisse la Gråkallbanen che per la maggior parte del percorso viaggiava in sede proprio, non condivisa con il traffico privato. Il tram, però aveva molti ed agguerriti sostenitori che fondarono persino un partito per avere maggior peso nelle scelte politiche. Così nel 1990 è stata creata una nuova società di proprietà di 1400 “sostenitori del tram”, la AS Gråkallbanen, che ha ripristinato il servizio sull’unica linea rimasta utilizzando i nuovi tram acquistati pochi anni prima. Nel 2004 la divisione norvegese di Veolia Transport, ha acquistato la società, che dal 2016 ha assunto il nome di Boreal Bane AS.
Nel muovo millennio sono stati discussi molti progetti di espansione della rete tranviaria, ma ad oggi nessuno portato è stato portato a termine. Dopo essere risorta grazie alla caparbietà dei suoi sostenitori la linea 9 continua a portare cittadini e turisti sulla collina di Trondheim.

La Gråkallbanen nel 1927 (da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gråkallbanen_tram_1927.jpg)
Il Museo tranviario
Il primo nucleo della collezione museale è stato messo insieme nel 1979, quando è stata costituita l’associazione per la salvaguardia dei vecchi tram cittadini. Il museo è stato aperto nel 1995 e conserva una ricca collezione di mezzi di varie epoche, cimeli, pannelli descrittivi, un fornito book shop. Alcuni tram storici sono in servizio in occasioni speciali e noleggiati a chi ne fa richiesta. Tra le tante curiosità vi è la descrizione dettagliata del sistema di regolazione del traffico sulla Gråkallbanen tramite il cosiddetto “bastone pilota “che fu introdotto dopo un incidente nel 1931. Questo sistema era in uso anche su molte ferrovie a binario unico fino all’avvento di sistemi più moderni. Quando il manovratore deve impegnare un tratto a binario unico per aver la garanzia che lo stesso tratto non sia impegnato da altri convogli deve trovate un oggetto, il “bastone pilota”. La mancanza dell’oggetto significa che un altro convoglio sta impegnando quel tratto di linea ed è in possesso del “bastone”. All’arrivo del mezzo incrociante avviene lo scambio dell’oggetto e si ha la garanzia che sul tratto a binario unico non ci siano altri mezzi.






Fonti:
https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim_Tramway
https://www.urbanrail.net/eu/no/trondheim/trondheim.htm
http://sporveishistoriskforening.no/museet/
https://en.wikipedia.org/wiki/Trondheim_Sporvei
https://www.facebook.com/trondheimsporvei/
Foto dell'autore se non espressamente indicato

Come ad ogni inizio di nuovo anno, in questo articolo vengono passate in rassegna le variazioni riguardanti il “Sistema tram” che sono avvenute nel mondo nel corso dell’anno precedente, ordinate per paese e, in subordine, per città.
Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Railway Gazette International; Urbanrail.net.
Il 2024 ha fatto registrare parecchi prolungamenti di linee esistenti, ma due sole aperture di nuovi sistemi (Dujiangyan in Cina e Resita in Romania, evidenziate in giallo).
Nel campo delle tranvie storiche, il 2024 non è stato un buon anno, vista la chiusura della rete di Memphis (U.S.A, evidenziata in azzurro) e il fermo dei tram storici di Blackpool (U.K.).
AUSTRALIA
· SIDNEY (New South Wales). Il 20 dicembre è stata inaugurata una nuova linea tranviaria denominata “L4”: congiunge Westmead con Carlingford ed è interamente ricompresa nel comune di Parramatta (facente parte dell’area metropolitana di Sidney); è lunga 12 km ed è completamente isolata del resto della rete tranviaria.
La rete tranviaria di Sidney ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 36,7 km distribuiti su quattro linee (numerate da L1 a L4), con una flotta di 89 tram a pianale interamente ribassato (29 CAF Urbos3+60 Alstom Citadis 305). Su un tratto centrale di 2 km, comune alle linee L2 ed L3, non è presente la catenaria e l’alimentazione viene fornita dal suolo col sistema APS di Alstom; anche su un tratto della linea L4 non è presente la catenaria, ma in questo caso viene usato il sistema ACR di CAF abbinato ai supercapacitori.
BELGIO
· BRUXELLES. Prosegue l’ampliamento della rete tranviaria: il 23 settembre la linea 10 è stata prolungata da Heembeek a Hôpital Militaire su un tratto di nuova costruzione lungo 4,4 km.
La rete tranviaria di Bruxelles conta ora 17 linee e 150 km di sviluppo.
BRASILE
· RIO DE JANEIRO. Il 5 marzo è stato inaugurato un nuovo tratto di 0.4 km da Rodoviária a Terminal Intermodal Gentileza, su cui è stata instradata la linea T2. Contemporaneamente è stata istituita la linea T4 da Praça XV (Barcas) a Terminal Intermodal Gentileza.
La rete tranviaria moderna di Rio, il cui primo tratto era stato inaugurato nel 2016 in occasione delle Olimpiadi, si compone di 4 linee, si sviluppa ora complessivamente per 14,5 km ed è alimentata completamente senza catenaria con il sistema APS di Alstom. Il parco rotabile è composto da 32 tram a pianale interamente ribassato Alstom Citadis 402.
Rimane in funzione anche una minuscola porzione della rete tranviaria di prima generazione, a forma di Y e composta da due linee, completamente separate dalla rete moderna e mantenute essenzialmente come servizio turistico: il “Bonde de Santa Teresa. L’offerta tranviaria della città carioca è completata poi dalla Tranvia a cremagliera del Corcovado, che raggiunge la statua del Cristo Redentore posta sulla cima della omonima altura: nel 2019 sono entrati in servizio tre moderni convogli articolati forniti dalla casa svizzera Stadler.
CINA
· DUJIANGYAN (Sichuan). Il 15 maggio è stato inaugurato un nuovo sistema tranviario, espressamente dedicato ai turisti in visita alle attrazioni della zona. Sono in funzione 2 linee con capolinea in comune a Bajiao Temple, colleganti rispettivamente Mt. Qingcheng e Zijingcheng, con uno sviluppo totale di rete di 17,3 km; il parco rotabile è costituito da 26 tram Citadis 302 a pianale interamente ribassato costruiti in Cina da CRRC su licenza Alstom.
ESTONIA
· TALLIN. Il 1° dicembre la linea 2 è stata instradata su un tratto di nuova costruzione tra Suur Rannavärav (ex Linnahall) e Vanasadam – Paberi, che attraversa la zona del porto situata a nord-est del centro storico.
La rete tranviaria della capitale estone, a scartamento di 1067 mm, è ora composta da cinque linee con uno sviluppo totale di 22,2 km.
FINLANDIA
· HELSINKI. Il 12 agosto è stata istituita la nuova linea 13, ad andamento tangenziale da Pasila (Maistraatintori) a Nihti, che segue un tratto di nuova costruzione di 4,3 km.
La rete tranviaria della capitale finlandese ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 79 km (a scartamento metrico) su 12 linee.
FRANCIA
PARIGI. Il 5 aprile la linea tranviaria 3b (tangenziale nord) è stata prolungata di 3,2 km da Porte d’Asnières a Porte Dauphine. La linea tranviaria di cintura forma ora un semicerchio che segue i confini del comune di Parigi per 29,5 km ed è spezzata in due distinti tronconi (linea 3a da Pont du Garigliano a Place de la Nation e linea 3b da Place de la Nation a Porte Dauphine). La chiusura completa del cerchio (da Porte Dauphine a Pont du Garigliano) non è per ora ipotizzata.
La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 187 km ed è composta da 14 linee gestite in modo indipendente (e per la maggior parte non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono due linee urbane tangenziali, sei linee periferiche, due linee di tram su gomma e quattro linee di tram-treno.
GERMANIA
· STOCCARDA (Baden- Württenberg). Il 18 ottobre la linea U5 è stata prolungata su un nuovo tratto di 0,7 km da Leinfelden Bahnhof a Leinfelden Neuer Markt.
La rete tranviaria di Stoccarda è un sistema di Stadtbahn (LRT) altamente protetto con uno sviluppo totale di 130 km (di cui 24,5 km in sotterraneo), 13 linee e una flotta di 204 veicoli. Vi è inoltre una linea a cremagliera (linea 10) lunga 2 km.
LETTONIA
· DAUGAVPILS. Il 25 gennaio la linea 5 è stata instradata su un percorso di nuova realizzazione fra Butlerovaiela e Stropu Ezers, lungo 1,8 km di binario unico: si è così creato un anello percorso nelle opposte direzioni dalle linee 3 e 5.
La rete tranviaria, a scartamento largo “russo” (1524 mm), è composta da 5 linee ed ha un’estensione totale di 29 km.
LUSSEMBURGO
· LUSSEMBURGO. Il 7 luglio l’unica linea tranviaria della città è stata prolungata da Lycée Bouneweg a Stadion su un nuovo tratto di 3,7 km, raggiungendo una lunghezza complessiva di 12,2 km (di cui 3,6 km senza catenaria).
Il parco rotabile è composto da 32 tram CAF Urbos 100 articolati da 45,4 metri a pianale interamente ribassato, equipaggiati con il sistema ACR a supercapacitori.
MAROCCO
· CASABLANCA. Il 24 settembre sono entrate in funzione le nuove linee T3 Gare de Casa-Port a Hay El Wahda (14.1 km) e T4 Parc de la Ligue Arabe a Mohammed Erradi (12.5 km). La città di Casablanca ha attualmente la maggiore rete tranviaria dell’Africa con quattro linee e un’estensione totale di 72,6 km. La flotta, tutta di produzione Alstom a pianale interamente ribassato, è composta da 124 tram Citadis 302 e 66 tram Citadis X05, per un totale di 190 veicoli. Tutti i vecoli sono bidirezionali ma con una sola cabina di guida, per cui devono viaggiare permanentemente accoppiati coda contro coda.
PAESI BASSI
· AMSTERDAM. Il 21 luglio la linea suburbana 25 è stata prolungata di 5,4 km da Amstelveen Westwijk a Uithoorn Centrum.
La rete tranviaria di Amsterdam conta 14 linee e si sviluppa in totale su 100 km.
POLONIA
· CRACOVIA. L’8 gennaio è stato attivato un prolungamento di 0,7 km delle linee 18 e 50 da Papierni Pradnickich a Gorka Narodowa.
La rete tranviaria di Cracovia è composta da 23 linee e ha un’estensione totale di 94 km.
· LODZ. Il 1° luglio è stata ripristinata la linea interurbana 43 (che era stata soppressa nel 2018) ma non raggiunge più Lutomiersk bensì è limitata a Konstantynow.
Attualmente, oltre a 3 linee interurbane (41 per Pabianice, 43 per Konstantynow, 45 per Zgierz) sono gestite altre 15 linee urbane. La rete tranviaria di Lodz, a scartamento metrico, ha un’estensione totale di 145 km.
· STETTINO. Il 28 giugno è stato inaugurato un nuovo tratto di 0,8 km fra Krzekowo e Osiedle Zawadzkiego su cui sono state prolungate le linee 5 e 7.
La rete tranviaria di Stettino (Szczecin) è composta da 12 linee con un’estensione totale di 54 km.
· VARSAVIA. Il 5 marzo è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,8 km nella zona centrale fra Reduta Wolska e Szpital Wolski, su cui sono state instradate le linee 10-11-26-27.
Il 14 maggio la linea 11 è stata prolungata su un tratto di 2,1 km di nuova costruzione da LiGoworka a Sielce (Czerniakowska).
Il 29 ottobre le linee 14 e 16 sono state prolungate verso la periferia sud-est da Spacerowa a Miasteczko Wilanów su un tratto di 6,3 km di n uova realizzazione.
La rete tranviaria della capitale polacca è composta ora da 25 linee con un’estensione totale di 132 km.
PORTOGALLO
· OPORTO. Il 28 giugno la linea E è stata prolungata su un nuovo tratto di 3,1 km nel territorio del comune di Vilanova de Gaia da Santo Ovídio a Vila d'Este.
Il sistema tranviario di Oporto comprende una rete moderna a standard di LRT (“Metro do Porto”, con 6 linee (A, B, C, D, E, F) per complessivi 70 km e una rete storica (“Carro eléctrico”) con 3 linee (1, 18, 22) per complessivi 9 km.
QATAR
· LUSAIL. L’8 aprile sono stati aperti al traffico 10,4 km di nuovi impianti tranviari (in parte sotterranei) ed è stata attivata la seconda linea (“Pink line”) da Legtaifyia a Seef Lusail north, mentre la “Orange line” (che era stata inaugurata nel 2018) è stata prolungata da Al Wessil a Rawdat Lusail.
In questa città-satellite che confina a sud con la capitale Doha sono in servizio 28 tram Alstom Citadis X05 con APS parziale.
REGNO UNITO
· BLACKPOOL (Inghilterra). Il 16 giugno è stata inaugurata una diramazione di 0,5 km da North Pier a North Station. Il servizio è stato riorganizzato su 3 linee: T1 (Starr Gate-Fleetwood), T2 (Starr Gate-North Station) e T3 (North Station-Fleetwood). La rete tranviaria ha ora uno sviluppo complessivo di 18,4 km; sono in servizio 18 tram Flexity2 di Bombardier.
Blackpool è rinomata anche per i suoi tram storici, tra cui 6 English-Electric “Balloons” a due piani che erano utilizzati in servizio regolare come servizio integrativo su una sezione della linea costiera (da Pleasure Beach a Little Bopsham). Il 6 dicembre 2024 la direzione dell’azienda ha annunciato la sospensione di tutti i servizi con tram storici, motivando la decisione con problemi di sicurezza e manutenzione e sostenendo che d’ora in poi l’attenzione si sarebbe focalizzata sui tram moderni. Quattro giorni dopo, viste le forti proteste, con un altro comunicato è stato annunciato che i tram storici torneranno a circolare in un non precisato futuro, dopo non precisati lavori di adeguamento.
ROMANIA
· RESITA. Il 20 dicembre è stato riattivato il servizio tranviario in questa città. Quella di Resita era una delle nuove reti che erano state inaugurate dal regime di Ceausescu negli anni Ottanta ma avevano dovuto chiudere dopo meno di 30 anni di servizio per prematura obsolescenza: il precedente sistema tranviario comprendeva due linee ed era stato aperto nel 1988 e chiuso nel 2011. La nuova linea ha uno sviluppo di 8,5 km e sono in servizio 13 tram Panorama prodotti in Turchia da Durmazlar..
RUSSIA
· EKATERINBURG. Il 17 febbraio la linea 9 è stata prolungata su un nuovo tratto di 1,7 km da Ul. Musorskogo a Luchistaya Ulitsa.
La rete tranviaria di questa importante città siberiana comprende 24 linee e si sviluppa su 95,4 km, piazzandosi al terzo posto in Russia (dopo San Pietroburgo e Mosca) e al primo posto in Asia.
· MOSCA. Il 23 settembre è stato inaugurato un nuovo tratto di 0,8 km in zona centrale tra Kostomarovskiy Most e Metro Ploschad Ilyicha, su cui è stata instradata la linea 2.
SPAGNA
· BARCELLONA. Il 10 novembre la linea T4 è stata prolungata da Glories a Verdaguer su un tratto di 1,8 km senza catenaria dotato di sistema APS. E’ in costruzione un ulteriore prolungamento lungo la Avenida Diagonal fino a Francesc Macià, che permetterà di connettere tra loro le due parti di rete tranviaria attualmente indipendenti (“Trambaix” a ovest con le linee T1, T2 e T3 e “Trambesòs” a est con le linee T4, T5, T6).
Attualmente la rete tranviaria di Barcellona si estende complessivamente su 31 km ed è gestita con una flotta di 45 tram Alstom Citadis di due generazioni.
· SIVIGLIA. Il 19 giugno l’unica linea esistente (T1) è stata prolungata su un nuovo tratto di 1 km fra San Bernardo e Eduardo Dato.
Il 18 novembre è stato inaugurato un ulteriore prolungamento di 0,5 km della linea T1 da Eduardo Dato e Luis de Morales, raggiungendo una lunghezza totale di 4,2 km.
STATI UNITI D’AMERICA
· MEMPHIS (Tennessee). Il 18 agosto l’intero servizio tranviario è stato chiuso per “ragioni economiche”. Ricordiamo che nel 1993 era stata aperta una rete di tre linee con uno sviluppo complessivo di 10 km e gestita con una flotta di 19 tram storici, poi chiusa per “obsolescenza e scarsa sicurezza” nel 2014 e infine riaperta progressivamente a partire dall’aprile 2018.
· SEATTLE (Washington). Il 27 aprile è stato inaugurato un tratto di 10,6 km della nuova linea 2 di LRT, per ora isolato, da South Bellevue and Redmond Technology. Sono entrati in servizio 30 nuovi tram Siemens S700 a pianale parzialmente ribassato, che si aggiungono ai 122 già esistenti.
Il 30 agosto la linea 1 di LRT è stata prolungata da Northgate a Lynnwood su un nuovo tratto di 13,6 km.
La rete tranviaria di Seattle ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 70 km ed è composta da due linee di LRT (63.6 km) più due linee di streetcar (tram tradizionale, 6,3 km).
TAIWAN
· KAOHSIUNG. Il 1° gennaio è stato inaugurato l’ultimo tratto di 4,9 km della linea di LRT della capitale, che è così diventata una circolare di lunghezza complessiva di 22 km. Con i prolungamenti, sono entrati in servizio 15 tram Alstom Citadis 305 dotati di supercapacitori, che si aggiungono ai 9 CAF Urbos già in servizio (dotati di sistema ACR). L’intera linea è completamente sprovvista di catenaria: la ricarica si effettua alle fermate tramite contatto dall’alto con apposite sezioni di alimentazione.
TURCHIA
· IZMIT. Il 17 marzo è stata inaugurata una diramazione lunga 3 km da Kanal Yolu – Sehir Hastanesi e contemporaneamente è stata istituita una seconda linea tranviaria.
La rete tranviaria di Izmit, il cui primo tratto era stato attivato nel 2017, si estende adesso complessivamente su 13,2 km con due linee e un parco veicoli formato da 28 tram di produzione turca.
· SMIRNE. Il 27 gennaio è stata inaugurata la nuova linea T3, ad andamento circolare nel quartiere di Cigli, che segue un anello di nuova costruzione di 9,9 km da Çevre Yolu a Katip Çelebi Üniversitesi.
La rete tranviaria di Smirne è composta da tre linee tra loro isolate, con un’estensione totale di 31,5 km e un pa

Giornata indimenticabile, quella del 15 dicembre scorso, per i soci dell'ATTS che hanno partecipato alla gita a Berna, affascinante città il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Lo scopo principale del gita era il viaggio sul tram a vapore che dal 2002 circola nuovamente a Berna, ma solo un paio di volte all’anno. Viaggiare sul tram a vapore è una grande emozione che fa rivivere ai torinesi i tempi delle tranvie extraurbane, negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento: erano i tempi in cui numerose linee di tram con trazione a vapore consentivano di raggiungere Torino da tante località della provincia.

In attesa del momento culminante della giornata, la visita a Berna è iniziata con una piacevole passeggiata lungo la via centrale, che dalla “fossa degli orsi” conduce alla stazione, con i portici e le caratteristiche fontane al centro. Qui abbiamo potuto pregustare il giro sul tram a vapore vedendolo passare con il caratteristico sbuffo di fumo bianco. Alle 13 è arrivato finalmente il momento di salire sulla vettura trainata da una locomotiva a vapore restaurata, che dal centro ci ha portati a un capolinea tranviario periferico, accompagnati dai simpatici volontari dell’Associazione Bernmobil Historique. Dopo una breve sosta per la foto di gruppo e per una bevanda calda, abbiamo iniziato il viaggio di ritorno tra lo sguardo stupito dei passanti. Il tram a vapore fu utilizzato sulla seconda linea tranviaria di Berna, dal 1894 al 1902, quando la rete fu elettrificata. La linea era esercita con otto locomotive e dodici rimorchi.

La giornata è proseguita, per una parte del gruppo, con la visita, riservata ad ATTS, al Museo del Tram, normalmente chiuso al pubblico. Dalla fermata presso la stazione ferroviaria, la linea tranviaria 3 ci ha portati al capolinea di Weissenbühl: abbiamo viaggiato su uno dei vecchi tram ABB Vevey che tra pochi mesi verranno dismessi dal servizio. Il ritorno è invece avvenuto su un Combino Siemens. Il Museo del tram, istituito nel 2006 da un’associazione di volontari, Tramverein Bern (TVB), presenta un’esposizione di tram di Berna di diverse epoche (metà anni ‘40, anni ‘60 e 1973). Siamo stati accolti da un socio volontario che ci ha accompagnati parlando un buon italiano. Molto interessante la descrizione della storia del trasporto di Berna con testi e fotografie, lungo un’intera parete del deposito.


Nella giornata di domenica 1 Dicembre 2024 a Torino si è tenuta la 18° edizione del Torino Trolley Festival, consueto appuntamento organizzato da ATTS - Associazione Torinese Tram Storici. Quest'anno l'evento ha trovato una quinta d'eccezione in piazza Statuto, ritornando nel centro città dopo la precedente edizione 2023 organizzata all'Allianz Stadium, nel quartiere Vallette, ove sicuramente non mancava lo spazio ma si perdeva un poco di "scenografia". La lontananza da piazza Castello quest'anno era dovuta principalmente alla concomitante maratona di Torino tenutasi nella stessa domenica ed ai lavori tuttora in corso sulla sede tranviaria di via Po.
All'appuntamento sicuramente molto sentito e partecipato di piazza Statuto (forse quasi più bello rispetto a piazza Castello grazie alla vicinanza con la Stazione di Porta Susa, alla presenza di spazi verdeggianti ed al poterlo raggiungere comodamente con la linea metropolitana GTT nonché ovviamente con la ferrovia) erano presenti le seguenti elettromotrici:
- elettromotrice 116 , serie 101/150, costr. Diatto-Siemens-TIBB del 1911, trasformata in motrice di servizio da anni '50 al 1976, indi preservata e ritornata in ordine di marcia nel 2006.
- elettromotrice 502, serie 501/506, costr. Ansaldo-Siemens-TIBB del 1924, trasformata in motrice di servizio T433 sino al 2000, recuperata prima staticamente e poi integralmente nel 2009
- elettromotrice 2592 , serie 2500/2599, costr. FIAT Materfer-TIBB-CGE del 1933, preservata dal 2009
- elettromotrice 2598, serie 2500/2599, costr. FIAT-TIBB-CGE del 1933, restaurata nel 2010, con mezza porta posteriore
- elettromotrice 2759, serie 2700/2771, costr. SNOS Savigliano del 1958, realizzata mediante unione casse motrici ex serie 600 e 700, preservata e funzionante dal 2012.
- elettromotrice 3179, serie 3100/3279, sottoserie 3165/3224, costr. FIAT Materfer-CGE del 1958, ricostruita da Seac Viberti nel 1976/77, modificata nel 2007 come Tram Teatro.
- elettromotrice 3501 , esemplare unico, costr. Officine ATM-CGE del 1946, con parti meccaniche della 3001 del 1942, soprannominata "la sposa".
- elettromotrice T427 , costr. Diatto-TIBB-CGE del 1911, trasf. ATM anni '50, dotata di nuova cassa nel 1989, vettura in origine ex serie 446/500, già 174/230 della "Belga".
- elettromotrice 447 ex ACEGAT Trieste, costr. OMS Stanga del 1938, poi STEFER Roma dal 1963, recuperata nel 2015 a Torino
- elettromotrice MRS 312 ex STEFER Roma, costr. Carminati & Toselli del 1935, serie 301/312, completamente ristrutturata onde esser preservata atta dal 2010
- elettromotrice 201 ex ATM Bologna , costr. Stanga del 1934, serie 201/229, preservata e ripristinata monodirezionale anche se nata bidirezionale, trasferita a STEFER Roma dal 1963 al 1980 in seguito accantonata e recuperata a Torino dal 2011.
A corredo della manifestazione erano presenti anche due veicoli su gomma preservati uno da Storicbus - Museo dell'Autobus Italiano di La Spezia e l'altro da un singolo privato:
- autobus Menarini M 201/2 NU da 10,5m ex matr. 18 di AMC Casale Monferrato (AL) del giugno 1988
- autobus Iveco 370S.12.30 Orlandi da 12m ex matr. 841 di SITA SUD dell'anno 1988.
Nelle foto alcune immagini delle protagoniste dell'evento, sia tranviarie che su gomma, colte nella ampia e verdeggiante piazza Statuto, oltre allo storico Iveco 370S ritratto anche all'incrocio tra via Cernaia e corso Siccardi/Ferraris.

La rete tranviaria di Berna (BernerStrassenbahn-Netz), attiva dal 1890, è uno dei pilastri del sistema di trasporto pubblico della capitale svizzera. Attualmente composta da cinque linee, tra cui la ferrovia Berna – WorbDorf, questa rete è costruita su binari a scartamento ridotto di 1.000 mm. Nel corso dei decenni, il sistema è stato testimone e protagonista dello sviluppo urbano e tecnologico di Berna, rappresentando un'importante testimonianza storica e culturale. Inizialmente, i tram di Berna erano alimentati da aria compressa, un sistema innovativo ma poco affidabile, successivamente affiancato dai tram a vapore nel 1894. Dal 1901, con l'elettrificazione della rete, i tram iniziarono a essere alimentati da corrente a 600 V CC, un cambiamento che segnò una svolta decisiva nella modernizzazione del trasporto pubblico cittadino.
Oggi, la rete è gestita da Bernmobil, denominazione commerciale adottata nel 2000 dalla Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB). L'azienda coordina un sistema integrato che comprende cinque linee tranviarie, tre linee di filobus e sedici linee di autobus, garantendo collegamenti efficienti tra il centro città, la periferia e i sobborghi. Dal 2006, la flotta si distingue per la caratteristica livrea rossa e comprende 57 tram, 28 filobus e 134 autobus. A completare l'offerta, un servizio notturno opera nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, servendo le principali zone della movida.

Un moderno Siemens Combino a 7 casse
Omnibus a cavalli
Il trasporto pubblico urbano a Berna ha origini risalenti agli anni Settanta del XIX secolo, quando venne inaugurato il primo servizio di omnibus a cavalli, noto localmente come Rösslitram. La linea, che collegava la Torre dell’Orologio (Zytglogge) con il villaggio di Wabern passando per l’odierna Eigerplatz, offriva un servizio limitato a quattro corse giornaliere. Tuttavia, la scarsa domanda e i costi elevati portarono presto alla bancarotta della compagnia, segnando un difficile inizio per il trasporto pubblico a Berna. Nel 1885, fu introdotto un nuovo servizio di tram-omnibus trainato da due cavalli, con corse più frequenti — ogni mezz’ora o ogni ora — lungo un percorso che collegava la stazione ferroviaria a Bärengraben, esteso in seguito fino al cimitero di Bremgarten. Nonostante l’espansione, anche questo progetto non riuscì ad attrarre un numero sufficiente di passeggeri e fu interrotto nel 1889.

Omnibus trainato da cavalli per Wabern nel 1885. Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil#/media/Datei:Berner_Pferde-
Omnibus_1885.jpg
Tram aereo
Nel 1888 fu fondata la Compagnia Tranviaria di Berna (BernerTranway Company, BT), che ricevette, il 18 luglio 1889, una concessione di 80 anni dall’Ufficio Federale dei Trasporti (EAV) per gestire le linee tranviarie municipali della città. La costruzione della prima linea iniziò immediatamente e il 1° ottobre 1890 entrò in funzione il servizio inaugurale. I tram, noti come Lufttrams (tram aerei), utilizzavano un sistema ad aria compressa sviluppato dall’ingegnere parigino Louis Mékarski. La linea I collegava Bärengraben (Fossa degli Orsi), sede del deposito, alla stazione ferroviaria e al cimitero di Bremgarten. Ai capolinea, piattaforme girevoli permettevano di invertire il senso di marcia dei veicoli. Nonostante l’innovatività del sistema, l’aria compressa si dimostrò poco affidabile: nei mesi invernali, le tubazioni spesso si congelavano, interrompendo il servizio anche per diversi giorni. Questo limite tecnico evidenziò la necessità di soluzioni più stabili e segnò il declino di questa tecnologia.
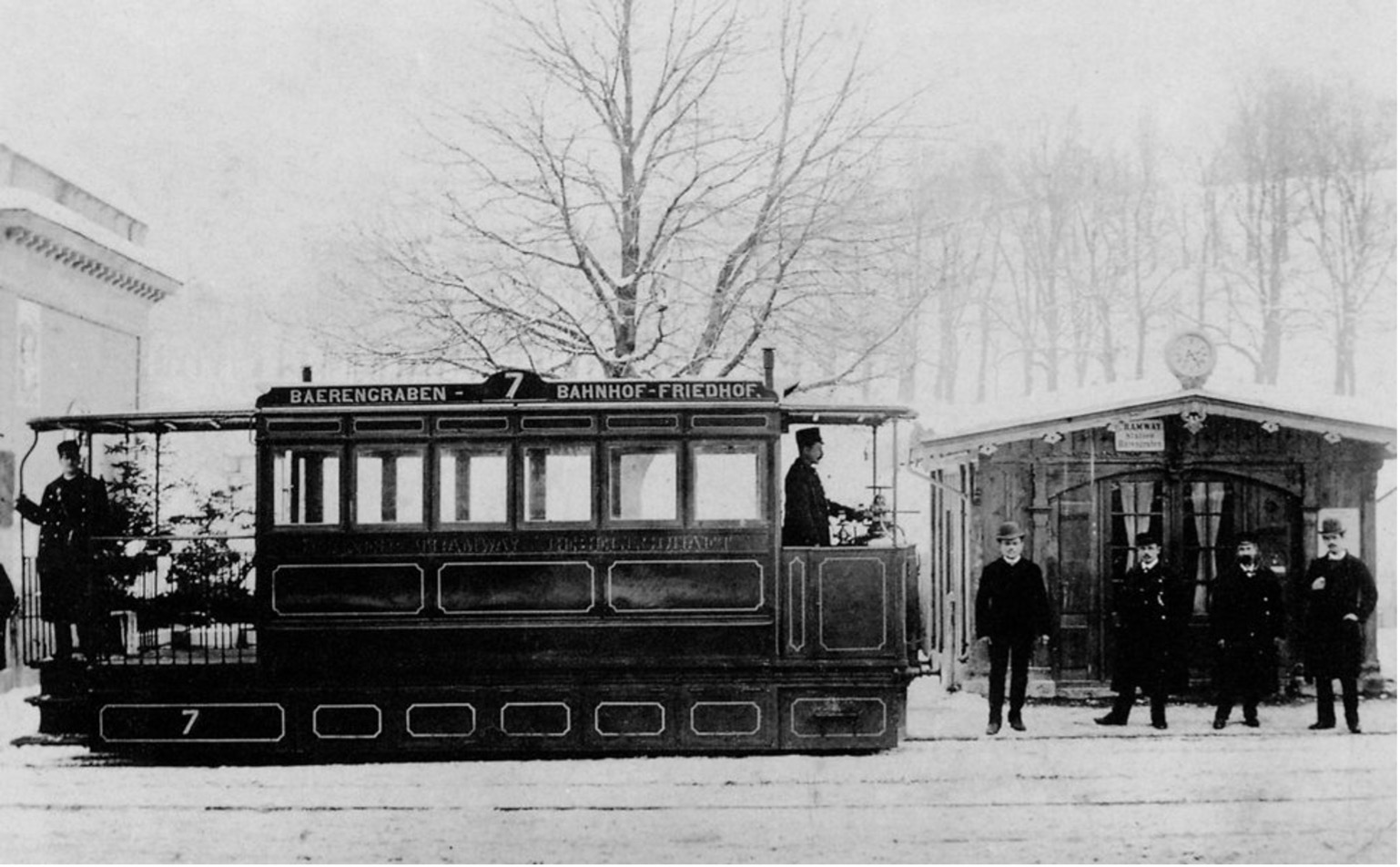
Tram aereo del 1890.
Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil#/media/Datei:Wagen_Nr._7_der_Berner_Druckluftstrassenbahn_ca._1890_beim_B%C3%
A4rengraben.jpg
Tram a vapore
I limiti tecnici dei tram aerei, aggravati dalla complessa topografia di Berna, portarono nel 1894 all’introduzione della seconda linea tranviaria, questa volta alimentata a vapore. La nuova linea, inaugurata il 17 maggio e denominata linea II, collegava il quartiere di Länggasse con il villaggio di Wabern, attraversando la stazione ferroviaria e Mattenhofquartier (Eigerplatz). Tuttavia, l’introduzione dei tram a vapore, una novità per un centro urbano svizzero, suscitò numerose proteste a causa delle emissioni, complicando ulteriormente il rapporto tra innovazione tecnologica e accettazione pubblica.

Tram a vapore del 1894. Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil#/media/Datei:Dampftram_G_3-3_12_(cropped).jpg
Elettrificazione
All’inizio del XX secolo, Berna seguì l’esempio di altre città svizzere e internazionali nel modernizzare la propria rete tranviaria. Un momento chiave fu il referendum del 1898, con il quale la cittadinanza approvò l’acquisto della concessione della Compagnia Tranviaria di Berna e la conversione della rete al funzionamento elettrico con linee aeree. Dal 1° gennaio 1900, la gestione della rete passò al nuovo dipartimento municipale StädtischeStrassenbahnen Bern (SSB), responsabile del trasporto pubblico cittadino fino al 1947. L’elettrificazione della rete iniziò nel 1901. Le due linee esistenti, il tram aereo (linea I) e il tram a vapore (linea II), furono convertite all’alimentazione elettrica, mentre una terza linea venne progettata e realizzata con tecnologia elettrica sin dall’inizio. La linea III, inaugurata nel 1902, collegava Breitenrain alla Zytglogge (Torre dell'Orologio) e a Burgernziel. L’espansione proseguì con la costruzione della linea IV, inaugurata il 27 giugno 1908, che introdusse un sistema radiale, collegando la stazione ferroviaria a Brückfeld. Nel 1911, la rete fu riorganizzata: la stazione ferroviaria divenne il principale nodo di scambio e i percorsi delle linee II, III e IV vennero modificati per ottimizzare i collegamenti.
Dalle lettere ai numeri
Nel 1912, le linee tranviarie furono inizialmente contrassegnate con lettere per facilitare l’identificazione dei percorsi. Tuttavia, il sistema risultò poco intuitivo e venne presto sostituito con la numerazione araba, ancora oggi in uso. Ogni capolinea ricevette un numero specifico, un approccio che semplificò notevolmente la comprensione del sistema per i passeggeri.
Crisi ed espansione (1914–1947)
La rete tranviaria durante la Prima Guerra Mondiale
L'espansione della rete urbana di Berna proseguì fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che segnò l'inizio di un periodo di crisi. La mobilitazione generale ordinata dal Consiglio Federale comportò l'arruolamento di numerosi dipendenti della SSB, causando gravi carenze di personale. La società fu costretta a ridurre le attività al minimo indispensabile, concentrandosi esclusivamente sui lavori di manutenzione più urgenti. L’inflazione e l’aumento dei prezzi delle importazioni aggravarono ulteriormente la situazione economica, obbligando il Consiglio Comunale di Berna a sospendere i progetti di ampliamento della rete tranviaria, precedentemente in discussione. Nonostante le difficoltà, il trasporto pubblico di Berna si dimostrò essenziale per la città. In un periodo di incertezze globali, la rete tranviaria continuò a operare, garantendo la mobilità necessaria per le attività quotidiane e il collegamento tra i principali quartieri, rafforzando così la resilienza della città.

Illustrazione di un tram in transito in Bubenbergplatz intorno al 1915.
Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Strassenbahn_Bern#/media/Datei:SVB21wiki.jpg
Tra le due guerre: ristrutturazione e innovazione (1918 – 1939)
Dopo la fine del conflitto, Berna intraprese una serie di interventi per migliorare e modernizzare la rete tranviaria. Nel 1930, importanti lavori di ristrutturazione trasformarono la zona di Bahnhofplatz e Bubenbergplatz, modificando l’aspetto urbano e ottimizzando i percorsi delle linee. Nello stesso anno, la SSB introdusse i pannelli colorati per segnalare i percorsi, un sistema che rimane in uso ancora oggi. Nel frattempo, la rete tranviaria raggiunse uno sviluppo complessivo di 18,2 km nel 1932. Parallelamente, fu avviata un’operazione di rinnovo della flotta, che vide la ristrutturazione del materiale rotabile esistente. Tra le innovazioni principali, gli archetti furono sostituiti con pantografi e vennero immessi in servizio due nuovi tram motorizzati a quattro assi del tipo Be 4/4. In campo urbano, un'ulteriore evoluzione si verificò nel 1922 con la nascita della SOB (Stadt-Omnibus Bern), una nuova azienda municipale che inaugurò, nel 1924, la prima linea di autobus urbani in Svizzera. Questo segnò l’introduzione del trasporto su gomma come alternativa complementare al tram

Illustrazione di Bahnhofplatz alla fine degli anni '30. Foto da https://de.wikipedia.org/wiki/Strassenbahn_Bern#/media/Datei:SVB15wiki.jpg
La Seconda Guerra Mondiale e l’introduzione del filobus
Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la rete tranviaria subì un nuovo rallentamento. Nel 1939, la mobilitazione generale sottrasse molti lavoratori alle SSB, portando a una riduzione dei servizi. Nonostante queste difficoltà, lo stesso anno la rete tranviaria superò per la prima volta i 20 milioni di passeggeri annuali, dimostrando la crescente centralità del tram nella vita cittadina. Nel 1940, una rilevante innovazione trasformò ulteriormente il sistema di mobilità urbana di Berna: il filobus. Introdotto inizialmente come mezzo complementare ai tram, il filobus trovò impiego su percorsi brevi, servendo le linee principali. La prima linea, inaugurata il 29 ottobre 1940, collegava Bärengraben a Schosshalde e venne estesa fino alla stazione centrale nel 1941. Durante il conflitto, la scarsità di carburante rafforzò ulteriormente il ruolo del filobus come componente strategica del trasporto pubblico, rendendolo un’alternativa più sostenibile agli autobus. Nel frattempo, la rete tranviaria continuava a evolversi: nel 1941, il tratto tra Zytglogge e Bärengraben fu chiuso, mentre il resto della rete fu convertito interamente a doppio binario. Nonostante le restrizioni e le carenze di materiali, il numero di passeggeri continuò a crescere fino alla fine del conflitto.

Illustrazione di filobus in transito sul ponte Nydeck nel 1941. Foto da https://bernmobil-historique.ch/trolleybus-13/
Dopoguerra: unificazione e consolidamento (1945 – 1947)
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il trasporto pubblico a Berna riprese gradualmente la normalità. Nel 1945 furono ripristinati gli intervalli regolari di cinque minuti, mentre l’anno successivo la linea 5/6 venne prolungata da Burgernziel a Ostring. Questo segnò il primo passo verso un’ulteriore espansione della rete tranviaria. Il 1° settembre 1947 rappresentò una svolta significativa: la fusione tra le due principali aziende di trasporto, la SSB e la SOB, portò alla creazione della Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB). La nuova entità introdusse una tariffa unica per tutti i mezzi di trasporto urbani e riorganizzò i percorsi delle linee tranviarie per ottimizzare il sistema. In questa occasione venne abolita la numerazione separata secondo i sensi di marcia, e il sistema delle linee assunse la forma che avrebbe caratterizzato il trasporto urbano per i decenni successivi:
Linea 1: Stazione merci – Stazione ferroviaria – Brückfeld
Linea 3: Weissenbühl – Stazione ferroviaria
Linea 5: Länggasse – Stazione ferroviaria – Ostring
Linea 9: Wabern – Stazione ferroviaria – Campo militare
Linea 11: Fischermätteli – Stazione ferroviaria
Con la fusione, la SVB intraprese anche un programma di rinnovo del materiale rotabile, introducendo le prime carrozze tranviarie con flusso di passeggeri migliorato. La razionalizzazione del sistema, unita a queste innovazioni, pose le basi per un futuro più efficiente e sostenibile del trasporto pubblico bernese.
Conclusione
La fusione del 1947 tra SSB e SOB segnò la fine di un’era e l’inizio di una nuova fase per il trasporto pubblico di Berna. Questa unificazione non solo consolidò la gestione dei mezzi di trasporto urbani, ma introdusse innovazioni che prepararono il terreno per un futuro più moderno. Con una rete sempre più capillare e una gestione razionalizzata, il tram si affermò come elemento essenziale della mobilità cittadina. La storia del trasporto pubblico a Berna fino al 1947 è quella di una città che, tra sfide e cambiamenti, ha saputo adattarsi e innovare, ponendo le basi per un sistema che ha continuato a evolversi negli anni successivi.
Fonti Storiche:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernmobil
https://de.wikipedia.org/wiki/Strassenbahn_Bern
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt-Omnibus_Bern
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4dtische_Strassenbahnen_Bern
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckluftstrassenbahn_Bern
https://en.wikipedia.org/wiki/Trams_in_Bern
Fonti Moderne:
https://www.travel365.it/berna-come-muoversi.htm
https://ambientenonsolo.com/berna-e-il-concetto-di-integrazione/
https://www.itinari.com/it/location/tram-museum-bern

Una storia lunga 140 anni quella vissuta dalla tranvia Sassi-Superga, suggellata da un importante riconoscimento da parte dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) che ha assegnato la certificazione di storicità ai veicoli che fanno servizio sulla linea. Una dimostrazione del valore di una delle eccellenze di Torino che è di stimolo ad agire per garantire le condizioni per un futuro di sempre maggiore successo.

ATTS, che ha come missione la valorizzazione del tram come patrimonio storico e culturale della città, ha partecipato con entusiasmo all’organizzazione dell’evento garantendo l’accoglienza e l’accompagnamento degli ospiti per tutto l’arco della giornata. La tranvia Sassi-Superga è una linea storica in quanto utilizza esclusivamente veicoli d’epoca originali: le elettromotrici sono state costruite nel 1934, mentre i rimorchi sono i rotabili più anziani in servizio a Torino, già in dotazione alla funicolare Agudio fin dal 1884. Tutti i veicoli sono stati completamente revisionati e restaurati da una ditta specializzata nel 2000.

Sabato 30 novembre, davanti a un folto pubblico, è avvenuta la consegna della “Targa Oro”, che contraddistingue i veicoli storici omologati ASI, al convoglio composto dall’elettromotrice D2/D3, dal rimorchio D11/D12 (tipo “chiuso”, invernale) e dal rimorchio D13/D14 (tipo “aperto”, estivo). Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal Presidente ASI, Alberto Scuro, al Presidente GTT, Antonio Fenoglio, e al Presidente ATTS, Roberto Cambursano. Erano presenti la Presidente del Consiglio Comunale di Torino Maria Grazia Grippo e l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano.

La giornata è iniziata con un tour della città guidato dai soci ATTS per gli ospiti dell’ASI, a bordo di due tram storici (”Peter Witt” n° 2598 del 1933 e il “tram di Cinecittà” n° 312 del 1935) che, a metà mattina, hanno raggiunto la stazione di Sassi. Qui gli accompagnatori ATTS hanno condotto gli ospiti alla visita nel deposito/officina e nella sala espositiva storica della tranvia, ricca di cimeli storici, che ospita l’esemplare unico di tram a cavalli restaurato. Nel pomeriggio l’evento è proseguito con un viaggio sulla tranvia fino a Superga. La giornata si è conclusa nuovamente a bordo dei tram storici che hanno portato gli ospiti alle stazioni di Porta Susa e Porta Nuova.

Il collegamento, tra la borgata torinese di Sassi e la Basilica di Superga inizia nel 1884 con un originale sistema a funicolare, ideato dall’ing. Agudio. Nel 1935 avviene la trasformazione in tranvia a cremagliera ancora oggi in funzione con lo stesso parco rotabile. Tutti i veicoli sfoggiano un’elegante livrea rosso-crema con un filetto giallo-blu. L’alimentazione a 600 Vcc è fornita dalla terza rotaia tramite appositi pattini di presa corrente, di cui tutte le motrici sono dotate. In 90 anni di servizio i tram D2-D3 hanno percorso oltre un milione e mezzo di chilometri trasportando milioni di persone.
Foto a cura di Studio DB Agency
Nell'ambito della preservazione del patrimonio storico di Torino, il restauro di tram circolanti nel secolo scorso ha assunto un ruolo sempre più rilevante. La motrice 614, parte della storica serie 600 dell'Azienda Tranvie Municipali (ATM) di Torino, rappresenta un esempio affascinante di come la tecnologia moderna possa rivitalizzare il passato. Grazie all'uso di sofisticati software di simulazione, è possibile valutare se la vettura sia idonea o meno a tornare in servizio, garantendo la sicurezza e l’affidabilità richieste per un mezzo destinato al trasporto pubblico. Realizzato alla fine degli anni Venti (1929) e operativo fino ai primi anni Sessanta, questo tram è stato recuperato e preservato dall'Associazione Torinese Tram Storici (ATTS), la quale nel 2023 ha avviato i lavori di restauro. L'associazione ha coinvolto il Politecnico di Torino per eseguire un’analisi simulativa avanzata sul comportamento dinamico della vettura, con l’obiettivo di certificarne la sicurezza per un possibile impiego come mezzo turistico.

Dell'originale motrice 614, l’unico elemento recuperato fu la cassa, abbandonata per anni in un parco lungo le rive del Po, nel comune di Gabiano (AL), dove subì un deterioramento dovuto all’esposizione agli agenti atmosferici. Nel 2013, ATTS decise di recuperarla con l’obiettivo di restaurarla, ma il progetto riuscì ad avviarsi solo nel 2023 grazie alla donazione di un socio ATTS e al sostegno della Fondazione CRT. Data l’assenza di alcuni componenti originali della vettura, si è reso fondamentale recuperare parti provenienti da motrici di altre serie, in particolare alle serie 2700 e 2800 (i caratteristici tram arancioni ancora in circolazione a Torino), simili alla serie 600. Per assemblare questi componenti, è stato indispensabile realizzare adattamenti capaci di resistere alle sollecitazioni durante la marcia, i quali sono stati verificati strutturalmente tramite software di calcolo avanzato per garantirne l'integrità strutturale.

La collaborazione con il Politecnico di Torino e la simulazione dinamica
Il restauro della motrice 614 ha coinvolto non solo l’aspetto estetico, ma anche la parte meccanica e strutturale, grazie a una serie di analisi tecniche e simulazioni dinamiche eseguite dal Politecnico di Torino con il software di simulazione “SIMPACK”. Basato sulla logica multibody, il programma simula l'interazione tra i vari componenti della motrice come corpi interconnessi attraverso forze, vincoli e gradi di libertà. Questo approccio ha permesso di creare un modello virtuale della motrice per valutare parametri dinamici essenziali, come il coefficiente di deragliamento Y/Q, la sagoma limite e gli angoli di rollio, beccheggio e imbardata. Queste verifiche mirano a garantire la conformità della vettura alle normative di sicurezza, così da poterla omologare come mezzo turistico, trasformandola in un autentico “museo in movimento” per le strade di Torino.

Le simulazioni condotte con SIMPACK hanno permesso di valutare le prestazioni della motrice 614, concentrandosi sui tratti più critici della rete tranviaria torinese, corrispondenti alle curve più strette, con raggi che spaziano tra i 15 metri (le più ridotte della città) e i 30 metri. I test hanno confermato che, nonostante le modifiche e l'uso di componenti provenienti da altre motrici, il tram rispetta pienamente i parametri di sicurezza. In particolare, i risultati hanno mostrato che i valori chiave, come il fattore di deragliamento e la resistenza alle sollecitazioni dinamiche in curva, rientrano nei limiti imposti dalle normative ferroviarie, senza alcun problema relativo alla sagoma limite. Questi dati confermano la sicurezza della motrice 614, pronta per essere utilizzata sia come attrazione turistica sia come mezzo dinamico nel parco veicoli dell’associazione.
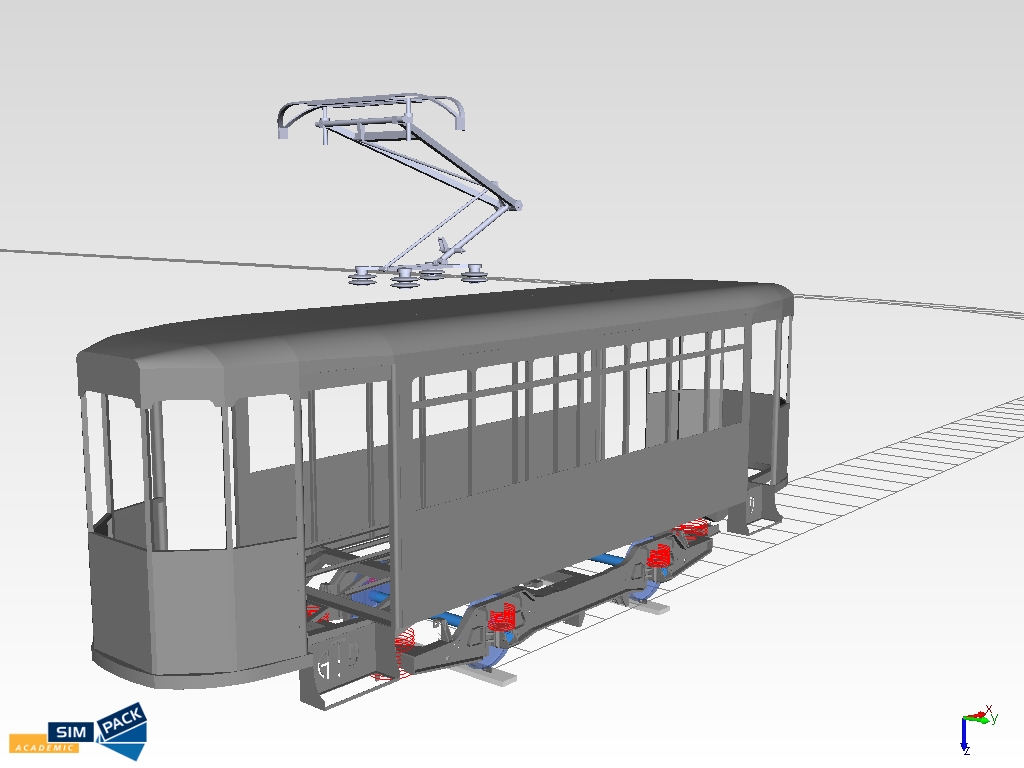
La storia del tram 614 dimostra come il restauro di veicoli storici possa diventare un progetto di valorizzazione culturale. Grazie all’impegno di ATTS e alle competenze tecniche e ingegneristiche del Politecnico di Torino, la motrice 614 potrebbe presto tornare a circolare, riportando in vita un pezzo della storia torinese e offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di compiere un autentico viaggio nel tempo.
*Federico Tripoli si è laureato, il 10 ottobre 2024, presso il Politecnico di Torino nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica – settore Trasporti - con la tesi “Simulazione del comportamento dinamico di un veicolo tranviario storico restaurato” con la votazione di 110 e lode su 110. La stesura della tesi è avvenuta nell’ambito di un tirocinio svolto presso l’ATTS nei mesi precedenti.
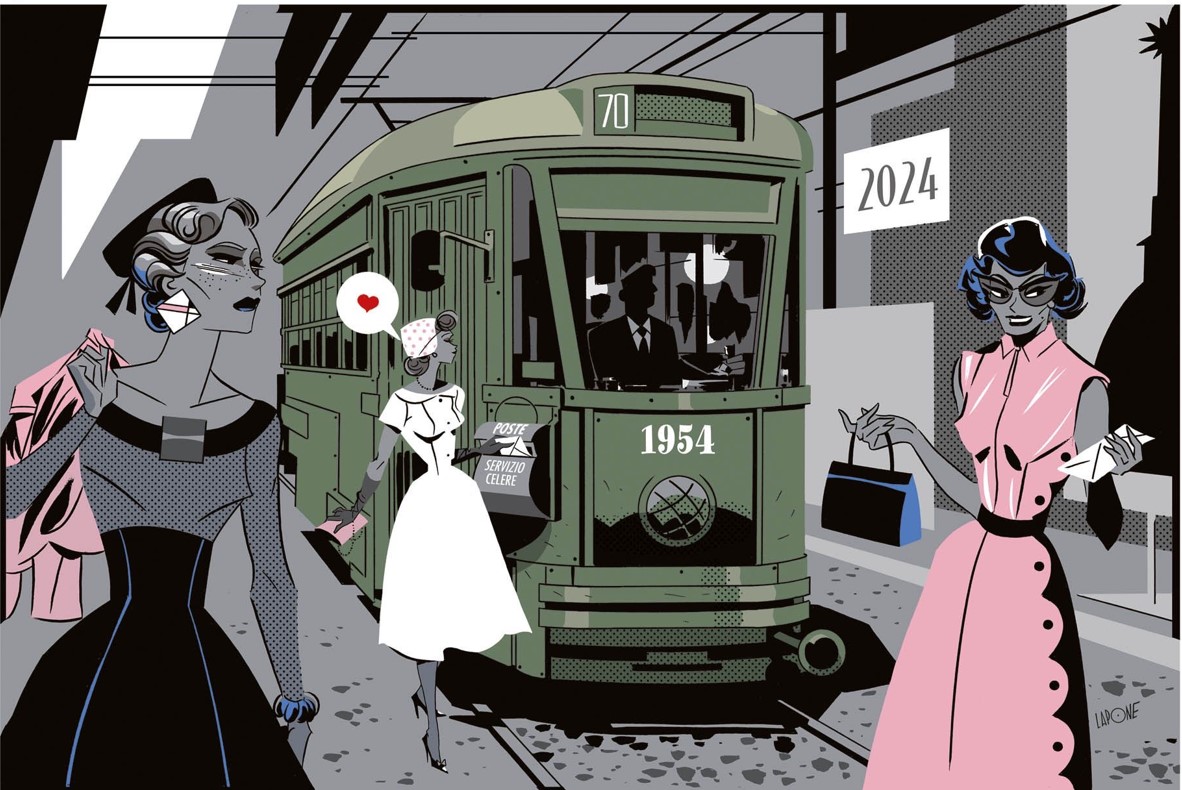
Cosa ci fa una cassetta postale su un tram?
Forse non tutti sanno che un tempo la posta viaggiava anche in tram. La necessità di raccogliere, trasportare e distribuire la corrispondenza postale ha richiesto nel tempo l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto che si rendevano di volta in volta disponibili. Anche le linee tranviarie, sia urbane che extra-urbane, hanno svolto questo compito, con modalità, intensità, diffusione e durata spesso diverse da paese a paese. Nel periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale sono noti servizi di questo tipo su diverse reti urbane ed extraurbane. Il servizio di “Posta Celere” fu reintrodotto in alcune città nel periodo 1952-54. In particolare, fu attivato su linee tranviarie (ma anche di filobus e autobus) in transito dalle stazioni ferroviarie di Napoli, Milano, Torino, Trieste e Roma per il rapido avviamento delle corrispondenze ai treni. A Torino il servizio fu inaugurato alle 11:30 del 27 novembre 1954 alla presenza del ministro delle Poste e telecomunicazioni on. Gennaro Cassiani, ma esistono corrispondenze annullate con questi bolli già nei mesi precedenti. Il cosiddetto “Avviamento Celere” o “Posta Celere” prevedeva nella parte anteriore dei tram circolanti sulle linee tranviarie che transitavano per la stazione di Porta Nuova la collocazione di una cassetta postale. Ad ogni passaggio presso la stazione ferroviaria la cassetta veniva svuotata e la corrispondenza riceveva il bollo “avviamento celere”, che permetteva un rapido inoltro della corrispondenza via ferrovia.
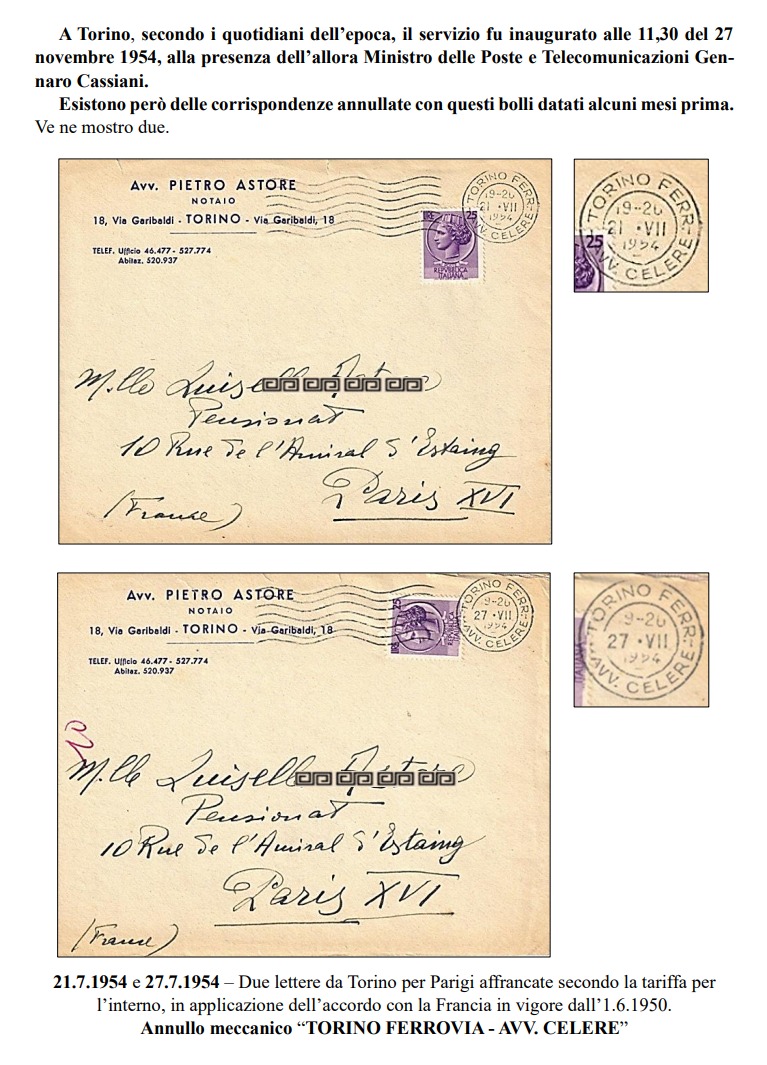
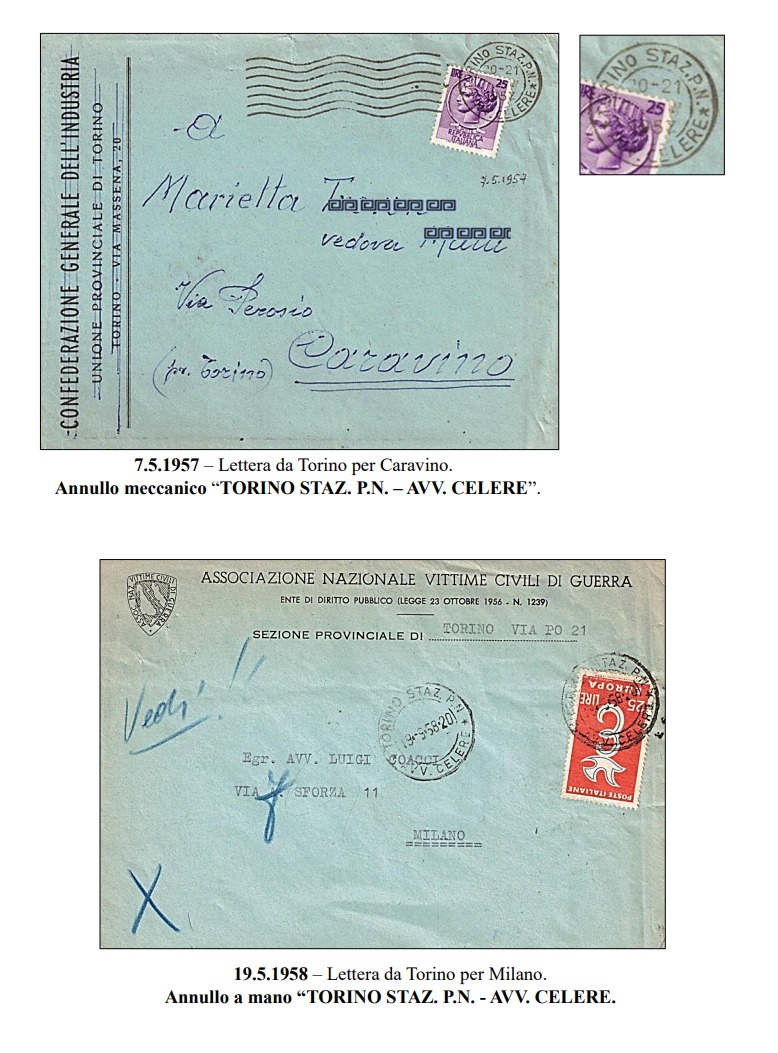
Documenti tratti dalla mostra realizzata da Unione Filatelica Subalpina
Sabato 28 settembre Atts, Poste Italiane, Associazione dei Circoli di Torino e provincia e Unione Filatelica Subalpina hanno realizzato un evento per ricordare questo servizio a 70 anni dall’inaugurazione. Il tram 2592 del 1933, in sosta per tutta la giornata in piazza Carlina e dotato dell’unica cassetta postale ancora in possesso dell’associazione ha accolto il pubblico di appassionati filatelici e non solo. Passanti, torinesi e turisti sono stati attratti da quello strano oggetto di colore verde, dalle forme arrotondate che mostrava i segni del tempo. Le scritte “poste” e “servizio celere” forse sono state un primo indizio per svelare un possibile utilizzo. Una volta saliti a bordo una mostra fotografica raccontava attraverso le immagini di buste, cartoline e anche di tram l’”avviamento celere”. La passione e la competenza degli addetti di Poste Italiane e dei circoli filatelici hanno accompagnato il pubblico alla scoperta di un mondo non molto conosciuto, ma affascinante. I soci Atts hanno raccontato le caratteristiche del tram, unico esemplare della serie 2500 modificato in alcune parti dopo un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Per l’occasione sono stati realizzati un annullo speciale, una busta con l’immagine di un tram e all’interno alla storia del servizio ed una bellissima cartolina, opera di Antonio Lapone. Tanti i visitatori che hanno provato a spedire la corrispondenza imbucandola direttamente sul tram: per tutti è stata la prima volta. Anche i soci ATTS presenti non si sono sottratti all’operazione immortalata da tante foto e video. Raccontare la storia dei mezzi di trasporto significa anche fare un viaggio nella storia della nostra società e delle trasformazioni che l’hanno pervasa e sono state così veloci e sconvolgenti negli ultimi decenni. Oggi si spediscono oggetti di tutti i tipi, ma le lettere viaggiano via internet e le cartoline sono un vezzo di pochi nostalgici o collezionisti. Pensare che solo settanta anni fa si cercava un modo per velocizzare la corrispondenza e questo si era realizzato grazie ai nostri amati tram, che all’epoca svolgevano un servizio essenziale e capillare ci fa un po’ riflettere e forse rendere orgogliosi della nostra missione di conservazione e tutela dei mezzi storici. Chissà…magari qualcuno dei visitatori del nostro evento durante il suo prossimo viaggio spedirà una cartolina e cercherà un tram alla ricerca di una cassetta dove imbucarla.
Per un breve video dell'evento clicca qui


Il tram con la cassetta postale e le operazioni di svuotamento della stessa
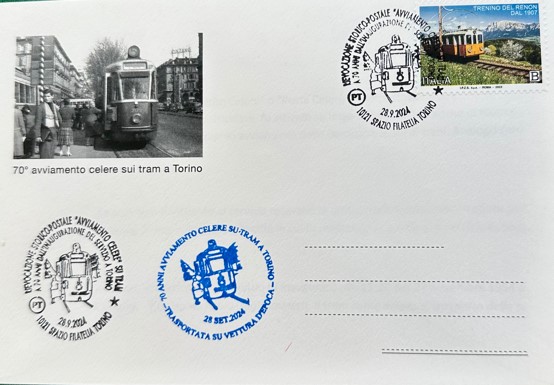 b
b 
La busta realizzata da Associazione dei Circoli di Torino e provincia e l'annullo di Poste Italiane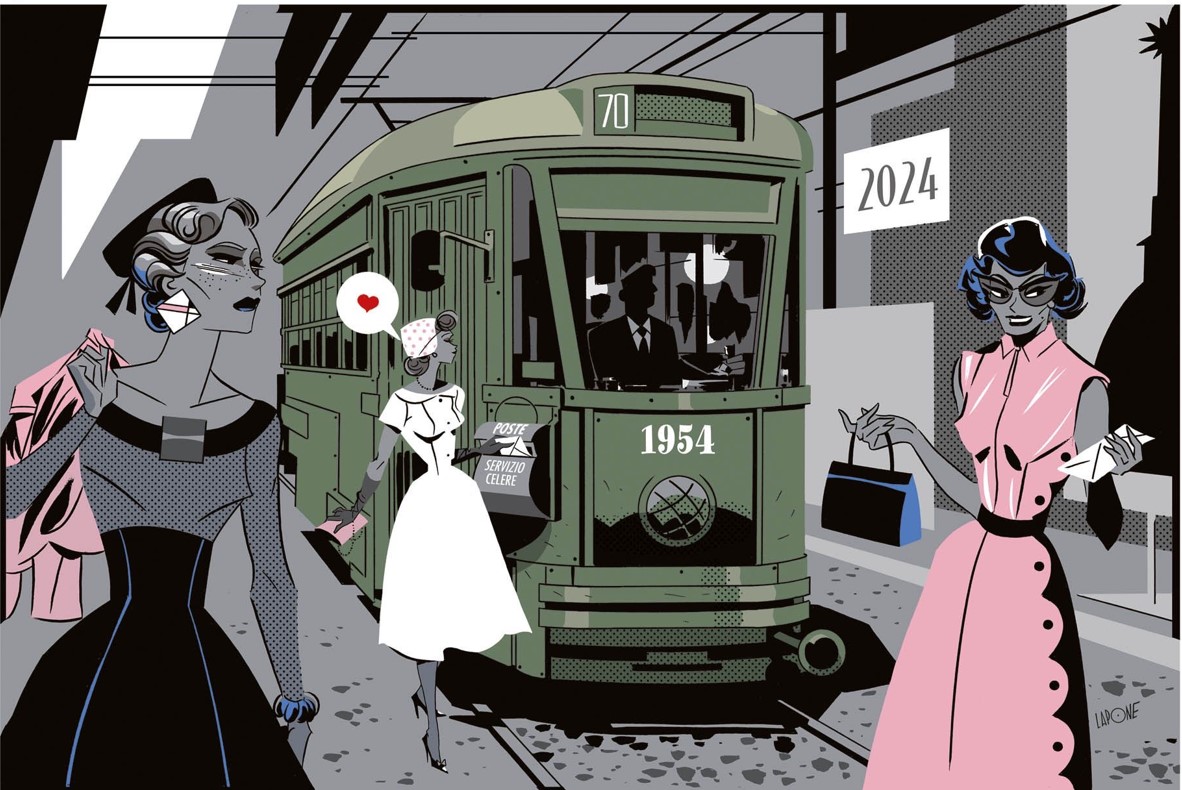
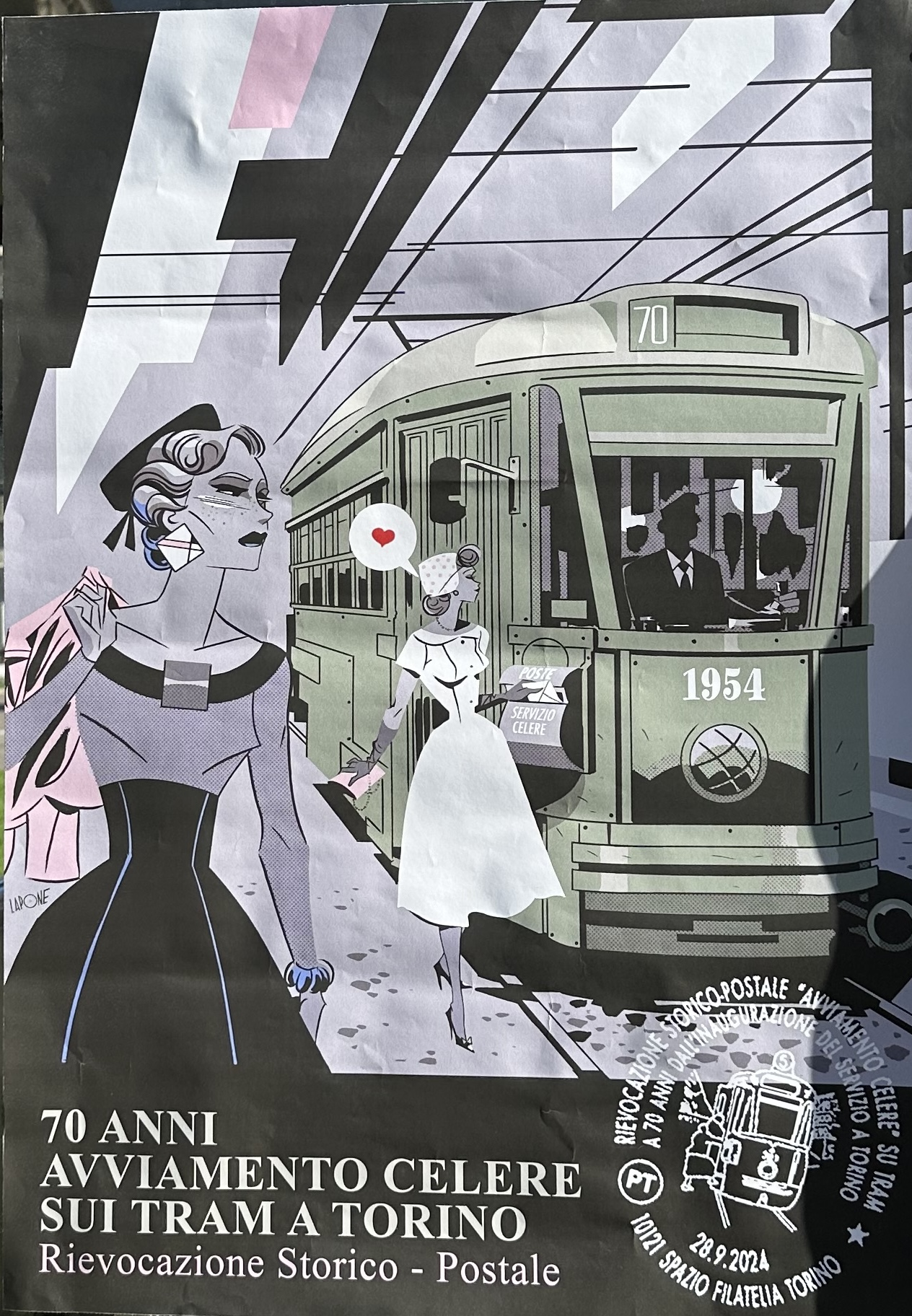
La cartolina e la locandina realizzate con la grafica di Antonio Lapone
A circa un’ora dal confine italiano del Brennero, nonché a 20 minuti e 40 km da Innsbruck, nella valle dell’Inn possiamo incontrare la cittadina di Jenbach, nota nel settore ferroviario per via della presenza in passato della Jenbacher Werke, conosciuta come "la Jenbach", costruttore di rotabili ferroviari. Presso tale località la stazione possiede una caratteristica particolare ovvero quella di essere l’unica stazione in Austria (ed una delle poche in Europa) in cui sono presenti ben tre scartamenti differenti: il classico 1435 mm di OBB Austria, il piccolo 760 mm della Zillertalbahn (noto come scartamento bosniaco) ed infine il classico scartamento metrico 1000 mm della Achenseebahn.
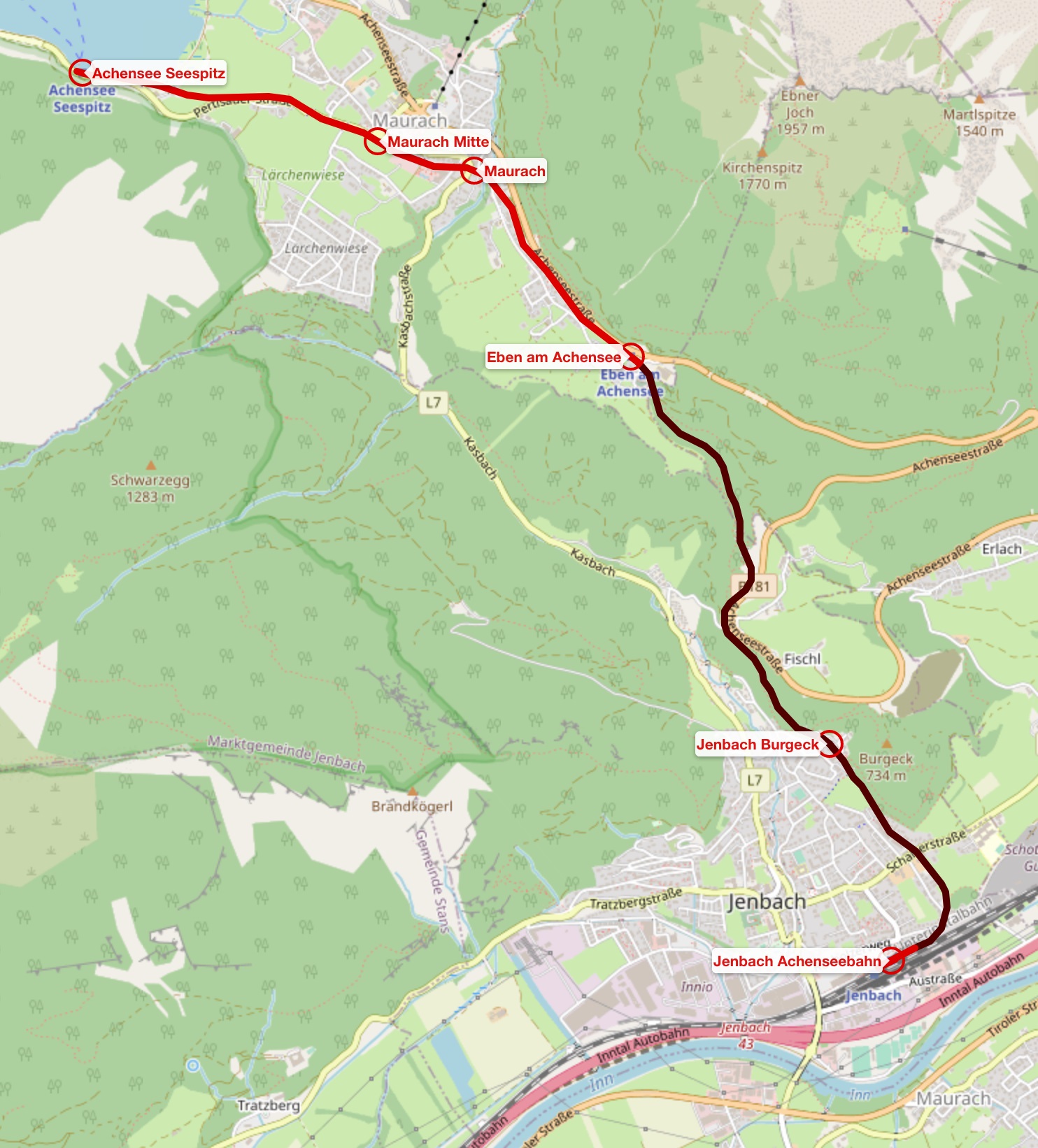
Il percorso della Achenseebahn (6,7 km) con indicato in rosso scuro il tratto a cremagliera.
Una ferrovia a vapore, scartamento metrico e cremagliera
La Achenseebahn o Ferrovia del lago Achen mette in comunicazione il paesino di Jenbach con il suddetto lago, il più grande del Tirolo. Si tratta di una linea di 6,76 km a scartamento metrico che si eleva per circa 440 m, passando dai 500 m di Jenbach per arrivare al bordo del lago a circa 930 m di altezza, toccando la punta massima presso la stazione di Eben a 940 m sul livello del mare. La rotaia centrale a cremagliera, tipo Riggenbach, inizia all’incirca a 176 metri dalla stazione di Jenbach ed accompagna ed agevola le locomotive a vapore sino alla stazione di Eben: circa 3,5 km con una pendenza del 160 per mille. Il restante percorso è ad aderenza naturale. La linea venne inaugurata nel Giugno 1889 con l'intenzione di utilizzarla come ferrovia turistica ma per un veto di un monastero locale (proprietario al tempo del lago, e che tra l’altro già gestiva la navigazione su di esso) non poteva raggiungere il bordo dello specchio d’acqua ma si doveva fermare qualche centinaio di metri prima. I passeggeri erano trasportati sino al lago attraverso una piccola ferrovia a scartamento 600 mm con forza motrice "a braccia". Nel 1916 questo tratto fu trasformato con lo scartamento metrico e nel 1929 fu acquisito dall’Achenseebahn.
Negli anni la ferrovia ha sempre fatto servizio senza essere ammodernata, solo nel 1971 venne rinnovata la stazione di Seespitz, punto di corrispondenza tra ferrovia e navigazione del lago. Un periodo di difficoltà fu nel 2018 a seguito del ritiro dei finanziamenti da parte del governo regionale del Tirolo in quanto “ferrovia turistica che funziona solo stagionalmente”. Peggiorata la situazione economica e fatiscenti i rotabili e parte dell'armamento, la ferrovia ha dovuto dichiarare fallimento e sospendere l’esercizio sino al 2022 quando venne fondata una nuova società.
Originariamente la proprietà dell’azienda era in carico ai Comuni della zona, Eben, Jenbach ed Achenkirch, mentre nel secondo dopoguerra per un certo periodo passò in mano alla Tiroler Wasserkrafte AG (TIWAG, ancora oggi esistente ed in mano alla Regione Tirolo), per poi tornare ai Comuni nel 1979. Oggi la proprietà è della “Achenseebahn Infrastructure and Operations GmbH”, fondata nel 2021: i Comuni locali ne controllano il 20%, la Regione Tirolo ne detiene il 60% e la vicina Zillertalbahn il 20%: quest'ultima è la responsabile della gestione operativa della Achenseebahn.
Esercizio e rotabili
Il percorso si sviluppa tra viste stupende e boschi immacolati (nonostante il vapore): partendo da Jenbach si incontrano le fermate di Burgeck (l’unica sul tratto a cremagliera), Eben (ove termina la cremagliera, con raddoppio), Maurach e Maurach Mitte (quest'ultima realizzata ed attiva solamente dal 2012) per arrivare infine a Seespitz. La linea presenta sostanzialmente solo due punti di incrocio: il primo presso la stazione di Eben (presso la quale durante l'orario estivo avvengono gli incroci e si attesta anche una coppia di corse per i villeggianti da Seespitz); mentre il secondo raddoppio è situato proprio poco fuori il capolinea terminale di Seespitz. Il servizio viene svolto da fine Aprile a fine Ottobre, ed è suddiviso tra un orario Primavera-Autunno (3 coppie di corse) e un orario Estivo che da metà Giugno a metà Settembre garantisce 5 coppie di corse più una sesta svolta solo sul tratto ad aderenza naturale tra Eben e Seespitz.
L’esercizio estivo avviene nel seguente modo: in direzione del lago od in “ascesa”, per ragioni di sicurezza la locomotiva spinge da valle in salita le due carrozze da Jenbach ad Eben sul tratto a cremagliera ed in pendenza, indi in tale stazione si porta in testa al convoglio per poi riportarsi in coda nuovamente al raddoppio situato poco vicino a Seespitz. Al ritorno invece la locomotiva rimane sempre in testa al convoglio.
Nel 1889 entrarono in esercizio 4 locomotive a vapore numerate 1-2-3-4 realizzate dalla Floridsdorf di Vienna su progetti della MFE MaschinenFabrik Esslingen (5,6 m per 18,2 tonnellate in servizio e una potenza di 180 cavalli, 132 kW); come di consueto ricevettero dei nomi, in questo caso curiosamente tutti maschili ovvero Theodor, Hermann, Georg e Karl. Tra le quattro la meno fortunata è stata sicuramente la 4 che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata utilizzata per recuperare pezzi di ricambio, mentre la 1 è rimasta coinvolta in un incendio nel 2008 ma è stata ricostruita l'anno successivo. Con i componenti dismessi da altre locomotive (la trasmissione della 3, il telaio della 2 e una nuova caldaia realizzata in Polonia) nel 2009 è stata rimessa in attività una nuova numero 4, battezzata "Hannah".
Le carrozze sono tutte originali: le "aperte" hanno i numeri 1-2-3-4 e sono state realizzate dalla Grazer Maschinen und Waggonbau Aktiengesellschaft nel 1889, azienda che costruì numerosi rotabili tranviari nell’Austria del tempo. Nel 1903 e 1907 sono state realizzate dalla MFE Esslingen invece le vetture "chiuse" numero 5 e 6.
Merita infine di essere citato il piccolo locomotore Diesel D1 che movimenta i rotabili sul piazzale del deposito di Jenbach: si tratta di una macchina realizzata dalla ditta Schöma nel 1949 e acquistata nel 1995 dalla Inselbahn Langeoog, ferrovia situata su un'isola nella Frisia orientale, in Germania. Curioso scoprire che Schöma è l'acronimo di Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH, azienda avente sede a Diepholz (non lontano da Brema e Bielefeld, Germania) e che tuttora realizza macchine da manovra, per cantieri e per miniere.
Un particolare e sentito ringraziamento va a Vittorio Cervigni, Ivan Beltramba ed Andrea Mattiato per la revisione dei testi.
FOTO
(Tutte del 20 e 22 Agosto 2024)

La locomotiva 1 "Theodor" è appena giunta a Jenbach con le vetture "aperte" numero 3 e 2 effettuando la corsa 108 del giorno 20 Agosto 2024, inizia a spostare le due vetture che verranno ricoverate sullo sfondo mentre il "Theodor" andrà a riposarsi nel capannone successivo. E' interessante notare come sul piazzale Achenseebahn di Jenbach i treni arrivino e scarichino i passeggeri presso un binario e partano invece da un altro differente.

La vettura "aperta" 1 ritratta al capolinea terminale di Seespitz a pochi metri dal lago. La vettura risale al 1889 anno di apertura della linea, analogamente alle altre vetture "aperte" 2, 3 e 4 utilizzate tutte e quattro nella stagione estiva mentre probabilmente nei mesi primaverili ed autunnali vengono impiegate anche le vetture "chiuse" 5 e 6. Da notare le ampie piattaforme sulle quali il personale della ferrovia aiuta le famiglie a caricare passeggini e biciclette.

La locomotiva 1"Theodor", realizzata dalla Floridsdorf di Vienna nel 1889 e dedicata al paese di Jenbach. Da notare la pendenza del piano della locomotiva e il cappellino del fuochista con il simbolo aziendale.

Al mattino del 20 Agosto 2024, la locomotiva numero 3 "Georg" intitolata ad Achenkirch (Comune principale posto sul lago omonimo Achensee) con le carrozze "aperte" 1 e 4, si appresta ad effettuare manovra e posizionarsi poi sul binario di partenza in comune con il binario OBB. Sullo sfondo è possibile notare le altre due vetture "aperte" 2 e 3 che andranno a comporre l'altro convoglio della giornata insieme alla locomotiva 1 "Theodor".

La stessa composizione ritratta a Jenbach la ritroviamo 430 metri più in alto, presso il capolinea Seespitz, punto di partenza poi di un servizio lacuale con motonavi che possono accogliere il quadruplo dei passeggeri del trenino, visto l'alto movimento turistico della zona.

Presso il deposito di Jenbach vediamo la locomotiva 3 Georg impegnata nelle attività di caricamento del carbone; sullo sfondo in rimessa invece la locomotiva "Theodor" attende il suo turno per andare ad effettuare poi il secondo treno in ascesa della giornata.

La locomotiva 3 Georg è impegnata nelle varie manovre per andare a "prelevare" le vetture dopo aver effettuato rifornimento.

Il 22 Agosto 2024 la corsa discendente del pomeriggio era effettuata dalla locomotiva "Hannah", nata tra il 2008 ed il 2009 con componenti di altre locomotive della famiglia e una caldaia di nuova fabbricazione realizzata in Polonia. A tutt'oggi in effetti nessuna delle 4 locomotive risulta essere formalmente originale in quanto col passare del tempo sono state tutte dotate di componenti ricostruiti.

La carrozza numero 4 è facilmente riconoscibile in quanto è l'unica tra le quattro "aperte" ad esser dotata di livrea verde. Le vetture aperte 1-2-3-4 risalgono tutte al 1889, realizzate dalla Grazer Maschinen und Waggonbau Aktiengesellschaft di Graz,.

Il pomeriggio del 22 Agosto 2024 vediamo giungere a Jenbach la locomotiva 4 "Hannah" in arrivo da Seespitz, dal quale è partita 440 metri più in alto ed all'incirca 40 minuti prima. E' possibile vedere il punto ove termina la cremagliera Riggenbach, il cui inizio è identificato da un cartello con la lettera A.
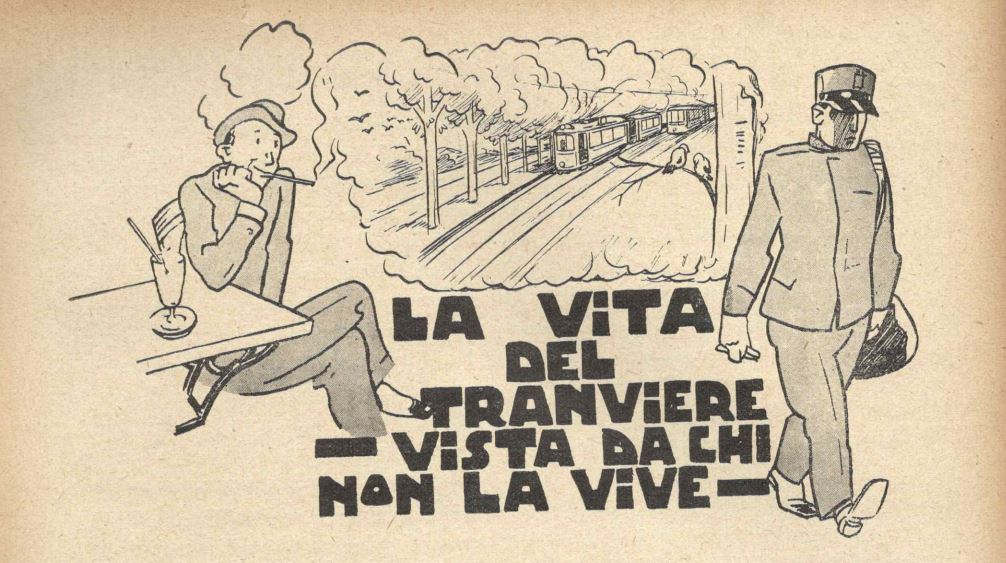
I gioielli possono essere realizzati con un'ampia gamma di materiali e per la loro fattura ci si affida a materiali e pietre preziose. I gioielli, quelli veri, non subiscono alterazioni nel corso degli anni mantenendo le proprie qualità, caratteristiche, prestigio e valore. E spesso accade che man mano passano gli anni il valore di essi aumenta. Per questo motivo oggi vi proponiamo un gioiello prezioso sia in termini tranviari che letterari, linguistici e storici. Un articolo scritto da Ugo Manunta e pubblicato nel numero di giugno del 1927 della Rivista dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino. Visto che, di fronte a tale originalità mancano le parole, lo trascriviamo tale e come è stato pubblicato…97 anni fa.
“Gli uomini, eterni schiavi di quel senso di incontentabilità che impedisce di assaporare la felicità assoluta, sono sempre pronti ad ammirare la bellezza esteriore delle occupazioni altrui, ma non sempre riescono a cogliere e ad apprezzare le condizioni vantaggiose del proprio mestiere. Eppure non v’è lavoro, sia pure umile e faticoso, che non presenti a chi lo osservi con un po’ di amore, almeno un lato interessante.
«Se nascessi un’altra volta…»: ecco la frase caratteristica di tutti gli scontenti. E’ inutile stare a sentire cosa farebbero, se potessero realizzare il miracolo di ritornare in fascie con l’esperienza di una vita già vissuta: su cento persone, novantotto almeno penserebbero certamente di iniziarsi alla facile carriera del… milionario; le altre due forse si accontenterebbero di meno, ma in fondo il miraggio dell’umanità è oggi eminentemente pratico.
Io, invece, se potessi ritornare indietro, non avrei rimorso di regalare a qualche altro che ne avesse bisogno, tutta quella poca esperienza che ho accumulato sinora. Credo cioè che considererei già come un grande dono la possibilità di poter vivere due vite. Ma -intendiamoci- due vite completamente diverse, perché credo che sarebbe noioso raddoppiare gli anni per insistere a battere una stessa strada.
Tutto ciò può sembrare paradossale, ma non lo è, in fondo, che in parte. Supponiamo per un momento che se potessi nascere una seconda volta mi toccasse di fare il tranviere. Non è evidentemente il mestiere più ideale e lucroso di questo mondo. Eppure, credete, che non mi adatterei? Tutt’altro. Mi sentirei invece di cogliere e di apprezzare qualche lato interessante del mestiere, giacché anche questo ne ha uno, e non trascurabile.
Intendiamoci: non che mi sia accorto di avere delle speciali disposizioni per questo mestiere. Lasciatemi però pensare che esso possa confacersi con un modo di vita che io considero ideale, e debba nello stesso tempo conciliare il lavoro col desiderio innato dell’osservazione.
Anzitutto io ho la convinzione che il tranviere sia continuamente alla ribalta della vita. La sua è una passeggiata continua. A volte lungo i grandi viali alberati; a volte lungo le arterie più congestionate. Una passeggiata a percorso fisso, a due binari, ma non è per questo priva di attrattive.
Il tranviere, dalla sua piattaforma, ha sempre un occhio sul convoglio e l'altro fuori. E’ il suo mestiere: vigilare il traffico all'interno del carrozzone e l’affluenza dei passeggeri dall’esterno. Due ordini di idee per ciascun occhio, due panorami diversi per ogni pupilla.
Se io fossi destinato nella mia seconda vita a fare il tranviere, credo quindi che potrei diventare l’osservatore per eccellenza, e che finirei per dondolarmi in una beatitudine spirituale senza confronti. Vivere per la gioia degli occhi. Pensate quale felicità sia mai quella di poter fissare per otto ore al giorno gli occhi su di un quadro continuamente mutevole com’è quello della strada? Non parlo dell’incalcolabile privilegio di poter camminare stando fermi in una immobilità dondolante. Il piacere fisico è una cosa troppo miserevole in confronto delle seduzioni intellettuali.
Parlo delle sensazioni che un uomo appena appena intelligente può cogliere quanto l’assillo del lavoro non lo costringa a guardare perennemente lo stesso ordigno o la stessa materia, e principalmente di quelle che ci vengono dalla grande realtà di sentirsi vivi: gioia senza confine che vi penetra nelle vene nei giorni di sole, che vi inebria al solo guardare lo sfondo verde di una collina, che sembra fatta di nulla, ma che in fondo è l’una gioia vera della vita. La gioia di vivere; il piacere di poter vedere il solo in tutto il suo splendore, il verde in tutta la sua chiarezza, la vita in tutta la sua fluidità veloce ed in tutte le sue armonie.
Il tranviere ha tante cose cui badare. Ma è un’attenzione che si concilia con l’altra. Sulla piattaforma, che è un posto di vedetta e di comando nel contempo, segue lo svolgersi dello scambio dei passeggeri. Che sale e chi scende: parodia della vita. Che si arrampica e si preoccupa della velocità del convoglio; chi si precipita a terra con un sospiro di soddisfazione. E intanto il tranviere vigila e con la leggera carezza di un dito su di un bottone elettrico dà il segnale della partenza.
Ma non è tutto - direte-: il tranviere ha pure da distribuire i biglietti e da vigilare che nessuno eluda la sua sorveglianza. E’ vero. Ma, vedete, se io fossi tranviere, troverei questa incombenza ancora più divertente delle altre. Già non è da disprezzarsi il privilegio di poter maneggiare tante belle monete di rame, di nichelio e d’argento, poiché, checchè se ne dica, il denaro ha sempre un tatto piacevole. Ed è bello, credete, poter dare a quelle monete per le quali si verificano le più cupe tragedie, un valore niente affatto personale. Non è più denaro, ma piccoli spezzati di rame e d'argento che a muoverli nella grande borsa di cuoio hanno un tintinnare di fronde battute dal vento: piccoli segmenti di sfera che si contano e si versano, a sera, senza che vi lascino fra le dita nessun marchio d’infamia.
Sapete, poi, che la profonda palestra psicologica debba essere quella che consente di poter esaminare migliaia e migliaia di esemplari d’uomini nel gesto di pagare?
Mettersi le mani nelle tasche del panciotto per versare in altre mani il proprio denaro è sempre un gesto seccante, e lo si fa, anche quando non sembri, a malincuore. Il tranviere osserva dunque anche in questo caso tutte le sfumature della psicologia umana. Osserva, e la sua anima a volte inondata di sorriso nei meriggi primaverili, a volte velata di tristezza, nelle giornate di pioggia, se ne compiace. Davanti ai suoi occhi passa veramente la vita, in tutti i suoi molteplici aspetti e nelle sue inevitabili deformazioni.
Fuori è il quadro d’assieme; l’umanità che si accalca, inseguendo infiniti ideali: gente che si urta per andar via più veloce, gente che si apparta nei lunghi viali ombrosi e che cammina lentamente invocando dal tempo altrettanta lentezza. Gente che si insegue, che si sorride o che si guarda in cagnesco, ma che in fondo dà alla vita il ritmo del suo tempo: quello della creazione.
Dentro, esposizione di soggetti, agglomeramento dei tipi più diversi. L’operaio, il giovanotto azzimato che sta in piedi per non guastarsi la riga dei pantaloni, matrone ansimanti, ragazzine profumate come serre di primavera che ostentano la bellezza di certe gambe tirate su alla trafila, uomini d’affari che inseguono cifre dappertutto, studenti bontemponi, bimbi irrequieti e chiacchieroni… Tutta la gamma della scala sociale insomma. Tutti i tipi: dal faceto al grottesco; dall’accigliato all’incosciente; dal bonaccione al maligno.
E il tranviere sempre lì, impassibile, come un giudice; osservatore, spesso dimenticato, di tutta una umanità; termometro infallibile della psicologia collettiva.
Convenitene: egli è veramente l’uomo della vita; l’uomo che a sera, rincasando, ha sempre da raccontare ai suoi qualche scenetta succosa, o qualche quadro grottesco, forse appena intravisto in velocità. E vi par poco avere sempre qualche cosa di vero da raccontare?
Pensate che descrittori meravigliosi della vita potrebbero essere questi spettatori!”
Fonte:
La vita del tranviere vista da chi non la vive, Ugo Manunta, Rivista ATM, anno III, numero 2, gennaio-febbraio 1928.
Didascalie:
Le immagini riportate illustrano l’articolo citato.

La nebbia creava sconcerto tra i passeggeri del tram suburbano n. 75 della Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur di Buenos Aires, i quali, lungi di abituarsi ad essa cercavano di non sommare un motivo di angoscia in più e di affrontare nel migliore dei modi l’inizio di una nuova giornata di lavoro.
Quella mattina infernale del mese di luglio, la nebbia si era impadronita di Buenos Aires e quella sporca e traballante vettura -affollata sin dal capolinea- continuava a fare salire dei passeggeri. Come dire di “no” a quei lavoratori -emigrati italiani molti di loro- che all’alba dovevano recarsi nelle fabbriche metropolitane per iniziare il proprio turno di lavoro che sarebbe durato circa 12 ore?
Sul tram della linea 105 che quel 12 luglio 1930 era partito poco dopo le cinque di mattina dal capolinea di Lanùs, gli argomenti di conversazione erano due: il debutto della nazionale di calcio nel prossimo Mondiale di Uruguay e la crescente consapevolezza –persino fra quelle classi sociali che di politica se ne intendevano poco- di un possibile colpo di stato.
Si trattava di un "tram operaio" termine con il quale venivano designate le linee tranviarie, di solito suburbane, che gli operai, apprendisti e donne di servizio prendevano per recarsi ai rispettivi lavori. Essi abitavano per lo più nelle periferie, in quartieri popolari che il passaggio del tram aveva contribuito a creare e si recavano quotidianamente ai propri lavori nelle case agiate, nelle fabbriche e nelle officine di Buenos Aires. Il tram partiva da Lanùs, municipio della periferia sud di Buenos Aires e ripercorreva 44 km prima di arrivare al capolinea nella stazione ferroviaria di Constituciòn in centro alla città. A separare l’agiata realtà metropolitana della lugubre periferia sud vi era il Riachuelo, un piccolo fiume che lungo il suo percorso era guarnito da alcuni ponti mobili costruiti in ferro. Tra questi, il funesto Puente Bosch, situato nel cuore dei quartieri industriali e portuali del capoluogo argentino.
A lamentarsi della nebbia c’era anche il comandante della piccola petroliera Itaca II che in quel momento navigava le torbide acque Riachuelo avvicinandosi a Puente Bosch. Come da regola, la Itaca II fece due fischiettii all’operatore del ponte per richiedere il passo e, Manuel Rodrìguez, cittadino spagnolo di 68 anni nonché operatore del ponte, iniziò la manovra di sollevamento dopo aver consentito la circolazione a due tram. Per farlo, accese prima le luci rosse che indicavano che la parte centrale del ponte, quella mobile, avrebbe iniziato a sollevarsi.
Intanto, il tram operaio manovrato dall’italiano Giovanni Vescio di 31 anni, faceva l’ultima svolta prima d’imboccare via Bosch, quella che dava il nome al ponte e permetteva di attraversare il Riachuelo da una sponda all’altra.
“Quando il ponte iniziava a sollevarsi – ricorda Manuel Rodrìguez- mi è parso di sentire il cigolio di un tram ed ebbi un sudore freddo. Mi affacciai alla finestra del mio casello e intravidi, nella nebbia, le luci dei finestrini del tram che aveva iniziato a percorrere la prima parte del ponte ad alta velocità.” Disperato, Rodrìguez iniziò ad urlare dal suo casello al manovratore (all’epoca chiamato “motorman”) di fermarsi; ma fu inutile, il tram marciava troppo veloce e anche se il manovratore l’avesse ascoltato non avrebbe avuto il tempo di arrestare la vettura. “Il tram passò sotto la mia finestra e secondi dopo lo vidi cadere in acqua.” Da quel momento il silenzio fu assoluto e agghiacciante, erano circa le 6:10 di una mattina d’inverno.
Non è possibile stabilire la quantità esatta di passeggeri sul tram n.75, ma si calcolò che vi erano tra 60 e 70 anime di cui solo 4 sopravvissero. Uno di loro, Remigio Benadassi, era salito sul tram al capolinea di Lanùs. Era uno dei tanti emigrati italiani, un meccanico di professione che si recava al suo lavoro nella Compañía General Fabril ed ebbe la fortuna di sopravvivere al disastro: “ero seduto davanti, vicino al finestrino e quando il tram imboccò via Bosch vidi le luci di pericolo e mi è parso strano che il tram non si arrestasse. Dopo una sensazione simile alla discesa in ascensore mi sono subito trovato in acqua. Non riesco ancora a capacitarmi come ho fatto ad uscire, penso si sia rotto il vetro del mio finestrino visto che ho una ferita da taglio alla fronte.”
Una task force formata da sub del Ministerio de Obras Públicas riuscì a recuperare 56 corpi. L’ultimo fu quello del motorman Giovanni Vescio, da quattro giorni dipendente dell’azienda. Era la sua seconda volta alla guida di un tram. La autopsia consentì di accantonare l'ipotesi di ubriachezza. Altrettanto successe a Manuel Rodrìguez, l'operatore del ponte che dopo qualche giorno di detenzione fu liberato in quanto non ritenuto responsabile della tragedia grazie a delle testimonianze che attestavano che egli avesse compiuto tutte le misure di sicurezza previste per l'innalzamento del ponte mobile.
Intanto entrambe le sponde del Riachuelo si riempivano di curiosi ed il loro chiasso diminuiva man mano i corpi venivano estratti dalle torbide acque. In quei momenti il silenzio era assoluto ed angosciante. Tra i corpi restituiti dalle acque del Riachuelo, vi era quello di un piccolo apprendista, un ragazzino di 14 anni che aveva ancora il suo panino in tasca.
Le polemiche
Mentre il paese intero era paralizzato dalla tragedia, la ricerca dei colpevoli sembrava inarrestabile. Persino Antoine de Saint-Exupéry, autore del Piccolo Principe e residente all’epoca a Buenos Aires nella veste di direttore della linea Aeropostale Argentina-Francia, scrisse nel suo diario: “Ho ascoltato una notizia tremenda. Nella bruma il manovratore del tram non avvertì che il ponte era stato aperto per consentire il passaggio ad una barca. Crìtica (noto quotidiano dell’epoca) afferma che l’unico colpevole è il governo per non eseguire i dovuti accertamenti”.
Malgrado le accuse che inizialmente gravarono sul manovratore Vescio, il processo concluse che l’incidente era dovuto a una falla meccanica in quanto la manovella che aziona il freno era difettosa per via dell’usura e, rimanendo inceppata non appena azionata, lasciò la vettura accelerata anziché consentirle di frenare. Il povero Vescio, che lasciava vedova e tre figli, era diventato un’altra vittima del tramonto del sistema tranviario della città di Buenos Aires.
La percezione sociale fu però quella di una colpa condivisa. Da una parte, dell'azienda tranviaria per non effettuare dei controlli tecnici nelle unità destinate agli operai. Dall’altra, lo stato quale istituzione assente al momento di controllare i gestori dei trasporti. E in mezzo vi erano 56 poveri lavoratori che hanno pagato con la propria vita le profonde crepe di un sistema tranviario che, qualche decennio dopo sarebbe crollato per non risollevarsi mai più.
Appena estratto dalle acque, a quel macabro tram n. 75 furono cambiati i motori e la vettura fu rimessa in circolazione con il numero 575 dove continuò a prestare servizio sotto la Corporaciòn de Transportes fino agli anni ’40.
Galleria Immagini


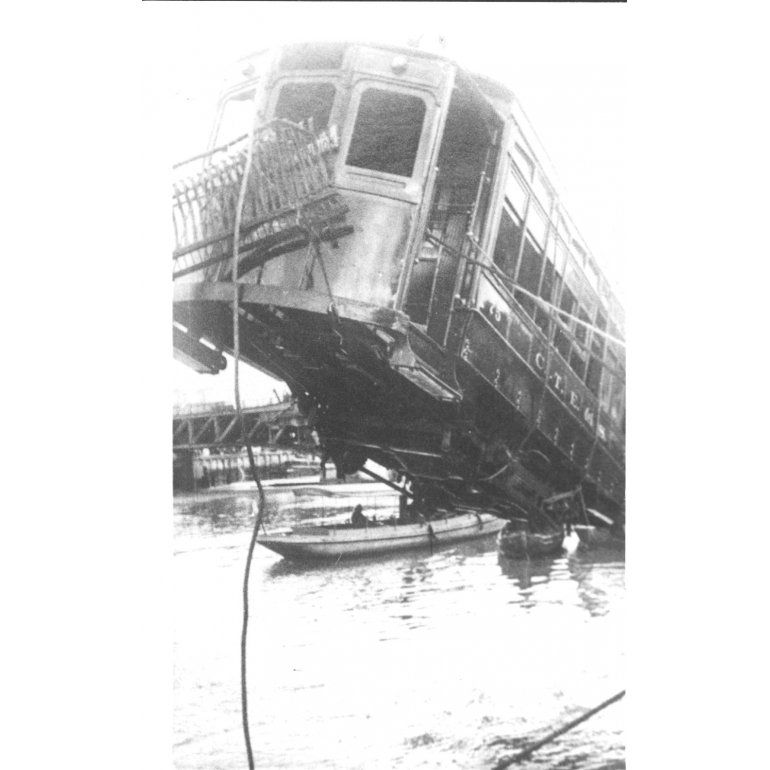
Foto 1 a 3: il recupero della vettura n. 75 dalle acque del Riachuelo.
La Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur (C.T.E. del S.), era stata fondata nel 1905 da capitali privati nazionali e nel 1930 contava con cinque linee tranviarie. La linea 105, nella quale prestava servizio il tram n.75, era stata inaugurata nel 1914. I tram di questa azienda erano di color rosso vino e la n.75 era una tra le cinque vetture a due assi, essendo tutte le altre della compagnia a quattro assi. I posti a sedere erano 36.
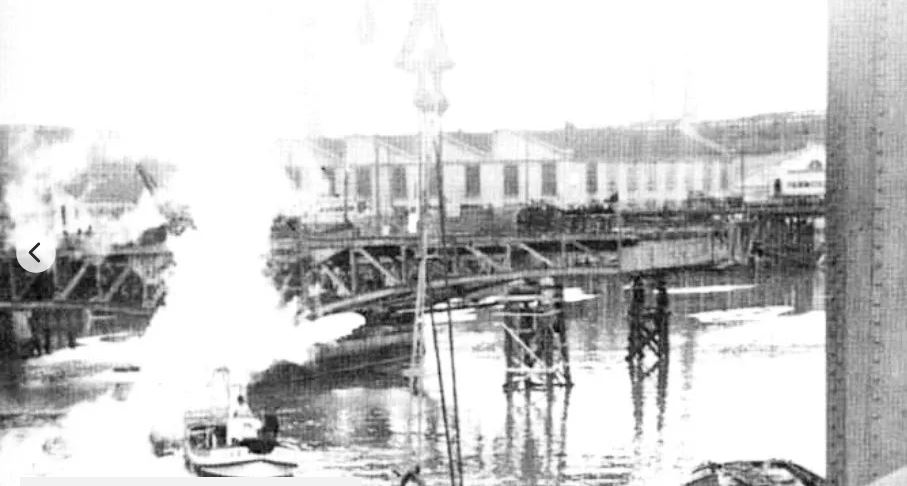
Foto 4: Immagine di Puente Bosch negli anni ’30.
Per arrivare a Buenos Aires, il tram doveva attraversare Puente Bosch sul Riachuelo un fiume que già all’epoca era la destinazione di tutti i rifiuti industriali delle aziende circostanti e le cui acque hanno ancora oggi un aspetto denso e nero difficile da descrivere. Riachuelo in spagnolo vuol dire “fiumiciattolo” ed è ancora il nome che viene dato al Rio Matanza vicino alla sua sfociatura nel Rio de la Plata. Sulla sponda destra c’è la città di Buenos Aires e sulla sinistra la periferia industriale e portuali del Comune di Avellaneda.
Una legge del 1901 autorizza la circolazione della linea tranviaria 105 e predisponeva altresì che la C.T.E. del S., avrebbe dovuto attraversare il Riachuelo per un ponte di loro proprietà. Quindi la C.T.E. del S. dovette costruire il ponte con i propri mezzi il quale fu inaugurato nel 1908. Il ponte si imbocca dalla via Bosch nel quartiere di Avellaneda.

Foto 5: Puente Bosch oggi.
Il ponte sul Riachuelo è notevolmente basso e mobile nella sua struttura centrale consentendo di sollevarsi per far passare le piccole navi che all’epoca ripercorrono il Riachuelo numerose. Dalla sponda di Buenos Aires vi era il casello per l’operatore del ponte incaricato di azionare i comandi ogni volta che una nave lo sollecitasse con due fischiettii. Pur essendo di proprietà dell’azienda tranviaria il ponte prevedeva due marciapiedi per i pedoni. Nel 1925 la sicurezza fu incrementata collocando delle luci rosse all'inizio e alla fine del ponte che venivano azionate quando il ponte iniziava ad sollevarsi.

Foto 6: questo è oggi il percorso nel senso in cui lo percorreva la linea 105.
Puente Bosch venne chiuso nel 2001, e dopo importanti modifiche strutturali fu reinaugurato per il suo centenario: nel 2008, questa volta senza rotaie, abilitato al transito ma con restrizioni di peso ed altezza delle vetture.
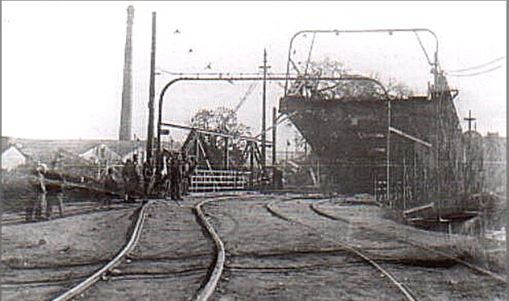
Foto 7: Puente Bosch sollevato all’epoca dell’incidente nello stesso senso in cui lo percorreva il tram.
Fonti
La tragedia del tranvìa obrero: https://web.archive.org/web/20160304103952/http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2007/07/01/z-04201.htm#
A 80 anos de un viaje trágico en tranvia: https://archive.vn/20121230224331/http://www.diasdehistoria.com.ar/content/80-a%C3%B1os-de-un-viaje-tr%C3%A1gico-en-tranv%C3%AD
Historias del Puente Bosch: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/historias-del-puente-bosch-nid1306323
56 cadaveres sepultados en las aguas del Riachuelo: https://www.diariopopular.com.ar/te-acordas-de/56-cadaveres-sepultados-las-aguas-del-riachuelo-n219275
Puente Bosch: https://en.wikipedia.org/wiki/Bosch_Bridge

La tranvia Sassi-Superga è uno dei tre impianti a cremagliera oggi in funzione in Italia (gli altri due sono a Genova e a Catanzaro) e uno dei sessantuno esistenti nel mondo, e vanta alcune peculiarità che la rendono interessante come attrazione turistica a sé stante. Fu inaugurata nel 1884 come funicolare (con il particolarissimo sistema Agudio) e trasformata in tranvia a cremagliera nel 1935.
Per il suo 140esimo anniversario che cade quest’anno, l’ATTS ha pubblicato il libro “Rotaie tra Sassi e Superga”, che fornisce tutti i dettagli storici e tecnici a chi vuole approfondire le sue conoscenze.
La tranvia Sassi-Superga è attualmente gestita integralmente con materiale rotabile originale d’epoca, una caratteristica davvero rara che testimonia il suo lungo e glorioso passato: le motrici sono state costruite nel 1934 e i vagoni rimorchiati sono ancora quelli della funicolare del 1884. La gestione fatta totalmente con veicoli storici è certamente suggestiva e di alta valenza culturale, ma la loro età avanzata suggerirebbe la precauzione, in analogia a quanto attuato su numerosi impianti simili all’estero, di integrare il parco rotabile con veicoli nuovi da impiegare nell’ordinario servizio, riservando quelli storici a un numero ristretto di corse speciali e assicurandosi in tal modo una loro sopravvivenza ancora per lunghi anni.
Che fare dunque? Per procedere in modo razionale alla formulazione di una proposta, esaminiamo anzitutto la situazione in altre realtà simili: nella tabella che segue sono riportate alcune linee a cremagliera oggi operanti nel mondo, selezionate in quanto comparabili alla Sassi-Superga per le caratteristiche tecniche seguenti:
· Esercizio con convogli bidirezionali di grande capienza;
· Lunghezza linea compresa tra 2 e 7 km;
· Massima pendenza superiore al 15,5%;
· Binario unico con punti di raddoppio per incrocio convogli;
· Scartamento non inferiore a 1000 mm;
· Cremagliera integrale su tutto il percorso;
· Tipo di cremagliera compatibile con passo dei denti=10 cm (Strub, Von Roll o Riggenbach);
· Alimentazione elettrica.
Come si può notare (la tabella che segue è in ordine cronologico secondo l’anno di entrata in servizio del materiale rotabile più recente), ad eccezione della linea di La Rhûne (situata nei Pirenei francesi) la Sassi-Superga è quella che ha in servizio ordinario il materiale più anziano. Per ognuna delle linee citate è anche mostrata una foto del materiale impiegato in servizio: tutti i veicoli più recenti sono stati fabbricati dalla casa svizzera Stadler, erede della altrettanto svizzera SLM e ormai praticamente monopolista mondiale degli impianti a cremagliera.
Tabella comparativa linee a cremagliera
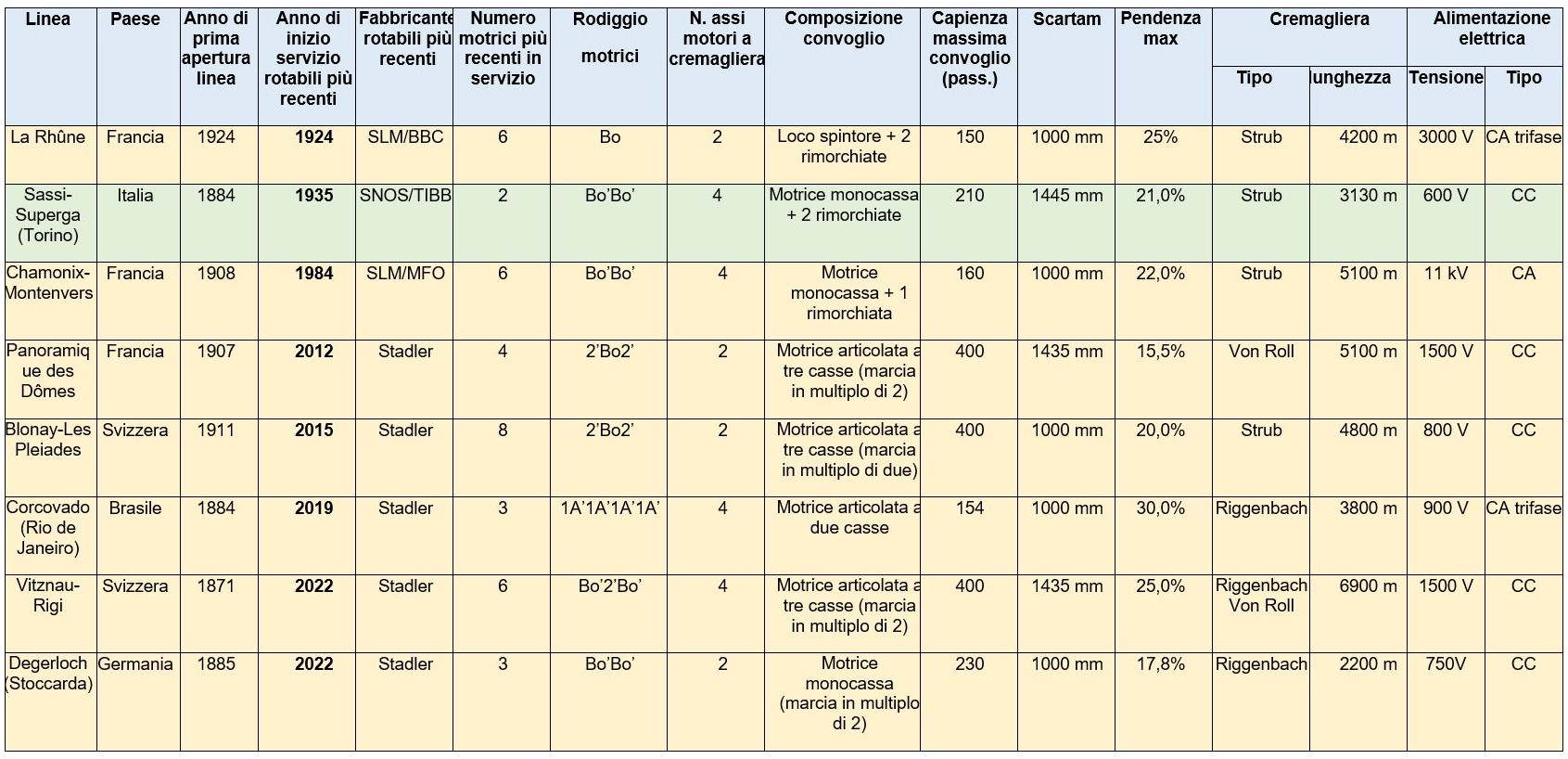

Figura 1: Linea St. Ignace-La Rhûne (Francia): convoglio formato da loco-spintore a 2 assi a cremagliera SLM e due rimorchiate, in arrivo al capolinea inferiore.
Foto R. Cambursano 2019.

Figura 2: Linea Chamonix-Montenvers (Francia): convoglio formato da motrice monocassa a cremagliera SLM e una rimorchiata, in partenza dal capolinea superiore.
Foto R. Cambursano 2019.

Figura 3: Linea Panoramique des dômes (Francia): convoglio di motrici a cremagliera articolate Stadler in doppia trazione, in arrivo al capolinea superiore.
Foto R. Cambursano 2019.

Figura 4: Linea Blonay-Les Pleiades (Svizzera): motrice a cremagliera articolata Stadler, in arrivo al capolinea superiore.
Foto S. Wohlfahrt 2023.

Figura 5: Linea Rio de Janeiro-Corcovado (Brasile): motrice articolata a cremagliera Stadler, in prossimità del capolinea superiore.
Foto www.tremdecorcovado.rio 2019.

Figura 6: Linea Vitznau-Rigi (Svizzera): convoglio di motrici articolate a cremagliera Stadler in doppia trazione, in transito a Rigi Staffel.
Foto Heitersberg-Lic. CC BY-SA4.0-2022

Figura 7: Linea 10 Stoccarda (Germania): motrice monocassa a cremagliera Stadler con carro trasporto biciclette, in transito al bivio per il deposito.
Foto Joma2411-Lic. CC BY-SA4.0-2022
La soluzione ideale per la Sassi-Superga sarebbe quella dell’acquisizione di due moderne motrici: la loro capienza le renderebbe adatte a tutte le situazioni, eliminando il ricorso a materiale rimorchiato e potendo essere gestite con un solo agente. Nel dettaglio, ogni motrice potrebbe avere le seguenti caratteristiche:
· Piena compatibilità di esercizio con il materiale storico esistente;
· Capienza 200 passeggeri (somma seduti + in piedi), comparabile con i 210 passeggeri degli attuali convogli;
· Lunghezza max. 34,5 m (comparabile con i 32,5 m degli attuali convogli)
· Larghezza 2,65 m (come oggi);
· Pianale parzialmente ribassato con 2 porte per lato allo stesso livello delle banchine (anziché pianale alto attuale);
· Velocità max. a pieno carico: 20 km/h (anziché 14 km/h attuali)
· Gestione ad agente unico (anziché con 2/3 agenti attuali)
· Alimentazione elettrica da terza rotaia a 600 Vcc (come oggi)
· Azionamento completamente elettronico con recupero energia in discesa (anziché dissipazione su resistenze attuale)
· 2 carrelli motori a cremagliera di estremità + 1 carrello portante centrale (4 assi motori a cremagliera totali)
· 2 casse lunghe di estremità + 1 cassa corta centrale, oppure 2 casse lunghe con carrello Jakobs centrale
· Possibilità di agganciamento del carro S21 per trasporto biciclette (ora non possibile con convoglio a tre pezzi).
Oltre ai considerevoli risparmi di gestione dovuti al minore impiego di personale e ai minori consumi, le elevate prestazioni dei veicoli moderni consentirebbero anche un potenziamento del programma di esercizio, con possibilità di cadenzare le partenze ogni 20 minuti nelle fasce di massima domanda (anziché ogni 30 minuti come attualmente). Ciò si tradurrebbe in un aumento della portata oraria massima della linea dall’attuale valore di 420 a 600 persone/ora, permettendo di soddisfare una domanda di trasporto crescente nelle giornate festive più cariche.
Allo stesso tempo, risulterebbe possibile effettuare corse integrative con il materiale storico (con posti prenotati e tariffa maggiorata, come avviene nelle altre realtà estere), mantenuto in servizio in modo molto meno intenso. Proprio acquisendo dei veicoli nuovi sarebbe perciò possibile salvaguardare al meglio quelli storici (che il mondo ci invidia!) e garantire loro una prospettiva di vita attiva di altri 100 anni.
Assodato che i costi di gestione risulterebbero quantomeno dimezzati e che gli introiti aumenterebbero, rimane da capire come finanziare l’acquisto di due veicoli che potrebbero costare almeno 4 milioni di Euro cadauno. Mi permetto di considerare che questa spesa non può essere messa a carico dell’azienda esercente, in quanto si tratta di un investimento straordinario, indispensabile per il buon funzionamento del “Sistema Superga” nel suo complesso, patrimonio della Città di Torino al pari della Mole Antonelliana e del Parco del Valentino. Intanto il tempo passa e le care vecchie motrici si avviano a compiere un secolo di vita….
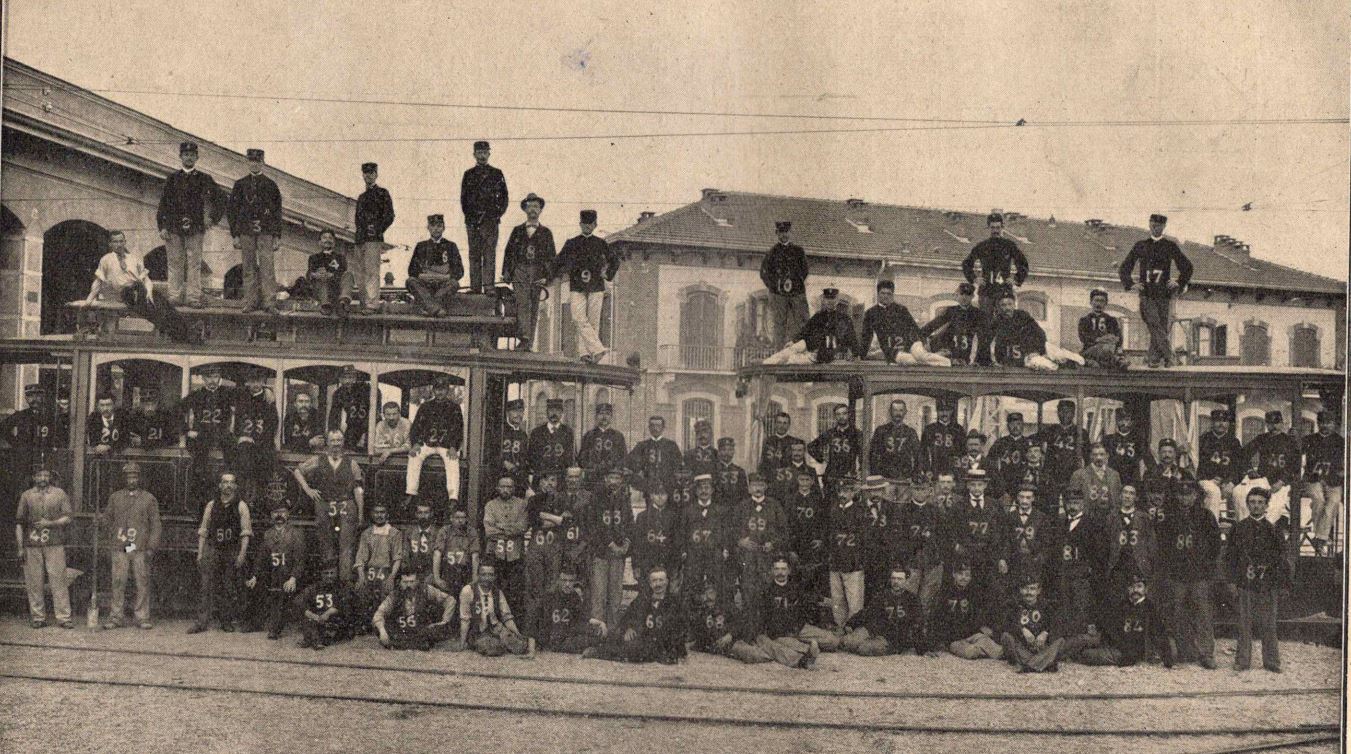
Come il Vaso di Pandora, gli archivi riescono a riportare in vita quegli episodi del passato che, inghiottiti dalla routine quotidiana, vengono poi risucchiati dal passare del tempo. Sembrano ormai scomparsi del tutto, senza che di loro rimanga nemmeno un ricordo, nessun sopravvissuto, nessuna fotografia, nessun resoconto.
Ed è proprio in questo punto che gli archivi ci richiamano per sorprenderci ancora una volta. All’interno di quell’aggregazione fatta di passioni individuali e collettive, di piccoli mondi in tempi ed epoche diverse, si trovano le tracce dei ricordi perduti.
ATTS (Associazione Torinese Tram Storici), tra le sue molteplici iniziative, conserva e cura un archivio storico, fotografico e documentale. Una raccolta di preziosi documenti e oggetti che forniscono un resoconto dei diversi passaggi della storia tranviaria della città. Tale patrimonio viene restituito al pubblico tramite i numerosi libri, articoli storici e mostre sulla storia dei mezzi di trasporto pubblici.
E’ ospite di questo archivio la Rivista ATM (Azienda Tranvie Municipale di Torino) che dal 1926 fu l’organo di comunicazione dell’ATM con i propri dipendenti e allo stesso tempo, funge da strumento per renderli consapevoli delle aspettative nutrite dall’ Azienda Tranvie Municipale di Torino nei confronti dei propri lavoratori.
L’Azienda Tranvie Municipale di Torino è nata il 28 novembre 1906, quando con 55 voti a favore e 12 contrari, il Consiglio Comunale di Torino deliberò il riscatto della rete tranviaria della Società Elettricità Alta Italia e la municipalizzazione del servizio tranviario torinese. Dall’ anno successivo e per i successivi 96 anni, l’ATM avrebbe trasportato generazioni di torinesi sopravvivendo a ben due guerre mondiali e al regime fascista prima di convergere, nel 2003, nell'attuale GTT (Gruppo Torinese Trasporti).
Nel 1927 l’Azienda Tranvie Municipale pubblica nella propria rivista un articolo del titolo “Quando l’azienda era… in fascie!.." L’articolo consisteva in una fotografia di 26 anni prima, cioè del 1901. In essa erano ritratti i dipendenti dell’allora Società Elettricità Alta Italia.
“Riteniamo di far cosa gradita pubblicando questa fotografia che risale al 1901 e quindi riproduce un gruppo di nostri compagni in servizio 26 anni or sono -si legge nel numero della Rivista ATM del mese di giugno del 1927- Non tutti, purtroppo, sono ancora presenti. A quelli ancora vivi e presenti, l’augurio di poterli ancora così fotografare fra altri…26 anni!”.
La pubblicazione della fotografia destò tale scalpore e curiosità tra i dipendenti che gran parte di loro si misero in contatto con la redazione affinché identificasse i dipendenti presenti nella fotografia. Difatti, erano trascorsi ben 26 anni e le fisionomie erano indubbiamente mutate. Perciò, nel numero successivo, agosto-ottobre del 1927, l’Azienda decise di accontentarli pubblicando nuovamente la fotografia. Questa volta era stato assegnato un numero ad ogni dipendente ritratto nell’immagine. Nella pagina a fianco, vi era l’elenco dei numeri con il nome di ogni impiegato e, per quelli ancora in servizio, le loro funzioni.
Prima di allora, ai tempi di quella foto, nel 1901 erano tutti dipendenti della Società Elettricità Alta Italia, società che ebbe a suo carico l’esercizio della prima linea tranviaria elettrica di Torino.
Il primo tram elettrico, corrispondente alla linea N.1 della società, fece la sua prima corsa per le strade di Torino la mattina del 4 aprile del 1898 in partenza da Piazza Castello e diretto fino all'Esposizione Nazionale di Torino. L’Esposizione Nazionale del ’98 contò con circa 8.000 espositori, 43 congressi e tre milioni e mezzo di visitatori e commemorava il cinquantesimo anniversario dello Statuto Albertino.
Il giorno prima, il 3 aprile una schiera di giornalisti torinesi avevano potuto visitare i locali della centrale elettrica della società e assistere a una dettagliata spiegazione su come l’energia elettrica veniva prodotta e distribuita lungo la rete tranviaria. Infine furono fatti accomodare in diverse carrozze a trazione elettrica e riaccompagnati al deposito di corso Regina Margherita.
Gli anni passarono, e il tram divenne una consuetudine di quelle che, in modo del tutto naturale, riescono nelle più ambiziose trasformazioni sociali. La Società Elettricità Alta Italia fu riscattata dal Comune di Torino diventando ATM e quest’ultima assorbì, nel 1922 le altre due concessionarie: la Societé Anonime Generale des Tramways de Turin (popolarmente detta Belga) e la Società Anonima Torinese Tramways e Ferrovie Economiche (popolarmente detta Torinese). E con quest’ ultimo passaggio il destino dei trasporti pubblici rimase segnato e gli sguardi, del tutto rivolti al futuro, non ripararono più in quella prima corsa del 4 aprile del 1898.
Finchè un giorno del 1928, a trent'anni di distanza, arrivò alla redazione della rivista ATM un'insolita missiva: redatta da Francesco Borgo, il fattorino che si trovavo in servizio in quella prima corsa a trazione elettrica.
“Domani, 4 aprile, ore 11 antimeridiane, compie il 30mo. anno dacché la prima vettura tranviaria elettrica di codesta On. Azienda uscì dal Deposito di corso Regina Margherita n. 14 per fare servizio da Piazza Castello all’Esposizione sulla linea N.1. Tutta Torino era ansiosa di vedere le nuove vetture elettriche ed io prestavo servizio quale fattorino su tale vettura”.
Francesco Borgo nutriva ancora dei sentimenti amorevoli verso quella che fu una delle sue prime esperienze di lavoro, e la prima del tram elettrico a Torino: “essendomi venuto in mente tale episodio, dopo 30 anni, mi onoro di significarlo all’On. Signor Direttore e con questo mio scritto, voglio notificare che mi ricordo sempre dei miei antichi superiori che ora Lei rappresenta: mi vanto d’aver appartenuto per 44 mesi alla famiglia tranviaria senza riportare mai né multe né rimproveri come risulta dal mio foglio matricolare.”
Dopo trenta anni Francesco Borgo ricordava ancora per filo e per segno i nomi dei colleghi: Brida, Calzia, Prono, Bonaudo, Carelli tra tanti altri e non nascondeva il suo rammarico per non essere riuscito a continuare la carriera tranviaria. “Essendomi stato caro il mio inizio di carriera -ricorda- sempre mi ricordo del servizio che dovetti abbandonare per ragioni particolari di famiglia, ma con grande rincrescimento. Spero, Egregio Signor Direttore, che vorrà gradire questa mia misera lettera e perdonarmi la libertà che mi sono preso.”
Naturalmente, il sig. Borgo ricevette una risposta dalla redazione della rivista ATM accompagnata dalla richiesta di fare pervenire la sua fotografia per essere pubblicata. Francesco ne inviò ben due: una che lo trattava nel 1928 e l’altra della sua gioventù.
L’articolo fu pubblicato nel mese di maggio del 1928 e il piccolo mondo di un giovane fattorino, in piedi sul predellino di quel primo tram elettrico la mattina del 4 aprile del 1898 sarebbe per sempre diventato l’appassionante mondo di tutti.
Fonti archivistiche:
Quando l’azienda era… in fascie!.., Rivista dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino - anno II, numero 3, pagina 117 - Archivio ATTS.
Rivista dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino, anno II, numero 4 (agosto-ottobre 1927), pagina 177- Archivio ATTS.
Il fattorino che 30 anni fa è uscito con la prima vettura tranviaria elettrica in Torino, Rivista dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino - anno III, numero 2 (maggio 1928) pagine 90-91 - Archivio ATTS.
Didascalie:
Foto 1: Dipendenti della Società Elettricità Alta Italia nel 1901. La foto fu pubblicata nel numero 4 della Rivista ATM, anno 1927. La foto riporta un numero assegnato ad ogni dipendente così da consentire la loro identificazione.
Foto 2: elenco dei dipendenti che accompagnava la precedente fotografia nell’articolo pubblicato nella rivista ATM del 1927.
Foto 3: Francesco Borgo, fattorino del primo tram elettrico di Torino. A destra la foto del 1928, la foto a sinistra lo ritratta alcuni anni prima. Si tratta della tessera del Partito Nazionale Fascista a cui si era iscritto dal maggio 1922.
Foto 4 e 5: intestazione dei primi numeri della Rivista dell’Azienda Tranvie Municipali di Torino distribuita tra i dipendenti. Alcuni numeri sono attualmente conservati nell'Archivio della Associazione Torinese di Tram Storici (ATTS).

Nella primavera del 1894, la rete tranviaria urbana di Berna venne ampliata con l’entrata in servizio della seconda linea tranviaria che portava dal villaggio di Wabern, passando attraverso la stazione ferroviaria, fino al quartiere Länggasse.
La nuova linea, denominata linea II, era gestita come tram a vapore e fu introdotta dalla Compagnia tranviaria Berner (Berner Tranway Company, abbreviata BT o BTG), la società incaricata del servizio di trasporto pubblico urbano di Berna che, per questo scopo, acquistò otto locomotive a vapore (serie 12 – 18) e dodici rimorchi (serie 19 – 30). Le locomotive, costruite dalla società Schweizerische Lokomotiv (SLM) nella sede di Winterthur, furono molto apprezzate dalle ferrovie nazionali ed estere grazie alla loro struttura compatta e all’elevata affidabilità.
Tuttavia, lo sviluppo delle reti tranviarie urbane in Svizzera e all'estero all'inizio del XX secolo non passò certo inosservato a Berna. Nel 1901 fu avviata l’elettrificazione della rete urbana bernese che si completò l’anno successivo e che vide coinvolta anche la seconda linea aperta pochi anni prima. I tram a vapore furono quindi progressivamente sostituiti da veicoli elettrici ma, nonostante la cessazione dell’esercizio delle linee a vapore, nella capitale Svizzera rimasero comunque operative alcune locomotive e rimorchi che furono utilizzati per mansioni di servizio fino al 1959.
Due delle locomotive “a vapore” bernesi esistono ancora oggi: la 12 e la 18.
La locomotiva 18, dopo un lungo periodo di servizio sulla ferrovia Stansstad-Engelberg, fu trasferita nel Museo Svizzero dei Trasporti a Lucerna in esposizione statica dove è inoltre possibile ammirare anche il rimorchio numero 26.
La locomotiva 12 fu utilizzata fino al 1943 come locomotiva da lavoro presso una segheria di Bienne. Nel 1959 finì nella collezione del museo della scienza “Technorama Winterthur” e successivamente è stata esposta in varie località svizzere fino agli anni ‘90. Nel 1994 ritornò infine a Berna per una revisione che gli permetta di tornare in servizio e che verrà completata negli anni successivi. Dal 2002 il tram a vapore circola di nuovo sulla rete tranviaria di Berna ed è utilizzato insieme al rimorchio numero 31 (replica ricostruita secondo i progetti originali) in occasione delle domeniche dell’avvento, consentendo di poter osservare “dal vivo” il fuochista al lavoro: oggi è il tram circolante più anziano dell’intero parco storico bernese.
Dati tecnici
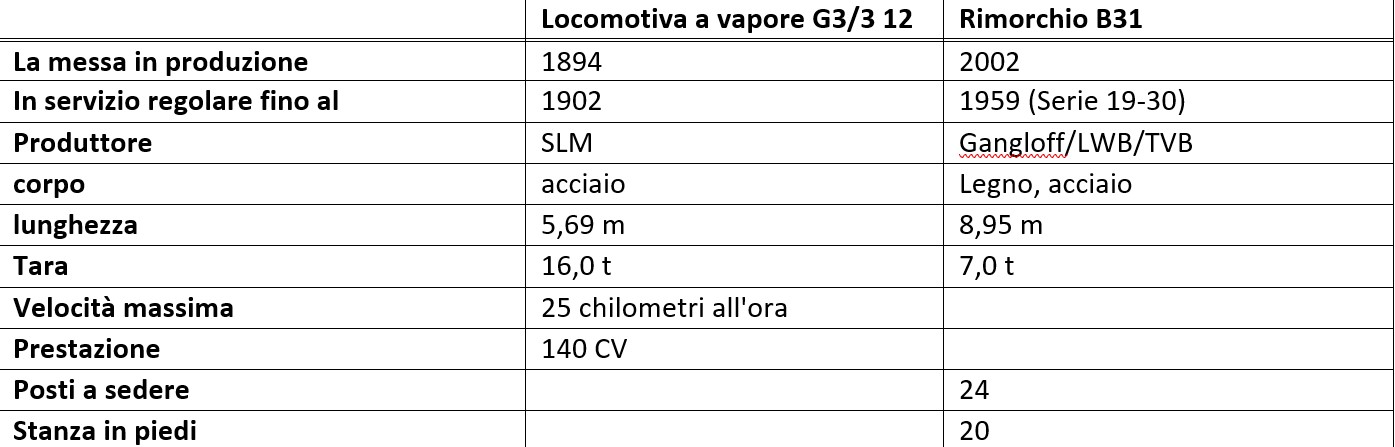

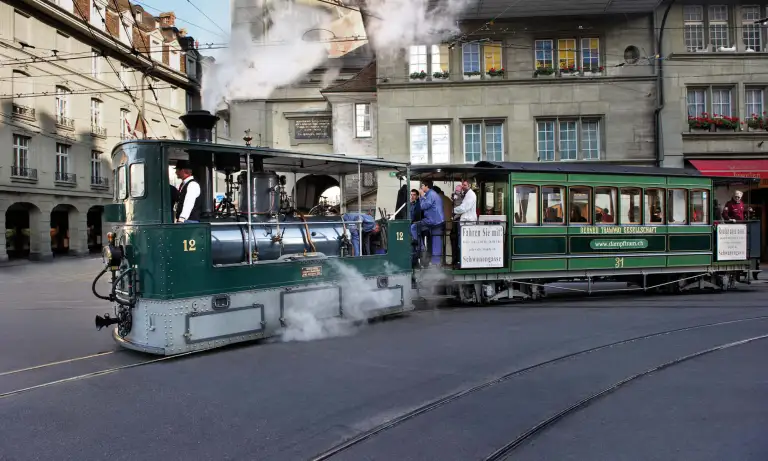


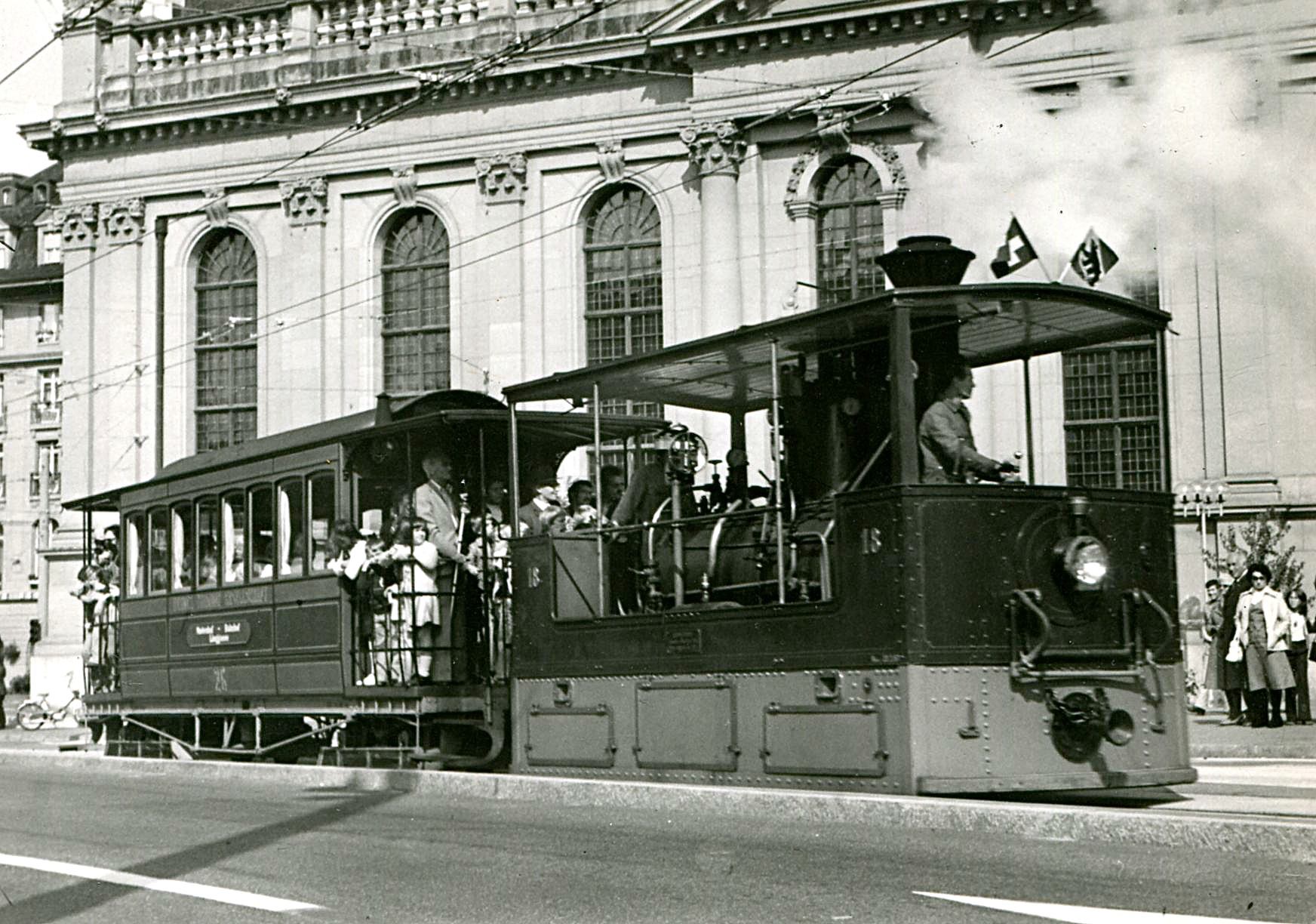
ATTS organizza una gita sui tram a vapore di Berna il prossimo 15 dicembre. Per informazioni e iscrizioni https://www.atts.to.it/eventi/608-20241215-gita-berna -

NOVITA' TRANVIARIE DAL MONDO
di Roberto Cambursano
Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo, intervenute nel periodo dicembre 2018-novembre 2019. Sono evidenziate in giallo le “nuove città tranviarie”. Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Railway Gazette International; Urbanrail.net.
Aggiornamento al 1° dicembre 2019
ALGERIA
COSTANTINA: il 3 giugno 2019 la linea tranviaria esistente (inaugurata nel 2013) è stata prolungata di 6,9 km da Zouaghi Slimane a Ali Mendjeli. La linea ha ora una lunghezza complessiva di 14,7 km e il parco rotabile è formato da 47 tram Alstom Citadis 402 a pianale interamente ribassato, la seconda serie dei quali è stata fabbricati in Algeria dalla Cital (azienda partecipata al 49% da Alstom e al 51% da imprese algerine).
ARGENTINA
MENDOZA: il 7 maggio 2019 la linea tranviaria esistente è stata prolungata di 5,1 km dalla ex-stazione ferroviaria ad Avellaneda. Sono entrati in servizio altri tre veicoli di tipo Düwag U2 a pianale alto, acquisiti si seconda mano dalla città statunitense di San Diego, che si sono aggiunti agli altri undici identici già in servizio. La linea è costruita interamente a standard “LRT” con banchine alte e segue il tracciato di una ferrovia abbandonata; con una lunghezza complessiva di 17,6 km (il primo tratto è stato inaugurato nel 2012).
AUSTRALIA
NEWCASTLE (New South Wales): il 18 febbraio 2019 ha preso servizio la prima linea tranviaria di questa città, lunga 2,7 km, che collega la Stazione ferroviaria con il centro e la spiaggia; sono utilizzati sei tram a pianale interamente ribassato del tipo Urbos3 prodotti da CAF, provvisti del sistema ACR con batterie e supercapacitori per la ricarica (che avviene tramite pantografo in 23 secondi esclusivamente ai due capilinea); non è presente la linea aerea di alimentazione.
CANBERRA (Australian Capital Territory): il 20 aprile 2019 è stata inaugurata la prima linea tranviaria della capitale australiana, lunga 12 km e denominata “R1”, che collega Alinga Street nella zona centrale con Gungahlin Place, situata alla periferia nord della città. Sono in servizio 14 tram a pianale interamente ribassato del tipo Urbos3, forniti dal costruttore spagnolo CAF e lunghi 33 metri.
AUSTRIA
VIENNA: il 6 dicembre 2018 ha iniziato il servizio commerciale sulla linea 67 il primo tram del tipo “Flexity Wien”, prodotto da Bombardier e ordinato dall’Azienda di trasporto della capitale austriaca in 119 esemplari (più un’opzione per altri 37). Questo nuovo veicolo, lungo 34 metri e largo 2,40, differisce dai Flexity delle altre città per l’altezza ridotta del pianale (21,5 cm dal piano del ferro contro i 30 cm consueti) ed è destinato a sostituire il materiale rotabile più datato; si affiancherà progressivamente al tram “ULF” (dotato di pianale ultraribassato a soli 18 cm dal piano del ferro, ma dal costo molto maggiore), presente oggi a Vienna in ben 302 unità e non più in produzione.
INNSBRUCK: il 26 gennaio 2019 è stato inaugurato un nuovo tratto tranviario che collega la zona del Villaggio Olimpico a est della città, fra Leipziger Platz e Josef-Kerschbaumer Strasse, lungo 4,3 km e percorso dalle linee 2 e 5. Dopo questa modifica, il capoluogo tirolese dispone ora di una rete tranviaria di complessivi 44 Km, con 6 linee di cui 2 interurbane (la famosa “Stubaitalbahn” e la linea 6 per Igsl). Sono stati acquistati da Bombardier altri 20 tram di tipo Flexity a pianale interamente ribassato, che si vanno ad aggiungere ai 32 già in servizio e che serviranno anche per future altre estensioni.
BRASILE
RIO DE JANEIRO: il 26 ottobre 2019 è stato inaugurato un nuovo tratto di linea tranviaria della lunghezza di 1 km nel centro della città, fra la Stazione ferroviaria centrale (Cristiano Ottoni) e Candelaria, che ha permesso di istituire la terza linea della rete tranviaria moderna (T3, che collega la stazione ferroviaria centrale con Santos Dumont). La rete moderna, il cui primo tratto era stato inaugurato nel 2016 in occasione delle Olimpiadi, si sviluppa ora complessivamente per 14 km ed è alimentata completamente senza catenaria con il sistema APS di Alstom. Il parco rotabile è composto da 32 tram a pianale interamente ribassato Alstom Citadis 402.
Rimane in funzione anche una minuscola porzione della rete tranviaria di prima generazione, a forma di Y e composta da due linee, completamente separata dalla rete moderna e mantenuta essenzialmente come servizio turistico: il “Bonde de Santa Teresa. L’offerta tranviaria della città carioca è completata poi dalla Tranvia a cremagliera del Corcovado, che raggiunge la statua del Cristo Redentore posta sulla cima della omonima altura: proprio nel 2019 sono entrati in servizio tre moderni convogli articolati forniti dalla casa svizzera Stadler.
CANADA
OTTAWA: Nella capitale canadese il 14 settembre 2019 è stata inaugurata la “Confederation Line” (Linea 1), una nuova linea lunga 12,5 km, di cui 2,5 km in tunnel nel centro cittadino, da Tunney’s Pasture a Blair. E’ a pieno standard “LRT”, ad elevato grado di separazione, e vi fanno servizio 34 tram Alstom “Citadis Spirit” da 48,5 metri a pianale interamente ribassato (espressamente costruiti negli USA per il mercato americano). Nella stessa città esiste anche la “Trillium Line” (linea 2), lunga 8 km e inaugurata nel 2015 sulla sede di una preesistente ferrovia, definita anch’essa “LRT” ma gestita con materiale ferroviario diesel di tipo Alstom Coradia.
WATERLOO (Ontario): il 21 giugno 2019 è stata inaugurata la prima sezione di una nuova linea tranviaria interurbana che collega le città di Waterloo e Kitchener. Il tracciato è lungo 16 km e vi fanno servizio 14 tram Bombardier Flexity Freedom da 30,2 metri a pianale parzialmente ribassato, costruiti in Canada ed espressamente destinati ai sistemi nord-americani di LRT.
CINA
CHENGDU (Sichuan): il 26 dicembre 2018 è stata inaugurata la linea T2, prima linea tranviaria moderna di questa città (che finora disponeva solo di una piccola sezione di linea a scartamento metrico, residuo della vecchia rete tranviaria, gestita come servizio storico/turistico). Il tratto ora in funzione, lungo 13,6 km fra Chenguang ed Hexin Road, è situato alla periferia nord-ovest della città e costituisce la prima fase di una rete di 40 km a forma di Y composta da due linee e con funzione di adduzione alla rete di metropolitana; la flotta dei tram in servizio, la cui consistenza ammonterà a regime a 40 unità, è formata da tram lunghi 33 metri a pianale totalmente ribassato di tipo Citadis 302 costruiti in loco dalla CRRC su licenza Alstom.
SANYA (Hainan): il 1° gennaio 2019 il capoluogo dell’isola di Hainan ha inaugurato la sua prima linea, diventando la diciassettesima città tranviaria cinese. Il primo tratto, dalla stazione ferroviaria a Jiefang Lu, è lungo 3,9 km e vi fanno servizio tram forniti dalla CRRC, a pianale interamente ribassato e dotati di supercapacitori per la ricarica delle batterie in fermata. I piani di sviluppo prevedono una rete di quattro linee tranviarie per complessivi 60 km.
SHANGHAI: il 26 dicembre 2018 è stata inaugurata una nuova linea tranviaria tra Zhongchen Road e Canghua Road, denominata T2 al servizio del quartiere di Songjiang nella periferia sud-ovest; la lunghezza della prima tratta è di 13,9 km, su cui sono in servizio 15 tram a pianale totalmente ribassato di tipo Alstom Citadis. La più grande metropoli cinese dispone anche di una linea di “tram su gomma” (sistema Translhor), in funzione dal 2010 nel quartiere di Zhangjiang alla periferia est: tutte le linee tranviarie hanno funzione di adduzione alla vasta rete di metropolitana, la cui costruzione ebbe inizio nel 1995 e che oggi conta 17 linee sviluppate su oltre 600 km.
Il 10 agosto 2019 la linea T2 è stata prolungata ed è diventata una linea circolare; nel contempo è stata inaugurata la linea T1, facente parte della stessa sottorete tranviaria di Songjiang, (che ora comprende due linee aventi un lungo tratto in comune) con una estensione complessiva di 30 km. La flotta di tram Citadis ha raggiunto la consistenza di 30 unità.
SHENYANG (Liaoning): Il 5 gennaio 2019 sono entrate in esercizio le due nuove linee 4 e 6, con un incremento complessivo di rete di 4,1 km. La rete tranviaria, che copre la zona sud della città al di là del fiume Hunhe, si estende ora su 60 km ed è composta da sei linee con una flotta complessiva di 35 tram. I veicoli, fabbricati in Cina da un consorzio che comprende la locale Changchun Railway Vehicles Company e la casa tedesca Voith, sono a pianale interamente ribassato e sono dotati di supercapacitori per il superamento di alcune tratte non dotate di linea aerea.
DANIMARCA
AARHUS: il 30 aprile 2019 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria (L1), da Aarhus H a Grenaa: si tratta di un servizio di tram-treno che sfrutta in massima parte la sede di una ex-ferrovia locale a binario unico lunga 69 km a nord-est della città. Contemporaneamente è stato anche attivato un prolungamento di 4 km della linea già esistente (L2) da Lisbjerg a Lystrup. Aarhus è attualmente l’unica città danese dotata di tram: la sua rete, il cui primo tratto è stato inaugurato nel 2017, si estende adesso su 110 km complessivi e comprende due linee. La linea L2 (da Odder a Lystrup) ha una gestione complessa, perché il tratto sud (Odder-Aarhus H) è gestito come tram-treno ed è a binario semplice, mentre il restante tratto di 14 km (Aarhus H-Lystrupp) ha caratteristiche urbane ed è a doppio binario. Il parco rotabile è composto interamente da tram Stadler, di cui 14 “Variobahn” a pianale interamente ribassato per il tratto urbano della linea T2 e 12 “Tango” a pianale parzialmente ribassato per le tratte interurbane.
FRANCIA
AVIGNONE: il 19 ottobre 2019 è stata inaugurata la prima linea (T1) del tram di Avignone, da Saint Roch a Saint Chamand, lunga 5,2 km. Sono in servizio 14 tram Alstom “Citadis X05 compact” a tre casse, a pianale interamente ribassato e lunghi 24 metri (sono i più piccoli della gamma Citadis, identici a quelli già in servizio a Aubagne e Besançon). Con questa “new entry”, la Francia può contare ora su 29 città tranviarie.
BORDEAUX: il 2 febbraio 2019 è stato inaugurato il prolungamento della linea C da Lycée Vaclav Havel a Villenave Pyrénées, per una lunghezza di 1,4 km. La rete tranviaria di Bordeaux è composta da tre linee e, con uno sviluppo complessivo di 65,5 km, è la terza rete di Francia per estensione dopo Parigi e Lione.
CAEN: il 27 luglio 2019 è stata inaugurata la nuova configurazione della rete tranviaria, estesa su 16,4 km e formata da tre linee. Il parco veicolare è costituito da 26 tram articolati Alstom Citadis X05 a pianale interamente ribassato, che hanno preso il posto dei tram su gomma GLT di Bombardier. Con questa trasformazione, la città di Caen ha quindi sconfessato il sistema GLT (rivale del più diffuso Translhor), che era entrato in funzione nella città normanna in anteprima mondiale nell’anno 2000 ed aveva funzionato, con deludenti risultati, fino al 31 dicembre 2017. Sopravvive per il momento a Nancy (che ha acquisito parti di ricambio da Caen) l’unica altra installazione GLT esistente.
LIONE: il 22 novembre 2019 è stata inaugurata la linea T6 da Debourg a Hopitaux Est Pinel, che utilizza un tratto di nuova costruzione di 6,7 km. La rete tranviaria di Lione si sviluppa ora complessivamente su 73 km e conta 7 linee, di cui una interurbana che collega l’aeroporto Saint Exupéry (Rhonexpress). Il parco rotabile è composto da 92 (+11 in fase di consegna) motrici a pianale interamente ribassato tipo Alstom Citadis 302/402 e 6 tram Stadler Tango a pianale parzialmente ribassato per il Rhonexpress. Vi sono inoltre 2 linee di tram-treno (“tram-train de l’ouest”) gestite da SNCF che utilizzano linee ferroviarie dismesse completamente separate dalla rete tranviaria urbana, per complessivi altri 40 km.
NIZZA: il 15 dicembre 2018 è stata inaugurata una diramazione (completamente sprovvista di catenaria) lunga 1,7 km della linea T2 che congiunge la fermata di Grand Arénas con l’Aeroporto: a corse alterne, il servizio viene effettuato sul percorso Magnan-Aeroporto oppure sul percorso Magnan-CADAM.
Il 28 giugno 2019 la linea T2 è stata prolungata di 2 km su un percorso sotterraneo verso il centro della città da Magnan a Jean Médecin, dove incrocia la linea T1 che transita in superficie.
Il 13 novembre 2019 è stata inaugurata la linea T3, dall’Aeroporto a Saint Isidore, che utilizza un tratto di nuova costruzione di 3,8 km lungo il fiume Var fra Digue des Francais (dove incontra la linea T2) e Saint Isidore. Sono in servizio sei nuovi tram Citadis 405 di Alstom identici a quelli della linea T2. L’intero percorso è senza catenaria.
PARIGI: il 12 ottobre 2019 la linea T1 è stata prolungata di 800 metri nel comune di Asnières da Les Courtille a Quatre Routes.
SAINT ETIENNE: il 16 novembre 2019 e stato inaugurato un nuovo tratto di 4,2 km fra Châteauxcreux Gare e Roger Rocher su cui è stata instradata la linea 3. La rete tranviaria, che ha un inconsueto scartamento metrico ed è composta da tre linee, ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 16 km. Sono entrati in servizio 16 nuovi tram Urbos3 a pianale interamente ribassato prodotti da CAF, che si affiancano a 27 tram Alstom TFS a pianale parzialmente ribassato già in servizio.
STRASBURGO: il 17 giugno 2019 la linea E è stata prolungata di 1,6 km da Boecklin a Robertsau L’Escale. La rete tranviaria di Strasburgo è composta da sei linee (di cui una internazionale che arriva in Germania a Kehl) e ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 46 km.
GERMANIA
ULMA (Baden-Württenberg): l’8 dicembre 2018 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria della città (linea 2), che congiunge la Città della Scienza con Kuhberg e condivide un tratto centrale con la linea 1. Sono stati realizzati 9 km di nuova linea, che portano la città di Ulma a totalizzare 19 km di rete tranviaria a scartamento metrico; sono andati ad aggiungersi alla flotta 12 nuovi tram Avenio a pianale interamente ribassato prodotti da Siemens.
FRIBURGO (Baden-Württenberg): il 16 marzo 2019 è stato inaugurato il prolungamento della linea 5 da Heinrich-von-Stephan Strasse a Europaplatz, nella zona centrale della città, per una lunghezza di 1,9 km. La rete tranviaria di Friburgo conta 5 linee per complessivi 35 km.
ITALIA
FIRENZE: l’11 febbraio 2019 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria della città (T2), che congiunge la centrale Piazza dell’Unità d’Italia con l’aeroporto di Peretola e condivide con la linea T1 una breve tratta di 400 metri presso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. La nuova tratta è lunga 5 km e porta l’estensione della rete tranviaria fiorentina a un totale di 16,5 km, con una flotta di 46 tram Sirio prodotti da Hitachi Rail Italy. I piani per il futuro prevedono due prolungamenti della linea T2 (a nord fino a Sesto Fiorentino e a sud-est verso il centro cittadino) e la realizzazione della nuova linea T4 (da Porta al Prato a Le Piagge) in parte lungo un sedime ferroviario abbandonato.
MILANO: La gara bandita da ATM per la fornitura di nuovi tram è stata vinta da Stadler con il modello bidirezionale “Tramlink S3 Leo” da 25 metri. Il bando prevede la fornitura di un primo lotto di 30 unità, seguito da altre 50, di cui 30 destinate alle due linee interurbane per Limbiate e Desio.
TORINO: La gara bandita da GTT per la fornitura di nuovi tram è stata vinta da Hitachi Rail Italy con un nuovo modello monodirezionale lungo 28 metri che sostituisce il “Sirio” di Ansaldobreda. Il bando prevede la fornitura di un primo lotto di 30 unità, eventualmente seguito da altre 35.
MAROCCO
CASABLANCA: il 24 gennaio 2019 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria della città (T2), da Ain Diab a Sidi Bernoussi, che ingloba la diramazione della linea T1 già operante fra Anoual e Ain Diab; contemporaneamente, anche la linea T1 è stata prolungata da Facultés a Lissasfa. Si sono aggiunti complessivamente altri 17 km di binari, portando la città di Casablanca al primo posto in Africa con un totale di 48 km di rete tranviaria. Altri 50 tram a pianale interamente ribassato di tipo Citadis 302, sono stati ordinati ad Alstom e sono in fase di progressiva consegna, portando la consistenza totale della flotta al considerevole valore di 152 veicoli.
MAURITIUS
PORT LOUIS: il 3 ottobre 2019 è stato inaugurato il “Metro Express”, una linea interurbana a standard di LRT che collega la capitale Port Louis con i centri della costa ovest dell’isola e segue in gran parte il percorso abbandonato di una antica ferrovia. Il primo tratto arriva fino a Rose Hill ed è lungo 13 km. Il materiale rotabile è costituito da 18 tram Urbos LRV bidirezionali a pianale parzialmente ribassato costruiti da CAF.
PAESI BASSI
L’AIA: il 19 maggio 2019 è stato attivato un prolungamento di 2 km della linea tranviaria interurbana 4 da Ooterheem a Lansingerland-Zoetemeer, dove è stata inaugurata una nuova stazione di interscambio con la rete ferroviaria nazionale. La linea 4, assieme alla linea 3, fa parte del sistema interurbano chiamato “Randstadrail”, comprendente anche una linea di metropolitana (E) che collega l’Aia con Rotterdam. Le linee 3 e 4 sono gestite con tram-treni Alstom Regio-Citadis: all’interno della città dell’Aia condividono i binari con i tram tradizionali, mentre all’esterno sfruttano in gran parte sedi ferroviarie dismesse. Vi è un tratto di 5 km in comune con la linea E di metropolitana, in cui i binari sono gli stessi ma le banchine di fermata sono costruite in due sezioni di altezze diverse. La rete tranviaria dell’Aia conta 12 linee e si sviluppa in totale su 119 km (comprese le tratte di tram-treno).
POLONIA
BRESLAVIA: il 22 giugno 2019 è stato inaugurato un nuovo tratto di 0,9 km da Pulaskievo a Prudnicka, su cui è stata instradata la linea 8. La rete tranviaria di Breslavia (Wroclaw) è composta da 22 linee e ha un’estensione totale di 90 km.
RUSSIA
KAZAN: il 18 novembre 2019 la linea 5 è stata prolungata di 1 km da Solnechniy Gorod a Ul. Midkhata Bulatova. La rete tranviaria è attualmente composta da quattro linee e ha uno sviluppo totale di 59 km.
SAN PIETROBURGO: Il 1° settembre 2019 è stata completata la sottorete di “fast-tram” nella zona est della città (gestita da un operatore privato distinto dall’Azienda tranviaria municipale), con l’inaugurazione di un nuovo tratto di 1,8 km e l’ammodernamento di altri tratti già esistenti. Le linee private sono passate da una a quattro (contraddistinte dai numeri 8, 59, 63 e 64), e formano una sottorete di 14 km attualmente isolata dalla rete municipale, che a sua volta si sviluppa su 208 km con 37 linee. La flotta privata, composta dai nuovi tram Staldler Metelitsa, ha raggiunto una consistenza di 23 unità totali, mentre la flotta municipale conta circa 730 veicoli in servizio di linea.
TVER: è stata confermata la chiusura definitiva della rete tranviaria di questa città, che si era ridotta a una sola linea e versava in grave stato di ammaloramento. Il servizio era stato sospeso dal 14 novembre 2018.
SERBIA
BELGRADO: il 5 luglio 2019 è stato inaugurato un nuovo tratto di 3,3 km da Hipodrom/Gospodarska Mehana alla stazione ferroviaria di Novi Beograd, che attraversa il fiume Sava sul Ponte Ada ed è utilizzato dalle linee 11 e 13. La rete tranviaria della capitale serba, a scartamento metrico ed estesa su 47 km in totale, conta undici linee.
STATI UNITI D’AMERICA
OKLAHOMA CITY (Oklahoma): un’altra “new entry” si è aggiunta all’elenco delle città tranviarie americane dal 14 dicembre 2018. Sono ora in esercizio 8 km di binario unico che servono il centro cittadino con un percorso a forma di otto su cui circolano due linee: una principale (Downtown loop) che percorre l’intero tracciato e una integrativa (Bricktown loop) che percorre solo una parte dell’anello a sud e solo nelle giornate di venerdì e sabato. Compongono la flotta 7 motrici di tipo “Liberty”, lunghe 20,3 metri, a tre casse a pianale parzialmente ribassato, fabbricate in Pennsylvania da Brookville e dotate di batterie che permettono il superamento di brevi tratte non alimentate da catenaria.
DENVER (Colorado): il 17 maggio 2019 è stato inaugurato un prolungamento di 3,7 km da Lincoln Station a Ridge Gate Parkway, comune alle linee E, F ed R. Il sistema di LRT comprende attualmente 8 linee e ha una estensione totale di 94 km.
PHOENIX (Arizona): il 18 maggio 2019 la linea esistente (“Valley Metro Light Rail”) è stata prolungata di 3 km da Mesa Drive a Gilbert Road. La linea, la cui lunghezza totale è ora di 45 km, collega Phoenix con le città confinanti di Tempe e di Mesa, facenti parte della stessa area metropolitana.
SVIZZERA
ZURIGO: il 2 settembre 2019 la linea 2 è stata prolungata per 2,9 km nella parte ovest dell’area metropolitana, su un tratto di nuova costruzione da Farbhof a Schlieren/Geissweid. Si tratta della prima tappa della realizzazione di una nuova linea interurbana (Limmattalbahn) che collegherà Zurigo/Altstetten con le località esterne di Schlieren, Dietikon e Killwangen e sarà lunga 13,4 km. La più grande rete tranviaria svizzera, a scartamento metrico, si estende attualmente su 129 km in totale e comprende quindici linee urbane, due linee interurbane e una linea a cremagliera.
TAIWAN
TAIPEI: la capitale dell’isola è diventata la seconda città tranviaria del paese, dopo Kaoshiung, con l’inaugurazione della “Green Mountain line” avvenuta il 23 dicembre 2018. Si tratta di una linea a standard di metropolitana leggera, in parte sopraelevata, lunga 7,4 km e situata nel quartiere di Tamsui alla periferia nord: è la prima di una rete di 4 linee (la “Danhai Light Rail”), con funzione di adduzione alla linea 2 di metropolitana. Sono in servizio 15 motrici lunghe 34,5 metri fabbricate in loco da un consorzio internazionale di aziende, bidirezionali a pianale interamente ribassato e dotate di batterie per il superamento di alcuni incroci dove non è presente la linea aerea.
TURCHIA
ANTALYA: l’11 agosto 2019 è stato inaugurato il primo tratto della nuova linea T3, da Atatürk a Varsak, lungo km, per il momento isolato dal resto della rete. La rete tranviaria locale dispone ora nel suo complesso di tre linee, di cui due (T1 e T3) a standard di “light rail” e una (T2) gestita provvisoriamente con materiale storico ex-tedesco, destinata ad essere ammodernata e assorbita dal futuro prolungamento della linea T3. In totale sono in esercizio 41 km di rete moderna, con una flotta composta da 14 tram forniti dalla casa spagnola CAF e da 18 tram Eurotem (costruiti in collaborazione fra la casa coreana Hyundai Rotem e quella turca Tüvasaş), oltre a 4,7 km di binario unico di linea storica nel centro cittadino su cui corrono due tram ex-Norimberga.
IZMIT: il 9 febbraio 2019 è stato inaugurato il prolungamento dell’unica linea tranviaria da Sekapark a Playjolu, per una lunghezza di 2,2 km. La linea, il cui primo tratto era stato attivato nel 2017, è adesso lunga complessivamente 9,2 km.
ESKISEHIR: il 10 marzo 2019 è stato inaugurato il prolungamento di 3 km della linea gialla da Acelya a Sehir Hastanesi. La rete tranviaria a scartamento metrico della città ha raggiunto l’estensione complessiva di 48 km, con 7 linee gestite.
SAMSUN: il 5 luglio 2019 l’unica linea tranviaria è stata prolungata di 6 km da Omü Rektörlük a Yurtlar, nella zona del Campus universitario. La linea, il cui primo tratto è stato aperto nel 2010, è ora lunga 36 km e vi fanno servizio tram di produzione italiana (Sirio di Ansaldo Breda), cinese (CNR) e turca (Durmazlar), tutti a pianale interamente ribassato.
UNGHERIA
BUDAPEST: il 9 luglio 2019 la linea 1 è stata prolungata di 1,5 km da Etele Ut a Kelenfold Vasutallomas. La vasta reta tranviaria della capitale ungherese comprende attualmente 25 linee e si estende in totale su 160 km.
INDUSTRIA TRANVIARIA
La Commissione Europea ha bocciato all’inizio del 2019 il progetto di fusione tra Alstom e Siemens, con la motivazione che la grande dimensione della nuova azienda unificata sarebbe stata nociva per la concorrenza e avrebbe portato a un rialzo dei prezzi.

TORONTO: ULTIMO STRIDIO DI RUOTE PER GLI ARTICOLATI
di Lorenzo Aleardo Gasparini
Lunedì 2 settembre 2019 sarà una data che gli appasionati di tram (o meglio, streetcar, come vengono chiamati i tram oltreoceano) di Toronto non dimenticheranno. Perché in quel giorno, dalle 14 alle 17, le due ultime vetture articolate 4204 e 4207 saranno in servizio sulla linea 501 per far stridere le loro ruote un’ultima volta. Introdotti nel 1988, gli Articulated Light Rail Vehicles, o ALRV, affettuosamente chiamati “bendy streetcar” (tram pieghevole), sono, anzi, erano, la versione articolata dei più piccoli CLRV (per fare un paragone di grandezza gli ALRV sono come le nostre 2800 mentre I CLRV sono come le 2500). Questi veicoli ad alta capienza furono studiati e costruiti per espletare servizio sulla lunga e sempre frequentata linea 501, che attraversa la parte sud della città da est a ovest. Durante le ultime corse, sempre tutte affollate, sono state molte le persone che hanno voluto salutare questi tram, chi raccontando un ricordo o chi facendo foto ad una delle due vetture. Il signor Carini, dipendente della TTC nel reparto sicurezza, ha commentato, durante un’intervista al The Globe And The Mail, dicendo “ci siamo lamentati di questi mezzi per 30 anni ed ora siamo tristi nel vederli andare via”. Anche uno dei due manovratori, Stephen Welsh, ha commentato il viaggio finale di queste due vetture “è bello averli in giro nuovamente” e rivolgendosi ai passeggeri ha detto loro di godersi il giro; questi ultimi, dopo le parole del manovratore, hanno applaudito fragorosamente. Infine, sulla via del ritorno del giro finale il conduttore del mezzo ha chiesto ai suoi passeggeri “siete contenti di non rivedere più questi tram?” e, tutti insieme, con molto dispiacere hanno urlato “NO!” anche se, qualcuno che non si è fatto prendere dal sentimentalismo del momento ha risposto “hanno fatto il loro tempo”. Se non siete riusciti a vedere queste vetture, non disperate. Un tram di questa serie, come anche uno di quelli più piccoli, verrà conservato presso il “Halton Country Radial Railway Museum”
Immagine di testa presa dal articolo “Toronto’s bendy streetcars take their last ride”, apparso sul quotidiano “The Globe and The Mail” https://www.theglobeandmail.com/canada/toronto/article-torontos-bendy-streetcars-take-their-last-ride/. Immagine al fondo di Lorenzo Aleardo Gasparini.


I TRAM TATRA T2 TORNANO SULLA RETE DI PRAGA
di Gianpiero Bottazzi
Sui binari di Praga, il 7 e 8 marzo scorsi, sono stati presentati due tram Tatra T2 perfettamente restaurati e riportati alle condizioni originarie. L’aspetto curioso è che questi motrici non hanno mai viaggiato nella capitale boema, che ha avuto nella sua storia tranviaria solo due prototipi di questo modello in servizio dal 1955 al 1964.
Si tratta infatti di tram costruiti nel 1958 per la rete di Ostrava che poi vissero una seconda vita a Liberec: qui viaggiarono dal 1995 fino al 17 novembre 2018 (prima con i numeri 26 e 27, poi furono rinumerati 18 e 19) sulla linea 5 e, accoppiati, sulla linea 11. Dopo essere stati ritirati dal servizio sono stati accuratamente restaurati e consegnati a Praga nel dicembre 2019. Qui hanno ricevuto la numerazione 6003 e 6004 che si spiega con il fatto che i due prototipi T2 avevano i numeri 6001 e 6002.
I T2 restaurati hanno un particolare che li differenzia: la 6003 è stata ricostruita com’era in origine, con un solo faro anteriore e il “baffo”, mentre la 6004 è nella versione successiva con due fari. Al momento i due tram viaggiano sulla linea 2 ma è previsto il loro utilizzo sulla linea storica 23 in composizione doppia. Praga ha oggi due linee tranviarie storiche: la linea speciale 41 gestita con tram a due assi degli anni ’20 e ’30 e la linea 23, integrata nella rete ordinaria, e su cui viaggiano esclusivamente tram Tatra T3 con la configurazione originale.
I tram originali T2 di Praga furono realizzati da Tatra nel 1955. La motrice 6001 fu impiegata prima sulla linea 4, e rimessata nel deposito di Motol; poi, dal 1963, sulla linea 21 e custodita nel deposito di Žižkov. L’anno successivo venne accantonata e nel 1965 fu venduta a Olomouc dove prestò servizio, con il numero 115, per vent’anni. Nel gennaio 1986 fu infine demolita. La 6002 restò a Praga per poco tempo: viaggiò sulla linea 4 e venne rimessata nel deposito di Motol. Nel 1956 venne dotata di carrelli per lo scartamento metrico e trasferita prima a Liberec e poi, l’anno successivo, a Bratislava. Nella capitale slovacca ha viaggiato con il numero 6002 fino al 1977 e venne anche utilizzata per la scuola guida. Poi è tornata a Praga ed è attualmente custodita nel Museo del Tram di Střešovice.
Tatra ha costruito complessivamente 771 tram del modello T2, fra il 1955 e il 1962: 2 prototipi per Praga e 389 vetture di serie per le città di Bratislava, Brno, Košice, Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Plzeň e Ústí nad Labem. Altri 380 tram di questo modello furono esportati in Unione Sovietica, denominati T2SU e utilizzati sulle reti di Kiev, Kujbyšev, Leningrado, Mosca, Rostov sul Don e Sverdlovsk. Le prime serie furono costruite con tre porte come quelli per le città ceche, le successive con solo due porte su richiesta dei committenti.
Un ringraziamento all’amico František Zahnáš per il prezioso aiuto e per le belle foto che ci ha donato.
IMMAGINI
Foto 1 - Tatra T2 n° 6003 ripreso durante il giro inaugurale a Praga il 7 marzo 2020
Foto 2 - Tatra T2 n° 6004 ripreso durante il giro inaugurale a Praga il 7 marzo 2020
Foto 3 - Tatra T2 n° 6002 ripreso a Praga il 20 settembre 2015
Foto 4 - Tatra T2 n° 115 (ex 6001) ripreso a Olomouc il 1° maggio 1981
Foto 5 - Tatra T2 n° 18-19 ripresi a Liberec il 26 agosto 2017
Foto 6 - Tatra T2 ripresi a Ostrava l’8 aprile 1976

NOVITA' TRANVIARIE DAL MONDO
di Roberto Cambursano
Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo, prendendo come riferimento iniziale i dati contenuti nel libro “Un mondo di tram” (prima edizione aggiornata a fine 2017). Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Railway Gazette International; Urbanrail.net.
Aggiornamento al 1° dicembre 2018
ALGERIA
• OUARGLA: un’altra città algerina si è aggiunta alle quattro già dotate di tram: la prima linea, inaugurata il 20 marzo 2018 fra Hai Nasr e Cité Administrative, è lunga per ora 9,8 km e la flotta di tram in servizio è composta da 23 Citadis lunghi 44 metri fabbricati da Alstom.
• SETIF: la prima linea della sesta rete tranviaria algerina è stata inaugurata l’8 maggio 2018 fra la Città Universitaria e 11/12/1960: è lunga 14,7 km e la flotta di tram in servizio è composta da 26 Citadis fabbricati da Alstom.
AUSTRIA
• GMUNDEN: il 1° settembre 2018 è stato attivato un nuovo tratto di binario di 600 metri, fra Franz Josef Platz e Seebahnhof, che ha permesso di collegare fra loro due linee finora separate, entrambe a scartamento metrico. La situazione precedente comprendeva una linea urbana, lunga 2,3 km fra stazione ferroviaria e Franz Josef Platz e una linea interurbana, la “Traunseebahn” fra Seebahnhof e Vorchdorf-Eggenberg, lunga 15 km. Ora esiste un’unica linea interurbana che collega la Stazione di Gmunden con Vorchdorf-Eggenberg, lunga complessivamente 18 km, sulla quale fanno servizio 8 veicoli “Tramlink V3” forniti da Vossloh-Kiepe (ora Stadler) e gestiti dalla compagnia privata Stern & Hafferl.
BELGIO
• BRUXELLES: prosegue l’ampliamento della rete tranviaria con due nuovi tratti: dal 1° settembre 2018 è stata attivata la nuova linea 9 fra Simonis e Arbre Ballon, comprendente un nuovo tratto di 3,2 km fra Miroir e Arbre Ballon, mentre dal 29 settembre la linea 94 è stata ridenominata 8 sul percorso Louise-Roodebek, comprendente un prolungamento di 2 km dal Museo del tram a Roodebeek. La rete tranviaria di Bruxelles conta ora 16 linee e 143 km di sviluppo.
• LIEGI: si concretizza il ritorno del tram: a settembre 2018 le autorità della Regione Vallonia hanno assegnato al Consorzio Colas-led Tram’Ardent i lavori di realizzazione della prima nuova linea tranviaria e di successiva manutenzione; la linea, la cui inaugurazione è prevista entro il 2022, sarà lunga 21 km e collegherà i sobborghi di Sclessin e di Herstal passando dal centro cittadino. Nell’ambito del consorzio, la casa spagnola CAF si è aggiudicata la fornitura di 20 tram del tipo Urbos 100, dotati del sistema a supercapacitori ACR che sarà utilizzato nelle sezioni di linea non dotate di catenaria.
BRASILE
• CUIABA’ (Mato Grosso): è stata lanciata una gara per completare la costruzione della rete tranviaria, la cui entrata in funzione era stata inizialmente prevista per il 2014 in occasione dei Campionati Mondiali di Calcio e poi interrotta; sono previste due linee per complessivi 22,1 km; i 40 tram di tipo Urbos erano già stati consegnati da tempo dal costruttore spagnolo CAF senza poter essere utilizzati. L’inaugurazione è ora prevista per il 2020. Anche il costruendo tram di Brasilia ha vissuto la stessa situazione di blocco, ma di esso non ci sono più notizie.
CANADA
• TORONTO (Ontario): proseguono le disavventure legate alla mega-commessa di 204 nuovi tram (con un’opzione per ulteriori 60) affidata dalla Toronto Transit Commission a Bombardier: oltre ai ritardi nelle consegne, a luglio 2018 sono stati scoperti difetti strutturali in 67 veicoli (sugli 89 già consegnati), che hanno dovuto essere ritirati dal servizio e rinviati allo stabilimento di produzione: come conseguenza, si prevede ora di avere in servizio l’intera flotta solo alla fine del 2022. I tram, del tipo Flexity-Outlook, sono monodirezionali e lunghi 30,2 metri e hanno la particolarità di aver iniziato il servizio con il trolley, che è in fase di graduale sostituzione con il pantografo a mano a mano che le singole linee non vengono più gestite con i tram di vecchia generazione; sono destinati a rimpiazzare completamente il parco circolante, composto da 196 motrici monocassa di tipo CLRV e da 53 motrici articolate di tipo ALRV, prodotte in Canada da UTDC negli Anni 70 e 80.
CINA
• WUHAN (Hubei): il 1° aprile 2018 sono state inaugurate due nuove linee tranviarie (Guanggu tram), contrassegnate come L1 (Huazhong University-Fuzoling) e L2 (Tangxunhu City Railway Station-Optics Valley Botanical Garden): si tratta di collegamenti periferici di adduzione alla rete di metropolitana nella zona sud-est, con caratteristiche di moderne linee di LRT e con una flotta complessiva di 26 tram. Le due nuove linee si aggiungono alla linea T1, inaugurata nel 2017, portando lo sviluppo totale della rete tranviaria a 46 km.
• SUZHOU (Jiangsu): il 31 agosto 2018 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria, da Longkang Road a Suzhou New District, lunga 17,2 km; vi fanno servizio 18 tram prodotti in Cina da CRRC con licenza Skoda. Lo sviluppo totale della rete tranviaria, comprensivo della prima linea inaugurata nel 2014, ammonta ora a 43 km.
DANIMARCA
• AARHUS: il 25 agosto 2018 è stata inaugurata la prima linea di tram-treno della Scandinavia, tra Aarhus (Stazione ferroviaria centrale) e Odder, un centro situato nella cintura sud della città; è lunga 29 km e vi fanno servizio i 12 tram Tango prodotti da Stadler e che saranno condivisi anche dalla seconda linea che sarà attivata l’anno prossimo nella zona a nord della città. Nel contempo, la linea urbana 1 (inaugurata a fine 2017) è stata prolungata di 3,5 km fino a Lisbjergskolen ed è ora lunga 10 km.
FRANCIA
• CAEN: dal 1°/1/2018 è cessato il servizio del “tram su gomma” (sistema TVR di Bombardier). L’amministrazione locale, visti le deludenti prestazioni del sistema (che era in funzione dal 2002 e comprendeva due linee e una flotta di 24 veicoli) ha deciso di rimpiazzarlo con un vero tram. I lavori di ricostruzione delle sedi tranviarie sono iniziati nel corrente anno e si prevede che finiscano alla fine del 2019. Sono stati ordinati 23 tram ad Alstom del tipo Citadis X05 (di cui il primo è giunto a Caen il 4 ottobre), che saranno impiegati su una rete di 16,8 km. Il sistema TVR, concorrente del più fortunato Translhor, sopravvive ormai solo a Nancy, che ha acquistato da Caen parti di ricambio dei tram su gomma dismessi.
• NIZZA: il 30 giugno 2018 è stato inaugurato il primo tratto di 7 km della seconda linea tranviaria (T2), fra Cadam e Magnan. La nuova linea ha un andamento parallelo alla costa ed è priva di linea aerea di alimentazione elettrica in superficie; una volta ultimati nel 2019 i lavori di costruzione del tratto centrale sotterraneo lungo 3,2 km, incrocerà la linea T1 (attiva dal 2007) in due punti centrali (Jean Medecin e Garibaldi) e sarà lunga in totale 11,3 km. Sono in servizio i primi 19 esemplari di una nuova serie di tram Citadis X05 forniti da Alstom, dotati di supercapacitori per la ricarica delle batterie alle fermate: è questa la prima applicazione in assoluto del sistema di alimentazione senza catenaria SRS di Alstom.
• PARIGI (1): sono partiti il 5 ottobre 2018 i lavori di costruzione della linea T13 di tram-treno nella banlieue ovest; la prima tratta da Saint Cyr a Saint Germain-en-Laye, la cui attivazione è prevista per il 2021, sarà lunga 18,8 km e sarà gestita con 11 veicoli di tipo Citadis Dualis costruiti da Alstom.
• PARIGI (2): il 24 novembre 2018 la linea tranviaria 3b (tangenziale nord) è stata prolungata di 4,3 km da Porte de la Chapelle a Porte d’Asnières. La linea tranviaria di cintura forma ora un semicerchio che segue i confini del comune di Parigi per 26,2 km ed è spezzata in due distinti tronconi (linea 3a da Pont du Garigliano a Porte de Vincennes e linea 3b da Porte de Vincennes a Porte d'Asnières). E’ già stato deciso un prossimo prolungamento di 3,2 km della linea 3b fino a Porte Dauphine, mentre la chiusura completa del cerchio (da Porte Dauphine a Pont du Garigliano) non è per ora ipotizzata. 14 nuovi tram Alstom di tipo Citadis X02 si sono aggiunti alla flotta già esistente per gestire il prolungamento.
• STRASBURGO: il 23 novembre 2018 è stato prolungato il percorso internazionale della linea D, che fin dal 2017 collega Strasburgo con la città tedesca di Kehl sulla sponda destra del Reno. Il nuovo tratto è lungo 1,1 km e raggiunge il centro di Kehl (Rathaus).
GERMANIA
• FRANCOFORTE SUL MENO (Assia): L’azienda di trasporto locale ha assegnato alla Alstom una commessa per 43 tram con un’opzione per ulteriori 10. I veicoli, la cui consegna inizierà a fine 2020, saranno battezzati “Citadis Frankfurt” e saranno lunghi 31,5 metri, con pianale interamente ribassato. Si tratta della seconda commessa tranviaria tedesca riguardante tram di fabbricazione francese: i primi veicoli francesi in assoluto a circolare in Germania erano stati i 28 tram-treni Regio-Citadis di Kassel nel 2004.
• MANNHEIM (Baden-Württemberg): l’Agenzia Rhein-Neckar, che gestisce il trasporto tranviario sulla rete a scartamento ridotto comprendente le città di Mannheim, Ludwigshafen e Heidelberg, ha assegnato all’azienda ceca Skoda una mega-commessa di 80 tram con un’opzione per altri 34. I veicoli prescelti, la cui consegna inizierà nel 2021, sono del tipo Forcity Smart, fabbricati in Finlandia dalla consociata Transtech e simili a quelli ordinati da Helsinki e Tampere: saranno bidirezionali con carrelli rotanti, a pianale interamente ribassato e di lunghezza variabile da 30 a 58 metri.
• POTSDAM (Brandeburgo): fra il 18 e il 20 settembre 2018, nell’ambito del salone Innotrans di Berlino, si sono svolte a Potsdam alcune prove su strada del sistema di guida autonoma sviluppato da Siemens, utilizzando un tram di tipo Combino (in servizio sulla rete di Potsdam dal 1998) appositamente attrezzato e in grado di muoversi senza guidatore; sembra che gli esperimenti abbiano avuto esito positivo, anche se non ci sono per il momento previsioni di applicazione di questo sistema in reale servizio.
ITALIA
• FIRENZE: il 16 luglio 2018 è stata inaugurato il prolungamento della linea T1 da Santa Maria Novella all’ Ospedale di Careggi: la nuova tratta (che doveva secondo i piani originali essere una linea separata con denominazione T3) è lunga 4,1 km e porta la lunghezza totale della linea a 12 km; sono già disponibili i 29 tram aggiuntivi Sirio prodotti da Hitachi Rail Italy (ex Ansaldobreda), che serviranno anche per la linea T2 di prossima apertura.
• MILANO: l’8 settembre 2018 è stato attivato il prolungamento della linea 15 nel comune di Rozzano da Viale Romagna a Via Guido Rossa, per un totale di 1,6 km.
NORVEGIA
• OSLO: la più grande commessa di tram della storia della Scandinavia è stata assegnata dall’azienda della capitale norvegese alla CAF, con un ordine di 87 tram del tipo Urbos 100 e un’opzione per altri 60. I veicoli, bidirezionali a pianale interamente ribassato e lunghi 34 metri, dovrebbero essere tutti in servizio entro il 2024 e sono destinati a rimpiazzare completamente la flotta attuale, composta da 40 motrici di tipo SL79 (Asea-Düwag) e da 32 motrici di tipo SL95 (Ansaldobreda).
NUOVA ZELANDA
• AUCKLAND: dal 6 agosto 2018 è cessato il servizio della linea storica (“Wynard Quarter heritage tramway”), in concomitanza con l’inizio di grandi lavori di riqualificazione della viabilità nella zona del porto. Non ci sono previsioni di riapertura per questa linea, inaugurata nel 2011, che era lunga 1,5 km ed impiegava 2 tram.
PORTOGALLO
• LISBONA: il 24 aprile 2018 è stata riattivata la linea tranviaria 24, tra Luis Camões e Campolide, che era rimasta fuori servizio per 23 anni: è gestita con i caratteristici tram “remodelados”, senza aumento della flotta complessiva. Lo sviluppo totale della rete tranviaria è attualmente di 27 km.
REGNO UNITO
• SHEFFIELD (Inghilterra): dal 25 ottobre 2018 è operativo il primo tram-treno inglese: una nuova linea interurbana tra Sheffield Cathedral e Rotherham si è aggiunta alle due linee urbane già esistenti, sfruttando un nuovo raccordo di collegamento con la ferrovia e portando lo sviluppo totale della rete tranviaria a 35 km. Sono in servizio 7 veicoli “Citylink” forniti da Vossloh-Kiepe (ora Stadler), alimentati a 750 Volt CC provvisoriamente anche sul tratto ferroviario (che prima non era elettrificato) e predisposti per viaggiare in un prossimo futuro anche col sistema di alimentazione standard ferroviario (25 KVolt 50 Hz CA).
RUSSIA
• SAN PIETROBURGO: il 7 marzo 2018 è entrata in funzione nella zona est della città una nuova linea suburbana di “tram veloce” (linea 8), gestita da una compagnia privata separata da quella tranviaria municipale; il primo tratto inaugurato, fra Ladozhskaya e Khasanskaya Ulitsa, è lungo 4,2 km e vi sono impiegati nove nuovi tram di tipo Melitsa costruiti nello stabilimento Stadler di Minsk, bidirezionali a pianale interamente ribassato e lunghi 33,5 metri. Proseguono intanto i lavori di ampliamento di questa sottorete, che una volta completata avrà uno sviluppo totale di 14 km con 4 linee e 23 tram.
• KOMSOMOLSK SULL’AMUR: Sparisce il servizio tranviario da un’altra città dell’ex Unione Sovietica, Komsomolsk, situata nella Siberia orientale in riva al fiume Amur. La rete di Komsomolsk, che era stata inaugurata nel 1957 e che versava in cattivo stato di manutenzione, è stata definitivamente chiusa a partire dal 30 settembre 2018; era estesa su 18 km e comprendeva 4 linee con una flotta di 39 tram.
STATI UNITI D’AMERICA
• CHARLOTTE (North Carolina): il 16 marzo 2018 è stato attivato un prolungamento di 14,9 km della Lynx Blue Line da 7th Street a UNC-Charlotte Main, un servizio di LRT in sede completamente protetta, che ha ora raggiunto una lunghezza complessiva di 30 km; sono entrati in servizio 22 nuovi convogli aggiuntivi Avanto S70 prodotti da Siemens.
• EL PASO (Texas): il 9 novembre 2018 il tram ha fatto ritorno nella città al confine con il Messico, dove è stato inaugurato un tracciato di 7,7 km a binario unico con due anelli che si congiungono a formare un grande otto su cui circolano due linee: una (Uptown loop) sull’intero tracciato e l’altra (Downtown loop) solo sull’anello più a sud. Compongono la flotta 6 motrici PCC storiche originali del 1937, accuratamente restaurate e ricondizionate dalla ditta americana Brookville.
• MEMPHIS (Tennessee): Ad aprile 2018 è stata riattivata la rete storica di Memphis, già aperta nel 1993 e poi chiusa per obsolescenza e scarsa sicurezza nel 2014; in una prima fase è stata riattivata solo una linea, che impiega 6 tram storici, ma entro fine anno saranno nuovamente in funzione tutte e 3 le linee, con uno sviluppo complessivo di rete di 11 km e con una flotta di 16 tram storici.
• MILWAUKEE (Wisconsin): un nuovo nome si aggiunge all’elenco delle città tranviarie americane, con l’inaugurazione, avvenuta il 2 novembre 2018, della prima linea tranviaria moderna a Milwaukee, soprannominata familiarmente “the hop” (per il momento è attivo solo un primo tratto lungo 3,3 km). Vi fanno servizio 5 tram articolati a pianale parzialmente ribassato “Brookville Liberty” di produzione locale, lunghi 20,4 metri e dotati di batterie, in grado di marciare su tratti di percorso sprovvisti di linea aerea di alimentazione elettrica.
• SAINT LOUIS (Missouri): il 16 novembre 2018 è stata inaugurata una linea tranviaria storica (“Delmar Loop”) lunga 3,5 km, che va ad aggiungersi alle due linee di metrotranvia già esistenti (Metrolinx) sviluppate su 73 km di rete. La linea è gestita regolarmente dal giovedì alla domenica con tre tram, di cui uno ex-Melbourne originale e due “replica cars” assemblati dalla Gomaco Trolley (una ditta americana specializzata nel costruire nuovi tram dall’aspetto “vintage” che utilizzano solo alcune parti originali di vecchi tram, come i carrelli).
• SANTA ANA (California): la Contea di Orange ha assegnato a Walsh Construction Co. i lavori di realizzazione di una linea tranviaria che collegherà la città di Santa Ana con Garden Grove, lunga 6,7 km, con la previsione di iniziare il servizio nel 2021; Siemens si è aggiudicata la fornitura di 8 veicoli.
SVIZZERA
• SAN GALLO: dal 7 ottobre 2018, con l’apertura al transito del nuovo tunnel del Ruckhalde (lungo 725 metri e situato alla periferia sud della città di San Gallo), è stata eliminata l’ultima e più ripida sezione di cremagliera rimasta sulla linea San Gallo-Appenzell; ciò ha permesso di realizzare un vero e proprio servizio passante, convogliandovi la tranvia extraurbana di Trogen proveniente dalla parte opposta della città che è stata prolungata fino a Appenzell e denominata S21, raggiungendo una lunghezza totale di percorso di 30 km (con un servizio di rinforzo chiamato S22 limitato a Teufen). Nel contempo sono stati immessi in servizio sulle due linee i 11 nuovi tram Tango di Stadler della compagnia Appenzeller Bahnnen, che non necessitano di cremagliera (con una massima pendenza dell’8%, questa è ora la più ripida linea svizzera ad aderenza naturale).
UZBEKISTAN
• SAMARCANDA: il 18 marzo 2018 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria, fra la stazione ferroviaria e Siab Bazaar, lunga 4,9 km, che si aggiunge alla prima linea attivata nel 2017; sulla rete tranviaria, ora lunga complessivamente 11 km, sono impiegati 18 tram monocassa Vario LF fabbricati dalla casa ceca Pragoimex e provenienti dalla capitale Taskent, la cui rete è stata chiusa nel 2016. Nel frattempo, la città ha affidato alla Pragoimex una commessa per ulteriori 42 tram dello stesso tipo, da impiegare su altre due nuove linee tranviarie in fase di costruzione.
INDUSTRIA TRANVIARIA
• Nel mese di settembre 2018 la casa costruttrice spagnola CAF ha acquisito il 100% della proprietà della polacca Solaris.
• Prosegue l’iter per la fusione tra Alstom e Siemens, già approvata da entrambi i partner e ora all’esame della Commissione Europea in ottica antitrust. La nuova mega-azienda costruttrice potrebbe iniziare ad operare alla fine del 2019 e diventerebbe la seconda al mondo, dopo il colosso cinese CRRC (che comunque sarebbe grande il doppio).

Con la notizia del prossimo arrivo dei nuovi 70 tram HitachiRail realizzati per Torino, si è aperto un ampio dibattito sul futuro dei tram serie 2800. Molti appassionati e simpatizzanti si sono allarmati sulla sorte dei tram arancioni che da quarant’anni accompagnano la vita dei torinesi, caratterizzando il paesaggio urbano. Ma quali sono i “tram arancioni” della serie 2800? Anzitutto una breve descrizione: si tratta di tram articolati a pianale non ribassato, a due casse e tre carrelli, lunghi 20 metri, tutti ricavati dall'accoppiamento di due precedenti tram più corti (monocassa) che la FIAT Materfer aveva realizzato per l'Atm di Torino nel corso degli Anni 30. Sono stati costruiti in tutto 103 esemplari di tram serie 2800, che si dividono in due sotto-serie.

La prima sotto-serie (2800-2857) fu costruita nel 1958-60 dalle Officine Moncenisio di Condove utilizzando 116 motrici a due carrelli della serie 2100-2200. Dei vecchi tram manteneva l'aspetto originale torinese storico: colore verde, testate con parabrezza originali verticali, duomi indicatori di linea, eleganti interni in legno, finestrini di ridotta larghezza, tre porte di cui la prima di sola salita e le altre due di sola discesa (sistema Peter Witt).
Alla fine degli anni 70 i tram di questa sotto-serie furono pesantemente ristrutturati dalla Seac/Viberti per adattarli al nuovo sistema di biglietteria a terra: divennero arancioni, le testate furono modificate secondo la moda dell'epoca, i vecchi finestrini furono sostituiti da nuovi molto più grandi, la plastica prese il posto del legno degli interni e fu aggiunta una quarta porta. Oltre al significativo peggioramento estetico, questi tram persero così il loro carattere originale.

Nel primo decennio del nuovo secolo, GTT aveva accantonato una decina di vetture serie 2800-2857. Nel 2011 GTT e ATTS hanno recuperato e restaurato una di queste motrici dismesse, riportandola alle condizioni di origine del 1960: si tratta della vettura numero 2847, oggi impiegata spesso sulla linea 7. Un altro tram tra quelli dismessi, la 2840, fu donata dalla città di Torino al municipio di Santos, in Brasile, dove è stata restaurata e trasformata nel 2015/16 in un tram ristorante polifunzionale (il Bonde Arte).
I tram della prima sotto-serie sopravvissuti e ancora circolanti (a parte la 2847 e i tre esemplari trasformati in tram ristoranti: 2823, 2840 e 2841) sono oggi logori e non più adatti a un servizio di trasporto moderno. Oggi è infatti improponibile usare nel normale servizio dei tram con pianale alto e inoltre dotati di componenti elettro-meccanici vecchi di 90 anni. L'ATTS si propone comunque di conservare come testimonianza storica anche un secondo esemplare della prima sotto-serie in configurazione arancione attuale. La ricostruzione di altri tram serie 2800 in configurazione anni 60 (come è avvenuto per la 2847) è impensabile per motivi di costo.

La seconda sotto-serie (2858-2902), fu costruita dalle officine Seac/Viberti di Carmagnola nel 1982 utilizzando 90 motrici a due carrelli della serie 2500. Furono realizzate direttamente in versione arancione con "biglietteria a terra", molto simili alle sorelle della prima sotto-serie già ristrutturate negli anni immediatamente precedenti. Nel 2007 su una motrice (la 2874) venne creata una cabina chiusa, climatizzata e di maggiori dimensioni per il manovratore. Vennero rimodernizzate anche le apparecchiature elettriche in cabina, eliminando i portafusibili a 600V con moderni magnetotermici a 24V. Tale prototipo ottenne successo e la modifica venne estesa sulle altre 43 vetture della seconda sotto-serie. I lavori della modifica furono svolti dalla ditta BM di Montirone (BS) tra il giugno 2009 e il maggio 2010. Tale modifica venne poi estesa anche su 10 motrici della prima sotto-serie (tra l’aprile 2011 e il maggio 2012), quelle ritenute in migliori condizioni.
I tram della seconda sotto-serie risultano essere complessivamente meno usurati e l’intrinseca robustezza potrebbe consentire loro di continuare il servizio ancora a lungo. Finché non verranno acquistati da Gtt altri nuovi tram oltre i 70 già decisi, una parte di essi sarà ancora indispensabile. Come per la prima sotto-serie, l’ATTS si propone di conservare come testimonianza storica anche un esemplare della seconda sotto-serie.

La flotta di tram storici di Torino, arricchita da questi e dagli altri tram recuperati da Torino e da altre città, sarà tra qualche anno più che sufficiente per gestire la linea 7 ed eventualmente anche una seconda linea storica, distinta dalle normali linee di trasporto pubblico che devono disporre di materiale adeguato agli standard moderni.
I tram storici tipo Ventotto di Milano non sono paragonabili alla serie 2800, ma piuttosto alla coeva serie 2500, in quanto hanno mantenuto quasi inalterata la splendida estetica degli anni 30 e, proprio per questo motivo, sono diventati delle icone della città.
I tram serie 2800 rappresentano dunque un’importante testimonianza di un’epoca storica della città di Torino e dell’evoluzione del mezzo tranviario. Le vetture preservate continueranno a circolare sulle strade cittadine, conformemente al concetto di “museo in movimento” che è alla base dello scopo sociale di ATTS.

AVANZAMENTO RESTAURO TRAM STORICO 447
di Luca Giannitti
La motrice Triestina 447 è un restauro che sta procedendo tuttora, benché la vettura sia stata già omologata e circoli da oltre un anno e mezzo. Le vicissitudini che ha avuto sono state molteplici, da un finestrino “capriccioso” che si è rotto ben tre volte per un difetto, agli interni, completamente ricostruiti secondo lo schema giunto da Trieste, adattato alla sistemazione monodirezionale del tram. Anche le matricole esterne sono state pesantemente riviste dalle prime provvisorie, che tante critiche sollevarono, senza sapere che si trattava di una scelta temporanea per permetterne la rapida omologazione. Un altro dettaglio che tanto ha destato commenti è il cosiddetto “cono”, ovvero l’elemento porta numero presente in testa alla vettura, quello che a Torino viene chiamato “duomo”. Provenendo da Roma, il tram aveva perso i suoi “coni” originali che si distinguono in due gruppi: quelli cilindrici, piatti, e quelli più aerodinamici utilizzati negli anni ‘50. In ogni caso né uno né l’altro erano più disponibili e andavano ricostruiti da zero.
La vettura è stata restaurata secondo lo schema di inizio servizio (anni ‘30) e quindi la scelta è ricaduta sui porta-numeri meno aerodinamici, ma restavano due grossi problemi: a chi farli fare e in che modo dare le caratteristiche tecniche (dimensioni, particolari, etc…). Su questi due ultimi aspetti ci è venuto in soccorso un amico triestino che non solo ci ha recuperato il campione da duplicare, ma si è anche impegnato nella ricerca di una ditta che potesse costruirli. Purtroppo le ditte capaci di un simile lavoro spesso non hanno preso in carico l’opera perché troppo artigianale. Ad Atts servivano solo due esemplari mentre tante aziende ragionavano con ordini di grandezza molto superiori. Alla fine della lunga ricerca si è trovata una ditta che non solo aveva le competenze, ma anche la sensibilità necessaria per intraprendere il lavoro, considerato il valore storico del pezzo e il fine per il quale Atts lo ricercava: il restauro dell’unico tram urbano di Trieste che circola ancora in Italia.
I tempi di consegna sono stati più lunghi del previsto perché non è stata data una scadenza ferrea per venire incontro alle esigenze della ditta. Gli artigiani coinvolti hanno promesso costi contenuti e in cambio Atts si è adeguata alle loro priorità.
Il “cono” porta-numero è composto da una staffa di supporto a cui sono saldati due alloggiamenti per le bandierine triangolari (Italia e Trieste), previste durante i giorni di festa. Il supporto sorregge sul fianco un cilindro di circa 40 cm di diametro: il retro è chiuso mentre il fronte è trasparente ed è retroilluminato da una lampada. Il coperchio ha una scanalatura per inserire esternamente una maschera metallica di colore nero, con il numero di linea intagliato. La vettura è stata ambientata sulla linea 6, una delle ultime linee urbane di Trieste, arrivata alla soppressione nel 1966.
Parallelamente sono arrivati degli elementi decorativi dei fianchi delle panche interne, realizzati artigianalmente da un falegname, sullo stile di quanto rilevato dalle fotografie d’epoca. Sarà tutto montato durante il breve fermo della vettura necessario per l'installazione dei "coni".

IN GITA SUI TRAM DI ZURIGO
di Gianpiero Bottazzi
Una delegazione di ATTS ha partecipato nell’ultimo week end di ottobre alla gita a Zurigo, accolta dagli amici del Museo del tram (TMZ). Quando nel 2016 i soci dell’associazione zurighese vennero a Torino rimasero entusiasti dell’accoglienza da parte di ATTS. Come ringraziamento hanno organizzato una giornata speciale sulla rete tranviaria con ben due tram storici gratuiti a nostra disposizione e l’accompagnamento di due guide esperte di trasporto, gli amici Martin Gut e Tommy Grunberg.
Per un amante del tram visitare Zurigo è un vero piacere. Fin dal primo momento, quando siamo entrati in città, abbiamo potuto apprezzare la rete tranviaria. L’hotel dove abbiamo pernottato, l’Olympia situato in Badenerstrasse, nella zona ovest della città, non poteva essere in posizione migliore: davanti transitavano ben due linee tranviarie, la 2 e la 3, veloci e silenziose. La giornata di sabato, interamente dedicata a Zurigo e ai suoi tram, è iniziata alle 9 quando siamo saliti sulla motrice storica a due assi n° 2 che ci ha portato al deposito/officina di Oerlikon. Qui abbiamo potuto vedere, fra l’altro, l’operazione di aggancio di un rimorchio alla motrice e la tornitura delle ruote di un tram. Abbiamo poi ripreso il tour a bordo di un altro splendido tram storico, un “Mirage” articolato a tre casse degli anni ‘60. I nostri amici ci hanno quindi portato a visitare l’officina in cui l’associazione restaura i veicoli, una piccola ex rimessa a Wartau. Intanto i morsi della fame hanno cominciato a farsi sentire e abbiamo quindi molto apprezzato una breve sosta per assaporare un bratwurst, la famosa salsiccia svizzera.
Nel pomeriggio ci siamo spostati con i normali mezzi pubblici e ne abbiamo apprezzato l’efficienza. Abbiamo viaggiato su numerose linee tranviarie, sui nuovissimi filobus e, a più riprese, sulla linea storica 21 gestita dalla TMZ nell’ultimo week end di ogni mese. Non poteva mancare un giro sulla tranvia a cremagliera Donderbahn, che in poco più di 5 minuti porta su una collina che sovrasta Zurigo percorrendo una lunghezza di 1,3 chilometri con un dislivello di 162 metri. Infine siamo arrivati al Museo del Tram in Forchstrasse, nella zona est della città, che ospita mezzi di tutte le epoche e molti plastici e modellini tranviari. Qui abbiamo conosciuto da vicino altri soci della TMZ che ci hanno offerto un aperitivo tranviario. Davanti al Museo abbiamo potuto vedere in servizio i tradizionali tram rossi della Forchbahn, una delle due linee interurbane della città. Il ritorno in hotel, dopo la cena, non poteva che essere con il tram che, anche di sera, è una presenza costante nella città.

IL TRAM FANTASMA DEL DEPOSITO SAN PAOLO
di Antonio Accattatis
È quasi la mezzanotte del primo settembre 1958, una tiepida serata di fine estate a Torino.
Il manovratore della motrice a tre casse 2742, in servizio sulla linea 6, concluso il suo turno, sta riportando la vettura al deposito San Paolo di via Monginevro angolo corso Trapani. Entrato in deposito, si attesta su uno dei binari di sosta in modo che, come ogni sera, il tram venga preso in consegna da parte di uno degli operai addetti alle ordinarie operazioni di manutenzione; fatto ciò il conducente si prepara per scendere e avviarsi verso il gabbiotto del responsabile per segnare l’ingresso in deposito.
A questo punto avviene qualcosa che ha dell’incredibile: per una distrazione il tranviere lascia la leva dei motori sulla marcia avanti e la manovella del reostato sulla prima tacca. Il sistema di bloccaggio automatico impedisce però ai motori di funzionare finché almeno una porta rimane aperta; una volta disceso dalla vettura il manovratore chiude la porta dal comando esterno e volge le spalle al tram che, silenziosamente e lentamente, si avvia.
In quel momento nessuno fa caso a un tram che si aggira da solo, come un fantasma, lungo i binari all’interno del deposito; del resto, a quell’ora nella rimessa c’è un gran movimento: tram che rientrano, vetture che vengono trasferite da un binario all’altro per i consueti controlli e per le operazioni di pulizia.
Ovviamente, non essendoci nessuno a bordo per comandare gli scambi, il tram segue un percorso disegnato dal caso e così percorre tutto l’anello del deposito ed esce dalla rimessa per imboccare via Monginevro in direzione del centro. La velocità inizia ad aumentare, sia perché una volta superata l’inerzia dell’avvio anche solo la prima tacca del reostato è sufficiente a sostenere una pur modesta accelerazione, sia perché la via, tra il deposito e piazza Sabotino è leggermente in discesa, quasi impercettibile, solo del 6‰, ma abbastanza per un tram privo di manovratore.

Per fortuna a quell’ora le strade sono quasi deserte, per cui la vettura oltrepassa corso Trapani, via Isonzo, via Issiglio, via Caraglio, via Cumiana, corso Racconigi senza causare alcun incidente.
Nel frattempo qualcuno in deposito inizia a domandarsi dove sia finita la motrice 2742: dopo averla cercata nei vari binari di sosta, il dubbio che qualcosa d’impensabile sia avvenuto comincia a farsi strada tra gli sguardi allibiti dei tranvieri. A questo punto uno dei graduati prende il telefono e chiama il chiosco di piazza Sabotino per chiedere se hanno visto passare la bisarca. Purtroppo, quando il telefono squilla, la vettura è appena transitata lungo la piazza, anche qui, incredibilmente, passando incolume attraverso il sia pur modesto traffico di corso Peschiera. Gli agenti Atm del chiosco provano a rincorrere la vettura per sganciare l’asta dalla rete, ma ormai il tram procede a oltre 25 km/h, per cui ogni tentativo d’inseguimento a piedi è destinato al fallimento.
Oltrepassata la piazza, il tram prosegue lungo via Monginevro e all’incrocio con via Scalenghe investe, fortunatamente di striscio, una Fiat 600, a bordo della quale ci sono il dott. Capurso e la moglie. Lo spavento è grande, ma per fortuna i due coniugi non riportano alcuna ferita: rimangono però sconcertati dal comportamento di quel manovratore che, dopo averli investiti, non si è nemmeno fermato!
Un giovane automobilista, Nicola Cavadini, abitante in borgo Vittoria, sta rincasando in compagnia della moglie e assiste allo scontro. Anch’egli rimane allibito dall’incoscienza del manovratore e inizia a inseguire la vettura tranviaria per annotarsene il numero e denunciare all’Atm il comportamento criminale di un suo dipendente! Nel frattempo la vettura, dopo avere superato indenne corso Ferrucci, ha imboccato via Pier Carlo Boggio. Cavadini riesce, non senza difficoltà, a raggiungere e superare il tram solo quando questo sta svoltando in corso Vittorio Emanuele e qui si accorge con sgomento che alla guida non c’è nessuno.
Dopo un attimo di riflessione, il giovane decide di precedere la vettura per farle in qualche modo strada e così imbocca anch’egli il corso. Oltrepassato corso Duca degli Abruzzi, giunge nei pressi del monumento, all’incrocio con corso Galileo Ferraris, dove si accorge che un altro tram sta procedendo sugli stessi binari del tram fantasma: si stratta della vettura 3185 in servizio sulla linea 5.
Con prontezza di spirito supera anche questa vettura, si pone di traverso sui binari e, sceso dall’automobile, corre incontro al tram, facendo ampi gesti al manovratore, Vincenzo Trucco, il quale, per capire cosa stia accadendo, apre la porta anteriore; Cavadini irrompe sul mezzo gridando che sta sopraggiungendo un tram privo di manovratore. Dopo un momento di perplessità, durante il quale manovratore, bigliettaio e i sette passeggeri presenti sulla vettura si chiedono se questo giovane agitato abbia esagerato con l’alcool, il Trucco si rende conto che effettivamente un tram sta arrivando e grida ai passeggeri di balzare a terra.
Pochissimi istanti dopo che gli occupanti del tram si sono messi al sicuro, la 2742 tampona violentemente la 3195, facendole percorrere una decina di metri prima di fermarsi. Le vetture riportano danni rilevanti ma non irrimediabili: verranno entrambe riparate e rimesse in servizio.
Con un’inimmaginabile dose di fortuna, un tram gira incontrollato per la città, per un tragitto di oltre tre km, e al termine di questa corsa non c’è una sola persona che riporti anche solo un graffio in questa incredibile sera di fine estate del 1958.
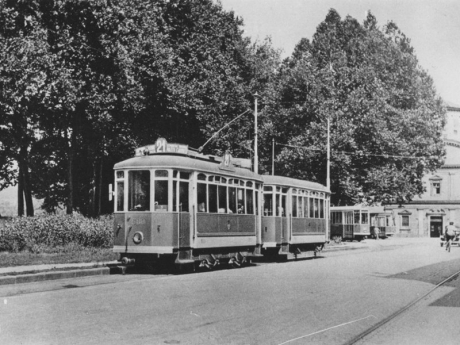
MADONNA DEL PILONE: LA VECCHIA BORGATA DI TORINO IN CUI NACQUE MIO PADRE
di Michele Bordone
Innumerevoli sono i ricordi di gioventù legati al tram in quel borgo. Ricordi piacevoli di un mondo che purtroppo non esiste più. Non ho fatto a tempo a vedere la tranvia intercomunale di Gassino, ma le linee 21 e 23 sono ancora nella mia memoria.
Bellissimo, il capolinea davanti alla chiesa, con l’anello che girava attorno a enormi platani, e addirittura due con binari tronchi ai lati del binario di sosta. Per accedervi occorreva partire in direzione Torino (a quel tempo gli abitanti della borgata, in buona parte miei parenti, parlavano di “andare in città” per dirigersi verso la non lontanissima piazza Vittorio); dopodiché, si doveva retrocedere verso i binari tronchi.
Non perdevo occasione di andare a passeggiare con la nonna “Po” sulla “leja” per vedere il 21 che girava: era bellissimo vedere il bigliettaio che azionava lo scambio manuale per far girare la vettura, quasi sempre una 2500.
Ritornando a ricordi più felici, una domenica di metà anni ’50 riuscii persino a salire su uno degli ultimi, se non l’ultimo, rimorchio tranviario in servizio sulla linea 21. Non ho idea di quale fosse la vettura motrice, ma ricordo benissimo quella fune che serviva da sirena per la prenotazione della fermata.
Dopo la soppressione della linea 23, il capolinea del 21 fu spostato su un anello in piazza Marco Aurelio (nello stesso luogo dove molti anni dopo venne collocato il capolinea dell’autobus 66), impianto che comprendeva anche un originale scambio manuale di sicurezza. Per partire dal capolinea, il bigliettaio azionava manualmente lo scambio, dopodiché – passato il tram sullo stesso – rincorreva la vettura in mezzo all’incrocio per risalirvi sopra. Questo era dovuto al fatto che il capolinea era in discesa ed un eventuale contrattempo ai freni avrebbe portato il tram ad occupare l’incrocio, creando un pericolo alla circolazione.
Nella piazza esiste ancora la mitica “Società” (anche se oggi è un ristorante rinomato), in cui le mogli andavano a raccogliere i mariti un po' “su di gomito” per riportarli a casa!
Dinanzi al locale, la linea 23 iniziava un tratto di percorso a binario unico con uno scambio a molla.
Malauguratamente, quello scambio fu fatale per Serse Coppi, il fratello del Campionissimo, che durante una Milano-Torino con arrivo al vicino Motovelodromo infilò una ruota dentro l'incavo e si fratturò la testa con conseguenze letali.
A volte, alla domenica andavo con la zia fino al capolinea, per acquistare dal bigliettaio l’abbonamento per la settimana entrante. Non ho mai capito perché non potesse acquistarlo direttamente il lunedì mattina sul primo viaggio, ma non ho mai sentito nessuno lamentarsi per aver interrotto la pausa tra un viaggio e l’altro.
Tra le attrazioni delle giornate passate alla Madonna del Pilone c’era anche la filovia di Chieri, gestita dall’Autoindustriale, che faceva passare in via Boccaccio quei suoi filobus Fiat 668, veicoli abbastanza recenti ma che a me parevano già piuttosto sgangherati, e che rimasero in servizio sino alla sua soppressione e successiva sostituzione con la linea automobilistica 30 ATM. Mi affascinava molto l’intreccio dei fili della linea aerea in corso Casale a partire da piazza Carrara e fino a piazza Borromini (la mitica “Barriera”). La linea 21 diretta verso via Millefonti incrociava l’ingresso e l’uscita dal deposito dei filobus, posto di fronte all’ex-cinema Eridano, e poi – prima della piazza Borromini – si spostava sulla sinistra per affiancarsi al binario della direzione opposta, percorrendo contromano l’ultimo tratto prima della piazza.
Crescendo, ho iniziato a frequentare le scuole superiori in via Figlie dei Militari e ho purtroppo assistito alla famigerata riforma del 1966, che ha semplicemente soppresso alcune linee di tram per sostituirle con autobus. In quest’occasione, il bus 61 ha sostituito il mio amato 21, portandomi via un pezzo della mia bellissima gioventù tranviaria.

UNA GITA A... WUPPERTAL
di Mario Positello
Per un appassionato di mezzi di trasporto, Wuppertal vuol dire “Schwebebahn”, celebre monorotaia sospesa, lunga 13 km, in servizio dal 1901 e che è diventata il simbolo e la principale attrazione della città del Nordreno-Vestfalia, unica nel suo genere. Wuppertal però, possiede anche il triste primato di essere stata l’ultima città tedesca a sopprimere il più tradizionale tram (a scartamento ordinario) nel maggio del 1987, e fino al 1970 ebbe anche una vasta rete tranviaria a scartamento metrico, di oltre 100 km, che varcando i confini comunali si spingeva nella cosiddetta Bergische Land (“Regione delle colline”). Proprio sul finire degli anni ‘60, quando ormai la soppressione delle ultime linee a scartamento ridotto era alle porte, un gruppo di appassionati fondò l’associazione “Bergische Museumsbahnen e. V.“, con lo scopo di salvaguardare il patrimonio storico che stava per scomparire.
Nella primavera del 1969, su un pittoresco tratto di circa 3 km dell’appena soppressa linea extra-urbana numero 5, i volontari presero in carico la gestione dell’infrastruttura e iniziarono i lavori di restauro e di manutenzione sulle prime vetture preservate.
La scelta di questa tratta non fu casuale: il percorso, che supera un dislivello di 150 metri, è quasi interamente immerso nel bosco, non vi sono interferenze con il traffico privato, a parte qualche strada agricola, nell’area del “nuovo” capolinea inferiore di Kohlfurther Brücke fu costruito un deposito/officina che divenne anche la sede dell’associazione.
Nacque così il museo tranviario di Wuppertal-Kohlfurth (Bergische Straßenbahnmuseum - BSM), che raccoglie una collezione comprendente varie vetture di quella che fu una delle più grandi reti a scartamento ridotto d’Europa.
Nel 1991 l’associazione ottenne la concessione per poter esercitare un trasporto pubblico di persone e nel 1992, alla presenza dell’allora primo ministro tedesco Rau, venne inaugurato ufficialmente il servizio che continua tutt’ora.
Percorrendo 2,5 km, si raggiunge il capolinea superiore di Gueuel, immersi nella natura ma su un tram! A Greuel c’è la possibilità di ammirare un bel panorama sulla Bergisches Land, di intraprendere varie escursioni sui sentieri presenti in zona e anche di rifocillarsi in una tipica Gasthaus.
Il binario in realtà prosegue ancora per altri 500 metri, verso l’abitato di Cronenberg, ma l’ultimo tratto è oggetto di controversie con alcuni residenti della zona, che non gradirebbero il passaggio del tram e dei turisti vicino alle loro case e giardini… La questione è tutt’ora aperta.
Il parco veicoli della tranvia-museo è costituito principalmente da vetture a due assi, ma non mancano un paio di vetture a carrelli e un’altra articolata proveniente dalla città di Bochum. I tram funzionanti sono circa una decina, di cui sei atti al servizio passeggeri. Il museo è aperto ogni seconda e quarta domenica del mese, da aprile a ottobre, normalmente con due/tre tram in servizio con frequenza ogni 30 minuti.
Per raggiungere il BSM dalla Hauptbahnhof di Wuppertal si prende il bus city express 64 in direzione Solingen e si scende dopo circa 30 minuti alla fermata Kohlfurther Brücke, situata a circa 250 metri dal museo.
Wuppertal, quindi, oltre alla famosa Schwebebahn offre questa ulteriore attrattiva, rendendola una meta consigliatissima per un prossimo tour tranviario!
Per maggiori informazioni: https://www.bmb-wuppertal.de/
Foto Mario Positello: https://flic.kr/s/aHskCXqsJr

UN CONCERTO ITINERANTE SU UN PALCO DEGLI ANNI '30
a cura dell'associazione Sità Scoté
Al nostro passaggio le persone in strada si fermano: chi fa le foto col telefono, chi invece ride incredulo, nessuno però capisce cosa stia accadendo. Un tram degli anni ’30, la vettura ex ATM Torino n° 2598, per una sera diventa il palco di un concerto itinerante per il centro di Torino.
Gli artisti che si alternano al microfono sono molti e tutti hanno una cosa in comune: essere parte del progetto Sità Scoté.
Il progetto nasce nel 2018 con l’idea di far conoscere alcune storie di vita legate alla città. Per questo diverse coppie di giovani artisti emergenti torinesi hanno “intervistato” alcuni testimoni che, con il loro racconto, hanno dato spunto ai testi e alle musiche delle canzoni.
Oltre all’aspetto musicale il progetto prevede anche la creazione di un documentario che in questo momento è in fase di realizzazione.
Il fulcro di Sità Scoté – che significa “città in ascolto” o “città da ascoltare” – è proprio il raccontare storie di vita. Questo progetto è un contenitore di pensieri, situazioni, attimi e anche un tram è o è stato un luogo nel quale le persone si incontrano, si parlano, si conoscono o semplicemente si ignorano. Quale palco migliore allora se non un tram, e per di più storico, che di storie ne ha conosciute tantissime e di storia ne ha vissuta molta.
Per questo motivo, venerdì 15 febbraio c’è stato il secondo concerto itinerante che, come il primo, è stato completamente gratuito.
L’incontro era fissato per le 20.30 o per le 22 (in base al turno prescelto) in piazza Castello e da lì si partiva per un viaggio tra musica e storie in giro per il centro di Torino.
Per un’ora si sono alternati sul palco artisti quali: Eugenio Cesaro – fontman degli Eugenio in via Di Gioia -, Lince, Chelo, Artbeat, Isole di Neve, Pietro Giay, Nicolò Piccinni, Fran e i pensieri molesti e Claudio Lo Russo degli Atlante.
L’evento, che sta raccogliendo sempre più adesioni, potrebbe tornare in futuro, anche in previsione al lancio dei nuovi artisti e delle nuove storie di Sità Scoté.

AHN 2019: TUTTI A DRESDA IN TRAM STORICO!
di Gianpiero Bottazzi
Anche quest’anno ATTS ha partecipato al convegno AHN, giunto alla 31esima edizione. L’incontro si è svolto a Dresda, la “Firenze sull’Elba”, dal 25 al 28 aprile. AHN è una rete di associazioni europee che si occupano di storia, cura, restauro e gestione di veicoli storici legati al trasporto pubblico (tram, filobus e autobus). ATTS è entrata in questo gruppo nel 2007 e nel 2011 ha organizzato l’evento nella nostra città. La partecipazione a questi incontri è un’importante occasione di conoscenza fra le associazioni e di confronto tra esperienze. La sede del meeting è stato lo splendido Museo del Tram, realizzato in un ex deposito tranviario a fianco della sede dell’azienda dei trasporti cittadina. I partecipanti sono stati un centinaio, in rappresentanza di quasi trenta associazioni, in gran parte tedesche.
Il convegno è iniziato con la presentazione di Dresda, della sua azienda di trasporti (la DVB che ha circa 1800 dipendenti, 172 tram, 12 linee tranviarie, 134 km di rete e trasporta complessivamente 163 milioni di passeggeri) e dell'associazione (Strassenbahnmuseum Dresden e.V.), fondata nel 1992, che si occupa di 35 veicoli storici, raccolti sin dagli anni '60. Dal 1996 i volontari sono nell’attuale sede del museo, restaurato nel 2010-2011. Nel pomeriggio si è svolto un tour della città a bordo di due tram storici, "il grande e il piccolo luccio" (così chiamati per la forma dei tram), la risposta tedesca alle PCC americane. Il prototipo fu realizzato nel 1929 dal professore Alfred Bockemuhl, una vera celebrità tra gli appassionati di tram. In serata, visita al Museo del Tram, ricco di oggetti e immagini che ripercorrono la storia tranviaria di Dresda dalle origini (1872) ai giorni nostri.
Nella seconda giornata sono intervenute le associazioni di Stoccarda, Norimberga, Chemnitz, Monaco, Dresda e delle città del Reno-Neckar. Fra i principali temi trattati: come allargare il pubblico che partecipa alle manifestazioni di tram storici, quali strategie per avvicinare i giovani e gli effetti del nuovo regolamento europeo della privacy sulle nostre associazioni. È stata sottolineata l’importanza di essere attivi su molti fronti, collaborare con altre realtà ed essere creativi. Sono caratteristiche che ATTS ha cercato di mettere in pratica in questi anni con risultati positivi. Interessante la presentazione dell’associazione Amici del Museo del Tram di Monaco che ha presentato un criterio per valutare il materiale che merita maggiormente di essere conservato. Lo schema, applicato finora a 47 veicoli, comprende alcuni parametri (ad esempio la condizione, il valore storico, l’epoca, il tempo e il costo del restauro) e ad ognuno di essi è abbinato un peso. Terminati gli interventi, abbiamo visitato l’officina dei tram di Gorbitz, raggiunta con 2 tram Tatra: la T3 n° 2000 in composizione tripla (2 motrici e un rimorchio) e la T6. La prima relazione del terzo giorno ha analizzato le prospettive del Museo del tram di Dresda, annunciando che nel 2021 vi si svolgerà un evento legato al tram “luccio” in occasione dei 125 anni della nascita del suo inventore; è seguita la presentazione “Un viaggio nel tempo nell’anno 1973” con una carrellata di foto scattate da un appassionato danese in visita nella città dell’allora Ddr. È quindi stato presentato il convegno AHN 2020 (a Graz, in Austria) e infine i delegati hanno assegnato l’organizzazione dell’edizione 2021 alle città tedesche di Naumburg e Halle. La giornata è proseguita sulle due funicolari di Dresda (la Standseilbahn e la Schwebebahn, quest’ultima molto spettacolare in quanto sospesa) e sulla ferrovia del parco cittadino (Parkeisenbahn), gestita da ragazzi, con oltre 4 km di linea e scartamento di 350 mm. In serata, tour a bordo di un autobus Büssing del 1938.
L’AHN 2019 si è concluso, domenica 28 aprile, con un viaggio sulla linea della Kirnitzschtalbahn, una tranvia intercomunale a scartamento metrico che entra nella riserva della valle del Kirnitz, partendo da Bad Schandau, cittadina a 36 Km da Dresda.

GLI ULTIMI MESI DELLA TORINO-RIVOLI
di Simone Schiavi
La tranvia elettrica Torino-Rivoli, inaugurata nel 1914, nasce sulle ceneri di precedenti infrastrutture (una ferrovia a vapore inaugurata nel lontanissimo 1871 e una parallela tranvia a vapore): infatti, già nel 1882 si raggiungeva il comune del celebre castello sabaudo e, nel tratto cittadino, era stato perfino costruito un “trincerone”, eliminato proprio con l’elettrificazione.
La tranvia elettrica serve con successo per decenni la parte ovest della città e della cintura. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tuttavia, vive uno strano destino. Da un lato, continua ad essere una linea di grandissima importanza, tanto che raggiunge il primo posto tra le tranvie interurbane italiane in base alla percentuale di proventi ottenuti dai biglietti (ossia un “coefficiente d’esercizio” pari a 0,86, un valore oggi semplicemente incredibile). Dall’altro punto di vista, ha gli stessi problemi di tutte le tranvie intercomunali dell’epoca, non solo a Torino: la necessità di importanti lavori all’armamento e alla linea aerea, rotabili in buona parte antiquati (molti dei quali risalenti al 1914, escludendo le poche “littorine”), abbondanza di pericolosi attraversamenti stradali. Il notissimo nomignolo di “tritatutto” non è certo meritato ma la pericolosità della convivenza col traffico crescente è inconfutabile.
Si decide così per la soppressione, scegliendo di realizzare una linea di filobus anziché acquistare semplicemente un po’ di autobus. La decisione è motivata dal traffico comunque notevolissimo e destinato a crescere ancora, o comunque a non diminuire: anche se l’automobile erode forti quote di passeggeri, si stanno però sviluppando i paesi lambiti o attraversati dalla tranvia, che diventano vere e proprie città. L’unico problema irrisolvibile sarà la cessazione immediata dell’ancora fiorente trasporto merci; così, il gestore – il consorzio CTREA – per decenni (!) organizzerà il trasporto di carri ferroviari completi via camion dalla stazione FS di Collegno alle aziende presenti lungo il percorso, ormai non più raccordate.
Prima della soppressione, avvenuta il 12 novembre 1955, viene ancora commissionato un servizio fotografico per testimoniare gli ultimissimi servizi della tranvia. In fondo, il tram ha accompagnato sotto varie forme lo sviluppo della cintura ovest per oltre settant’anni; un reportage realizzato “come si deve” è il minimo per celebrare il grande contributo e il suo posto nel cuore dei cittadini.
Le foto realizzate sono eccezionali. Riprendono, curiosamente, tutte le stazioni della tranvia tranne Leumann, ossia l’unico fabbricato tuttora esistente. In realtà, già nel periodo terminale del servizio la bella stazione liberty di piazza Statuto non esiste più: eliminata insieme ai relativi fasci di binari, è rimpiazzata dall’attuale grattacielo e dagli edifici vicini. Gli ultimi treni vengono infatti attestati lungo un binario tronco che percorre il tratto finale di corso Francia, affiancato da un gabbiotto provvisorio (ma dignitoso) in legno.
Comunque sia, nel servizio fotografico si trovano immagini di tutte le fermate: in piazza Bernini il pesante convoglio incrocia un nuovissimo autobus, in piazza Rivoli è alle prese con un moderno filobus, a Pozzo Strada si ferma di fronte alla fabbrica Tonolli, in piazza Massaua incrocia il misero gabbiotto della fermata e all’Aeronautica d’Italia, invece, si attesta davanti a una graziosa stazione in muratura.
I convogli del 1914, ormai in pessime condizioni, e le “littorine” relativamente giovani ma consunte corrono poi verso Rivoli. Incrociano la trafficata stazione di Collegno, poi il moderno edificio di Cascine Vica e, finalmente, il capolinea di Rivoli. Proprio in quest’ultima località, poco tempo dopo, una triste immagine mostrerà i passeggeri dell’ultimo convoglio mentre si congedano dal tram alzando i fazzoletti bianchi, con un velo di sincera tristezza.
Per fortuna, questo servizio fotografico è giunto fino a noi. Ben 28 immagini (praticamente tutte inedite) si trovano infatti su “Torino sconosciuta vista dal tram”, l’ultimo libro edito dall’ATTS, che offre uno sguardo inedito su una linea di cui credevamo di aver già visto tutto, o quasi.

STREETCAR E LRT NEGLI USA
di Giovanni Zampa
Spesso si pensa che negli Stati Uniti i servizi pubblici di trasporto siano poco significativi e che, per quanto ci interessa più da vicino, il trasporto su rotaia sia praticamente nullo o quasi. Molti ricordano i famosi “cable car” di San Francisco; in ambienti più ristretti si conosce anche la linea F, sempre di San Francisco, cui si è aggiunta la linea E gestita anch’essa con materiali storici, ma c’è stato un revival del trasporto urbano su rotaia interessante da approfondire. In assoluto siamo sui livelli francesi (in percentuale, ovviamente, no!), ma comunque è uno sviluppo significativo a cui ha partecipato anche l’Italia. Da queste considerazioni sono escluse le reti metropolitane.
Attualmente ci sono 40 città o territori che hanno impianti di questo tipo divisi tra tram (“streetcar”, “trolley”) urbani e interurbani, LRT urbani e interurbani, linee storiche (heritage streetcar) e 1 linea di tram-treno. In molti casi le nuove linee riutilizzano tracciati ferroviari abbandonati.
Per quanto riguarda i rotabili mancano le lunghe vetture all’europea, ma ci sono vetture a 1 sola cassa oppure a 2/3 casse eventualmente accoppiate e anche tram diesel. I costruttori sono i più vari, dal Giappone all’Italia per finire con gli spagnoli e i cechi.
Storicamente 6 città hanno sempre mantenuto un impianto su rotaia pur riducendolo negli anni, a partire da New Orleans e la linea a cavalli del 1835, per continuare con San Francisco e i suoi cable car del 1878, Boston dal 1897, Filadelfia con linee urbane e interurbane dal 1906, Cleveland dal 1913 e Newark dal 1935. Gli impianti originali erano sia urbani che interurbani.
La rinascita è iniziata nel 1980 da San Francisco sotto forma di una rete LRT.
Ampliando lo sguardo sul Nord America in generale, bisogna aggiungere il Canada, dove 4 città sono dotate di TPL su rotaia, e il Messico con 2 città. Tra l’altro la città di Toronto ha una rete di tram che funziona ininterrottamente dal 1861.
Tra queste bisogna contare che 5 hanno solo un “Heritage streetcar” in servizio ordinario con vetture effettivamente storiche o ricostruzioni moderne e 4 hanno impianti di “Heritage streetcar” oltre a reti moderne; tra queste la famosissima San Francisco, oltre a Boston, Filadelfia e Dallas. Queste linee sono gestite con vetture originali. La nascita delle “Heritage streetcar” è sempre stata una “rinascita” soprattutto a scopi turistici anche se bisogna notare alcuni esempi di chiusure soprattutto a causa di modifiche urbanistiche.
Per rimanere nell’ambito dei casi rari, bisogna citare anche 3 linee gestite con rotabili diesel (i GTW Stadler e Desiro Siemens) di cui una di tram-treno.
Per quanto riguarda le lunghezze, si va dai 2,6 km a Tacoma, nello stato di Washington ai 110 km di Filadelfia fino ai 150 km della rete LRT di Dallas, mentre per i passeggeri trasportati annualmente si va dai 158.000 del tram (non LRT) sempre di Dallas ai 51,5 milioni dei tram di San Francisco ai 68 milioni della LRT di Los Angeles.
A parte le reti delle città, bisogna aggiungere le realtà in ambito museale oppure no, nelle quali sono in servizio percorsi dedicati con vetture storiche originali.
Nei miei 3 viaggi negli USA ho utilizzato una dozzina di reti tramviarie e di LRT… (a seguire, la prossima puntata)
foto1: PCC della linea F di San Francisco.
foto2: vettura della rete urbana di Filadelfia.
foto3: vettura ad una cassa delle linee interurbane di Filadelfia.
foto4: vettura articolata della rete LRT del New Jersey nella stazione ferroviaria di Hoboken di fronte a New York oltre l’Hudson.
foto5: convoglio della linea LRT di Seattle nei pressi dell’aeroporto.
foto6: tram-treno diesel GTW in New Jersey.
foto7: armamento pesante della rete LRT di Pittsburgh con un convoglio in doppia
foto8: vettura panoramica a gradinate in esercizio nel Museo dei Trasporti su rotaia di Montrel.
foto9: vettura storica in servizio turistico ad Astoria alla foce del Columbia sul Pacifico. E’ dotata di carrello generatore in quanto il binario ferroviario non è elettrificato.

ZURIGO: TRAM BATTE METRO 18 A ZERO
di Roberto Cambursano
Zurigo, capoluogo dell’omonimo Cantone e più grande città della Svizzera, ha dimensioni paragonabili a quelle di Torino: mentre il comune conta circa 400.000 residenti, l’agglomerazione urbana arriva infatti a 1.300.000 abitanti.
Zurigo è una “città tranviaria” di prima grandezza, dove il trasporto pubblico raggiunge livelli di eccellenza inconsueti e frequentazioni altissime, mentre l’auto è ridotta ad un misero 17% del totale degli spostamenti: non a caso, si parla di “Modello Zurigo”.
Il trasporto nell’area urbana è incentrato essenzialmente sulla rete tranviaria a scartamento metrico: questa, pur essendo di tipo tradizionale ed estesa in massima parte in superficie, beneficia di soluzioni viabili e semaforiche progettate a suo completo favore ed è perfettamente integrata con la rete di “S-Bahn” (il servizio ferroviario metropolitano a scartamento ordinario, solo in minima parte sotterraneo e simile al nostro SFM).
Il primo tram a cavalli si mosse nel 1882, quando Zurigo già aveva strappato a Basilea il primato di città più importante della Svizzera grazie allo sviluppo industriale qui particolarmente imponente. La rete tranviaria, dopo la fase di boom di inizio Novecento, non smise mai di crescere e non conobbe quella fase di crisi generale che portò invece molte città del mondo occidentale a smantellare le proprie reti nel secondo dopoguerra.
Il “Modello Zurigo” attuale risale al 1973: in quell’anno fu indetto un referendum popolare per scegliere il futuro sistema di trasporto portante per la città, in cui ai cittadini era richiesto di esprimere la loro preferenza per la metropolitana classica o per il tram. La maggioranza dei cittadini si pronunciò contro la metropolitana e a favore del tram: gli zurighesi avevano compreso che un programma di ammodernamento e di deciso potenziamento della rete tranviaria poteva portare una città di quelle dimensioni, in vent’anni e con la stessa cifra necessaria per costruire una sola linea di metropolitana sotterranea, a disporre di più linee tranviarie con un servizio capillare ed efficiente. Proprio quella rete che oggi fa registrare il totale gradimento da parte dei suoi passeggeri e che il mondo le invidia. Un tratto periferico di linea sotterranea che era già stato costruito come futura metropolitana fra Milchbuck e Schwamendingerplatz è percorso oggi da due linee tranviarie e, poiché le tre stazioni intermedie sono dotate di banchina centrale “a isola”, dal 1986 i tram circolano su questo tratto tenendo la mano sinistra.
La rete di Zurigo ed è arrivata a disporre oggi di 18 linee tranviarie, interamente a scartamento metrico e sviluppate su un totale di 115 km. Di queste, 13 sono urbane in senso stretto (linee 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 17) e sono gestite dalla compagnia VBZ (Verkehrsbetriebe Zürich), che possiede una flotta di 240 tram dalla caratteristica livrea bianco-azzurra che richiama i colori della città; altre 2 (linee 10 e 12) raggiungono la zona dell’aeroporto nella parte nord dell’area metropolitana esterna e sono gestite dalla compagnia VBG (Verkehrsbetriebe Glattal) con un parco circolante di 18 tram. Vi sono poi due linee interurbane: la Forchbahn (linea S18), gestita con i caratteristici tram rossi dell’omonima compagnia che raggiunge Esslingen nella zona est dell’area metropolitana. e la Dietikon-Wohlen (linea S17) a ovest; queste due linee sono alimentate in corrente continua a 1200 Volt (tranne che nel tratto in comune con la rete urbana), a differenza del resto della rete che è alimentato a 600 Volt. Un’altra linea interurbana è in costruzione nella parte ovest dell’area metropolitana: è la Limmattalbahn, il cui primo tratto sarà in funzione dalla fine del 2019 e che, una volta completata, sarà lunga 13,4 km. Completano l’offerta urbana una tranvia a cremagliera (la Dolderbahn) e due funicolari. Vi è anche la linea storica 21, gestita dal Museo del tram ogni ultimo week-end del mese con vetture d’epoca e integrata nella rete ordinaria di cui adotta le normali tariffe. Vi sono poi 6 linee di filobus e molte linee secondarie di autobus, destinate a un servizio di adduzione alla rete principale, e anche un servizio di battelli sul Lago di Zurigo. La rete ferroviaria metropolitana, attivata a partire dal 1990, si compone di 26 linee con uno sviluppo totale di 380 km, gestite da due compagnie (la pubblica SBB e la privata ZSU) e ha il suo fulcro presso la stazione ferroviaria principale di Zurigo con un incrocio a livelli sfalsati.
Una caratteristica dei tram di Zurigo, finora immutata, è quella di essere stati tutti prodotti da industrie svizzere, sin dai tempi dei tram a due a assi. I primi tram di concezione moderna entrarono in servizio negli Anni 30: erano i cosiddetti “Elefanti”, costituiti da una motrice a una cassa e due carrelli capace di trainare fino a tre rimorchi. Seguirono a partire dagli anni 40 i “Tram standard svizzeri”, sempre monocassa, affiancati poi negli anni 60 dai tram articolati a tre casse “Mirage” (90 motrici e 36 rimorchi motorizzati soprannominati familiarmente “mucche cieche”). Tra il 1976 e il 1993 vennero poi immessi in servizio i primi tram ad azionamento elettronico, tuttora in circolazione: sono le 152 unità del “Tram 2000”, prodotte dalla BBC (poi divenuta ABB) in configurazione-base di lunghezza 20,5 metri a due casse, di cui 23 esemplari della serie più recente furono poi trasformati a tre casse nel 2004-2005 con l’aggiunta di una cassa intermedia ribassata. Vennero prodotte anche delle unità in configurazione senza cabina, sia a due casse che monocassa: questi rimorchi motorizzati, accoppiabili in comando multiplo, sono soprannominati “pony”. Una curiosità: una versione opportunamente adattata del “Tram 2000”, prodotta in Italia su licenza da Stanga e Ansaldo, venne scelta per i primi convogli della Metropolitana di Genova, inaugurata nel 1990.
Il tram più moderno che attualmente circola a Zurigo, l’unico a pianale interamente ribassato, è il “Cobra”, presente unicamente qui e prodotto in 88 esemplari fra il 2005 e il 2010 (ha mandato completamente in pensione i “Mirage”). I primi 6 prototipi hanno manifestato nel primo periodo di esercizio seri problemi strutturali e di rumorosità, tanto che la Bombardier, che nel frattempo aveva rilevato il progetto dal consorzio di aziende che lo aveva portato avanti, è stata costretta ad apportare sostanziali modifiche prima di iniziare la produzione di serie.
La VBZ ha ordinato recentemente alla Bombardier 70 nuovi tram di tipo “Flexity 2”, che dovrebbero essere consegnati a partire dalla fine del 2019 e sono destinati a sostituire la prima serie dei “Tram 2000”.
Il Museo del tram di Zurigo (TMZ) è un’associazione molto attiva fondata nel 1967, di dimensioni simili all’ATTS (ha circa 800 soci di cui un centinaio operativi). Sono conservati esemplari funzionanti di tram di tutte le epoche, alcuni dei quali sono di proprietà della TMZ, mentre altri appartengono alla VBZ; la sede espositiva è situata presso un vecchio deposito tranviario dismesso nella zona est della città ed è aperta al pomeriggio nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica. Le attività di restauro dei veicoli storici vengono invece svolte in una minuscola ex-rimessa situata all’altro capo della città. La TMZ, oltre ad organizzare manifestazioni per proprio conto, fornisce l’equipaggio completo dei tram storici in servizio sulla linea storica 21.
| RETE TRANVIARIA DI ZURIGO: DATI SALIENTI | |
| Aziende di trasporto | Urbano: VBZ / VBG. Interurbano: FB / AVA |
| Associazione tram storici | TMZ (www.tram-museum.ch) |
| Anno apertura | 1882 |
| Scartamento | 1000 mm |
| Alimentazione elettrica | 600 Vcc (urbana) / 1200 Vcc (interurbana) |
| Sviluppo rete | 115 km + 6 in costruzione |
| Numero linee | 18 + 1 in costruzione |
| di cui urbane | 15 |
| di cui interurbane | 2 + 1 in costruzione |
| di cui a cremagliera | 1 |
| Numero veicoli in servizio | 300 |
| di cui tram urbani | 258 |
| di cui tram interurbani | 40 |
| di cui tram a cremagliera | 2 |

SOGNANDO LA CALIFORNIA
di Roberto Cambursano
Forse non tutti sanno che il “Trolley Festival” che ogni anno l’ATTS organizza a Torino si ispira fortemente alla analoga manifestazione tenutasi a San Francisco negli Anni Ottanta, che favorì nel 1995 la nascita nella città californiana della prima e più importante linea tranviaria storica del mondo, la “Market Street Railway”. Da qui è partito l’impulso che ha portato alla realizzazione di molte altre linee storiche nel mondo e in particolare della Linea 7 di Torino nel 2011.
San Francisco, con quasi 900.000 abitanti, è la terza città in ordine di grandezza dello stato della California; mentre il nucleo urbano ha dimensioni paragonabili a quelle di Torino, la “San Francisco Bay Area” ovvero l’area metropolitana estesa (comprendente anche la città di San Josè, a sua volta dotata di una rete tranviaria) arriva a contare 7 milioni di residenti.
Il trasporto nell’area urbana è composto da una rete tranviaria di sei linee con standard di metrotranvia (qui definita LRT = Light Rapid Transit”), con transito in sotterraneo nella zona centrale e banchine di fermata alte, integrata da una rete di filobus e di autobus e da due linee tranviarie di superficie gestite interamente con materiale storico. L’offerta turistica è completata da tre linee di cable-car, uniche superstiti al mondo di tram con trazione a cavo sotterraneo, icona della città. C’è anche un sistema di metropolitana automatica (BART = Bay Area Rapid Transit) che attraversa in diagonale la città e serve l’area metropolitana circostante.
San Francisco fu fondata dagli spagnoli nel 1776 e passò agli USA nel 1848, dopo la guerra col Messico. Il primo tram a cavalli si mosse nel 1860, sei anni prima dell’arrivo in città della prima ferrovia transcontinentale d’America. Nel 1873 fu attivata la prima linea di cable-car lungo la Clay Street, ideata dal locale imprenditore di origine inglese Andrew Smith Hallidie. Nel 1906 si verificò un terribile terremoto, seguito da un incendio che distrusse buona parte della città che era fino a quel momento composta essenzialmente da case di legno: la successiva ricostruzione della città con case di materiale più solido e con criteri antisismici fu anche l’occasione per attivare i primi tram elettrici, che sono sempre coesistiti con i cable-car (da allora in poi progressivamente ridotti). Nel 1918 fu aperto al transito il “Twin Peaks Tunnel”, che collega il centro della città con la zona sud-ovest, ancora oggi percorso dai tram.
Negli Anni Sessanta fu approvato un Piano dei Trasporti che prevedeva la realizzazione di una rete di metropolitana regionale (il BART) e la trasformazione della rete tranviaria in un sistema di LRT imperniato su una lunga sottovia centrale lungo la Market Street (parallela al tunnel del BART scavato a un livello inferiore): nella fase finale, i binari in superficie avrebbero dovuto sparire completamente da questa via. Il primo tratto del BART sotto la Market Street fu inaugurato nel 1972, mentre la sottovia tranviaria fu aperta al transito gradualmente fra il 1980 e il 1982 e vi furono convogliate tutte le linee tranviarie esistenti. Ma in seguito al grande successo del “Trolley festival”, (manifestazione svoltasi nelle estati dal 1983 al 1987 in cui vennero fatti circolare dei tram storici sui vecchi binari destinati ad essere smantellati), per iniziativa della locale Camera di Commercio e visto l’entusiasmo della popolazione, la città fu costretta a cambiare i suoi piani e venne decisa l’istituzione di una linea storica permanente. Dopo il rinnovo completo dei binari in superficie, la linea denominata F fu inaugurata nel 1995 nel tratto tra Castro e Ferry Building, mentre nel 2000 fu attivato il prolungamento fino a Fisherman’s wharf, nella zona dell’Embarcadero.
La linea "F" è gestita con tram d’epoca provenienti da tutto il mondo: il percorso è lungo 10 km e segue interamente la Market Street (la larga via diagonale pianeggiante che delimita a sud la zona centrale collinare di San Francisco) piegando poi verso la zona del Porto (Fisherman’s wharf); il servizio è assicurato 365 giorni all’anno dalle 5,45 del mattino all’ 1,15 di notte, con frequenze dei passaggi dai 6 ai 20 minuti e con 20 veicoli impegnati nell’ora di massima punta; sono in vigore le normali tariffe dei trasporti urbani di San Francisco e vengono trasportati oltre 20.000 passeggeri al giorno. Con i medesimi criteri, nel 2015 è stata attivata una seconda linea storica (linea E), che con-divide un tratto della linea F nella zona dell’Embarcadero per poi dirigersi verso sud lungo la baia interna di San Francisco, condividendo i binari con la linea tranviaria municipale T. A causa dell'as-senza di un anello di inversione di marcia, su questa linea il servizio è assicurato esclusivamente da vetture PCC bidirezionali (dette “torpedo”), tutti i giorni con una frequenza di 16 minuti fra le 10 e le 18,30. Il parco storico circolante sulle due linee è costituito da circa 50 vetture provenienti da va-rie città americane (tra cui molti esemplari di PCC), inglesi, australiane e anche da Milano (tipo 1928), ma molti altri tram sono stati acquisiti e sono in restauro.
Naturalmente San Francisco è famosa anche per i suoi storici cable-car, oggi inseriti nel “National Register of Historic Places” come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Sono operative tre linee nella parte alta della città: la Powell-Mason, la Powell-Hyde e la California line, su cui circolano complessivamente 40 vetture. La “California Line” dispone di veicoli bidirezionali che invertono il senso di marcia mediante scambi di traversa, mentre sulle altre due linee sono impiegati tram monodirezionali che vengono girati a mano su piattaforme rotanti situate ai capilinea. Il sistema attuale, completamente rinnovato nel 1984, è composto da una centrale di produzione della forza motrice, alimentata da motori elettrici e collegata con un sistema meccanico di pulegge e rinvii a quattro funi di trazione (una per l’intera California line, una per il tratto in comune fra le altre due linee e una per ciascun ramo differenziato delle stesse) che corrono alla velocità costante di 9,5 miglia/ora su una pendenza massima del 21%. Il servizio è svolto 365 giorni l’anno dalle 6,30 alle 0,30 con frequenze comprese fra i 6 e i 15 minuti.
Le sei linee tranviarie moderne della rete di San Francisco hanno scartamento standard e sono sviluppate su un totale di 59 km, con un parco circolante di 215 tram. Sono contrassegnate da lettere (J, K, L, M, N, T) e tutte transitano attualmente nel tunnel lungo la Market Street dotato di nove stazioni sotterranee, ma una di esse (la linea T) è destinata a utilizzare un nuovo tunnel in costruzione che incrocerà ad angolo retto quello esistente all’altezza di Union Square per dirigersi a nord attraverso Chinatown e la zona centrale. Vi sono poi le due linee storiche (E e F), che aggiungono altri 10 km di doppio binario alla rete tranviaria. La rete metropolitana del BART si compone di 6 linee con uno sviluppo totale di 180 km.
La flotta attuale di tram moderni è composta da due tipi di veicoli, tutti articolati a due casse e tre carrelli a pianale alto: 151 motrici “Breda LRV” prodotte in Italia (entrate in servizio a partire dal 1996), più i primi 64 esemplari del “Siemens S200SF” (entrati in servizio a partire dal 2017), destinati a rimpiazzare completamente i Breda e a potenziare la flotta, che a regime arriverà a 260 unità totali.
La “Market Street Railway” è oggi una delle associazioni tranviarie storiche più grandi del mondo (ha circa 1200 soci). La sua sede, con Museo annesso, è situata in Steuart Street (lungo il percorso della linea F) ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17. L’associazione, oltre a curare le attività di restauro, manutenzione e pulizia dei tram storici, fornisce i bigliettai/accompagnatori in servizio sui tram storici delle linee E ed F: la guida è invece affidata al personale della Muni Metro. Tutti i tram storici sono rimessati presso un deposito della Muni Metro nella zona sud della città, non aperto al pubblico.
| RETE TRANVIARIA DI SAN FRANCISCO: DATI SALIENTI | |
| Azienda di trasporto | Muni Metro |
| Associazione tram storici | Market Street Railway (www.streetcar.org) |
| TRAM: Anno apertura | 1860 |
| Scartamento | 1435 mm |
| Alimentazione elettrica | 600 Vcc |
| Sviluppo rete | 69 km |
| Numero linee | 6 + 2 storiche |
| Numero veicoli in servizio | 215 + 50 storici (32 PCC+18 altri) |
| CABLE-CAR: Anno apertura | 1873 |
| Scartamento | 1435 mm |
| Sviluppo rete | 8 km |
| Numero linee | 3 |
| Numero veicoli in servizio | 40 |
1) giratura manuale di un cable-car sulla piattaforma girevole ("turnaround") al capolinea di Powell
2) cable-car in servizio con l'isola di Alcatraz sullo sfondo
3) tram di tipo PCC "torpedo" bidirezionale sulla linea storica E presso il capolinea di Fisherman's Wharf
4) tram di tipo PCC in livrea di Newark sulla linea storica F in Market Street presso il capo-linea di Castro.
5) interno del tunnel tranviario "Twin Peaks" con un tram Breda LRV e un tram Siemens S200

I TRAM DEL DRAGO
di Roberto Cambursano
La tranvia del Drachenfels, è la più anziana delle quattro linee a cremagliera oggi attive in Germania: all’epoca della sua inaugurazione, avvenuta nel 1883, fu anche la prima linea tedesca a cremagliera. Si trova nelle colline del Siebengerbirge (“i sette monti”) in bella posizione panoramica sulla riva destra del Reno nei pressi di Bonn, nella regione della Renania-Wesfalia. La cima più famosa di queste alture è senz'altro il Drachenfels (“Roccia del drago”), sormontato dalle rovine di un castello medievale a picco sul Reno a 360 metri di altitudine: secondo la leggenda, il mitico eroe nibelungo Sigfrido uccise il terribile drago che viveva qui e bagnandosi nel suo sangue divenne invincibile.
Il capolinea di valle è nel paese di Königswinter, situato in riva al Reno e raggiungibile da Bonn con la linea tranviaria 66, che fa parte del sistema di “Stadtbahn” locale. Dal capolinea di monte, posto a pochi metri sotto la cima del Drachenfels, si gode una vista spettacolare sul corso del Reno e sulle città di Bonn e di Colonia.
La linea, a scartamento metrico, è lunga 1500 metri ed è interamente provvista di cremagliera di tipo Riggenbach su una massima pendenza del 20%; il binario è unico, con un tratto di raddoppio intermedio che permette l'incrocio dei convogli alla stazione di Schloss Drachenburg; fra il capolinea di valle e quello di monte il dislivello è di 222 metri. Nel 1924 la gestione della linea del Drachenfels fu unificata con quella della vicina linea a cremagliera del Petersberg (oggi non più esistente) nella nuova compagnia “Bergbahnen im Siebengebirge”, che ne è tuttora l'azienda esercente.
Nel primo periodo di esercizio fu adottata la trazione a vapore, che rimase sempre affidata a locomotive tedesche fabbricate dalla Maschinenfabrik Esslingen: la prima serie di tre unità a due assi fu soppiantata da una seconda serie di quattro unità a tre assi nel 1926 (di cui una fu rivenduta nel 1938 alla tranvia Rüdesheim-Niederwald, anch’essa oggi non più esistente), ognuna delle quali poteva spingere fino a tre vagoni a una velocità massima di 10 km/ora. Una delle locomotive originali è oggi esposta staticamente presso la stazione di valle. Nel 1953 la linea fu elettrificata col sistema di alimentazione in corrente continua a 750 Volt, ma l'esercizio proseguì in modalità mista elettrica/vapore perchè fu immessa in servizio dapprima una sola motrice elettrica-prototipo (alienata già nel 1963), seguita poi progressivamente da altre quattro unità fra il 1955 e il 1960 (fabbricate in Germania dalle Officine di Rastatt) e da un sesto esemplare nel 1978 (costruito in proprio nelle officine aziendali). Il 14 settembre 1958 qui avvenne uno dei più gravi incidenti della storia delle cremagliere, che decretò l'abbandono definitivo della trazione a vapore: un treno formato dalla locomotiva n. 3 e da tre vagoni che stava effettuando l'ultima corsa discendente della giornata deragliò a causa dell'eccessiva velocità dovuta a un errore umano, provocando 18 vittime e 112 feriti. I cinque tram elettricioriginali, tutti dotati di equipaggiamento elettrico fornito dall’azienda svizzera BBC (Brown Boveri & C.ie), sono tuttora in servizio e sono numerati da E2 a E6; fra il 1999 e il 2001 sono stati rimodernati dalla SLM (Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik, la famosa azienda svizzera specializzata nella produzione di veicoli a cremagliera poi acquisita dalla Stadler), ma conservano il tipico look “Anni Cinquanta”. Sono veicoli bidirezionali a due assi (entrambi gli assi sono motori e provvisti di corona dentata per l’ingranaggio sulla cremagliera), lunghi 10,5 metri e dotati di tre porte su un solo lato, accoppiabili in trazione multipla di due unità, che possono raggiungere la velocità massima di 18 km/ora sulla massima pendenza.
Una curiosità: la colorazione in doppio tono di verde del materiale rotabilerichiama il marchio di un famoso profumo, l'“Acqua di Colonia 4711”: infatti la casa produttrice era di proprietà del fondatore della compagnia “Bergbahnen im Siebengebirge”, Ferdinand Mühlens. Completa il parco rotabile un vagone merci ricavato da una ex-carrozza passeggeri del 1883. La tranvia del Drachenfels è una linea molto frequentata sia dai turisti di ogni provenienza sia dai locali abitanti dell’area di Colonia-Bonn, per i quali costituisce una comoda gita “fuori porta”. Le corse sono cadenzate ogni 30 minuti o ogni ora, a seconda della fascia oraria e della stagione.
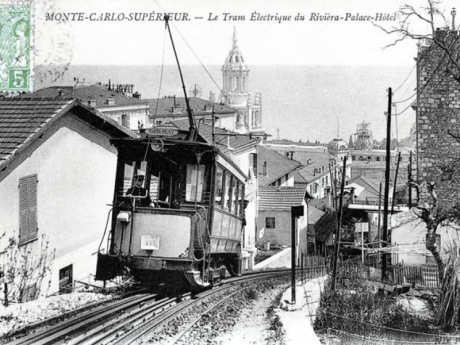
CREMAGLIERE... IN COSTA AZZURRA!
di Roberto Cambursano
Il regno delle ferrovie a cremagliera è notoriamente costituito dalle alte catene montuose: in particolare viene naturale pensare alle Alpi innevate e alla moltitudine di impianti di questo tipo che vi operano, specialmente in Svizzera. Ma esistono o sono esistiti binari dotati di cremagliera anche da altre parti; qui vogliamo ricordare due linee, ormai chiuse da tanto tempo, che sorgevano in riva al mare in prossimità del Principato di Monaco.
Iniziamo con la ferrovia Beausoleil-La Turbie, che fu inaugurata nel 1894. Il tracciato era situato interamente in territorio francese (Dipartimento delle Alpes Maritimes) nell'immediato entroterra del Principato di Monaco. La linea, a binario unico e scartamento metrico, era lunga 2660 metri e interamente armata con cremagliera di tipo Riggenbach, con una pendenza massima del 25%. La trazione era assicurata da quattro piccole locomotive a vapore a due assi, dotate di una ruota dentata centrale motrice che ingranava sulla cremagliera: ognuna di esse poteva spingere un solo vagone passeggeri alla velocità di 7 km/ora sulla massima pendenza. Completavano il parco rotabile cinque vagoni passeggeri da 60 posti, suddivisi in due classi, e due carri merci. Tutti i veicoli erano di produzione francese, fabbricati a Belfort dalla ditta SACM (Société Alsacienne de Constructions Mécaniques).
La stazione di partenza, denominata “Monte Carlo”, era posizionata nel comune francese di Beausoleil, a ridosso del confine internazionale con Monaco/Monte Carlo, mentre la stazione di arrivo era collocata al margine inferiore del paese di La Turbie, situato sulla “Haute corniche” della Costa Azzurra a 480 metri di altitudine in una bellissima posizione panoramica sul mare.
La linea ebbe sempre un carattere essenzialmente turistico e conobbe un notevole e crescente successo di pubblico, di pari passo con il “boom” della Costa Azzurra che proprio in quegli anni si andava affermando come meta del turismo internazionale di alto livello. Nel 1931 fu predisposto un progetto di potenziamento che prevedeva l’elettrificazione della linea in corrente alternata trifase, che però non ebbe il tempo di essere messo in pratica: l'anno seguente, l’8 marzo 1932, si verificò infatti un brutto incidente che pose bruscamente fine all' esistenza della linea. A seguito della rottura di un pignone di un asse della motrice, un convoglio ascendente partito da Beausoleil si fermò dopo aver percorso 160 metri dalla partenza e cominciò a indietreggiare senza controllo a velocità sempre più elevata, travolgendo il respingente terminale e arrestandosi contro un parapetto all'esterno della stazione. Viste le gravi conseguenze dell'incidente (due morti, quattro feriti e ingenti danni), le autorità locali bloccarono da allora ogni progetto di ripristino del servizio, attardandosi in disquisizioni sulla scelta di nuovi sistemi di sicurezza da adottare e facendosi nel frattempo sorprendere dalla Seconda guerra mondiale, che pose purtroppo fine a ogni discussione: gli impianti furono smantellati nel 1948.
Attualmente quasi tutta la sede della linea (eccetto il primo tratto a valle) è ancora ben riconoscibile ed è stata adibita a percorso pedonale; la stazione di monte esiste ancora, con tanto di banchina e pensilina in stato di notevole degrado, mentre la stazione di valle è stata demolita e sostituita da un nuovo fabbricato, che ha reso il luogo irriconoscibile.
Una vera stranezza tecnica della “Belle époque” è stata poi la tranvia elettrica Monte Carlo-Riviera Palace, a binario unico, scartamento metrico e cremagliera parziale di tipo Strub, che rimase in funzione per appena undici anni a partire dal 1903. Fu costruita dalla proprietà del Grand Hotel Riviera Palace, situato in territorio francese nel comune di Beausoleil, allo scopo di trasportare la facoltosa clientela dall'albergo al sottostante Casino di Monte Carlo. Nonostante la sua lunghezza limitata (627 metri in totale), è stata sicuramente la linea a cremagliera più complicata della storia mondiale: si trattava infatti di una linea internazionale con un tracciato suddiviso in tre sezioni, ognuna delle quali era attrezzata con soluzioni tecniche differenti. Il primo tratto si sviluppava per 95 metri in sede stradale ad aderenza naturale in territorio monegasco, dalla Fontaine Saint-Michel (l'attuale Rue des Iris, sopra il Casino di Monte Carlo) alla piazza della stazione della ferrovia di La Turbie; seguiva in territorio francese un tratto a cremagliera lungo 300 metri dove veniva raggiunta la massima pendenza del 26,6% e dove il binario si inseriva nella sede della ferrovia Beausoleil-La Turbie (senza scambi ma con rotaie e cremagliere intercalate e separate) poco oltre il termine del marciapiede di capolinea e la abbandonava dopo un breve tratto in comune; infine era presente un tratto terminale a semplice aderenza di 232 metri che raggiungeva la terrazza del Grand Hotel situata ad una altitudine di 180 metri sul livello del mare. L'incompatibilità fra i due diversi sistemi di cremagliera, lo Strub della tranvia del Riviera Palace e il Riggenbach della ferrovia Beausoleil-La Turbie, faceva sì che nel tratto in comune fra le due linee fossero posate in parallelo e a distanza di pochi centimetri ben quattro rotaie e due cremagliere!
Erano in servizio due tram a due assi fabbricati dalla Thomson-Houston, alimentati da una linea aerea alla normale tensione tranviaria di 600 Volt in corrente continua.: la velocità massima, pari a 7 km/h sul tratto a cremagliera e a 15 km/h sui tratti ad aderenza naturale, permetteva di effettuare il tragitto in cinque minuti. All’inizio la frequenza programmata dei passaggi era di 20 minuti, poi a partire dal 1910 il servizio fu ridotto a una sola motrice con venti corse giornaliere, in concorrenza con un servizio automobilistico che lo stesso hotel Riviera Palace aveva nel frattempo istituito; il servizio fu sospeso definitivamente nell’agosto 1914, allo scoppio della Prima guerra mondiale.
Anche per questa linea si ricorda uno spettacolare incidente, per fortuna non così grave come quello della linea della Turbie: il 27 febbraio 1903, appena quattro giorni dopo l’inaugurazione, un tram deragliò nei pressi della congiunzione con la linea della Turbie e, dopo aver ridisceso la pendenza a velocità folle, attraversò il Boulevard du Nord (l’attuale Boulevard Princesse Charlotte) tagliando in due una carrozza e schiantandosi nella bottega di un antiquario: miracolosamente, l’incidente provocò solo qualche ferito leggero!
Nessuna traccia è rimasta oggi di questa linea; l’edificio dell’Hotel Riviera Palace esiste ancora ma è stato trasformato in condominio.
IMMAGINI
- fig.1- LOCANDINA STORICA /Disegno H. d’Alesi /Manifesto pubblicitario della Societé Paris Lyon Mediterranée per la linea Beausoleil-La Turbie /Anni 1910.
- fig.2- LINEA BEAUSOLEIL-LA TURBIE /Cartolina d'epoca /Un convoglio a vapore sulla linea Beausoleil-La Turbie /Anni 1910.
- fig.3- STATO ATTUALE-STAZIONE DI LA TURBIE /Foto Roberto Cambursano /Come si presenta oggi la stazione di monte a La Turbie: la sede ferroviaria è diventata un sentiero, banchina e pensilina esistono ancora, l’edificio della stazione è situato in posizione rialzata sulla destra e collegato con una scala /2019.
- fig.4- STAZIONE DI BEAUSOLEIL/MONTE CARLO /Foto E. Trutat /Arrivo di un convoglio a vapore alla stazione di Beausoleil/Monte Carlo; si intravede sulla destra il raccordo con la tranvia elettrica a cremagliera dell'Hotel Riviera Palace proveniente da Monte Carlo /1905.
- fig.5- STAZIONE DI BEAUSOLEIL/MONTE CARLO /Cartolina d'epoca /Un tram della linea Monte Carlo-Riviera Palace sul binario di raccordo con la linea Beausoleil-La Turbie presso la stazione di testa denominata “Monte Carlo” /Anni 1910.
- fig.6- STATO ATTUALE-STAZIONE DI BEAUSOLEIL/MONTE CARLO /Foto Roberto Cambursano /Come si presenta oggi la piazza della stazione di valle: un edificio in costruzione ha preso il posto della vecchia stazione, mentre la rampa della tranvia del Riviera Palace è diventata una strada /2019.
- fig.7- TRANVIA MONTE CARLO-RIVIERA PALACE /Cartolina d'epoca /Un tram elettrico sul tratto a cremagliera della linea Monte Carlo-Riviera Palace /Anni 1910.

I TRAM DI OPORTO*
di Roberto Cambursano
Quando pensiamo al Portogallo come “paese tranviario”, istintivamente ci viene in mente Lisbona: in effetti la capitale lusitana, pur avendo conservato solo una piccola parte della sua rete tranviaria (è oggi ridotta ad appena 27 km!), è riuscita a fare dei suoi minuscoli tram gialli “Remodelados” un’icona universalmente nota. Ma in Portogallo c’è un altro posto dove il tram è ben più presente, nella duplice veste storica e moderna: si tratta di Oporto, la seconda città del paese.
Oporto sorge alla foce del fiume Douro sull’Oceano Atlantico a circa 300 km a nord di Lisbona; la municipalità vera e propria conta solo 240.000 abitanti, che salgono però a 1.700.000 se si considera l’area metropolitana.
Il trasporto urbano e suburbano è gestito da due aziende: la STCP (Sociedade de Transportes Colectivos do Porto) è l’azienda pubblica che gestisce la rete di autobus e la rete tranviaria storica, mentre l’azienda multinazionale Transdev gestisce la rete tranviaria moderna denominata “Metro do Porto”, che è strutturata a standard di metrotranvia con alcuni tratti sotterranei e si ispira al modello tedesco di “Stadtbahn”. Il sistema tariffario è strutturato a zone, i documenti di viaggio sono unici (sistema “Andante”) e valgono sui mezzi di entrambe le società.
La storia del tram a Oporto iniziò nel 1872, anno in cui entrò in servizio il primo tram a cavalli; il primo tram elettrico circolò nel 1895 e da allora la rete tranviaria continuò a crescere fino all’inizio degli anni Sessanta, quando iniziò il periodo di progressivo declino durato fino alla fine del secolo.
La rete tranviaria di Oporto dispone oggi di due sistemi indipendenti: la rete storica, residuo della rete di prima generazione, è strutturata su 3 linee e si sviluppa su un totale di 9 km, mentre la rete moderna conta 6 linee per un totale di 67 km. Per entrambi i sistemi, i binari hanno scartamento standard (1435 mm); l’alimentazione elettrica in corrente continua è a 600 Volt per la rete storica e a 750 Volt per la rete moderna.
Il Museo del tram di Oporto, inaugurato nel 1992, è gestito direttamente dall’azienda di trasporto SCTP e si trova presso il piccolo deposito di Massarelos, situato nei locali di una ex-centrale elettrica sulla sponda destra del Douro in posizione semi-centrale.
Oltre ad una ventina di veicoli storici in esposizione permanente (di varie epoche e in parte funzionanti), il comprensorio ospita anche una trentina di altri tram storici funzionanti e destinati a servizi speciali occasionali. Il Museo è aperto tutti i giorni dalle 10,00 (il lunedì dalle 14,00) alle 18,00.
La SCTP, oltre a gestire le operazioni di restauro e manutenzione dei tram storici, organizza tutte le uscite dei veicoli sia per manifestazioni che per noleggi e gestisce le linee storiche regolari.
La rete tranviaria storica è composta dalle linee 1, 18 e 22, che operano in una ristretta porzione di città che dal centro storico si estende lungo la sponda destra del Douro. Tutti gli impianti sono stati ricostruiti in anni recenti sugli antichi percorsi ma con nuovi criteri estetici “turistici” (massicciata in cubetti di pietra, impiantistica con caratteristiche di pregio, arredo urbano molto curato) e in massima parte in sede propria. Il risultato ottenuto è una integrazione molto buona con la viabilità cittadina, sia nelle zone pedonali sia nelle vie in cui è presente il traffico privato. La rete storica è in massima parte a binario unico e (tranne un piccolissimo tratto in comune fra le linee 1 e 18) non c’è sovrapposizione fra le tre linee, anche se esistono raccordi di servizio per passare da una linea all’altra che vengono usati per i rientri e le uscite dal deposito e per le corse speciali effettuate in occasione di manifestazioni e noleggi. Esistono parecchi punti di incrocio con raddoppio di binario, dotati di semafori tranviari regolati da un sistema centrale computerizzato: ciò permette un esercizio fluido e senza rallentamenti, anche perché gli intervalli dei passaggi non scendono di norma al di sotto dei 20 minuti. Il servizio si effettua tutto l’anno e in tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 20.
Sulle linee storiche sono validi gli ordinari abbonamenti della rete di trasporto pubblico di Oporto, mentre i turisti e i viaggiatori occasionali devono acquistare degli speciali biglietti di corsa semplice, non validi sulle linee ordinarie.
la linea 1 è la più trafficata e costeggia il fiume Douro dalla foce (Passeio Alegre) fino a Infante, nella zona centrale turistica di Ribeira; è gestita con tram a carrelli.
la linea 18 è gestita con tram a due assi e collega il centro cittadino (Carmo, dove transita la linea 22), con il Museo del Tram (Massarelos, dove incrocia la linea 1).
la linea 22 ha un percorso ad anello che prolunga la linea 18 all’interno della zona più centrale della città; anch’essa è gestita con tram a due assi. Il capolinea è nella piazza Batalha.
Il parco tranviario storico circolante è composto esclusivamente da veicoli originali della rete di Oporto risalenti agli anni Venti, Trenta e Quaranta; la livrea è per tutti di color crema e nocciola.
Il “Metro do Porto” è in funzione dal 2002, quando fu inaugurato il primo tratto della linea A che sfruttava la sede, in parte sotterranea, di una vecchia ferrovia dismessa. Lungo questo asse si sono via via aggiunte negli anni seguenti altre quattro linee (B, C, E, F), che hanno il tratto centrale in comune e si diramano in periferia in varie direzioni. Nel 2005 è entrata in funzione la linea D, la più carica della rete, che incrocia tutte le altre in corrispondenza della stazione di Trindade e ha anch’essa un percorso parzialmente sotterraneo: questa linea sovrappassa il fiume Douro sul famoso storico ponte in ferro a due piani “Luis I”, condividendone con i pedoni il piano superiore, mentre le auto transitano su quello inferiore. Una particolarità della sola linea B è lo sdoppiamento del servizio fra una linea principale che effettua tutte le fermate e una linea rapida che ferma solo nelle stazioni più importanti (denominata “B Expresso”).
Il materiale rotabile moderno è composto da due serie di veicoli di marca Bombardier, bidirezionali e multiarticolati, che possono marciare anche accoppiati in convogli di due unità; la livrea è di colore giallo con fasce nere. I più “anziani” sono i 72 “Flexity Outlook” (anche noti come “Eurotram” e molto simili a quelli in servizio a Milano e a Strasburgo, furono prodotti in origine da ADTranz, un’azienda poi acquisita da Bombardier), lunghi 35 metri e dotati di pianale interamente ribassato; i più recenti sono i 30 “Flexity Swift”, entrati in funzione nel 2008 e lunghi 37 metri, dotati di pianale parzialmente ribassato in quanto si tratta di un modello concepito per linee di “Tram-treno”.
Vi sono anche numerose linee di autobus di varie tipologie, in parte impiegati su linee di adduzione alla rete su ferro e in parte su linee forti nelle zone sprovviste di servizio tranviario.
Completano l’offerta urbana di trasporto una funicolare (“Funicolar dos Guindais”), che collega la riva destra del Douro con il capolinea di Batalha della linea storica 22 nella zona alta del centro storico e una cabinovia (“Teleferico de Gaia”) che costeggia la riva sinistra del Douro e collega la zona delle cantine del famoso vino di Oporto con la fermata della linea D posta all’estremità del ponte Luis I. Un’ultima curiosità: è’ esistita fra il 1891 e il 1924 una linea a cremagliera in sede stradale che collegava, tutta all’interno del territorio di Vila Nova de Gaia, la riva sinistra del Douro con la stazione ferroviaria, ma di essa non è rimasta alcuna traccia.
| RETE TRANVIARIA DI OPORTO: DATI SALIENTI | |
| Aziende di trasporto | Rete storica: SCTP www.stcp.pt |
| Museo del tram | (gestito da STCP) www.museu-carro-electrico.stcp.pt |
| Anno apertura | 1872 |
| Scartamento | 1435 mm |
| Alimentazione elettrica | Rete storica: 600 Vcc |
| Sviluppo rete | Rete storica: 9 km |
| Numero linee | Rete storica: 3 |
| Numero veicoli in servizio | Rete storica: 34 |
IMMAGINI (tutte le foto sono di Roberto Cambursano – agosto 2019)
fig.1- IL MUSEO DEL TRAM / Vista interna del Museo del Tram di Massarelos.
fig.10- LINEA B EXPRESSO / Un convoglio composto da due Flexity Swift di Bombardier in servizio sulla linea B Expresso in transito nella stazione sotterranea di Casa de Musica.
fig.11- LINEA E / Un Eurotram singolo in servizio sulla linea E per l’AerPorto in sosta sul terzo binario di capolinea nell’importante stazione sotterranea di Trindade.
fig.12- TELEFERICO DE GAIA / La cabinovia che collega la fermata “Jardim do Morro” della linea D con la zona delle cantine del vino Porto in riva al Douro.
fig.2- DEPOSITO DI MASSARELOS / Il capannone di rimessaggio nel deposito di Massarelos dei tram storici circolanti.
fig.3- LINEA 1 / Un tram storico a carrelli in servizio sulla linea 1, proveniente da Infante e diretto a Passeio Alegre, in transito nei pressi del Museo del Tram, sul corto tratto a doppio binario in comune con la linea 18.
fig.4- LINEA 1 / Un tram storico a carrelli in servizio sulla linea 1 in procinto di partire dal capolinea di Passeio Alegre diretto a Infante.
fig.5- LINEA 18 / Un tram storico a due assi in servizio sulla linea 18, proveniente da Massarelos, in arrivo al capolinea centrale di Carmo (punto di trasbordo sulla linea 22).
fig.6- LINEA 22 / Un tram storico a due assi in servizio sulla linea 22 in transito sul percorso centrale ad anello nella Rua 31 Janeiro.
fig.7- PONTE LUIS I / Lo storico ponte in ferro Luis I con un convoglio della linea D in transito al piano superiore.
fig.8- EUROTRAM SUL PONTE / Un convoglio composto da due Eurotram (Flexity Outlook) di Bombardier in servizio sulla linea D in transito sul Ponte Luis I diretto verso Vila Nova de Gaia.
fig.9- LINEA D / Un tratto superficiale in sede propria della linea D a Vila Nova de Gaia.
*Nella lingua lusitana la città si chiama "Porto", il cui significato è appunto quello di "porto". La dizione italiana "Oporto" ricalca la regola del portoghese di accompagnare il nome della città con l'articolo determinativo maschile "o" (= il) per distinguerla dal corrispettivo nome comune (altrimenti le città di norma non hanno alcun articolo). Per la stessa regola anche la città di Rio de Janeiro, in Brasile, viene sempre accompagnata dall'articolo determinativo maschile in quanto "rio" è il nome comune che indica "fiume", ma per motivi storici o fonetici, tale pratica non si riscontra anche nelle traduzioni italiane.

I TRAM DELLA CITTÀ D'ORO
di Roberto Cambursano
Praga è la capitale e la maggiore città della Repubblica Ceca: adagiata su dolci pendìi collinari al centro della regione della Boemia, è attraversata dal fiume Moldava (affluente dell’Elba) e conta circa 1.300.000 abitanti, che raddoppiano se si considera l’area metropolitana.
Oltre ad essere una città affascinante per i suoi monumenti e la sua storia che si colloca ai primi posti fra le mete turistiche mondiali, Praga è anche una grande “città tranviaria” dotata di una rete fra le più estese al mondo: qui il trasporto urbano su rotaia è veramente parte integrante dell’immagine cittadina e del suo patrimonio culturale.
Il trasporto nell’area urbana, gestito dall’azienda municipale DPP (Dopravni Podnik hlavnìho mesta Prahy) è incentrato su tre linee di metropolitana tradizionale, integrate da una fitta rete tranviaria che offre un servizio molto intenso ed efficiente e da una rete complementare di autobus.
La storia del tram a Praga iniziò nel 1875, anno in cui entrò in servizio il primo tram a cavalli; il primo tram elettrico circolò nel 1891 e da allora la rete tranviaria continuò sempre a crescere. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la presenza in loco dell’azienda produttrice CKD Tatra (esportatrice di ingenti quantitativi di tram in tutti i paesi del blocco comunista, di cui la Cecoslovacchia faceva parte) favorì lo sviluppo e il consolidamento della rete, che si conservò grande e integra anche nel successivo periodo di “occidentalizzazione”.
La rete di Praga ed è arrivata a disporre oggi di 22 linee tranviarie, tutte urbane e sviluppate su un totale di 143 km; i binari hanno scartamento standard e l’alimentazione elettrica è a 600 Volt CC. La flotta circolante si compone di 883 tram dalla caratteristica livrea rosso-crema, rimessati in sette depositi. La rete tranviaria trasporta attualmente il 28% dei passeggeri dell’intera rete urbana di Praga. Il tram a Praga circola in massima parte in superficie, ma beneficia di un elevato grado di separazione rispetto alla circolazione privata: oltre il 50% dei binari è collocato in sede riservata e quasi 200 semafori sono impostati per concedere la priorità ai mezzi pubblici.
Una caratteristica dei tram di Praga, finora immutata, è quella di essere stati tutti prodotti da industrie locali, sin dai tempi dei tram a due a assi. I primi tram a carrelli di concezione moderna prodotti dalla CKD Tatra entrarono in servizio negli Anni Cinquanta, e ancora oggi il modello T3 (prodotto fra il 1960 e il 1976) è il tram più numeroso a Praga.
Il parco tranviario circolante più anziano è così composto:
n. 427 Tatra T3 ad azionamento elettromeccanico, lunghezza 14 metri, una cassa e due carrelli: sono divisi in 4 serie, una delle quali è composta da 33 veicoli modificati con il ribassamento della parte centrale e lunghezza aumentata a 15,1 metri; quasi tutti sono stati rimodernati in varie fasi; i Tatra T3 marciano solitamente in multiplo in doppia trazione;
n. 93 Tatra T6 ad azionamento elettronico, lunghezza 14,7 metri, una cassa e due carrelli;
n. 56 Tatra KT8 ad azionamento elettronico, lunghezza 30,3 metri, tre casse (di cui una centrale ribassata) e quattro carrelli.
I tram di tipo più moderno sono invece i seguenti:
n. 57 Skoda 14T multiarticolati a pianale parzialmente ribassato, lunghezza 30,2 metri, cinque casse e tre truck rigidi;
n. 250 Skoda 15T (“Forcity”) multiarticolati a pianale interamente ribassato, lunghezza 31,4 metri, tre casse e quattro carrelli: sono i tram più recenti, molto affidabili, entrati in servizio fra il 2009 e il 2018.
Vi sono inoltre 20 tram storici funzionanti e una trentina di tram di servizio adibiti a vari usi. Non sono previste per il momento nuove ordinazioni di tram.
La rete di metropolitana di Praga, sviluppata su un totale di 65 km e 61 stazioni, si compone di tre linee sotterranee (A, B e C) che si incrociano a triangolo nel centro della città; le stazioni, ispirate al modello sovietico, sono molto profonde e dotate di lunghissime scale mobili. Anche il materiale rotabile della prima generazione, entrato in funzione nel 1974 (ristrutturato e tuttora circolante) è di produzione sovietica. Una quarta linea (D) è in progetto nella zona sud. Attualmente la rete di metropolitana trasporta il 48% dei passeggeri della rete di trasporto urbano di Praga.
Vi sono anche 124 linee di autobus, confinate per lo più in periferia e destinate a un servizio di adduzione alla rete principale, che trasportano nel complesso solo il 24% dei passeggeri dell’intera rete. Il parco circolante è costituito da 1175 autobus di varie lunghezze.
Completa l’offerta urbana una funicolare, che collega la città vecchia con la località collinare di Petrin. E’ inoltre in progetto una linea di filobus per collegare l’aeroporto, attualmente servito solo da autobus, con la rete di metropolitana.
Il Museo del tram di Praga è gestito direttamente dall’azienda di trasporto DPP e si trova presso il piccolo deposito di Stresovice nella zona nord-ovest della città (Patockova 4), che ospita anche la flotta di tram storici destinati al noleggio. Il Museo è aperto da aprile a novembre dalle 9 alle 17, il sabato, la domenica e nei giorni festivi. La collezione museale comprende una cinquantina di veicoli storici di tutte le epoche (tram, filobus e autobus), molti dei quali funzionanti.
La DPP, oltre a gestire le operazioni di restauro e manutenzione dei tram storici, organizza tutte le uscite dei veicoli sia per manifestazioni che per noleggi, oltre a gestire la linea storica 41 che fa capolinea proprio al Museo del tram.
Esistono due linee storiche tranviarie: la linea 41 è una linea speciale con tariffe ad hoc che circola solo nelle giornate di sabato e nei giorni festivi ed è gestita con tram a due assi degli Anni Venti/Trenta; la linea 23 è invece una normale linea integrata nella rete ordinaria di cui adotta le tariffe ordinarie, ma è gestita esclusivamente con tram Tatra T3 allestiti nella configurazione originale.
| RETE TRANVIARIA DI PRAGA: DATI SALIENTI | |
| Azienda di trasporto | DPP (Dopravni Podnik hlavnìho mesta Prahy) |
| Museo del tram | (gestito da DPP): www.dpp.cz |
| Anno apertura | 1875 |
| Scartamento | 1435 mm |
| Alimentazione elettrica | 600 Vcc |
| Sviluppo rete | 143 km |
| Numero linee | 22 |
| Numero veicoli in servizio | 883 |
IMMAGINI
fig.1- TRAM STORICO AL MUSEO DEL TRAM / Foto Roberto Cambursano / Un tram a due assi del 1923, normalmente utilizzato sulla linea storica 41, in sosta sul piazzale del Museo del Tram di Stresovice / 2019.
fig.2- TRE GENERAZIONI DI TATRA / Foto Luca Giannitti / I modelli Tatra T1, T2 e T3 a confronto all’interno del Museo del Tram / 2019.
fig.3- TRATTO A BINARIO UNICO NELLA CITTA’ VECCHIA / Un suggestivo scorcio del transito di un convoglio di due TatraT3 accoppiati in configurazione storica sul tratto a binario unico della linea 23 sotto il portico della via Letenska / Foto Frantisek Zahnas / 2019.
fig.4- TATRA T3 RIBASSATO / Foto Roberto Cambursano / Una delle 33 motrici Tatra T3 modificate con la parte centrale ribassata / 2019.
fig.5- TATRA T3 SCUOLA GUIDA / Foto Roberto Cambursano / Una motrice Tatra T3 appositamente modificata per le attività di scuola guida / 2019.
fig.6- TATRA KT8 / Foto Roberto Cambursano / Una motrice articolata Tatra KT8 con cassa centrale ribassata / 2019.
fig.7- SKODA 14T / Foto Roberto Cambursano / Una motrice articolata Skoda 14T a pianale parzialmente ribassato / 2019.
fig.8- SKODA 15T FORCITY / Foto Roberto Cambursano / Una motrice articolata Skoda 15T- Forcity a pianale interamente ribassato e “veri” carrelli / 2019.

I GIALLONERI DI DRESDA
di Georg Hehmann
Giallo e nero a Dresda? Sono i colori di una squadra di calcio o di una coalizione politica? Né l’uno né l’altro, perché i colori della Dinamo Dresda sono come quelli della città nero e giallo, anzi nero - oro, e nelle coalizioni liberal-conservatori hanno sempre avuto la dominanza numerica i democratici-cristiani, quindi “neri” prendendo il nero dai talari dei sacerdoti. Ma siccome i tram Tatra di Dresda, quando nel 1988 hanno cominciato a perdere la loro livrea “socialista” rosso-avorio a favore dei colori araldiche della città, furono inizialmente dipinti sopra nero e con una larga fascia gialla sulla pancia, si accorsero velocemente che di notte erano poco visibile. Allora si decise di usare il giallo come colore base e di evidenziare solo le finestre con una fascia nera. In questo modo nacquero i tram giallo-nero di Dresda.
Dopo che, in un numero precedente di Tranvìa 2.0, è stat brevemente presentato il museo dei tram di Dresda, nel quale ha avuto luogo quest’anno il convegno AHN, ci sembra ora opportuno esaminare un po’ più approfonditamente la rete tranviaria del capoluogo della Sassonia, ovvero della capitale storica dell’antico ducato e principato elettivo governato per diversi secoli dalla casata dei Wettin imparentati con le famiglie reali di mezza Europa.
Simile a tante altre città della ex DDR (Germania dell’Est) anche la “Firenze sul fiume Elba”, come viene anche denominata la città per la sua importanza storica, architettonica e artistica, ha mantenuto una infrastruttura tranviaria molto capillare e sotto tanti aspetti esemplare. Ciò non vuol dire che questa città non abbia conosciuto chiusure o sostituzioni di linee tranviarie con autobus. Ma con una rete di 12 linee urbane che in alcuni casi hanno una estensione interurbana (come ad esempio la cosiddetta “KulTour-Linie” 4 tra Laubegast e Weinböhla), vengono serviti tuttora 128 km di linea dai tram dell’azienda dei trasporti di Dresda DVB (Dresdner Verkehrsbetierbe), su complessivamente 296,1 km di binario tranviario tuttora esistente. In una città con appena 555.000 abitanti all’interno dei confini comunali e di circa 780.000 nell’intera area metropolitana, ciò non è poco, se si considera che Dresda possiede anche un articolato sistema ferroviario metropolitano (S-Bahn) con tre linee che collegano una serie di città e comuni limitrofi, in direzione nord-ovest lungo il fiume Elba fino alla città di Meißen (distante ca. 30 km), in direzione sud-est sempre lungo il fiume Elba fino a Bad Schandau e Schöna (distante ca. 40-50 km), ed a sud-ovest di Dresda fino a Freiberg (ca. 40 km) con complessivamente 48 stazioni e una estensione di 127,8 km di rete gestite però dalle Ferrovie Tedesche DB, ma accessibile con gli stessi biglietti del consorzio VVO (Verkehrsverbund Oberelbe / Consorzio dei trasporti dell’alta Elba). Entrambi le reti su rotaia vengono inoltre completate nella zona tariffaria di Dresda da 31 linee automobilistiche che hanno per lo più la funzione di linee navetta per il tram, ma anche, e questo vale soprattutto per le linee bus con i numeri tra sessantuno e sessantasei, di linee di forza che attraversano in parte anche quartieri centrali.
Dal 2010 la DVB svolge il traffico tranviario di linea quasi esclusivamente con i suoi 166 veicoli moderni a pavimento ribassato, di cui esistono quattro diversi tipi distinti dalla concezione costruttiva, lunghezza e capacità di trasporto, e naturalmente anche dagli anni di costruzione. Ma come riserva e per servizi speciali, come ad esempio i trasporti di studenti, di tifosi sportivi o per i visitatori delle varie fiere nei capannoni della “Messe Dresden” vengono mantenute in efficienza anche alcuni degli convogli Tatra (di tipo T4D e TB4D) a pavimento alto che hanno dominato il trasposto tranviario di Dresda dagli anni settanta fino a oltre il 2000 e che negli anni novanta sono state ancora rigorosamente modernizzate ricevendo non solo i nuovi colori aziendali (giallo e nero), ma anche la modifica dell’avviamento con controllo di marcia elettronico utilizzando tiristori.
Oltre a queste vetture, più di 30 motrici, rimorchi e veicoli di servizio popolano la ricca collezione storica del museo tranviario di Dresda, che si può ammirare durante i weekend di apertura nel vecchio capannone del Deposito di Trachenberge. Inoltre, la città offre altre perle della storia dei trasporti pubblici, come ad esempio le due funicolari, di cui una – unica al mondo – monorotaia e sospesa come quella di Wuppertal (che però non è trainata da una fune) supera un dislivello di 84,4 m su un percorso di 274m. Inoltre vale la pena, una visita alle due ferrovie economiche a scartamento ridotto (750 mm), cioè alla “Lößnitzgrundbahn” e alla “Weißeritztalbahn”, che in un contesto turistico sono rigorosamente gestite a vapore dalla società SDG (Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH, ovvero Società ferroviaria a Vapore Sassone s.r.l.) collegando i sobborghi di Dresda di Radebeul Ost (stazione di partenza per la ferrovia del Lößnitzgrund in direzione nord) e Freital-Hainsberg (inizio del tratto del trenino nel Val della Weißeritz in direzione sud) con importanti mete culturali e luoghi di villeggiatura e cura, come la palazzina di caccia di Moritzburg con i suoi numerosi laghetti, boschi ed oasi faunistici a nord-ovest di Dresda e la località di cura di Kipsdorf nei Monti Metalliferi Orientali non lontano dal confine ceco.
Se per gli amanti del vapore il tempo di fare una gita fuori città non è sufficiente, si possono accontentare con un giro sulla “Dresdner Parkeisenbahn”, una ferrovia in miniatura a scartamento di 381 mm gestita da ragazzi ed adolescenti appassionati nel loro tempo libero, con tanto di locomotori “lilipuzinai” a vero vapore e con vagoni aperti, con i quali si può compiere il giro per il “Großer Garten” in appena 35 min. Questo grande parco, originalmente di concezione barocca e non lontano dal centro storico della città, fu in origine la dimora estiva dei principi elettivi della Sassonia con un bel palazzetto delle delizie in mezzo, tuttora esistente, ed e un polmone verde nella città che si estende su una superfice di circa 1,8 km². Altra meta per un’escursione fuori porta è la “Kirnischtalbahn”, una tranvia turistica a scartamento metrico, che dalla località di cura di Bad Schandau (ca. 40 km a sud-est di Dresda lungo il fiume Elba e comodamente raggiungibile con la S-Bahn) entra per 8 km in una pittoresca valle delle montagne arenarie dell’Elbsandsteingebirge, che per le sue bizzare formazioni rocciose viene anche chiamata la Svizzera sassone. Con i convogli classici di questa pittoresca tranvia interurbana, di costruzione Gotha composti da motrice e uno o due rimorchi a due assi, si può raggiungere, tuttora quotidianamente e ad orari regolari, al suo capolinea montano, dove è possibile ammirare una suggestiva cascata nel mezzo del bosco con una famosa caffetteria-trattoria, e una vasta rete di sentieri per le passeggiate dei villeggianti.
Ma ritorniamo alla rete tranviaria di Dresda, per la quale sono da annotare altre particolarità, come ad esempio l’insolito scartamento di 1450 mm. Il motivo storico di questa caratteristica non è chiaro, ma pare che risalga ad un malinteso di misurazione nato già ai tempi della costruzione della prima ippovia tra il sobborgo benestante di Blasewitz e il Pirnaischer Platz nel centro della città, che fu eseguita fra marzo e il 26 settembre del 1872 dalla Continental-Pferdeeisenbahn-Actiengesellschaft di Arnold von Etlinger di Filadelfia con sede a Berlino. Già prima di questo concessionario, il comune aveva trattato con altri attori interessati alla costruzione di una tranvia a cavalli che si passarono poi le varie autorizzazioni da mano in mano. In questo modo dalla misura prevista di 1440 mm tra i bordi delle ruote si passò alla definizione della distanza tra le rotaie che successivamente fu chiamato “scartamento da città” cioè di 1450 mm.
Già nel 1879 questa prima linea di tram passò alla società londinese della Tramways Company of Germany, che promise l’estensione e la costruzione di nuove linee e che, a causa della livrea delle sue vetture, fu chiamata “Die Gelbe”, la gialla. In seguito a diatribe tra i dirigenti inglesi e il comune, dieci anni più tardi nacque con la Deutsche Straßenbahngesellschaft in Dresden una seconda rete tranviaria che, sempre per via del colore delle sue vetture, fu nominata nel linguaggio popolare “Die Rote” (la Rossa). Questa società aprì, già nell’estate del 1893 su un percorso all’interno della città, cioè fra Schloßplatz e Blasewitz, un primo tratto elettrificato della sua rete, mentre alla Tramways Company venne concessa di elettrificare solo i tratti extraurbani delle sue linee, il che portò velocemente alla dissoluzione di questa società straniera e al trasferimento di vetture ed impianti alla Dresdner Straßenbahngesellschaft appositamente istituita.
Nell’arco di appena dieci anni tutte le linee risulteranno elettrificate, e per razionalizzare l’esercizio al 1° gennaio 1906 entrambe le società vennero municipalizzate ed unite in una unica azienda. Ciò permise entro il 1909 di ristrutturare l’intera rete. Anche due linee suburbane a scartamento metrico vennero inglobate nella rete della municipalizzata della Städtische Straßenbahn zu Dresden e adeguate allo scartamento cittadino. Negli anni venti, la centrale piazza “Postplatz” venne trasformata in nodo principale di scambio tra le varie linee della rete, e per permettere ulteriori investimenti in data 1° gennaio 1930 l'azienda tranviaria municipale venne nuovamente trasformata in una società privata. La seconda guerra mondiale, con i sui devastanti bombardamenti, portò ad enormi distruzioni di impianti e vetture, e la sospensione totale dell’esercizio dal 23 al 28 aprile e dal 7 al 12 maggio 1945. Poi, dopo una faticosa ricostruzione sia della rete che del materiale rotabile nel periodo della occupazione sovietica, con la nascita della DDR, l’azienda tranviaria ottenne un'altra volta una nuova forma legale pubblica. A partire dal 1° apile1951 e con la socializzazione dell’intero capitale l’azienda tranviaria di Dresda diventò una “VEB”, cioè un’azienda di proprietà popolare, e venne gestita dalle direttive del partito socialista e degli organi statali di pianificazione.
La DDR portò anche delle novità sia a livello dello svolgimento del servizio sia di nuove vetture. Già nell’autunno del 1931 con il “luccio grande” (Großer Hechtwagen) fu messa in servizio a Dresda una vettura di concezione completamente nuova che poteva senz’altro competere con le più recenti innovazioni nel campo tranviario di allora, ovvero con le Peter Witt americane ed europee, se non con tanti aspetti delle PCC che allora dovevano ancora entrare in fase di progettazione. Oltre ad essere una vettura a carrelli a grande capacità, (che di per se, paragonata con la situazione generale tedesca dello sviluppo tecnologico nel campo tranviario, era già una innovazione rivoluzionaria) la vettura aveva già un acceleratore semiautomatico che veniva controllato da un semplice set di quattro bottoni e da un pedale che azionava un controller separato per la frenatura. La vettura era stata progettata dall’allora direttore dell’azienda tranviaria di Dresda, il professore Alfred Bockemühl, che la fece costruire dalla carrozzeria di Christoph & Unmark a Niesky e dal Sachsenwerk Licht- und Kraft AG di Niedersedlitz. Al prototipo seguirono ancora nello stesso anno 22 ulteriori tram di serie e negli anni successivi altri nuovi esemplari che erano necessari per poter servire la linea 11 esclusivamente con questo tipo di vettura. Successivamente, dopo la perdita totale di otto “lucci” durante la guerra (che hanno preso questo nome per via del loro muso estremamente rastremata), nel 1954 dalla VEB Lowa Waggonbau Görlitz vennero costruite altri due vetture per poter gestire di nuovo la linea 11 integralmente con questa tipologia di tram. Anche il “luccio piccolo” che aveva solo due assi e che venne impiegato su linee meno frequentate, aveva simile caratteristiche tecniche e rimase in servizio fino alla messa in servizio dei Tatra cechi, cioè fino alla fine degli anni sessanta.
Prima però che i paesi dell’Est, che economicamente erano collegati nel Comecon, decidessero di concentrare la produzione di veicoli tranviari per tutti gli stati membri nelle mani dell’impresa statale cecoslovacca ČKD Tatra di Praga, che aveva sviluppato su licenza PCC americana un nuovo tipo di vettura denominata Tatra, l’industria tranviaria tedesca aveva ripreso l’idea di una vettura tranviaria unitaria che trovò espressione fino alla metà degli anni cinquanta nelle vetture monodirezionali del VEB Lowa di Werdau, rigorosamente a due assi e composti in convogli fino a due rimorchi (ET e EB 54) e più tardi con i convogli di produzione Gotha (ET e EB 57-65) che negli anni sessanta vennero costruiti anche in versione lunga con carrelli (T4-62) e in versione articolata di tipo due camere e cucina (G4-59 / G4-61). In questo modo la rete di Dresda fu nuovamente campo di sperimentazione, in quanto in questa città non fu soltanto provata e esperimentata la vettura 2500, una delle due progenitrici dei primi tram articolati della DDR con cassa intermedia sospesa (Gotha G4-59) o i convogli di pre-serie dei tram a carrelli con grande capacità di produzione Gotha (T4/B4-62), a Dresda circolarono anche per la prima volta nella DDR i varie tipi e prototipi dei Tatra, come ad esempio nel 1964/65 i primi tre Tatra T3, prestati direttamente dall’azienda dei trasporti di Praga, vetture che però per la loro eccessiva larghezza di 2,50 m potevano circolare solo su alcuni tratti della rete. A questi seguivano poi nel 1968, i Tatra T4D e i rispettivi rimorchi B4D costruite appositamente per le reti della DDR che permettevano in genere solo vetture con larghezze di 2,20m o 2,30m. Ma questi tram davano almeno la possibilità di formare convogli grandi in trazione multipla (T4D+T4D+B4D), una composizione che divenne l`immagine tipica del tram della DDR. Ancora nel 1986 fu così provato a Dresda il prototipo di una nuova generazione di Tatra, il T6A2D, al quale seguì però, prima del crollo della DDR nel 1989/1990, solo alcuni esemplari di serie, prima che cominciasse negli anni novanta l’era dei tram a painale ribassato.
Anche nel campo della razionalizzazione e modernizzazione della rete e del servizio, Dresda ha sempre agito da battistrada. Già all’inizio degli anni sessanta fu abolito il bigliettaio nelle motrici dei convogli a più vetture, che venivano contrassegnate con una “Z” (Zeitkarteninhaber = abbonati), e chi non era in possesso di una biglietto valido doveva salire in seguito in uno dei, ovvero più tardi nel ultimo dei rimorchi. Tra 1963 e 1967 venne eliminato definitivamente la presenza del bigliettaio sui convogli, ed introdotto il pagamento della tariffa tramite “Zahlbox”, cioè una macchinetta a funzionamento manuale, montata nelle vicinanze delle porte, nelle quali bisognava introdurre, sotto una finestrina trasparente, in modo che il passeggero successivo potesse verificare l’ammontre, le monete per il biglietto che venne poi estratto tirando una leva.
Oltre ai vari ampliamenti di linee (ma anche la chiusure di alcuni tratti) e la costruzione di nuovi tracciati soprattutto verso i nuovi quartieri nati in periferia come fra altro Gorbitz e Pennrich, la struttura della rete e le numerazioni delle linee sono stati capovolti diverse volte a partire dalla introduzione del sistema di denominazione numerata con ben 27 linee che fu realizzata con la municipalizzazione nel 1906. La quantità maggiore di linee, la rete la raggiunse negli anni sessanta quanto si contavano ben 29 linee, le quali usavano però spesso tratti e binari in comune, e non raramente, come ancora oggi, più linee terminarono allo stesso capolinea. In ogni caso, ben dieci linee di queste vennero esercitate solo nelle ore di punta ‑ un traffico, che oggi viene svolto per lo più con vetture di rinforzo.
In seguito alle ultime grande riforme della rete all’inizio degli anni novanta e nell’anno 2000 sono stati stabiliti nuovi criteri guida per un’ulteriore modernizzazione della rete che prevede sì un graduale adattamento ad un sistema metro-tranviario ma non l’introduzione di una vera e propria metropolitana leggera o pesante, che sia. Il fatto che, dopo le pesantissime devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, la città è stata ricostruita in gran parte su planimetrie inedite o comunque più ampie, ha permesso la realizzazione di corridoi stradali molto larghi che accolgono comodamente i binari ed le infrastrutture tranviarie in gran parte, anche nel centro, separati dal traffico automobilistico individuale. Per questo motivo, la costruzione di tunnel o sottovie per il tram non è prevista. L’accesso alle vetture avviene, per via della flotta quasi totalmente a pavimento ribassata e la maggior parte delle fermate già dotate di banchine a 35 cm, in genere senza barriere, e i tratti di nuova costruzione (specialmente quelli in periferia) vengono realizzati con le dovute protezioni per poter circolare con velocità più alte. Anche la digitalizzazione della rete, con controllo centralizzato del traffico, computer e sistemi informativi a bordo delle vetture, nonché tabelle elettroniche per l’informazione dei passeggieri alle fermate e sistemi di guida per ipovedenti, ha raggiunto un alto livello di potenziamento tecnologico.
Con la messa in servizio dei primi 47 tram monodirezionali a pianale ribassato e le 13 sorelle bidirezionali del tipo NGT6DD (Tram articolato ribassato [NGT] a 6 assi [6] di tipo “Dresda” [DD]) prodotto dalla DWA di Bautzen, con un vasto programma di rinnovamento del materiale rotabile, è cominciato a Dresda, tra il 1995 e 1998, l’era dei tram moderni senza barriere architettoniche. Si è potuto così mandare man mano in pensione i primi convogli Tatra, anche se tanti di questi (costruiti tra 1968-1984) sono stati, a metà degli anni novanta, modernizzati con un nuovo tipo di avviamento elettronico a tiristori, e con nuovi interni e la livrea gialla-nera, diventando così Tatra di tipo T4D-MT (M = Modernizzato, T = tiristori). Nel caso dei NGT6DD (immatricolati con in numeri 2501-2547 per i monodirezionali e 2581-2593 per i bidirezionali) si tratta invece di tram ribassati a cinque casse, lunghi ca. 30 m, con ruote indipendenti fissate a coppia e con assi “virtuali” sotto la prima, terza e ultima cassa, mentre le casse intermedie sono realizzate a mo’ di portantine e dispongono ciascuna di due porte sul lato destro (ovvero su entrambi i lati nel caso delle bidirezionali). Con una motorizzazione di 4x95 kW le vetture monodirezionali posso trasportare, alla velocità di fino a 70 km/h, ca. 184 persone di cui 96 in piedi e 88 seduti. Nonostante che la rete di Dresda sia puramente monodirezionale e possiede a tutti i capolinea un cappio di inversione, la DVB ha voluto acquistare, con questa prima serie di NGT6DD, anche 13 vetture bidirezionale per poter gestire senza intoppi eventuali interruzioni di binari, ad es. per lavori, che altrimenti non darebbero la possibilità alle monodirezionali di invertire direzione in piena linea.
Per poter disporre di motrici adatte anche per le linee più frequentate, negli anni 2001/2002 la DVB si è fatta costruire dalla stessa carrozzeria di Bautzen, che nel frattempo, era passata alla Bombardier Transportation, una altra serie di 23 vetture della stessa tipologia, composte però da sette casse anziché cinque e denominate quindi NGT8DD, avendo 8 pseudo-assi. Questi tram, lunghi ca. 41 m, non hanno però soddisfatto del tutto le aspettative del committente DVB, soprattutto per l’alto consumo di rotaie e cerchioni in curva, causato per lo più dai carelli fissi sotto le casse munite di ruote che hanno un comportamento assai rigido. Quindi per la serie successiva, realizzata in un primo momento con 32 esemplari, fra il 2003 e 2005, la Bombardier di Bautzen è ritornata all’applicazione di carrelli veri e propriamente girevoli, montati, pur permettendo un pavimento ribassato, a due a due sotto la prima, terza e quinta cassa che sono collegate tra di loro da sezioni corti e sospesi (come una volta nelle “due camere e cucina”), cioè tra le casse lunghe che si appoggiano ciascuna su due carelli. Bassandosi sul prodotto Bombardier Flexity Classic, queste nuove vetture denominate NGT D12DD (“D” per Drehgestell = carrello, e “12” per le 12 assi) hanno una lunghezza di ca. 45 m e possono trasportare complessivamente 256 persone di cui 107 seduti.
Mostrandosi molto più favorevole nel rapporto ruota / binario, questa tipologia di vettura fu ordinata ancora alla Bombardier Transportation in versioni differente nella lunghezza, di cui i primi due lotti, consegnati nel triennio 2006 -2009, riguardarono 40 tram corti di ca. 30 m a tre casse di tipo NGT D8DD con una capienza di 172 (il primo lotto con le vetture 2601-2620) e 176 posti (secondo lotto immatricolato 2621-2640), mentre nel 2009/10 furono costruite ancora 11 tram NGT D12DD per poter gestire tutte le linee esclusivamente con vetture ribassate. Così in date 29 maggio 2010 terminò ufficialmente il servizio di linea dei convogli Tatra, e oggi vengono mantenute in forza solo 13 motrici T4D-MT e 6 motrici rimorchio TB4D (mortici senza cabina, ovvero con solo un banco giuda ausiliare, vetture che possono essere impiegate solo come veicolo guidato da una altro tram Tatra) per servizi speciali e di rinforzo.
Visto l’alto numero di passeggeri trasportati nell’anno 2018 (163 milioni), visto i progetti per un ulteriore ampliamento della rete e visto la domanda crescente, si pensa già a una nuova generazione di tram per Dresda che dovrebbero essere messi in servizio in 30 esemplari entro il 2023, con una opzione ulteriore di 30 vetture da acquistare successivamente. Nel capitolato per questo nuovo ordine sarà comunque stabilito che 21 delle nuove vetture dovranno essere monodirezionale, mentre 9 sono previste bidirezionali. Per la lunghezza saranno richieste sempre 45 m ca., come per i convogli lunghi attualmente in servizio, ma con 2,65 m i nuovi tram saranno esattamente 35 cm più larghi di quei attuali, “per poter disporre di più spazio per persone, carrozzine, bici e sedie a rotella”. Questa richiesta avrà però conseguenze per l’interbinario che deve essere ampliato ad almeno 3 m. Negli ultimi anni, durante i lavori su binari e strade, questo criterio è già stato applicato in gran parte, in modo che attualmente le nuove vetture potrebbero già circolare su ca. 80 % della rete. La cosa certa è che comunque negli prossimi anni, non mancheranno le interruzioni di interi tratti tranviari e la sostituzione temporanea con autobus per i lavori in corso.
Infine bisogna ancora fare cenno ad una particolarità delle rete di Dresda, che fino alla metà del novecento era un fatto comune pure a tante altre città tranviarie, oggi però è una assoluta rarità – cioè il servizio merce via trasporto tranviario. Con il logo “CarGoTram” dal 2001 sono presente nella flotta della DVB cinque motrici merci, con una cabina ad una sola estremità, e 7 motrici merci intermedie senza cabina di guida con cui si possono formare due convogli tranviari merci, bidirezionali, (con due motrice alle estremità e tre elementi intermedi) con una lunghezza di quasi 60 m e una capacità di carico complessiva di 60 tonnellate. Con questi convogli merci la DVB fornisce alla “Gläserne Manufaktur” (la “fabbrica delle cristallerie”) della Volkswagen, situata nelle adiacenze, ma sempre all’intero del perimetro del “Großer Garten” (lo stesso parco cittadino traversato dal treno in miniatura della “Dresdner Parkeisenbahn” di cui si è già dato notizia), i pezzi necessari per la produzione del modello Volkswagen e-Golf (fino al 2016 del modello VW Pheaton). Il tram trasporta i pezzi dal “Güterverkehrszentrum” (centro di logistica delle merci) di Friedrichstadt alla fabbrica che è distante circa 5,5 km e si trova dall’altra parte del centro attraverso arterie centrali della città avendo però a disposizione alcuni percorsi alternati per poter aggirare eventuali intoppi. Ogni trasporto con un CarGoTram può avvenire con cicli fino a 40 min., ha una capacità di 214 m², 60 tonnellate di carico, e sostituisce cosi tre camion che altrimenti contribuirebbero all’inquinamento della città.
| RETE TRANVIARIA DI DRESDA: DATI SALIENTI | |
| Azienda di trasporto urbano | DVB – Dresdner Verkehrsbetriebe (www.dvb.de) |
| Autorità trasporti regionali | VVO – Verkehrsverbund Oberelbe (www.vvo-online.de/en) |
| Associazione tram storici | Straßenbahnmuseum Dresden e.V. (www.strassenbahnmuseum-dresden.de) |
| Anno apertura | 1872 |
| Scartamento rete urbana | 1450 mm |
| Alimentazione elettrica | 600 V cc (linea aerea) |
| Sviluppo rete | 128 km |
| Numero linee | 12 |
| Numero veicoli in servizio | 166 a pianale ribassato di cui: 60 NGT 6DD (47 monodirezionale e 13 bidirezionale, anni di costruzione 1995-98), 23 NGT 8DD (2001-02), 40 NGT D8DD (2006-08) e 43 NGT D12DD (2003-05 e 2009-10). Più una riserva di 13 Tatra T4D-MT e 6 motrici rimorchi TB4D(costruzione 1969-79, ammodernamento 1994-97) |
| Numero veicoli CarGoTram | 5 mortici terminali (con cabina), 7 motrici intermedi (senza cabina) = 2 convogli (produttore: Schalker Eisenhütte, anno di costruzione: 2000) |
| Numero veicoli storici | 16 motrici (15 dinamiche/1 statica), 12 rimorchi e 9 veicoli di servizio |
| Depositi in servizio | 1. Gorbitz (con le officine centrali), 2. Reik, 3. Trachenberge (con sede amministrativo e museo), 4. Walterstraße (usato sole per vetture di servizio) |
| Depositi abbandonati | Johannstadt (demolito), Gohlis (oggi uso industriale), Naußitz (oggi supermercato), Blasewitz (oggi centro commerciale), Bühlau (demolito), Klotsche (demolito), Mickten (oggi centro commerciale), Tolkewitz (demolito, oggi campus scolastico). |
| FUNICOLARI (ferrovie collinari) DI DRESDA: DATI SALIENTI (www.dvb.de/en-gb/excursions/hillside-railways/) | ||
| Sistema (e meta): | Funicolare per “Weißer Hirsch” | Monorotaia sospesa “Oberloschwitz” |
| 1895 | 1901 |
| 547 m | 274 |
| 96 m | 84,2 m |
| 29,8% | 39.9% |
| 2 (59 persone/vettura) | 2 (40 persone/vettura) | |
| LINEE TURISTICHE IN E NEI DINTORNI DI DRESDA | |
| Dresdner Parkeisenbahn | Ferrovia del parco a scart. 381mm (www.dresdner-parkeisenbahn.de) |
| Lößnitzgrundbahn | Ferrovia econ. a vapore Radebeul-Radeburg (www.loessnitzgrundbahn.de) |
| Weißeritztalbahn | Ferrovia econ. a vapore Freital-Kipsdorf (www.weisseritztalbahn.com) |
| Krinitztalbahn | Tranvia elettrica turistica (www.ovps.de/Verkehrsmittel/Kirnitzschtalbahn/443/) |
Immagini:
- Foto 1) Motrice 2620 a pianale ribassato di tipo NGT D8DD davanti alla “Semperoper”, il teatro lirico di Dresda. Queste vetture sono una specie di “due camere e cucina” con dei carrelli veri e propri sotto le due casse esterni. (Foto: DVB)
- Foto 2) La versione lunga delle 2600 sono le NGT D12DD, con tre casse che poggiano ciascuna su due carrelli (=D [Drehgestell] con complessive 12 assi) e due casse corte sospese (per così dire un “tre camere e due cucine”). Qui una foto di presentazione della DVB sul piazzale del deposito di Gorbitz (Foto DVB)
- Foto 3) Le NGT 8DD (motrice [T] snodata [G] a pianale basso [N] con 8 assi [8] di tipo Dresda [DD]), immatricolate con i numeri 2701-2723, hanno invece, come le 6000 torinesi, le ruote sotto le sezioni corti. I “carelli” sono fissati in modo più o meno rigido direttamente sotto le casse che in curva si devono muovere insieme alle ruote. (Foto DVB)
- Foto 4) I primi tram a pianale ribassato entrato in servizio a Dresda dal 1995, le motrici NTG 6DD hanno solo cinque casse e sei assi. Esistono anche in versione bidirezionale per potere gestire il traffico anche in caso di cantieri. (Foto DVB)
- Foto 5) Un convoglio del CarGoTram davanti alla “Gläserne Manufaktur” della Volkswagen. Da quando nella fabbrica “delle cristallerie” viene prodotto l’e-Golf il tram cargo è di nuovo in attività “ad alta tensione”, come dice la pubblicità sul telo blu (Foto: Volkswagen Schweiz, twitter.com: @vwschweiz, 10/08/2018).
- Foto 6) Scarica merci nella fabbrica “delle cristallerie”. Tutti le vetture, anche quelle intermedie sono motorizzate con carelli provenienti da vecchi tram Tatra. (Foto: i.imgur.com, oppure Auto-Medienportal.Net/Volkswagen)
- Foto 7) Nodo tranviario nelle vicinanze della stazione centrale di Dresda (Foto DVB)
- Foto 8) Convoglio multitrazione Tatra con due motrice T4D-MT e una motrice rimorchio TB4D in coda alla fermata ausiliare davanti al cancello d’entrata del deposito di Trachenberge. I Tatra ancora in forza vengono impegnati oggi giorno solo per le corse di rinforzo (contrassegnato con un “E” in cabina [= Einsatzwagen]) o in occasioni di grandi manifestazioni. (Foto: Georg Hehmann)
- Foto 9) Convoglio Tatra storico con la motrice T4D 2000 in testa. Nei ultimi giorni di aprile 2019 fu impegnata in servizio speciale per portare i partecipanti del convegno AHN dagli alberghi alla sede nel museo di Trachenberge. (Foto: Georg Hehmann)
Sitografia:
www.wikipedia.de, www.wikipedia.it, www.dvb.de, www.vvo-online.de, www.strassenbahnmuseum-dresden.de, https://www.saechsische.de/neue-dvb-bahnen-kommen-bis-2023-3843436.html,
Flyer e depliant:
- DVB - Wir bewegen Dresden (a cura di): Hoch hinaus mit den Dresdener Bergbahnen. (DVB, September 2017)
- DVB - Wir bewegen Dresden (a cura di): Auf neuen Gleisen durch Dresden. Heute an die Zukunft von moorgen denken. In: bewegt! Das Kundenmagazin der Dresdner Verkehrsbetriebe AG, (Nr. 1/2019)
- Schlösserland Sachsen (a cura di): Dresdner Parkeisenbahn 2019. Die kleine Bahn im Großen Garten. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gemeinnützige GmbH
- VVO – Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (a cura di): H - Historische Verkehrsmittel 2019/20. Das gibt’s nur bei uns: Lößnitzgrundbahn & Weißeritztalbahn, Kirnnitztalbahn, Stadnseilbahn& Schwebenbahn. (VVO, Januar 2019)
- OVPS – Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH (a cura di): Kirnitztalbahn, seit 1898. (OVPS 2019)
- Straßenbahnmuseum Dresden e.V. (a cura di): Erleben Sie mit unse ine Zeitreise durch die Geschichte der Dresdner Straßenbahn. (senza anno)

UNA STORIA TORINESE: LA LINEA 10
di Michele Bordone
La rete tranviaria di Torino, nata nel 1871 (la prima in Italia), ha subito nel corso degli anni infinite modifiche. A partire dall'unificazione delle tre società che gestivano la rete urbana, nei primi anni ‘20 del secolo scorso, si sono susseguite innumerevoli modifiche dei tracciati.
Tra le varie linee, ve ne sono alcune che, pur variando percorso, hanno conservato la stessa denominazione, passando attraverso le ristrutturazioni dei percorsi, in particolare le riforme del 1966 e 1982.
Tralasciando la linea 16 – di cui si parla in un recente libro edito dall’ATTS – esiste un'altra linea che ha resistito alle varie trasformazioni: la linea 10.
Nata nel 1912 e gestita dall'ATM dopo una delibera comunale dell'anno precedente, ben presto acquista importanza assorbendo un'altra linea che la porta a unire largo Orbassano con il Regio Parco, attraversando il centro città. Prima dell'unificazione, le tre società non potevano percorrere con i loro mezzi tratti di binario in comune, per cui l'ATM (ex SAEAI) dovette scegliere percorsi alternativi, avendo già trovato occupate le principali vie. Curioso il percorso parallelo a Via Cernaia: per unire corso Vinzaglio a piazza Solferino, i tram percorrevano Via Valfrè e Via Giannone. Ma ancora più curioso il percorso attraverso le strettissime vie medievali Quattro Marzo e Porta Palatina per raggiungere Porta Palazzo. Dalla sua apertura, il sottopasso dei Molassi viene percorso per alcuni mesi dal 10 assieme alla linea 8, per raggiungere via Priocca e via Bologna. Questo sottopasso è un fornice che permette il transito tra piazza della Repubblica e via Priocca, tuttora esistente anche se non più percorso dai binari, eliminati nel 1966.
Con la completa unificazione e la razionalizzazione delle reti, a metà anni 20 il tram 10 può finalmente transitare nelle più comode via Cernaia e via Milano, e quasi contemporaneamente scambia il percorso con la linea 8 attestandosi lungo corso Giulio Cesare alla borgata Monterosa. Vi rimane, con piccoli aggiustamenti, sino al 1982. Inoltre, la linea 10 viene prolungata dal 1950 (assorbendo la linea navetta 28) lungo corso Agnelli sino a Mirafiori, dove si attesta tuttora seppure con alcune modifiche.
Con la nuova “rete a griglia”, dal 1982 abbandona la zona di Monterosa ceduta alla linea 4 per spostare il capolinea nord in Borgo Vittoria, attraverso le stazioni Porta Susa e Dora, a coprire il percorso della soppressa linea 9.
Dal 2006, con l'avanzamento dei lavori del passante ferroviario, viene purtroppo limitata in piazza Statuto, dove effettua capolinea tuttora esercendo solamente la tratta a sud della città. Si dovranno purtroppo attendere ancora alcuni anni prima del ripristino totale della linea, in quanto i lavori in corso Grosseto per la costruzione della galleria della Torino-Ceres impediscono tuttora la riattivazione sino al capolinea di via Massari. Inoltre, in piazza Baldissera mancano ancora i binari di attraversamento che avrebbero potuto, con una più lungimirante progettazione, essere posati contemporaneamente ai lavori di copertura del passante ferroviario . Un' ultima osservazione esaminando il progetto di posa binari nella piazza si evince che le vetture dirette al deposito Venaria non avranno più la possibilità di invertire la marcia sul posto ma dovranno recarsi almeno sino al Rondò della Forca con un evidente spreco di tempo e denaro.
Questa e' la storia sintetica di una linea tranviaria longeva ma decisamente travagliata: gliela dedichiamo, auspicandole un futuro decisamente migliore!

INCIDENTI TRANVIARI NEL DOPOGUERRA
di Mauro Pellegrini
La rete tranviaria torinese subì gravi danni in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sia alle vetture, sia agli impianti (binari e depositi). All’indomani della Liberazione, quindi, la situazione della rete di trasporti in città era piuttosto grave: molte linee, se non soppresse, erano limitate o deviate nel percorso, e la manutenzione delle vetture era assai carente. Questa situazione si protrasse per alcuni anni, e soltanto intorno al 1950 si può dire che fosse tornata quasi alla normalità. Per quanto riguarda l’estensione della rete e il numero di vetture in servizio, si raggiunse il record storico, se si eccettuano le tranvie extraurbane, che iniziarono rapidamente ad essere smantellate. Prima del boom economico, la stragrande maggioranza della popolazione utilizzava i tram per i propri spostamenti quotidiani, in quanto la motorizzazione di massa era ancora agli albori. In tale contesto, è facile capire come gli incidenti stradali in città coinvolgessero molto spesso le vetture tranviarie, vere padrone della strada. Dalle cronache del tempo, in particolare nel biennio 1949/50, emergono diversi episodi, fortunatamente non sempre con risvolti drammatici, ma alcuni piuttosto curiosi.
Il primo avvenne il 9 marzo 1949, quando un tram della linea 15 urtò nientemeno che un treno che usciva dalle Officine Grandi Motori, ed ebbe ovviamente la peggio. ‘La Stampa’ descrive così l’avvenimento: “Verso le 16.30 di ieri una vettura della quindicesima linea stava percorrendo a normale velocità corso Vercelli. Nelle vicinanze di una traversa del corso, e precisamente di via Carmagnola, c’è un grosso stabilimento; dal portone escono le rotaie della ferrovia che attraversano la strada e si dirigono verso lo scalo nord. […] Ora, proprio da quel portone stava uscendo ieri una colonna di carri merci, sospinta da una locomotiva. Alla testa della colonna era un ferroviere, il quale, visto avanzare la vettura tranviaria, si sbracciava in cenni e segnalazioni. Ora, vuoi che tali cenni fossero fatti confusamente, vuoi che il manovratore li abbia fraintesi, sta di fatto che il tram non rallentava la corsa e arrivava all’incrocio con i binari ferroviari proprio mentre il macchinista, credendo di avere via libera, aveva accelerato. Così l’urto era inevitabile. Il primo dei pesantissimi carri-merci arrivava sul fianco del tram, all’altezza del bigliettaio. I passeggeri si accorgevano, urlavano, il fattorino apriva le porte ma ormai era troppo tardi: il vagone investiva la vettura, la sfondava, la sbalzava addirittura dalle rotaie, in un fracasso orrendo di ferraglia e di vetri infranti cui si univano le grida di terrore dei passeggeri e le esclamazioni costernate dei passanti.” Per fortuna malgrado la violenza dello scontro non si ebbero a lamentare vittime, ma soltanto sei passeggeri feriti. La vettura tranviaria però fu distrutta pressoché totalmente.
La linea 15 era piuttosto sfortunata, in quanto il 12 gennaio 1950 fu protagonista di un altro incidente, stavolta contro una camionetta dei carabinieri, e a breve distanza dal precedente. Ecco uno stralcio dalla cronaca di ‘Stampa Sera’: “Il fatto è avvenuto esattamente alle 0.45, in corso Vercelli angolo piazza Crispi, ed è stato causato, a quanto pare, dalla fitta nebbia che in quel momento stagnava su tutta la zona. L’autocarro appartenente all’arma dei Carabinieri […] giungeva lungo corso Vigevano proveniente dalla stazione Dora, e svoltava in piazza Crispi per dirigersi verso il centro della città lungo corso Vercelli. Sull’autocarro erano venti carabinieri in servizio di perlustrazione notturna. In quello stesso istante giungeva lungo corso Vercelli, ugualmente diretta verso il centro di Torino, una vettura tranviaria della quindicesima linea, recante il numero 2535. […] A causa della scarsa visibilità i due veicoli non si scorsero che quando già si trovavano a brevissima distanza l’uno dall’altro; ogni manovra per evitare l’urto era ormai inutile. Tram e camion cozzarono in modo talmente violento che quest’ultimo compì un intero giro su se stesso.”
In questo caso fu il camion ad avere la peggio, e tutti i carabinieri che erano a bordo rimasero feriti, più o meno gravemente, mentre non si lamentarono che alcuni lievi contusi a bordo del tram, che subì soltanto lievi danni.
Il 3 giugno 1950 fu invece la tranvia Torino-Rivoli ad essere coinvolta in un incidente, stavolta causato da uno scambio difettoso, che causò il deragliamento e il conseguente rovesciamento di un vagone. L’episodio finì sulla prima pagina di ‘Stampa Sera’, che così descrisse gli avvenimenti: “Il convoglio era composto da una motrice e tre carrozze. Si presume che il numero di passeggeri salisse ad almeno quattrocento. […] Il convoglio era giunto alle ore 11.53 alla fermata che si trova nei pressi dello stabilimento dell’Aeronautica d’Italia. Ormai la stazione di arrivo era vicina, a pochi chilometri di distanza e a pochi minuti di percorso: tanto è vero che molti passeggeri, pur senza scendere dal vagone, avevano cominciato a farsi largo e a portarsi sui predellini per essere più pronti a balzare a terra quando il convoglio fosse nei pressi di piazza Statuto. È stata probabilmente questa circostanza fortunata a far sì che al momento in cui si verificò il drammatico incidente, molte persone potessero salvarsi lanciandosi tempestivamente al suolo. Alle 11.54 esatte, in perfetto orario, il convoglio ripartì. La sciagura avvenne subito dopo, quando il treno non aveva percorso che qualche decina di metri e quindi non aveva ancora acquistato eccessiva velocità. […] Subito dopo la fermata dell’Aeronautica d’Italia [n.d.r. corrente corso Francia 361] i binari si biforcano, e in quel punto si trova un congegno di scatto dello scambio, di quelli chiamati comunemente ad ‘ago’. La motrice superò questa biforcazione, ma subito dopo l’ago scattò da solo, azionando lo scambio stesso. […] Mentre la motrice proseguiva su un binario, la seconda vettura del convoglio e naturalmente le altre due, avanzavano su un altro che si stacca dal precedente. La carrozza deviata era quindi sottoposta a una trazione obliqua al suo asse, e questo fatto a poco a poco la fece inclinare verso il suolo, piegando poi fin quasi a toccare i binari.” Alla fine si contarono una quarantina di feriti, un bilancio piuttosto contenuto considerando il numero di passeggeri coinvolti.
L’incidente avvenuto la sera del 3 settembre 1950 causò invece tre feriti ma avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi vista la dinamica: un tram della linea 14 vuoto, fermo al capolinea di Ponte del Gatto, per un guasto ai freni andò giù per la discesa e terminò la sua corsa contro una casa di corso Moncalieri dopo aver urtato un’automobile. ’La Stampa’ il giorno 5 scriveva: “L’incidente è stato causato dallo scivolamento lungo via Sabaudia della vettura tranviaria n. 2018 ferma a Ponte del Gatto in attesa della partenza. Il manovratore e il bigliettaio, com’è risultato dalle prime indagini, avevano abbandonato la vettura temporaneamente come di solito avviene ai capolinea. […] Malauguratamente, per cause non ancora ufficialmente accertate, i freni della vettura si allentarono e la pesante carrozza prese l’abbrivio per la ripida discesa percorrendo oltre 400 metri, assolutamente priva di controllo, prima di deragliare e schiantarsi contro una casa.” I due dipendenti dell’ATM furono sospesi dal servizio, e per il manovratore fu un beffardo scherzo del destino, in quanto era ormai prossimo alla pensione. Questo è sola una parte dei numerosi incidenti avvenuti in quel periodo, e un cenno è d’obbligo alla nefasta giornata del 9 dicembre 1950, quando si contarono ben cinque incidenti tranviari, avvenuti in zone diverse della città e che coinvolsero tra le altre vetture delle linee 4, 7 e 14, e tra i feriti persino un vigile urbano.
Oggi il numero di tram è sensibilmente diminuito rispetto ad allora, e anche gli incidenti che coinvolgono vetture tranviarie sono molto meno frequenti, ma d’altra parte è aumentato in maniera esponenziale il numero di veicoli lungo le strade, e la maggior parte delle volte basterebbe un po’ più di prudenza e soprattutto meno distrazione alla guida per evitare spiacevoli conseguenze.
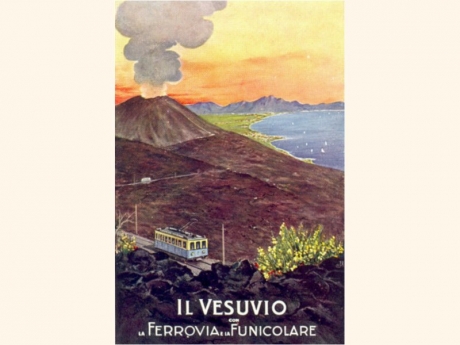
IN TRAM SUL VESUVIO
di Roberto Cambursano
“Funiculì funiculà!”: tutti conosciamo la celeberrima canzone napoletana scritta nel 1880 da Giuseppe Turco e musicata da Luigi Denza, che fu probabilmente il primo spot pubblicitario in grande stile nella storia del trasporto pubblico turistico. Era infatti nata come promozione della Funicolare del Vesuvio, un impianto inaugurato nello stesso anno che, a partire da un punto in quota raggiungibile a piedi o a dorso di mulo, superava l’ultimo tratto di montagna giungendo fin quasi al cratere del vulcano, situato a 1200 metri di altitudine. La prima funicolare, lunga 800 metri e su un dislivello di 421 metri, era costituita da due vie di corsa parallele dotate di una specie di monorotaia su cui viaggiavano due minuscole cabine (denominate “Etna” e “Vesuvio”): seriamente danneggiata da una prima eruzione vulcanica nel 1906, la funicolare fu completamente ricostruita e rimessa in funzione nel 1909 con un sistema diverso, a binario unico con raddoppio centrale e con due vagoni più grandi, ma l’imponente eruzione del 1944 la distrusse nuovamente e non fu più ricostruita. Fra il 1953 e il 1984 funzionò una seggiovia: a partire da allora, l’ascensione si può fare solo a piedi, oppure in auto arrivando fino al piazzale situato a quota 1000 m.s.l.m.; vari progetti di nuovi impianti di risalita sono stati presentati ma non hanno mai avuto seguito.
Qui vogliamo però parlare più approfonditamente di una linea meno nota ma che fu per mezzo secolo fondamentale per l’ascensione al vulcano, perchè collegava la base della montagna con la stazione di partenza della funicolare: la Tranvia a cremagliera del Vesuvio. La progettazione e la costruzione della linea furono affidate al tour-operator britannico Thomas Cook & Son, che già gestiva la funicolare e che gestì anche la tranvia fino quasi alla fine (prima direttamente e poi, a partire dal 1927, tramite una sua controllata italiana, la “Ferrovia e funicolare Vesuviana”). La tranvia del Vesuvio fu inaugurata nel 1903 e collegava la base del vulcano con la stazione inferiore della funicolare del Vesuvio partendo dalla stazione “Olivi” di Pugliano, una frazione del comune di Resina, in seguito ridenominato Ercolano. Nel 1911, per ottimizzare l’interscambio con la linea ferroviaria Napoli-Poggiomarino (parte dell’attuale Circumvesuviana), il capolinea inferiore fu fatto coincidere con la stazione ferroviaria di Pugliano (non più esistente dal 1972), anche se l'interscambio di materiale rotabile non era possibile a causa del diverso scartamento della "Circumvesuviana" (950 mm contro i 1000 mm della tranvia del Vesuvio); il percorso risultò quindi prolungato verso valle di 400 metri, arrivando a una lunghezza totale di linea di 7650 metri. La linea era a binario unico e superava un dislivello di 684 metri, partendo da quota 70 metri s.l.m. Superate la prime due fermate intermedie (Olivi e San Vito), si arrivava alla fermata denominata “Centrale”, posta quasi a metà percorso, dove era collocato il deposito-officina con la centrale di produzione dell’energia elettrica e dove era presente un raddoppio di binario per gli incroci dei convogli che procedevano in direzioni opposte; qui aveva inizio la tratta a cremagliera, lunga 1575 metri e armata con rotaia dentata di tipo Strub, su una pendenza massima del 25%. La cremagliera terminava alla successiva stazione di Eremo, al servizio dell’Osservatorio, dell’hotel Hermitage e della chiesetta di S.S. Salvatore, distante 2300 metri dalla stazione capolinea superiore situata a quota di 754 metri s.l.m. e in comune con quella di partenza della funicolare. L’intero tragitto era compiuto in 42 minuti (a fronte delle quattro ore in precedenza necessarie a una carrozza a cavalli); al di fuori della tratta più ripida, la pendenza della linea non superava l'8%; la trazione era elettrica in corrente continua alla tensione di 550 Volt.
La cronaca fece registrare un unico grave incidente, avvenuto il 28 novembre 1934, allorchè una motrice appena partita dal capolinea superiore acquisì una eccessiva velocità e deragliò nei pressi dell’Osservatorio, provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre nove.
Il problema della trazione sulla tratta a cremagliera fu risolto in economia, decidendo di impiegare normali tram elettrici ad aderenza naturale che, sulla sola tratta più ripida, venivano coadiuvati da appositi spintori a cremagliera (una soluzione peraltro già adottata in vari altri casi, come ad esempio nel 1902 sulla tranvia Trieste-Opicina). Fu quindi scartata l’opzione di acquistare motrici ad aderenza mista in grado di marciare autonomamente sull’intera linea, che sarebbe risultata molto più costosa ma che avrebbe per contro fortemente aumentato la velocità di esercizio.
Gli spintori, appoggiati sempre all’estremità di valle dei tram, li spingevano in salita o li trattenevano in discesa ad una velocità di 7 km/ora. Erano in servizio tre unità fornite dalla SLM di Winterthur, lunghe 4,2 metri e dotate di una coppia di motori dalla potenza complessiva di 120 o 147 Kw, equipaggiate con una ruota dentata motrice centrale che ingranava sulla cremagliera e poggianti su ruote folli montate su due assi: per questa ragione potevano operare esclusivamente sui binari dotati di cremagliera (tratta Centrale-Eremo e relativi scambi e raccordi di deposito).
Il parco rotabile comprendeva inoltre sette motrici tranviarie bidirezionali a due assi di tre diverse tipologie. Le prime tre vetture furono fornite dalla SWG (Schweizerische Waggonfabrik) con equipaggiamento elettrico BBC ed erano del tipo aperto “a giardiniera” con capacità di 24 passeggeri; furono seguite nel 1913 da altre due vetture di ugual fabbricazione, più grandi ma di tipo chiuso con capacità di 40 posti. Nel 1929 giunsero due ulteriori vetture realizzate in Italia dalle Officine Meridionali, chiuse e con capacità di 44 posti. Le motrici, che sfoggiavano una elegante livrea nella doppia tonalità azzurra e crema, procedevano singolarmente: non erano previste vetture rimorchiate. Completavano il parco cinque carri merci aperti a due assi.
L’eruzione del 1906 danneggiò gravemente anche la tranvia nella sua parte terminale, ma il servizio completo fu ripristinato già l’anno successivo e continuò fino al 1944, quando la linea venne nuovamente interrotta dalla nuova più grave eruzione. Nel 1945, subito dopo la fine della Guerra, la Ferrovia Circumvesuviana subentrò nella gestione alla Thomas Cook e avviò i lavori di ripristino, riavviando integralmente il servizio nel 1947; nonostante la crescita del flusso turistico nel dopoguerra, la linea non fu però in grado di reggere la concorrenza della nuova strada carrozzabile asfaltata, giunta nel 1952 fino alla località di Eremo e resa percorribile anche agli autobus. Negli ultimi anni rimase in funzione un servizio di navetta tranviaria solo sull’ultimo tratto di linea tra Eremo e la stazione superiore, mentre il tratto Centrale-Eremo fu degradato a percorso di servizio per il trasferimento a vuoto del materiale rotabile. Il servizio cessò definitivamente sull’intera linea nel 1955, anno in cui fu completata la strada asfaltata fino a quota mille; in gran fretta, i rotabili furono demoliti e la linea fu smantellata entro i successivi tre anni.
DIDASCALIE IMMAGINI
fig.1- LA PRIMA FUNICOLARE DEL VESUVIO /foto Knackstedt & Näther /La cabina “Etna” della prima funicolare del Vesuvio (1880-1906) /1900.
fig.2- LOCANDINA STORICA /Manifesto pubblicitario d’epoca / La ferrovia e la funicolare del Vesuvio /Anni 1930.
fig.3- VEDUTA GENERALE /Cartolina d’epoca tratta da opuscolo pubblicitario edito dalla Thomas Cook /Illustrazione mostrante il Vesuvio e le linee di adduzione /Anni 1930.
fig.4- PLANIMETRIA /Disegno tratto da “Cook’s travellers handbook” /Schema dei collegamenti per il Vesuvio /1924.
fig.5- ORARIO DI SERVIZIO /Quadro tratto da Indicatore generale Fratelli Pozzo /Orario di servizio della tranvia e della funicolare del Vesuvio /1919.
fig.6- STAZIONE DI PUGLIANO /Immagine tratta da “Le cremagliere d’Italia” di Ogliari-Abate ed. Arcipelago -Milano 2007 /La stazione di Pugliano-Vesuvio-Resina, interscambio con la Ferrovia Circumvesuviana /Anni 1930.
fig.7- FERMATA CENTRALE /Cartolina d’epoca /La fermata Centrale con l’innesto del tratto a cremagliera e spintore in attesa /Anni 1930.
fig.8- TRATTO A CREMAGLIERA /Cartolina d’epoca / Un tram in transito con spintore in coda sul tratto a cremagliera / Anni 1930.
fig.9- FERMATA EREMO /Cartolina d’epoca /La fermata Eremo con un tram in transito e un altro fermo sul binario morto /Anni 1930.
fig.10- TRATTO SUPERIORE /Cartolina d’epoca /Un tram in transito sul tratto superiore ad aderenza naturale /Anni 1930.
fig.11- TRATTO TERMINALE /Cartolina d’epoca /Ultimo tratto della tranvia e stazione di interscambio con la funicolare /Anni 1930.
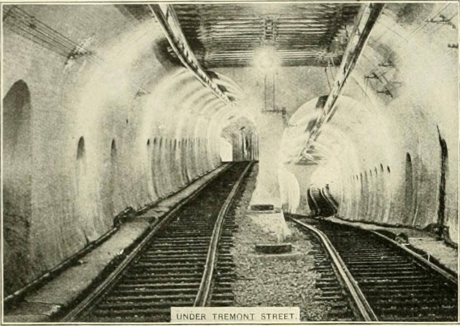
INNOVAZIONI…GIA’ VISTE
di Roberto Cambursano
PRIMA PARTE
Utilizzando i tram delle ultime generazioni, è naturale dare per scontato che le caratteristiche tecniche “innovative” siano il frutto del progresso più recente: al contrario, la sottovia tranviaria, la ricarica della forza di trazione in linea, l’alimentazione dal suolo, i tram articolati, il pianale ribassato, l’agente unico e altre cose che sono oggi l’emblema della modernità in realtà erano già state inventate e ingegnerizzate dai nostri antenati, che ovviamente l’avevano fatto usando le tecnologie disponibili all’epoca.
Con il supporto di immagini d’epoca, questo articolo passa in rassegna in ordine cronologico sei importanti innovazioni applicate ai trasporti pubblici urbani oltre un secolo fa, che sono alla base del funzionamento dei sistemi attuali.
LE SOTTOVIE TRANVIARIE
“Light rail”, “Stadtbahn”, “Pre-metro”, “Metrotranvia”: comunque vengano chiamate nei diversi paesi del mondo, le linee tranviarie moderne ad elevato livello di prestazioni fanno oggi uso in molti casi di tratte sotterranee, specialmente nelle zone centrali delle grandi città.
La prima realizzazione moderna di un tunnel tranviario avvenne a Bruxelles, in occasione dell'Esposizione Universale del 1958: nel sistema (apparentemente innovativo) definito “Pre-metro” venivano convogliate più linee tranviarie sulla stessa direttrice sotterranea, dotata anche di alcune stazioni. Ma la Sottovia tranviaria è vecchia quanto lo stesso tram: già un secolo prima, a New York esisteva il “Murray hill tunnel” lungo la 4^ Avenue di Manhattan (oggi Park Avenue). Su quella via era stata inaugurata nel 1832 la prima linea tranviaria della storia, la “New York and Harlem Railroad”, con trazione a cavalli: questa nel 1834 era stata prolungata verso nord e il nuovo percorso comprendeva un tratto di 500 metri al centro della strada, inizialmente scavato in trincea a cielo aperto e successivamente coperto: la prima sottovia tranviaria della storia! Dal 1898 i tram a cavalli furono rimpiazzati dai tram elettrici, che continuarono a percorrere il tunnel fino al 1935; nel 1937 il “Murray hill tunnel” fu adibito a sottopasso stradale, una caratteristica che ha mantenuto fino ai nostri giorni (Figura 1).
Anche in altre grandi città vennero costruite a partire dalla fine dell’Ottocento sottovie tranviarie centrali dotate di stazioni sotterranee in cui vennero fatte confluire più linee tranviarie, principalmente con la finalità di decongestionare il traffico di superficie (soprattutto quello degli stessi tram che cominciavano a essere troppi) e in qualche caso anche per superare particolari zone collinose all’interno dell’abitato. Alcuni di questi tunnel furono dismessi in occasione della chiusura delle reti tranviarie della prima generazione (come a Londra, Berlino, New York, Washington), altri invece sono rimasti in funzione e fanno oggi parte integrante della rete tranviaria moderna. Fra questi ultimi citiamo, in ordine di apertura: Marsiglia (Tunnel de Noailles, 1893), Boston (Tremont Street Subway, 1897) (Figura 2), Pittsburgh (Mount Washington transit tunnel, 1904), Filadelfia (Central City subway, 1907) e San Francisco (Twin peaks tunnel, 1918).
LA RICARICA IN LINEA
Come è noto, agli albori della storia del trasporto pubblico urbano l’energia necessaria per la trazione fu presa dapprima dagli animali, poi dal vapore e dall’aria compressa, e infine dall’elettricità. Furono sperimentati svariati sistemi di trazione e diverse modalità di fornitura dell’energia necessaria per la trazione stessa, fino ad arrivare alla conclusione che il sistema più efficiente era quello elettrico con una linea di alimentazione fissa e continua (come la classica catenaria). Ma vi fu un periodo, a cavallo fra i secoli XIX e XX, in cui sembrò che la soluzione ideale potesse invece essere rappresentata dalla “ricarica” in linea dell’energia necessaria per la trazione, con veicoli in grado di procedere scollegati dalla fonte di alimentazione con un certo livello di autonomia.
Il primo caso di tram a “ricarica” fu la locomotiva a vapore senza focolare (Figura 3), ideata allo scopo di ovviare agli inconvenienti dovuti alle emissioni fastidiose e nocive delle macchine a vapore in ambito urbano ed entrata in servizio regolare a Parigi nel 1878 ad opera dell’ingegnere francese Léon Francq (per la precisione, il sistema Francq costituiva un perfezionamento del precedente brevetto dell’americano Lamm, sperimentato per la prima volta a New Orleans nel 1872). Diffusosi in seguito anche in altre città francesi, il sistema consisteva in un piccolo locomotore tranviario a vapore a due assi che poteva rimorchiare fino a due vagoni passeggeri, dotato di caldaia (che fungeva da accumulatore di vapore) ma non di focolare, per cui non necessitava di rifornimento di carbone. In deposito, prima dell’uscita in servizio, la caldaia veniva caricata con acqua satura di vapore surriscaldato ad elevata pressione; il manovratore disponeva di una valvola che regolava la fuoriuscita del vapore dalla caldaia e lo inviava al sistema di cilindri e pistoni (analogo a quello delle normali macchine a vapore), trasmettendo il moto al tram: sottraendo vapore alla caldaia, la pressione interna calava provocando l’ebollizione dell’acqua e la conseguente produzione di altro vapore, fino ad esaurimento. L’autonomia di servizio era però molto bassa (15 km) ed i costi di gestione erano tali che questo sistema trovò poche applicazioni.
Il passo successivo fu il tram ad aria compressa (Figura 4), inventato dall’ingegnere polacco Louis Mekarsky e comparso nel 1879 a Nantes, che inizialmente sembrò promettere bene, tanto che entro la fine del secolo XIX acquisì una discreta diffusione specialmente in Francia (Parigi arrivò a disporre di sei linee). Il principio di funzionamento era semplice e costituiva in pratica una evoluzione della locomotiva a vapore senza focolare, in cui al posto del vapore veniva usato un altro fluido: l'aria compressa. Questa veniva convogliata mediante condutture sotterranee da una centrale di produzione a vari punti di presa situati in genere ai capilinea. Qui l’aria veniva caricata a bordo dei tram mediante tubi flessibili e stivata in grandi serbatoi posti sotto il pianale delle vetture, e poi da essi inviata ad appositi cilindri che trasmettevano il moto alle ruote; la regolazione della pressione e quindi della velocità avveniva tramite un volantino girato a mano dal manovratore. L'aria compressa proveniente dai serbatoi passava attraverso una caldaia cilindrica a pressione piena di acqua bollente (la “bouillotte”) installata sulla piattaforma di guida: questo sistema permetteva di riscaldare l' aria compressa (che, per effetto della decompressione subita nei cilindri motori, avrebbe avuto la tendenza a raffreddarsi eccessivamente) a una temperatura ottimale per il corretto funzionamento; il riscaldamento dell'acqua nella caldaia avveniva mediante il rifornimento di vapore ai capilinea tramite appositi tubi flessibili, contemporaneamente al carico dell'aria compressa. Ma il tallone d’Achille di questo sistema si rivelò presto il suo alto costo di esercizio, sia per la gestione delle stazioni di ricarica sia per le lunghe soste ai capilinea dovute alla sua limitata autonomia, (un tram ad aria compressa poteva percorrere solo una quindicina di chilometri fra due successive ricariche, ciascuna delle quali durava 20 minuti). L’ ultimo tram di questo tipo scomparve a Parigi nel 1917, soppiantato dalla trazione elettrica.
Con l’avvento della trazione elettrica, il concetto di ricarica in linea fu applicato al sistema di trazione ad accumulatori, con modalità simili a quelle poi riscoperte oltre un secolo dopo.
L’era degli accumulatori impiegati nella trazione ebbe inizio nel 1881, allorchè il chimico francese Alphonse Faure brevettò il primo accumulatore industriale e l’ingegnere Nicolas Raffard lo sperimentò per la prima volta a Parigi: si trattava di una vettura a due piani presa in prestito dalle locali tranvie a cavalli, sulla quale era stata montata una dinamo Siemens che fungeva da motore e che era alimentata da una batteria di accumulatori. Si era agli albori della trazione elettrica e questo sistema, all'apparenza il più semplice fra tutti perché consentiva di disporre dell'energia elettrica direttamente a bordo del veicolo, sembrava destinato al successo. Lo sviluppo della trazione ad accumulatori fu largamente favorito anche da ragioni estetiche, specialmente nelle grandi metropoli europee dotate di zone di particolare pregio architettonico, con una curiosa preveggenza rispetto ad oggi. Dopo un primo periodo pionieristico, già negli ultimi anni dell’Ottocento prese piede il sistema della ricarica degli accumulatori al capolinea (Figura 5), che avveniva tramite apposite prese elettriche fisse alle quali il tram in sosta veniva collegato: a parte qualche caso di linea gestita interamente ad accumulatori, generalmente il sistema adottato fu quello misto accumulatori/alimentazione aerea, in cui gli accumulatori venivano utilizzati in modo complementare al sistema a filo aereo solo per l’attraversamento di particolari sezioni che le amministrazioni locali non volevano “deturpare” con pali e fili: la prima applicazione di rilievo di un sistema di questo genere fu fatta ad Hannover nel 1895 su una rete di ben 130 km. L'arretrato livello tecnologico delle batterie di accumulatori del tempo, caratterizzate da un basso rendimento e da una incompleta e lenta capacità di ricarica (oltre che da altri fattori negativi non trascurabili come l’elevato peso ed ingombro e le fastidiose esalazioni chimiche), condannò comunque inesorabilmente all'insuccesso il sistema, che venne ben presto gradatamente abbandonato ovunque già nel primo decennio del Novecento. Il sistema di alimentazione tranviaria mista accumulatori/rete aerea si prese però la rivincita un secolo dopo, ricomparendo a Nizza nel 2007 in veste moderna con la tecnologia “nickel-ibrida” brevettata da Alstom ed evolvendosi poi nel sistema di ricarica puntuale alle fermate tramite i supercapacitori abbinati alle batterie (a partire dal sistema ACR di CAF introdotto a Siviglia nel 2011).
L’ALIMENTAZIONE DAL SUOLO
La smania del “catenary free” non è certo un’esclusiva dei nostri tempi: il periodo della grande espansione tranviaria mondiale fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fu anzi ancora più di oggi caratterizzato da aspre discussioni nelle assemblee comunali intorno alla scelta del sistema di alimentazione elettrica delle reti, specialmente nelle grandi capitali dotate di ampie zone auliche. Spesso le autorità locali furono particolarmente restie ad autorizzare la posa di pali e fili: esempi emblematici sono i casi di Vienna e di Londra, dove non fu mai concesso il permesso di impiantare tranvie elettriche all'interno del centro storico. Questa sensibilità estetica spinse i tecnici a ricercare sistemi di alimentazione elettrica alternativi a quello del filo aereo, ma anche alternativi a quello degli accumulatori che si stava dimostrando poco efficiente.
I primissimi esperimenti di alimentazione sotterranea furono attuati in America: nel 1884 una vettura attrezzata con il sistema Bentley-Knight circolò su un breve tratto a Cleveland, ma dopo qualche mese di deludenti risultati si ritornò alla trazione a cavalli; l'anno successivo fu realizzato a Denver un altro primitivo sistema di alimentazione a conduttore sotterraneo, inventato dal professore Sydney H. Short, che fu poi perfezionato e applicato su una vera e propria linea in servizio regolare, lunga circa 8 km, che però cessò di funzionare già nel 1887 visti i risultati evidentemente non brillanti.
Nello stesso periodo anche in Europa, e precisamente nella città inglese di Blackpool, venne messo in funzione nel 1885 un diverso sistema di alimentazione a conduttore sotterraneo, brevettato da Michael Holroyd Smith: purtroppo la linea tranviaria prescelta, costruita tutta a ridosso della spiaggia e quindi fortemente esposta all'acqua e alla salsedine, si rivelò del tutto inadatta ad un sistema del genere, che qui venne abbandonato e definitivamente sostituito da un sistema di alimentazione a filo aereo. Ma nel frattempo il sistema ideato da Smith (detto in inglese “conduit” e in francese “caniveau”) era stato perfezionato e reso affidabile, tanto da renderne possibile in pochi anni l’applicazione su larga scala in numerose città nel mondo, tra le quali New York, Parigi, Berlino, Bruxelles, Budapest, Praga, Londra e Washington. Nella maggior parte dei casi i veicoli erano dotati di un doppio sistema di captazione della corrente, potendo così circolare sia nei tratti alimentati dalla rete aerea (di solito in periferia) sia in quelli alimentati dal sottosuolo (di solito nelle zone centrali). Nella configurazione più diffusa (Figura 6), in asse al binario era collocata una scanalatura continua metallica, nella quale andava ad infilarsi un braccio meccanico montato sotto il pianale del tram; in una camera sotterranea era posata la linea elettrica di alimentazione a corrente continua, costituita da due profilati metallici di polarità opposta che si fronteggiavano e in mezzo ai quali scorreva il braccio dotato di pattini striscianti di contatto. In analogia a quanto avviene per il filobus, i due conduttori fungevano da andata e ritorno della corrente, per cui il binario di corsa non faceva parte del circuito di trazione, come invece normalmente avviene per i sistemi tranviari alimentati dal filo aereo. In altri casi (come a Budapest dal 1887) la scanalatura, anziché essere posta in asse al binario, era situata in asse a una delle due rotaie, la quale presentava una gola dotata di fessura per lasciare passare il braccio di presa di corrente. In alcune capitali, l’alimentazione dal suolo riuscì a sopravvivere fino alla scomparsa dell’esercizio tranviario della prima generazione, rispettivamente a Parigi fino al 1937, a Londra fino al 1952 (dove esisteva la rete con sistema “conduit” più estesa d’Europa con 124 miglia di binario) e a Washington (ultimo caso di sistema “conduit” funzionante nel mondo) fino al 1962. Negli altri casi, l’alimentazione dal suolo fu soppiantata da altri sistemi più convenzionali a causa dei suoi elevati costi di costruzione e delle complicazioni di gestione (si pensi ad esempio alle manovre da effettuarsi al passaggio da un tratto ad alimentazione aerea a uno ad alimentazione sotterranea e viceversa e ai notevoli problemi causati dall’accumulo di sporcizia e di neve nelle scanalature).
Trovò una certa diffusione in Europa anche un altro sistema di captazione della corrente dal suolo, quello “a contatti superficiali” (o “a borchie”): la sua prima applicazione (sistema Claret/Vuilleumier) venne sperimentata a Clermont-Ferrand e messa in funzione sulla linea dell’Esposizione di Lione nel 1894; nel 1899 venne inaugurata a Tours la prima linea dotata del più evoluto sistema Diatto (brevettato dal torinese Alfredo Diatto), poi diffusosi a Parigi e in altre città francesi; altri sistemi simili, tra i quali il sistema Dolter (Figura 7), furono inoltre adottati in alcune città inglesi e francesi. In questi casi, l’alimentazione elettrica veniva fornita da una sequenza di borchie metalliche poste in asse al binario e distanziate tra loro a intervalli regolari, in modo che sempre almeno una di esse venisse toccata da un lungo pattino di presa di corrente montato sotto il pianale del tram: il circuito elettrico era attivo (almeno in teoria…) esclusivamente nelle borchie situate sotto la vettura in transito, essendo attivato e disattivato localmente da elettromagneti comandati dai contatti di bordo. L’insuccesso dei contatti superficiali fu molto più netto e precoce rispetto a quello del sistema “conduit”, a causa dei gravi problemi di sicurezza causati dal sistema stesso: infatti le borchie rimaste accidentalmente alimentate causavano frequenti folgorazioni ad animali e anche ad esseri umani! Per fortuna tutti quanti i sistemi del genere non sopravvissero oltre il primo decennio del Novecento.
L’alimentazione sotterranea ricomparirà in versione moderna a Bordeaux nel 2003, con il sistema APS di Alstom/Innorail: è curioso notare che, fino a cinquant’anni prima, parte della rete tranviaria di questa città era ancora alimentata con il vecchio sistema a “conduttore sotterraneo” della prima generazione
ELENCO IMMAGINI
fig. 1 - IL “MURRAY HILL TUNNEL” / Immagine da www.pinterest.com / Veduta del “Murray Hill Tunnel” allo stato attuale sotto la Park Avenue a New York, adibito a sottopasso stradale / 2010.
fig. 2 - LA “TREMONT STREET SUBWAY” / Immagine tratta da “The Street Railway Journal” / Binari all’interno della “Tremont Street Subway” appena aperta al traffico a Boston / 1897.
fig. 3 - TRAM A VAPORE SENZA FOCOLARE / Cartolina d’epoca / Una locomotiva a vapore senza focolare sistema Lamm-Francq in servizio a Parigi / 1908.
fig. 4 - TRAM AD ARIA COMPRESSA / Cartolina d’epoca / Un convoglio formato da motrice ad aria compressa Mekarski e un rimorchio sul Lungo-Senna a Parigi durante una inondazione / 1910.
fig. 5 - TRAM AD ACCUMULATORI / Cartolina d’epoca / Un tram ad accumulatori delle tranvie suburbane parigine al capolinea del Ponte di Puteaux. Si notano le colonnine di ricarica elettrica / Anni 1910.
fig. 6 - SCAMBIO E INCROCI SISTEMA “CONDUIT” / Immagine tratta da “The street railway journal” / Costruzione di un gruppo di incroci e scambio con alimentazione sotterranea – sistema Smith per la rete di Londra / 1894.
fig. 7 - TRAM CON ALIMENTAZIONE A CONTATTI SUPERFICIALI / Cartolina d’epoca / Un tram in servizio a Torquay (Regno Unito) su una linea alimentata tramite contatti superficiali – sistema Dolter / Anni 191

INNOVAZIONI… GIA’ VISTE
di Roberto Cambursano
SECONDA PARTE
I TRAM ARTICOLATI
Una caratteristica dei tram delle ultime generazioni è quella di essere sempre più “lunghi”: oggi i veicoli sono tutti costruiti in modo modulare, con tante casse collegate da articolazioni.
Il problema di come aumentare la capienza dei veicoli se lo erano già posto i nostri antenati a partire dalla fine dell’Ottocento, quando i tram a una sola cassa cominciarono ad essere inadeguati nelle città di maggiori dimensioni che si trovavano a fronteggiare sempre maggiori livelli di uten-za. Prescindendo dalla soluzione del tram a due piani, che non ebbe mai una gran fortuna al di fuo-ri del mondo britannico, la prima tappa storica fu l’aggiunta alla vettura tranviaria motrice di uno o più rimorchi, il che comportava però una riduzione delle prestazioni di esercizio e un aumento dei costi di gestione dovuto alla necessità di presidiare con personale ogni vettura del convoglio.
Lo stadio evolutivo successivo fu il tram articolato, la cui idea nacque in America nientemeno che nel 1892, quando fu registrato il brevetto di Brewer e Krehbiel di un veicolo formato da tre casse, ottenuto dall’assemblaggio di due vecchie motrici a due assi unite fra loro mediante una nuova terza cassa centrale più corta e sospesa: un prototipo fu costruito dalla Kuhlman Car Com-pany e circolò a Cleveland a partire dall’anno successivo (Figura 8), guadagnandosi l’appellativo di “two rooms and a bath” (o “due camere e cucina” come lo chiamiamo da noi). Anche se que-sto tram si dimostrò affidabile, non si diede seguito alla produzione di altri esemplari perché il basso costo della manodopera continuava a rendere economicamente più convenienti i tram corti; le cose cambiarono negli anni della Prima Guerra Mondiale, quando le “due camere e cucina” ri-cavate dall’assemblaggio di vecchi tram divennero economicamente competitive, sia perché per-mettevano di ridurre i costi del personale, sia perché potevano essere costruite in economia da molte officine aziendali.
La prima motrice articolata a tre casse prodotta in serie entrò in funzione a Boston nel 1912 e fu realizzata in ben 110 esemplari; successivamente, il tram di tipo “due camere e cucina” si diffuse soprattutto in Europa e in particolare in Italia e in Germania, dove venne ancora prodotto fino ai primi Anni Sessanta. Le “due camere e cucina” presentavano numerosi inconvenienti come la ru-morosità, l’instabilità e la difficoltà di inscrizione in curva: era evidente che questa non era una soluzione sufficientemente affidabile e che bisognava trovare un sistema tecnologicamente più avanzato che potesse permettere di realizzare veicoli articolati facendo a meno dei vecchi rigidi truck e utilizzando i più snelli carrelli rotanti (“Jacobs”) come parte del sistema stesso di articola-zione.
Il primo tram articolato al mondo dotato di un carrello interposto fra due casse venne costruito a Milwaukee nel 1920 (Figura 9): le officine dell’azienda locale realizzarono una serie di 33 vei-coli articolati a due casse e tre carrelli, assemblando due vecchie vetture monocassa e accoppian-dole fra loro per mezzo di un piccolo carrello portante intermedio di nuova costruzione dotato di ralla, su cui poggiavano le estremità delle due casse sostenute da speciali travi in acciaio. La co-municazione interna fra le due parti del veicolo era costituita da uno stretto passaggio (con fun-zionamento simile a quello dei vagoni ferroviari), con un mantice esterno di protezione.
Sempre in America, negli anni immediatamente successivi furono realizzati alcuni altri veicoli articolati a carrelli e nel 1924 fu introdotta una innovazione per migliorare il sistema di comuni-cazione interna fra le casse, la cosiddetta “giostra” (“articulation device”), brevettata da Tho-mas Elliott (Figura 10) della Cincinnati Car Company. Si trattava di un dispositivo montato sopra il carrello intermedio, formato da una piattaforma circolare con funzione di pavimento e da due pareti laterali semicilindriche: nelle curve, le estremità dei pavimenti delle due casse contigue (sagomate con profilo circolare concavo) ruotavano intorno alla piattaforma centrale di uguale raggio. Le prime giostre furono montate nello stesso anno a Detroit su un convoglio a tre casse e quattro carrelli realizzato ex-novo, che rimase un esemplare unico (Figura 11): era il più lungo tram mai costruito fino ad allora (37,4 metri!). Le soluzioni tecniche adottate non erano tuttavia ancora soddisfacenti per far partire una produzione di larga serie: oltre a presentare un passaggio di comunicazione interna ancora troppo stretto fra le varie sezioni del veicolo, la ridotta libertà di movimento relativo fra le casse era causa di beccheggio e di grande usura e il fatto che i carrelli intermedi fossero piccoli e non motorizzati era causa di una mediocre tenuta di strada e di bassi valori di accelerazione. Una soluzione pienamente soddisfacente venne trovata solo quindici anni dopo, quando la giostra perfezionata dall’ingegner Mario Urbinati fece la sua comparsa a Roma e dall’Italia poi si diffuse universalmente, costituendo la base per la realizzazione dei tram articolati di tipo moderno. Tra le realizzazioni più significative, ricordiamo che, prima dell’avvento delle attuali tipologie di tram multiarticolati a pianale ribassato, per mezzo secolo a partire dal 1951 la casa produttrice tedesca Düwag e le industrie collegate sfornarono migliaia di tram articolati de-stinati ai mercati dell’Europa centrale, composti da due fino a cinque casse poggianti su carrelli di tipo “Jacobs” e con giostre intercomunicanti.
IL PIANALE RIBASSATO
Una prerogativa fondamentale dei tram moderni è il pianale ribassato, che permette l’incarrozzamento a raso in banchina, cosa impensabile fino a qualche anno fa….o forse no?
Può sembrare sorprendente, ma già nel 1912 circolarono a New York i primi tram a pianale ri-bassato della storia, con il pavimento alla strabiliante altezza di soli 25 cm dal piano del ferro (!), su progetto dell’ingegnere Frank Hedley, direttore della “New York Railways Company” e del suo collaboratore James Doyle. La casa costruttrice Brill di Filadelfia fornì tre differenti prototipi del cosiddetto “one step car” (anche detto “stepless car”), tutti altamente innovativi e immessi in regolare servizio pubblico sulla rete di Manhattan.
Il primo veicolo era un tram bidirezionale (Figura 12), lungo 14,2 metri con una sola porta cen-trale su ogni fiancata composta da due ante scorrevoli, con cassa in acciaio e presa di corrente sot-terranea (sistema “conduit”); il pavimento era del tutto privo di gradini interni, grazie all’adozione di due carrelli di tipo “maximum traction” (Figura 13), strutturati con un asse ante-riore (motore) dotato di ruote di grande diametro e da un asse posteriore (portante) con ruote di diametro più piccolo: questo permetteva di equipaggiare il tram con due soli motori (uno per car-rello) disponendo nel contempo di una sufficiente aderenza, dato che il peso del tram veniva a gravare sugli assi motori per il 75% anziché per il 50% come nella configurazione a due motori per carrello; la collocazione dei motori a sbalzo verso le estremità del tram permetteva inoltre di estendere il ribassamento del pavimento fino ad oltre la mezzeria dei carrelli, con una impercetti-bile pendenza interna che raccordava il centro del veicolo con le zone di estremità dove erano col-locati due “salottini” costituiti da sedili disposti a semicerchio (Figura 14). Dopo il successo della sperimentazione, questo tram fu poi costruito dalla Brill in una serie di 36 esemplari per alcune città californiane, mentre la Saint Louis Car Company ne costruì su licenza altri 175 esemplari per New York; altri prototipi circolarono in Canada a Vancouver e in Australia a Perth e Brisbane. Il secondo prototipo ribassato di New York era un tram di grandi dimensioni (a carrelli a due piani) e il terzo era un tram di piccola taglia (a due assi con alimentazione a batteria): entrambi rimasero però esemplari unici e non fu mai avviata una produzione di serie.
Tutti i tram del tipo “one-step car” furono ritirati dal servizio entro gli Anni Trenta (ad eccezio-ne di quello di Perth che sopravvisse fino al 1950). Il concetto di pianale ribassato sui veicoli tranviari era evidentemente troppo avanzato per i tempi, tanto che se ne perse la memoria per i successivi decenni: ricordiamo che il primo tram moderno prodotto in serie che permetteva l’incarrozzamento a raso in banchina fu il TFS2 prodotto da GEC-Alsthom, entrato in servizio a Grenoble nel 1987 e composto da una zona centrale ribassata a 35 cm dal piano del ferro e da due zone di estremità rialzate sopra i carrelli, raccordate con scalini interni. Per avere un tram di serie a pianale totalmente ribassato e privo di gradini interni si dovette attendere il 1990, quando fu presentato a Brema il prototipo del GT6N prodotto da AEG, che aveva il pavimento a 35 cm dal piano del ferro (ridotto a 30 cm in corrispondenza delle porte). Il record assoluto di “ribasso” fu perso dal vecchio e glorioso “one step car” solo nel 1995, con l’entrata in servizio a Vienna dell’”ULF” di Siemens/Elin/SGP, dotato di un pianale distante 19,7 cm dal piano del ferro (ulte-riormente riducibile a 18 cm con il dispositivo di “inginocchiamento, poi disattivato).
L’AGENTE UNICO
Il binomio manovratore-bigliettaio fa parte dell’iconografia tranviaria mondiale e alcuni dei let-tori di questo articolo certamente lo conserveranno nella propria memoria storica. Le prime espe-rienze dell’”agente unico” da noi risalgono alla fine degli Anni Sessanta, quando cominciò la “ri-scossione meccanizzata” seguita dalla “biglietteria a terra”.
Però, forse non tutti sanno che l’”agente unico” è un’invenzione americana che risale al 1916: in quell’anno venne infatti introdotto a Seattle un piccolo tram a due assi standardizzato ed econo-mico, il “Birney safety car” (Figura 15), così chiamato dal nome del suo inventore l’ingegnere Charles O. Birney. L’appellativo “safety car” era dovuto al fatto che la vettura era dotata di vari dispositivi di sicurezza, tra cui l’innovativo sistema elettro-pneumatico di “blocco porte”, che impediva la marcia nel caso in cui una porta fosse rimasta accidentalmente aperta. Il Birney era destinato alle reti delle città medie e piccole ed era progettato per l’esercizio con un solo agente col sistema “pay as you enter”. Era bidirezionale, con una sola porta posizionata sull’estremità di ogni fiancata; la porta era sufficientemente larga da consentire il flusso contemporaneo dei pas-seggeri in discesa e in salita (Figura 16): questi ultimi trovavano sulla piattaforma di accesso un “fare box” in cui versavano l’importo della tariffa di viaggio in monete o in gettoni, sotto il con-trollo visivo del guidatore; quest’ultimo non maneggiava perciò il denaro, che finiva per gravità in una cassetta sul fondo del fare box, chiusa a chiave e svuotata solo al rientro in deposito. Il suc-cesso di questo tram fu favorito anche dalla temporanea carenza di manodopera dovuta alla Prima Guerra Mondiale; grazie alle sue doti di leggerezza e robustezza, il Birney venne prodotto da varie case costruttrici (fra cui l’American Car Company e la Brill) in circa 6000 esemplari fino al 1941; la sua limitata capienza, l’eccessivo tempo perso alle fermate per l’assenza del bigliettaio e il suo peso ridotto (causa di numerosi svii e deragliamenti), finirono poi però per causarne la crisi: nelle città più grandi fu rimpiazzato da vetture più lunghe, mentre in quelle più piccole scomparve insieme alle rispettive reti tranviarie della prima generazione. Il sistema “pay as you enter” a un solo agente sopravvisse invece in parecchie città americane e fu poi esteso anche a vetture più grandi (come le famose PCC).
ELENCO IMMAGINI
fig. 8 - IL PRIMO TRAM “DUE CAMERE E CUCINA” / Immagine tratta da “The Street Railway Journal” / La presentazione a Cleveland del primo tram del mondo del tipo “due camere e cucina” di Brewer and Krehbiel / 1893.
fig. 9 - IL PRIMO TRAM ARTICOLATO A CARRELLI / Immagine tratta da “Electric Railway Journal” / Frontespizio di un articolo che descrive il primo tram articolato a carrelli del mondo, in servizio a Milwaukee dal 1920 / 1921.
fig. 10 - LA PRIMA “GIOSTRA” TRANVIARIA / Immagine allegata al brevetto originale US1501325-1924-07-15 di Thomas Elliott della Cincinnati Car Company / La prima “giostra” al mondo per tram articolato a carrelli / 1924.
fig. 11 – IL PRIMO TRAM MULTIARTICOLATO / Immagine da “S. Sycko Transit Collection” / Il tram articolato a tre casse e quattro carrelli con giostre Elliot costruito dalla Cincinnati Car Company, in servizio a Detroit / 1924.
fig. 12 – LA “ONE STEP CAR” / Immagine da “Library of Congress Archive” / Un tram a pianale ribassato del tipo “One step car”, costruito dalla Saint Louis Car Company, in servizio a New York / Anni 1910.
fig. 13 - CARRELLO “MAXIMUM TRACTION” / Immagine tratta da “Brill Magazine” / Il carrello di tipo “maximum traction” montato sul prototipo “Stepless car” della Brill a New York / 1912.
fig. 14 - FIGURINI DELLA “STEPLESS CAR” Immagini tratte da “Brill Magazine” / Figurini del prototipo Brill di “Stepless car” di New York in pianta e in sezione / 1912.
fig. 15 - IL “BIRNEY SAFETY CAR” / Immagine tratta da “Baltimore and Ohio Employees Magazine” / Disegno raffigurante un tram Brill tipo “Birney safety-car” ad agente unico / 1920.
fig. 16 - LAYOUT DI TRAM BIRNEY / Immagine tratta da “Brill Magazine” / Il layout interno di un tram Brill standard di tipo “Birney” / 1917.

IN VETTA AL MONTE WASHINGTON
di Roberto Cambursano
Il 3 luglio 1869 la prima ferrovia di montagna a cremagliera del mondo effettuava la sua corsa inaugurale raggiungendo la cima del Monte Washington in America: da allora questa linea non ha mai smesso di funzionare (è gestita ancora oggi in parte con materiale rotabile d’epoca!) e ed essa si sono affiancate successivamente numerosi altri impianti “ad aderenza artificiale” in ogni parte del pianeta. A distanza di 150 anni, questo articolo si propone di commemorare quella storica data.
Il Monte Washington (o Agiocochook nel linguaggio nativo americano) è situato nello stato del New Hampshire, circa 200 km a nord di Boston. Alto 1916 metri, è la cima più elevata delle delle White Mountains, appartenenti alla lunga catena dorsale dei Monti Appalachi che corre parallela alla costa atlantica, ed è famoso per le sue condizioni climatiche particolarmente inclementi (figura 1). Alle sue pendici, nel Grand Hotel Mount Washington di Bretton Woods, si tenne nel 1944 la famosa Conferenza che portò alla creazione del Fondo Monetario Internazionale.
A metà Ottocento le montagne non erano certo meta del turismo massa: le lunghe e faticose ascensioni a piedi erano riservate ad escursionisti appassionati ed esperti, talvolta aiutati da ani-mali da soma. L’idea di costruire una ferrovia di montagna ad uso turistico venne per prima a un imprenditore americano, Sylvester Marsh (1803-1884) (figura 2), che progettò espressamente un sistema a cremagliera in collaborazione con l’ingegnere e inventore Walter Aiken.
A dire il vero, una rudimentale cremagliera era già stata inventata dagli inglesi John Blenkinsop e Matthew Murray e utilizzata fra il 1812 e il 1838 in una ferrovia mineraria per il trasporto del carbone, mentre fra 1847 e il 1868 aveva funzionato in America un tratto di cremagliera sulla ferrovia Madison-Indianapolis con un sistema ideato da Andrew Cathcart: in entrambi i casi però, la cremagliera fu rimossa quando entrarono in funzione locomotive a vapore più potenti; inoltre le pendenze da superare non superavano il valore del 6%.
Il sogno di Marsh era di realizzare un’impresa eccezionale, una “railway to the moon” come fu definita ironicamente dai suoi detrattori, a dispetto dei quali egli riuscì a coinvolgere nel progetto le autorità locali e a trovare i necessari finanziamenti: i lavori iniziarono nell’estate del 1866 e tre anni dopo la linea fu completata.
La linea collega la stazione di Marshfield a quota 820 metri (antico nodo di interscambio con la “Boston & Maine Railroad” e sede del deposito vetture) con la cima del Monte Washington (figure 3 e 4), con un dislivello di 1100 metri. Il tracciato è lungo 4536 metri, interamente provvisto di cremagliera con scartamento di 1411 mm; il raggio minimo delle curve è di 150 metri. In origine, non essendo ancora stati inventati i moderni scambi a cremagliera, il cambio di binario si effet-tuava al capolinea/deposito mediante piattaforme girevoli; lungo la linea erano invece presenti due tratti di binario morto che permettevano l’incrocio dei treni ascendenti e discendenti, dotati ciascuno di un rudimentale scambio con nove parti mobili che dovevano essere manovrate a mano una per una. Dal 1941 sono presenti doppi scambi di tipo moderno sui due tratti intermedi di rad-doppio del binario, che permettono l'incrocio dei treni senza manovre di retromarcia (figura 5).
Una caratteristica peculiare di questa ferrovia a cremagliera è che è l'unica esistente al mondo che poggia quasi interamente su una incastellatura di legno formata da pali disposti a graticcio (“trestle”) (figura 6): la via ferrata non è quindi adagiata direttamente al terreno, bensì all’ incastel-latura che sostiene le traversine, sulle quali poggiano le rotaie e la cremagliera con l’interposizione di tre longherine longitudinali di legno. La scelta di questo particolare tipo di se-de permise di ridurre al minimo i costi di costruzione, dato che il binario ha potuto seguire la pendenza naturale del terreno senza bisogno di ponti, muri e gallerie e praticamente senza lavori di sterro o riporto di terra: ciò le conferisce un aspetto “western” molto diverso da quello delle linee europee.
La cremagliera (figura 7), posata in asse al binario, è costituita da due barre parallele in ghisa con sezione a “L” collegate da pioli orizzontali tondi in acciaio inseriti in fori a distanza regolare. L’aspetto della cremagliera Marsh è quello di una scala a pioli in miniatura, tanto che la struttura venne subito popolarmente soprannominata “Jacob’s ladder”, a ricordo della biblica “Scala di Giacobbe” che congiungeva la terra al cielo. Il sistema Marsh servì da modello per le prime ferrovie a cremagliera europee, costruite con il sistema Riggenbach (la seconda linea al mondo e prima in Europa fu quella del Monte Rigi in Svizzera nel 1871), anch’esso somigliante a una piccola scala a pioli e distinguibile dal Marsh essenzialmente per la sezione dei pioli, che è trapezoidale anziché cilindrica.
Ma la caratteristica tecnica più impressionante è l’inclinazione del tracciato, con una pendenza che arriva al vertiginoso valore del 37,7%: è stata la ferrovia ad aderenza artificiale più ripida del mondo fino al 1889, quando il primato le fu strappato dalla linea svizzera del Monte Pilatus (che ha una pendenza massima del 48% ed è dotata di cremagliera Locher a doppia ruota dentata orizzontale). E’ comunque a ancora oggi la seconda linea a cremagliera al mondo per pendenza e la prima fra quelle a ruota dentata verticale.
E' curiosa la storia della “Devil's shingle” (“Slitta del diavolo”) (figura 8), un marchingegno utilizzato agli inizi del Novecento dai lavoratori della compagnia per scendere individualmente lungo il binario a gran velocità sfruttando la forza di gravità. Questo consisteva in una tavola di legno lunga 90 cm e larga 25 cm, su cui sedeva a cavalcioni il malcapitato, sagomata in modo da scorrere longitudinalmente intorno al profilato della cremagliera centrale e dotata di maniglie laterali che, se tirate, fungevano da freno per attrito sul profilato metallico. Una tipica discesa durava 10 minuti, ma i lavoratori ingaggiarono una vera e propria competizione che portò il record a 2 minuti e 45 secondi! Dopo l'ennesimo incidente mortale però, la Compagnia proibì l'uso di questi infernali attrezzi nel 1907.
Nel normale esercizio, si ricorda un solo grave incidente avvenuto nel 1967, quando un deragliamento su uno scambio mal posizionato causò la morte di 8 passeggeri e il ferimento di altri 72.
Il parco rotabile circolante, tutto di produzione americana, è abbastanza eterogeneo. La prima locomotiva (figura 9), entrata in servizio già durante la fase di costruzione della linea e usata per il trasporto dei materiali, era dotata di una caldaia verticale che la faceva assomigliare a una bottiglietta di salsa piccante (di qui il nomignolo “Peppersass”) e disponeva di un’unica ruota dentata motrice collegata a due cilindri a vapore, montata sull’asse di valle in mezzo alle due normali ruote ferroviarie; le ruote dell’asse di monte erano folli e servivano solo a sostenere il peso del veicolo. Sulle altre locomotive entrate successivamente in servizio comparvero progressivamente varie innovazioni: il “freno atmosferico di sicurezza” (un dispositivo ad aria compressa di vitale importanza su pendenze così accentuate, che rendeva superfluo il ricorso alla frenatura a controvapore caratteristica delle macchine a vapore), la doppia ruota dentata motrice (che garantiva una trazione molto più potente con due doppi cilindri) e poi la caldaia orizzontale. Ogni motrice, sempre contraddistinta da un nome proprio, ha sempre potuto spingere un solo vagone passeggeri; per motivi di sicurezza, la locomotiva è sempre collocata a valle del convoglio, in modo da spingerlo in salita e trattenerlo in discesa (questa pratica si è poi sempre mantenuta sulle ferrovie di montagna fino ai nostri giorni). Quattro locomotive a vapore sono operative ancora oggi, tutte costruite in New Hampshire dalla Manchester Locomotive Works: la n. 2 “Ammonoosuc” (1875) (figura 10), la n. 3 “Agiocochook” (1883, proveniente dalla linea di Green Mountain), la n. 6 “Kancamagus” (1874) e la n. 9 “Waumbeck” (1908). Nel 1972 e nel 1983 furono costruite ex-novo dalle officine aziendali due macchine–replica a vapore, entrambe però ormai tolte dal servizio. La velocità di esercizio per i treni a vapore è di 4,5 km/ora in salita e 7,4 km/ora in discesa: i tempi ordinari di viaggio sono conseguentemente di 65 minuti in salita e di 40 minuti in discesa.
A partire dal 2008 è stata progressivamente ridotta la trazione a vapore allo scopo di ridurre i costi e ridurre i tempi di viaggio: attualmente ci si avvale in modo intensivo di sei locomotive diesel-elettriche fabbricate dalle officine aziendali e alimentate con una miscela di bio-diesel, obiettivamente assai brutte esteticamente, che effettuano la salita in 37 minuti (figura 11); la trazione a vapore è limitata a una o due coppie di corse ordinarie al giorno a seconda della stagione. Completano il parco rotabile otto vagoni passeggeri, tutti di tipo “replica” dall'aspetto antico e ca-paci ciascuno di portare fino 80 persone di cui 70 sedute.
L'orario di servizio, attivo da fine maggio a fine novembre, prevede sempre partenze ogni ora, con “plotoni” anche di tre convogli che si seguono a distanza ravvicinata. La debolezza della strut-tura in legno a graticcio che sostiene il binario spiega perchè, invece di costruire sei locomotori moderni che possono spingere un solo vagone e necessitano di due agenti per convoglio (il guidatore sul locomotore a valle e il frenatore sul vagone a monte), non si sia optato (come invece è avvenuto per la ferrovia di Pikes Peak in Colorado, l’altro famoso impianto a cremagliera americano) per la realizzazione di due nuovi grandi convogli articolati, ognuno dei quali avrebbe potuto caricare l'equivalente di 3 vagoni: l'economia di costruzione della linea si è trasformata in dispendio di costi di gestione!
La linea del Monte Washington è l’unico esempio di cremagliera esistente al mondo con il sistema Marsh, del quale si è avuta in passato una sola altra applicazione, sempre in America, sulla linea di Green Mountain (inaugurata nel 1883 e chiusa nel 1892). Tutte le altre ferrovie a crema-gliera costruite successivamente hanno adottato altri sistemi, via via più perfezionati, a cominciare dal Riggenbach e poi l’Abt, lo Strub e il Locher. Il fatto che dopo 150 anni la “Mount Washington Cog Railway” continui a funzionare con le stesse modalità, ne fa un vero e proprio Museo in movimento: auguriamoci che continui così ancora per molto tempo!
ELENCO IMMAGINI
fig. 1 - BROCHURE STORICA / Immagine da volantino d’epoca / Pubblicità della ferrovia del Monte Washington / Anni 1920.
fig. 2 – SYLVESTER MARSH / Fotografia d’epoca P.D.
fig. 3 - VERSO LA CIMA / Foto Stannate-Lic.CC.2.0 / Il binario sul tratto superiore della linea / 2009.
fig. 4 – ARRIVO IN CIMA / Foto DNoahg-Lic.CC4.0 / Convoglio formato dalla locomotiva a vapore “Agiocochook”e un vagone passeggeri “replica” in arrivo alla stazione di monte / 2017.
fig. 5– TRATTO DI RADDOPPIO CON SERBATOIO DELL’ACQUA/ Foto Roy Luck-Lic.CC2.0 / Un tratto intermedio di raddoppio del binario per l’incrocio dei treni, con serbatoio per la ricarica dell’acqua / 2018.
fig. 6 - THE “TRESTLE” / Cartolina d'epoca / Tipica immagine della ferrovia con la struttura portante a graticcio (“Trestle”) / Anni 1930.
fig. 7 - CREMAGLIERA MARSH / Foto Kremerbi-Lic.CC3.0 / Maquette con rotaia e ruota dentata Marsh esposta al Museo della Ferrovia del Monte Washington / 2012.
fig. 8 - LA “DEVIL'S SHINGLE” / Foto B.W.Kilburn-PD / La pratica della “Devil's shingle” (“Scandola del diavolo”) / Anni 1880.
fig. 9 - LOCOMOTIVA “PEPPERSASS” / Foto Dan Crow-Lic.CC3.0 / La “Peppersass”, prima locomotiva della linea del Monte Washington, esposta presso la stazione di valle / 2006.
fig. 10 - MANOVRA IN STAZIONE / Foto Gwernol-Lic.CC.3.0 / La locomotiva a vapore “Ammonoosuc” aggancia una vettura rimorchiata sul piazzale della stazione inferiore / 2006.
fig. 11 – CONVOGLIO A TRAZIONE DIESEL / Foto Fredlyfish4-Lic. CC.4.0 / Un convoglio spinto da un locomotore diesel moderno in prossimità della stazione superiore / 2010.

IL TRAM A MADRID: DALLA "TRACCIÓN DE SANGRE" AL "METRO LIGERO"
di Davide Fenoglio
Madrid, città che conta oltre 5.000.000 di abitanti nell’area metropolitana è servita da un’eccellente rete di metropolitana con 13 linee, 280 km di binari e 281 stazioni, oltre che da un sistema di treni locali – Cercanías – che penetrano in città, dove effettuano numerose fermate. I vecchi tram sono scomparsi all’inizio degli anni Settanta per poi ricomparire nel nuovo millennio sotto la veste di Metro Ligero.
Il servizio di trasporto pubblico nella capitale spagnola ha inizio nel 1871 con alcune linee di tram a trazione animale – Tracción de sangre – gestite da numerose compagnie private, generalmente a capitale straniero. Inizialmente il parco è composto da 24 tram e 120 muli impiegati a coppie. I veicoli dotati di una curiosa scaletta "avvolgente" con una disposizione dei posti che ricorda quella di una giardiniera hanno 38 posti, di cui 32 seduti. In alcuni punti prestabiliti, in genere in corrispondenza delle salite, i muli venivano cambiati e la coppia sostituita ritornava "fuori servizio" da sola al punto di partenza. Presto le giardiniere vennero trasformate in vetture chiuse a cause delle avverse condizioni atmosferiche.
Dal 1879 alcune linee iniziano ad utilizzare la "Tracción de vapor" soprattutto per le tratte più esterne alla città. I convogli, popolarmente conosciuti come "Tranvías de Fuego" erano composti da una piccola locomotiva a scartamento ridotto e un paio di vagoni passeggeri e merci.
La "Tracción electrica", invece arriverà a partire dal 1898 e darà notevole impulso all’espansione della rete: i passeggeri nei primi anni del secolo triplicheranno. I primi tram, chiamati Canarios per il colore giallo canarino sono costruiti in vari modelli, a secondo delle esigenze delle singole compagnie principalmente dalla Thompson-Houston e da Siemens e sono vetture ad assi e rimorchi della capienza massima di 30 persone.
Le vicende societarie fino agli anni Dieci vedono fusioni, incorporazione e nascita di nuove aziende, come la "Compañía Eléctrica Madrileña deTracción", a capitale tedesco, che gestisce una rete di 28 km a scartamento ridotto con piccoli tram rossi comunemente chiamati "Cangrejos" (granchi).
Il 17 ottobre 1919 alla presenza del Re Alfonso XIII viene inaugurata la prima linea di metropolitana.
In quegli anni la qualità del servizio peggiora costantemente, anche a causa di frequenti interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica ed i prezzi aumentano. Così, in seguito a violente proteste popolari, il 13 novembre 1920 le varie compagnie vengono nazionalizzate. Il servizio viene differenziato secondo tre segmenti di offerta: linee veloci "espresse" per la periferia con pochissime fermate, linee "intermedie con più fermate e linee "a gran capacità" per il centro storico. Nel 1923 arrivano 80 nuovi tram di produzione belga, le giardiniere vengono trasformate in rimorchi chiusi e la rete conosce uno dei periodi di massima espansione, anche in seguito ad una grossa crescita demografica della città. Nel 1924 compaiono anche i primi autobus Tilling Stevens di costruzione inglese con cui vengono attivate 5 linee, ma l’esperimento fallisce presto.
Nel 1935 viene acquistata dall’azienda di trasporti di Bruxelles, dove aveva circolato sperimentalmente, una "Peter Witt" milanese – forse la 1502 - che fu il primo tram a carrelli a circolare in Spagna. Numerata 1000 al termine della guerra ha ricevuto una terza porta posteriore, mentre quella anteriore è stata dimezzata. Negli ultimi anni ha circolato nel campus dell’Universidad Complutense dove è stata ribattezzata dagli studenti "El Abuelo", il nonno.
Terminata la Guerra Civile, si procede alla razionalizzazione della rete ed alla ricostruzione delle serie più recenti di tram ad assi. Dal 1943 tutti mezzi assumono la caratteristica colorazione blu-avorio. Intanto nel 1942 arriva in prova la prima PCC costruita a Torino da Fiat Materfer.
Negli anni successivi verranno consegnate 47 vetture di serie, mentre tra il 1951 ed il 1958 vengono costruite altre 110 motrici in Spagna. Le PCC, capienti, veloci e moderne apportarono un notevole miglioramento al servizio pubblico cittadino. Motrici analoghe saranno poi acquistate dall’ATM di Torino dove andranno a formare la serie 3100-3200.
In questo decennio si attua anche la completa municipalizzazione e la fusione con la compagnia dei bus e compaiono i primi filobus, destinati a scomparire dopo appena 20 anni.
Curiosamente solo nel 1948 si ha il passaggio alla circolazione veicolare a destra. Questa è l’occasione per apportare alcune modifiche alla rete tranviaria, che viene definitivamente eliminata dalle vie più strette del centro storico e dalla centrale "Puerta del Sol".
Negli anni Cinquanta la condizione della rete è ancora molto precaria, a tal punto che un deragliamento causa il più grave incidente della storia tranviaria madrilena. Un tram ad assi stracarico di passeggeri precipita dal Puente de Toledo finendo nel Manzanarre: 15 furono i morti e più di 100 i feriti.
Col trascorrere degli anni i tram sono sempre più insidiati dal traffico automobilistico e sostituiti dall’espansione della metropolitana, così dal 1972 vengono soppresse anche le ultime due linee sopravvissute agli anni Settanta.
Da allora e per più di trent’anni nessun tram ha più circolato per le strade della capitale spagnola.
Alcuni mezzi si sono conservati: il tram 477 del 1908 ed una PCC in corso di restauro da parte di un privato.
Tra il 2003 ed il 2007 è stata attuata la prima fase di espansione della rete di trasporto pubblico che ha dotato la città di 90 km di nuovi binari della metropolitana e di tre nuove linee tranviarie nell’agglomerato urbano, nonché della tranvia di Parla, cittadina situata all’estrema periferia meridionale.
Le 3 linee di Metro Ligero hanno uno sviluppo complessivo di 28 km e 36 fermate e hanno la particolarità di trovarsi in periferia. Le fermate sono molte distanziante e sono caratterizzate da lunghi tratti in sotterranea e priorità semaforica o attraversanti sopraelevati. Queste caratteristiche le rendono molto simili a metropolitane. Le linee madrilene sono state tutte inaugurate nell’estate del 2007 ed il servizio è espletato da moderni "Citadis" Alstom di colore rosso. La ML1 si sviluppa per 5,4 km alla periferia nord est della città e collega Las Tablas con Pinar de Chamartin. Le ML 2 e 3 formano il Metro Ligero Oeste, partono dalla fermata della linea 10 della metropolitana "Colonia Jardin" e dopo un breve tratto comune vanno a servire diversi comuni della periferia ovest e zone di recente urbanizzazione.
Oltre alla rete di Metro Ligero propriamente detta è presente un’altra piccola rete a Parla, comune di oltre 120.00 abitanti a sud ovest di Madrid. Entrata in servizio nel 2007 ha un percorso di 8,5 km circolare e collega il centro della cittadina con la stazione delle Cercanias. Il servizio è espletato da tram modello "Citadis" di colore verde.
Il tram storico 477
Il tram, a due assi, 477 fu messo in servizio nel 1908, pesa 10,90 tonnellate, è lungo 8,32 metri e largo 2,04. E’ dotato di due motori elettrici MTV 15 Charleroi con una potenza di 48 cavalli. La capienza è di 37 passeggeri, di cui 16 seduti.
Fu trasformato con nuovi frontali nel 1935 e ristrutturato nel 1943, ha prestato servizio fino al 1962. Nel 1971 è stato nuovamente ristrutturato per il centenario del trasporto pubblico.
Ha circolato per l’ultima volta il 31 maggio 1972, giorno di soppressione definitiva della rete tranviaria. Fu utilizzato per girare alcuni film, tra cui "Il Dottor Zhivago".
Nel 1991 è stato posto di fronte al Museo della Città, in occasione di una mostra. L’aspetto attuale risale ad un restauro del 1995 effettuato dalle Officine CAF. Attualmente è monumentalizzato a ricordo degli antichi tram della città nella stazione di Pinar De Chamartin, capolinea della linea 1 del Metro Ligero e punto di interscambio con la metropolitana.

UNA GITA A MARIAZELL
di Mario Positello
Nel panorama dei musei tranviari “fuori città” presenti in Europa, merita una puntata (oltre che una visita!), il museo dei Tramways di Mariazell (Museumstramway Mariazell - Erlaufsee), situato nella regione della Stiria, in piena Austria.
La cittadina di Mariazell (poco meno di 4000 abitanti) è nota per il celebre santuario, il più importante d’Austria, meta di numerosi turisti che vi ci giungono anche grazie alla Mariazellerbahn, la ferrovia a scartamento ridotto (760 mm), celebre per le sue storiche locomotive elettriche 1099, in servizio dal 1911 al 2013.
La storia del nostro museo tranviario inizia invece nel 1976, quando, dopo la soppressione della tranvia di St. Pölten, alcuni volontari, che già anni prima avevano iniziato a salvare alcuni tram e rotabili di ferrovie secondarie (le cosiddette “Lokalbahn”), iniziano la costruzione di una linea turistica/museale a scartamento di 1435 mm, recuperando rotaie, scambi, pali, sia da St. Pölten che anche da altre città austriache.
L’obiettivo è collegare la stazione di Mariazell con il lago di Erlaufsee, attraverso un inedito tracciato di circa 3 km, ma con rotabili e impianti d’epoca.
Un gran numero di tram viennesi, in buona parte restaurati, ma risultanti in esubero rispetto alle esigenze, vengono trasferiti a Mariazell così come alcuni rotabili di alcune “Lokalbahn” e ad alcuni tram preservati di St. Pölten e di Salisburgo.
Dopo alcune aperture a tratte, nel 1985 viene completato e inaugurato il percorso fino al lago di Erlaufsee.
Nel 2016, sfruttando in parte il tracciato meridionale dismesso della Mariazellerbahn, la linea tranviaria museale viene prolungata dalla stazione verso il centro città per un percorso totale di circa 4 km. Un ulteriore estensione di circa 500 metri è in progetto.

Solo la prima parte del percorso è elettrificato, tra l’altro utilizzando palificazione d’epoca.
Il servizio, attivo nei weekend, da giugno a ottobre, prevede quindi generalmente, l’impiego di un unico convoglio a vapore con due carrozze a due assi e un carro. I tram elettrici escono più raramente per qualche corsetta di rinforzo nel primo tratto e in occasione di eventi speciali. Sono poi conservati molti veicoli in attesa di restauro.
Dopo aver percorso 84 km su una spettacolare ferrovia a scartamento ridotto, si ha quindi, appena giunti al capolinea, la possibilità di visitare anche questa particolare tranvia museo, facendo di Mariazell una meta consigliatissima per una prossima gita!
Sito del museo: www.museumstramway.at
Foto Mario Positello: https://flic.kr/s/aHsmGbSfPb
IMMAGINI
Foto 1 - Rimessa principale del museo con un locomotore diesel Jung che manovra le carrozze della ex "Salzburger Lokalbahn".
Foto 2 - Motrice di servizio TU 6121 di Vienna in attesa di restauro
Foto 3 - Motrice tipo "K" di Vienna. In totale sono circa una quarantina le vetture della capitale conservate nel museo, oltre a svariati carri di servizio.
Foto 4 - "Triangolo" di inversione nei pressi del nuovo capolinea di Mariazell. Il convoglio ripreso è in regresso mentre inverte il senso di marcia. L'altro capolinea di Erlaufsee è invece ad anello.
Foto 5 - Interscambio alla stazione di Mariazell tra il treno della Mariazellerbahn che ha appena terminato il suo viaggio e il convoglio tranviario a vapore pronto a partire per Mariazell.
Foto 6 - Confronto tra il binario 750 mm della Mariazellerbahn e quello standard del museo del tram. La palificazione è stata recuperata dai vecchi impianti di St. Pölten e Vienna.

TRAM E PIOLE AL BORGH DEL FUM: STORIA TRANVIARIA DI VANCHIGLIETTA DAGLI ANNI '20 AI GIORNI NOSTRI
di Gianpiero Bottazzi
L'espressione "Borgh dël fum" si sta perdendo ma è sicuramente rimasta nei ricordi dei torinesi di una certa età. Si riferisce a Vanchiglietta (dal nome di una cascina della zona) cioè l'area compresa tra corso Tortona (fino a inizio '900 strada di Circonvallazione), il Po e la Dora Riparia. Il termine Vanchiglietta comincia ad essere utilizzato per indicare quel territorio dopo l'istituzione, nel 1853, della prima cinta daziaria che divideva il centro urbano dai borghi periferici. Un territorio che, in assenza di ponti, fino al 1928 era una vera penisola. Perché l'espressione "Borgh dël fum"? Per la fitta coltre di nebbia che copriva la zona, prodotta dagli impianti del gas, tra corso Regina Margherita e la Dora, e da molte ciminiere. Nei primi decenni del '900 sorgono infatti parecchie industrie e bòite, soprattutto ad opera di imprenditori provenienti dal biellese: in particolare lanifici, setifici, officine meccaniche, carrozzerie, fonderie e, in corso Tortona, gli stabilimenti Farina dove si costruivano auto di lusso. La presenza dei due fiumi contribuiva poi al ristagno del fumo.
La storia tranviaria di Vanchiglietta è strettamente legata a due linee. Il 5 che assume la denominazione di linea 15 a partire dal 1982, senza modificare sostanzialmente il percorso. E il 17 che, dal 1931 al 1966, consente agli abitanti del quartiere di raggiungere Porta Palazzo.
Il primo tram che raggiunge il "Borgh dël fum" è il 5, a partire dal 18 maggio 1924, quando viene inaugurato il nuovo tratto di linea da via Napione per via Fontanesi e corso Belgio, fino all'altezza di corso Chieti. Da quando la linea era stata istituita, nel 1901, da via Napione svoltava in corso Regina Margherita e arrivava alla barriera di Casale. All'estremo opposto, la linea raggiungeva Borgo San Paolo. Per quasi 60 anni, il 5 è il tram che ha accompagnato gli abitanti di Vanchiglietta nel centro cittadino e alla stazione di Porta Nuova. Proprio di fronte al nuovo capolinea del 5, all'inizio di corso Chieti, si trovava una delle tante piòle del borgo, quella di Molino con gioco delle bocce e biliardo. L'osteria con pergolato, che occupava l'area tra corso Belgio, corso Chieti e via Rosazza, veniva appunto abitualmente chiamata "Capolinea del 5".
L'arteria viabile principale era, e continua ad essere ancora oggi, corso Belgio che fino agli anni '20 si chiamava corso Graglia. Molte vie mantengono il nome dei paesi d'origine dei pionieri che sono emigrati dal biellese per aprire le bòite a Vanchiglietta: Andorno, Cossila, Mongrando, Oropa, Rosazza. Una curiosità: negli anni '20, in corso Belgio, fra corso Tortona e via Mongrando, c'era una casa non allineata con le altre, in mezzo alla strada, che costringeva il tram a fare una deviazione. Proprio a metà di corso Belgio, a due passi dalla Dora, al numero civico 91, in epoca fascista viene realizzato il circolo ricreativo dell'Azienda Tranvie Municipali, importante luogo di ritrovo non solo per i tranvieri ma anche per gli abitanti del quartiere. Dopo la chiusura per la guerra, riapre in occasione del 1° maggio 1949 con la partecipazione del direttore dell'Atm, ing. Fogliano. Per più di un decennio conosce un grande successo: vengono spesso organizzate feste per i pensionamenti dei tranvieri, pranzi per i matrimoni e balli al sabato e alla domenica con la partecipazione della Banda Atm.
Grande importanza per lo sviluppo di Vanchiglietta ha l'inaugurazione nel 1928 del ponte sul Po "Principe di Piemonte" (poi denominato di Sassi) all'altezza della confluenza della Dora, che toglie la zona dall'isolamento verso la zona di Sassi e la collina. Fino ad allora i collegamenti con la precollina erano garantiti da un traghetto sul Po, istituito nel 1882 all'altezza di Madonna del Pilone. Il nuovo ponte consente l'estensione della rete tranviaria lungo corso Belgio e fino alla stazione dell'allora funicolare Sassi-Superga in piazza Gustavo Modena.La tranvia extraurbana per Gassino viene fatta passare in corso Belgio e nel 1929 è istituita dalla Sbt-Stt la linea urbana 41 che collega Porta Palazzo a Sassi, mentre una linea barrata si ferma in largo Pasini. Il tram 41 ha però vita breve: nel 1930 l'Atm l'assorbe nella propria rete e l'anno successivo viene soppressa a seguito della modifica di percorso della linea 17.
Ex linea P della Belga, il 17 era nato nel 1924 per collegare la Barriera di Martinetto con quella di Casale. Dal gennaio 1931 inizia a servire Vanchiglietta e diventa una linea molto popolare in quanto passa da Porta Palazzo. Percorre infatti tutto corso Regina, poi svolta in corso Belgio e attraverso il ponte di Sassi raggiunge corso Casale e il capolinea di piazza Gustavo Modena. Sul 17 vengono impiegate le motrici più antiquate del parco, inizialmente le stesse motrici della gestione della Belga quando la linea era denominata P. Ancora negli anni Sessanta circolano le vetture della serie "600", motrici a due assi degli anni Trenta. In un articolo del 1950 sui tram di Torino si racconta questo aneddoto: due massaie sono in attesa del tram a Porta Palazzo e quando vedono una vettura in lontananza una chiede all'altra "E' il 22? La risposta è "No, l'è mach el des-set" (No è solo il diciassette). L'autore sottolinea come persino le massaie sono in grado di riconoscere in lontananza il 17 a causa delle vecchissime vetture che percorrono tale linea. Una curiosità a proposito delle motrici serie "600", che vennero accantonate a metà degli anni '60: la 605, per qualche tempo nella prima metà degli anni '70, è stata esposta nel cortile della scuola elementare "Alessandro Antonelli" di via Vezzolano, una parallela di corso Belgio.
Negli ultimi anni '50, una seconda linea tranviaria raggiunge Sassi percorrendo corso Belgio: si tratta del nuovo 5 barrato che viene istituito contestualmente alla soppressione della linea 23 (6 ottobre 1957). Ha il capolinea ovest in corso Trapani e si sovrappone in gran parte al 5 che mantiene il percorso Borgata Lesna - Vanchiglietta. Lo sdoppiamento del 5 dura solo tre anni: sulla planimetria della rete Atm 1960 non c'è infatti più traccia del 5 barrato. In quell'anno la linea 5 abbandona il capolinea di corso Chieti e viene prolungata a Sassi mantenendo il capolinea opposto a Borgata Lesna. Alla fine degli anni '50 entrano in servizio sulla linea le motrici serie 2800, più capienti, al posto delle 2500. Sono anni di forte espansione edilizia e di conseguente incremento della popolazione: viene gradualmente urbanizzato il territorio oltre piazza Toti, verso il ponte di Sassi, dove al posto di prati e cascine cominciano ad innalzarsi grandi caseggiati. All'angolo di corso Belgio con corso Cadore viene realizzato l'edificio della Motorizzazione Civile che da allora è diventato per decenni meta di tante generazioni di aspiranti autisti. Ora l'edificio non esiste più e al suo posto è stato costruito un condominio.
Anche la linea 17 fa le spese, nel 1966, della ristrutturazione della rete tranviaria e gli abitanti di Vanchiglietta si ritrovano privi del collegamento diretto, molto utilizzato, con il mercato di Porta Palazzo. Per raggiungere il cuore commerciale di Torino è necessario prendere due mezzi, il 5 fino all'incrocio di corso Belgio con corso Regina Margherita e poi il tram 2. Il comitato spontaneo di quartiere si fa portavoce del ripristino del tram 17 o, in alternativa, dell'istituzione di un 2 barrato che, da corso Regina svolti in corso Belgio anziché andare in collina come il 2. La richiesta viene infine accolta e il 20 maggio 1975 viene istituita la nuova linea 7 sul percorso della vecchia linea Sbt-Stt numero 41: capolinea sulla perimetrale di piazza della Repubblica, corso Regina, corso Belgio e capolinea in piazza Gustavo Modena. E' una linea breve, meno di 5 km, che resterà in funzione fino al 1982.
Nel 1977 viene realizzato il nuovo capolinea di Sassi in piazza Coriolano, alcune centinaia di metri più all'esterno rispetto a quello di piazza Modena. E' l'impianto tranviario ancora presente oggi con due binari per la fermata delle motrici: fino all'82 vi sostavano il 5 e il 7, poi con la soppressione di quest'ultimo solo più un binario è rimasto occupato stabilmente.
Con la rete '82 il tram 15 prende il posto del 5 coprendone quasi per intero il percorso da Sassi a via Monginevro. Cambiano solo il tratto terminale e il capolinea ovest che viene portato da via Fattori a via Brissogne (ex capolinea del 3). Nel 1987, a seguito dei lavori per la nuova linea 3 in corso Regina Margherita, il suo tracciato viene rettificato su via Napione, via Fontanesi e corso Belgio in direzione Sassi. Fino a metà anni '90 sul 15 viaggiano le motrici serie 3100, quindi subentrano quelle della serie 2800 e negli ultimi anni circa la metà delle corse sono effettuate con le vetture serie 5000, a pianale parzialmente ribassato.
Il vecchio capolinea del 5 di corso Chieti è stato utilizzato in occasione di limitazioni delle linee tranviarie per lavori o interruzioni provvisorie. L'ultima volta che i tram sono transitati sull'anello situato a metà di corso Belgio è stata nel giugno 2001 quando, per lavori in piazza Coriolano, il 15 è stato limitato per una decina di giorni. Da allora i binari sono rimasti inutilizzati per anni fino allo loro rimozione, nel maggio 2009, in occasione dei lavori di rifacimento dell'area del mercato di corso Chieti. Ma proprio negli stessi anni si realizza l'importante allacciamento della rete tranviaria con il piazzale dell'officina della tranvia Sassi-Superga. Da allora i tram storici custoditi nella rimessa di Sassi cominciano a viaggiare sui binari di corso Belgio per raggiungere il centro in occasione di giri speciali organizzati da ATTS.
IMMAGINI (Collezione Paolo Chiesa)
Foto 1: tram in corso Belgio negli anni 30
Foto 2: rotonda all'incrocio di corso Belgio con corso Tortona
Foto 3: corso Belgio e la Mole dal Ponte di Sassi
Foto 4: tram in corso Belgio di fronte alla Schiapparelli

UNA "TREMILA" CARIOCA: IL TRAM CAFÉ
di Luca Giannitti
Nel 2008 la città di Torino accolse una richiesta da parte della Prefeitura di Santos, Brasile, per ottenere due motrici tranviarie da integrare nella locale linea storica. Santos è il principale porto dell'america latina, a pochi kilometri dalla megalopoli di San Paolo, sede della prima storica borsa del caffé ma ovunque più nota per la principale squadra di calcio brasiliana, il Santos, dove giocò buona parte della sua carriera Pelé.
Le due motrici regalate furono un tram serie 3250, per la precisione la 3265 e uno serie 2800, la 2840. La scelta cadde su queste due vetture perché condividono tutte le componenti meccaniche (i carrelli sono gli stessi) e questo aspetto era importante in ottica manutentiva futura. Una serie di sponsor sovvenzionò l'intero trasferimento, iniziato nelle officine centrali GTT il 20 gennaio 2009 e proseguito a bordo di una nave porta containers partita da Livorno, la MSC Carolina, fino al 19 febbraio 2009, dove una festa ha accolto i tram torinesi nel porto commerciale di Santos. Tre giorni dopo la 3265 è esposta nella piazza Visconde de Maua, proprio di fronte all'edificio municipale di Santos. Di seguito una serie di immagini dal carico delle vetture in Torino fino alla presentazione in piazza a Santos.
Il primo restauro riporta la vettura nelle condizioni di poter circolare sulla linea turistica, viene riparato un carrello danneggiato durante il trasporto e viene rimessa in ordine la carrozzeria, riverniciando il tram in un bi-verde simile a Torino. Vengono adottate alcune misure indispensabili per poter circolare a Santos, come ad esempio il ripristino dell'asta e la modifica dello scartamento da 1445 mm (Torino) in 1350 mm (Santos). Viene anche installato un piccolo condizionatore per la cabina di guida, che comunque risulta essere totalmente aperta, di conseguenza la sua efficienza è bassissima tanto che si vede installato anche un piccolo (e curioso) ventilatore. Il 23 settembre 2010, in occasione dell'anniversario della linea storica, il tram di Torino viene presentato e inizia così servizio. Rispetto alla versione torinese il numero di posti a sedere è aumentato con una doppia fila di sedili. In basso alcune immagini del restauro, dell'inaugurazione e dell'impiego sulla linea turistica.
Quattro anni esatti dopo, il 23 settembre 2014, sempre in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della linea storica, si presenta il progetto di Bonde Café, in collaborazione con il locale museo del caffé. In portoghese europeo tram si dice "eléctrico" mentre in portoghese brasiliano il termine è "bonde", una delle tante parole che variano tra la lingua base e quella parlata nelle (ex) colonie. I lavori di modifica della vettura, interamente pagati dal museo del caffé per un equivalente investimento di 15.000 Euro, durano un paio di mesi durante i quali la parte interna viene totalmente smontata e completamente rinnovata. Si installa un potente condizionatore per l'intera vettura, l'illuminazione interna è totalmente modificata e al fondo i finestrini sulla piattaforma posteriore sono oscurati per dare spazio a una postazione bar con una macchina professionale e un frigo. Vengono aggiunti dei tavolini con fori dove incastrare i bicchierini di carta in cui viene servito il caffé ed esternamente la vettura è riverniciata in bianco per rendere ottimale la base su cui attaccare la speciale pellicola adesiva decorata. Viene anche installata una pedana per il sollevamento delle carrozzine in corrispondenza della seconda porta, in modo da dare completo accesso anche alle persone disabili. Qui sotto un bozzetto del progetto.

Nel gennaio 2015 la vettura è presentata al pubblico che si ritrova un tram dalla gradevole colorazione verde chiara uniforme su cui sono disegnati diversi motivi che richiamano al caffé e al museo. A Santos i tram storici vengono spesso decorati per alcuni periodi e i motivi cambiano nel tempo perché si da importanza alla storicità della vettura ma anche alla promozione del turismo locale. La 3265 non è da meno a questa tradizione, tanto che la pellicolatura viene ulteriormente cambiata nel 2017, quando il tram ritorna al suo bi-verde originale, con il mantenimento del marchio "Bonde Café". Il prezzo del viaggio (2019) è di 7 Reais, dura circa 25 minuti e inizia nella piazza Marquês de Monte Alegre, proprio di fronte al Museo di Pelé. Il servizio è effettuato nelle giornate di venerdì dalle 13.30 alle 16.30, sabato dalle 11.50 alle 16.50 e la domenica dalle 12.30 alle 16.30, sempre con partenze ogni 60 minuti.
In alto varie immagini della trasformazione della 3265 in "Bonde Café".

CREMAGLIERE E FUNICOLARI A LIONE
di Roberto Cambursano
La città di Lione (Lyon) è situata al centro della Francia alla confluenza del fiume Saône nel Rodano ed è il capoluogo della Regione Alvernia-Rodano-Alpi. Ha una popolazione di 523.000 abitanti, che salgono a 2.300.000 considerando anche i comuni dell’area metropolitana, piazzandosi al secondo posto per numero di abitanti fra le agglomerazioni francesi dopo Parigi. Dispone di una efficiente rete di trasporti pubblici a impianto fisso con una invidiabile varietà di sistemi: metropolitana, tram urbano, tram-treno, filobus e funicolare.
Il centro storico è collocato sulla riva destra della Saône e su parte della penisola compresa fra i due fiumi, alle pendici di zone collinari sulle quali la città si è progressivamente estesa. La conformazione del territorio ha fatto sì che il trasporto urbano in queste zone di Lione abbia dovuto ricorrere a sistemi funicolari e a cremagliera per superare le forti pendenze esistenti.
La storia dello sviluppo di questi collegamenti è caratterizzata da successive aperture e chiusure di impianti e di conversioni dal sistema funicolare al sistema a cremagliera e viceversa, ed è ancor più interessante perché è legata ad alcune particolarità uniche al mondo.
Oggi la città dispone di due funicolari e di una linea a cremagliera, tutte facenti parte integrante del sistema di trasporto urbano gestito dalla società TCL, e precisamente:
• La funicolare Saint Jean-Saint Just (linea F1);
• La funicolare Saint Jean-Fourvière (linea F2;
• La Linea C della metropolitana (a cremagliera), erede della funicolare Croix Paquet-Croix Rousse.
Sono esistite inoltre altre due linee:
• La funicolare Rue Terme-Croix Rousse: inaugurata nel 1862, fu la prima funicolare al mondo; era lunga 489 metri, con pendenza massima del 16%; fu chiusa nel 1967.
• La funicolare Saint Paul-Fourvière: rimase in esercizio dal 1900 al 1937; era lunga 514 metri, con pendenza massima del 24,3%.
Esaminiamo ora più in dettaglio la storia e le caratteristiche delle tre linee attualmente esistenti.
La linea Saint Jean-Saint Just ha una storia complicata: è nata come funicolare nel 1878, su un percorso che si sviluppa in buona parte in galleria e collega la città vecchia (stazione di Saint Jean attualmente servita dalla linea D della metropolitana, nonché capolinea comune con la funicolare della Fourvière) con il quartiere collinare di Saint Just. Il dislivello fra monte e valle è di 91 metri e la pendenza raggiunge un valore massimo del 18,3%; circa a metà percorso sorge l’unica stazione intermedia di Minimes. La prima funicolare era dotata di doppio binario a scartamento standard; il servizio cessò nell’anno 1900.
Nel 1901 il servizio riprese sotto forma di tranvia a cremagliera. La lunghezza della linea risultò leggermente aumentata (983 metri) e venne mantenuto il doppio binario ma con scartamento metrico, interamente attrezzato con cremagliera di tipo Abt a doppia lamella; l’alimentazione elettrica era in corrente continua alla tensione di 550 Volt. Il progetto originario, redatto dall’ azienda esercente (la FOL, o Compagnie Fourvière Ouest Lyonnais), prevedeva di congiungere questa tratta con la propria rete tranviaria a scartamento metrico già esistente che da Saint Just serviva alcune località a ovest di Lione, in modo da creare un collegamento diretto con la città bassa: furono così acquistati dei tram a carrelli ad aderenza naturale ma muniti di ruote dentate con funzione di frenatura, che sulla tratta a cremagliera avrebbero dovuto essere “aiutati” da appositi locomotori a cremagliera collocati a valle del convoglio. Le prove di messa in esercizio furono però così disastrose da indurre l’azienda a optare per una diversa soluzione, mantenendo la sezione a cremagliera come linea a sé stante e utilizzando i quattro locomotori acquistati in abbinamento a tre rimorchi ricavati dalla ristrutturazione dei tram precedenti. I locomotori, forniti dalla SLM con equipaggiamento elettrico BBC, erano a due assi ad aderenza mista e potevano raggiungere la velocità massima di 9 km/ora sul tratto a cremagliera spingendo una rimorchiata dalla capacità di 65 passeggeri. Completavano il parco rotabile tre curiose automotrici a pianale basso a 3 assi, anch’esse costruite dalla SLM (con un carrello motore e un asse fisso portante), originariamente concepite per caricarvi le vetture dei tram a cavalli che dovevano trasferirsi dalla città bassa a quella alta e successivamente utilizzate per il trasporto di merci ma anche di passeggeri in piedi. La cremagliera rimase in servizio fino al 1954.
Nel 1958 la linea fu rimessa in funzione come funicolare, ricostruita stavolta su un dislivello di 91 metri e dotata di binario unico a scartamento metrico su una lunghezza di 783 metri, con un incrocio intermedio alla stazione di Minimes; tra il 1985 e il 1988 avvenne una approfondita ristrutturazione, che vide anche l’entrata in servizio del materiale rotabile attuale, costituito da due vetture monocassa lunghe 10 metri forniti da Gangloff/Von Roll che possono procedere ad una velocità di 16 km/ora portando 70 passeggeri; a partire dal 2011 la linea è denominata F1.
La linea Saint Jean-Fourvière è l’unica a non aver mai mutato la propria natura di funicolare. Fu inaugurata nel 1900 per raggiungere il quartiere collinare di Fourvière, sede di una frequentata basilica, a partire dalla stazione di Saint Jean, già capolinea della funicolare di Saint Just. Il percorso si sviluppa quasi interamente in galleria su una lunghezza di 421 metri e senza fermate intermedie, con una pendenza massima del 31%. La prima funicolare aveva scartamento metrico con un binario unico e un incrocio intermedio. La funicolare di seconda generazione entrò in servizio nel 1970, con scartamento aumentato all’inusuale misura di 1330 mm. Il materiale rotabile, modernizzato nel 2018, è costituito da due convogli bidirezionali a due casse lunghi 23,4 metri forniti da Gangloff/Von Roll che possono procedere ad una velocità di 29 km/ora portando 216 passeggeri; a partire dal 2011 la linea è denominata F2.
La linea C della Metropolitana è l'unico caso al mondo di una ferrovia metropolitana dotata di cremagliera e ha anch’essa una storia alquanto complicata, iniziata nel 1891 allorchè fu inaugurata la funicolare Croix Paquet-Croix Rousse. Dotata di doppio binario a scartamento standard e costruita totalmente in galleria (salvo che in corrispondenza delle due estremità), questa era lunga 474 metri su una massima pendenza del 17, 6%; il servizio cessò nel 1972.
Dopo una completa ricostruzione, la linea riprese servizio nel 1974. L’esigenza di aumentare la capacità della linea su una pendenza elevata rese inevitabile il ricorso alla cremagliera (di tipo Strub), confermando il doppio binario con scartamento di 1435 mm; la linea fu elettrificata con alimentazione da linea aerea in corrente continua a 750 Volt. Nel 1978 fu attivato un primo prolungamento in galleria profonda, sempre a cremagliera, verso il centro della città da Croix Paquet all'Hotel de Ville, e la linea assunse la denominazione di Linea C. La stazione di capolinea inferiore funge da interscambio con la linea A della metropolitana lionese, entrata in funzione nello stesso anno. Dopo un secondo prolungamento di percorso sviluppato parzialmente in galleria verso la periferia da Croix Rousse a Cuire, attuato nel 1984 usufruendo di una tratta ferroviaria dismessa, la linea C raggiunse l’attuale lunghezza totale di 2435 metri, con cinque stazioni. La cremagliera è presente solo sul primo tratto di 936 metri fra Hotel de Ville e Croix Rousse, mentre oltre i treni procedono ad aderenza naturale. La linea C non è raccordata al resto della rete metropolitana e possiede un suo piccolo deposito/officina indipendente situato presso la stazione intermedia di Hénon. Il tempo di percorrenza totale è di nove minuti, mentre la frequenza del servizio varia da 3,5 minuti nell’ora di massima punta a 7,5 minuti nelle altre ore.
Nei primi anni di esercizio a cremagliera prestarono servizio tre elettromotrici bidirezionali a carrelli costruite dalla svizzera SLM con equipaggiamento elettrico BBC, ad aderenza mista e a cassa unica; erano lunghe 15,2 metri e larghe 2,65, con una capienza di 120 passeggeri, e adottavano la livrea storica lionese rossa con bande bianche. Dopo soli dieci anni di servizio (!), furono sostituite nel 1984 da cinque convogli bidirezionali ad aderenza mista forniti da Alstom/SLM di tipo MCL80, lunghi 36,6 metri e larghi 2,65, composti ciascuno da due elettromotrici accoppiate, con due carrelli motori ciascuna, in grado di trasportare 252 passeggeri in totale; inizialmente colorate in arancione, dopo una grande revisione terminata nel 2008 hanno assunto la livrea unificata della metropolitana di Lione, bianca con bande rosse e porte grigie. Per motivi tecnici, la velocità sul tratto a cremagliera è limitata a 21 e 17 km/h (rispettivamente in salita e in discesa), anche se la velocità massima raggiungibile sarebbe di 35 km/h; il passaggio dal tratto a cremagliera a quello ad aderenza naturale e viceversa si fa presso la stazione di Croix Rousse alla velocità di 7 km/ora, mentre la velocità massima sul tratto ad aderenza naturale è di 75 km/ora.
IMMAGINI
fig. 1 SCHEMA FUNICOLARI E CREMAGLIERE / Disegno Tibidibtibo-Lic.CC.3.0 / Mappa schematica di tutte le funicolari e cremagliere di Lione / 2014.
fig. 2 STAZIONE DI SAINT JEAN / Cartolina d'epoca / La vecchia stazione di Saint Jean: si riconoscono un convoglio della tranvia a cremagliera per Saint Just e uno della funicolare della Fouvrière / 1911.
fig. 3 MOTRICE MERCI A CREMAGLIERA / Disegno tratto da “Zahnradbahnen der Welt” di Walter Hefti-Birkhauser Verlag 1971 / Una motrice a cremagliera SLM per il trasporto merci impiegata sulla linea Saint Jean – Saint Just / 1926.
fig. 4 FUNICOLARE DI SAINT JUST / Foto Florian Fèvre-PD / La funicolare di Saint Just (linea F1) nel tratto inferiore presso la stazione di Saint Jean / 2008.
fig. 5 FUNICOLARE DELLA FOUVRIERE /Foto Moi-Lic.CC2.5 / La funicolare della Fouvrière (linea F2) in prossimità dell’ingresso nella stazione di Saint Jean / 2006.
fig. 6 LINEA C -VECCHIO VEICOLO / Foto Smiley. Toerist-Lic.CC3.0 / Una motrice a cremagliera SLM di vecchio tipo in servizio sulla linea C della metropolitana presso la stazione di Croix Paquet / 1982.
fig. 7 LINEA C NUOVI VEICOLI / Foto Matthieu Riegler-Lic.CC3.0 / Due convogli a cremagliera Alstom/SLM di nuovo tipo in servizio sulla linea C della metropolitana si incrociano alla stazione di Croix Paquet / 2012.
fig. 8 STAZIONE HOTEL DE VILLE / Foto Elliot Brown-Lic.CC2.0 / La stazione sotterranea di Hotel de Ville-Louis Pradel, capolinea della linea C della metropolitana / 2012

BONDE ARTE: IL RISTOTRAM IN CHIAVE BRASILIANA
di Luca Giannitti
Nell'estate 2008 una delegazione proveniente da Santos, Brasile, venne in visita a Torino per richiedere ufficialmente la cessione di due motrici tranviarie da integrare nella locale linea turistica. Santos è una delle prime città ad essere fondate in Brasile (anno 1546) e si trova a una trentina di kilometri a sud di San Paolo, conta poco più di 400.000 abitanti con un reddito medio superiore al resto del paese grazie alla presenza del principale porto mercantile dell'America Latina e alle attrazioni turistiche che rendono la città meta di molti visitatori.
In alto le operazioni di carico del tram in officina centrale Gtt nel gennaio 2009
I tram scelti per la donazione furono due vetture accantonate, un tram monocassa serie 3250 (3265) e uno articolato serie 2800, (2840). Per quanto diversi i due tram sono tra loro imparentati dato che la serie 3250 nacque nel 1959 riutilizzando i carrelli avanzati dall'accoppiamento dei tram serie 2100/2200 (divenute le articolate serie 2800) e acquistando dalla Fiat altre casse come quelle delle 3100. Questo aspetto è molto importante in chiave manutentiva ed è stato il motivo principale della scelta. Una serie di sponsor sovvenzionò l'intero trasferimento, iniziato nelle officine centrali GTT il 20 gennaio 2009 e proseguito a bordo di una nave porta containers partita da Livorno, la MSC Carolina, fino al 19 febbraio 2009, dove una festa ha accolto i tram torinesi nel porto commerciale di Santos.
La festa nel porto di Santos all'arrivo dei tram da Torino
Il progetto per la 2840 è quello di un tram ristorante, il primo dell'America e l'ispirazione venne presa proprio dal Ristocolor. Il restauro è stato effettuato da una equipe della CET, la locale azienda di trasporto (Companhia de Engenharia de Tráfego) con l'appoggio economico dell'ufficio dello sviluppo, del governo statale e del municipio, per un totale di 500.000 Reais pari a poco meno di 83.000 Euro.
L'inizio dei lavori è avvenuto all'inizio del dicembre 2015 e sono durati fino all'estate 2016. L'intervento di carrozzeria ha visto per prima cosa l'installazione di una pedana per sollevare le carrozzine nella terza porta e poi è proseguita sull'allestimento vero e proprio. Sul tram è stato posto un bagno nella parte posteriore mentre nella parte anteriore è stata allestita una cucina dotata di piano cottura, lavandino, due frigoriferi nautici e forno microonde. La sala invece ha quattro televisori a schermo piatto, aria condizionata, un impianto di videosorveglianza e 36 posti. Meccanicamente i due interventi più importanti hanno riguardato lo scartamento, che è stato ridotto dai 1445 mm di Torino ai 1350 mm di Santos, e la posizione dell'organo di presa di corrente, riportato ad asta ma in una curiosa posizione posteriore e non centrale come invece era a Torino. In realtà era più anomala la posizione centrale dell'asta torinese, in quanto per manovrarla occorrevano ben due corde, una per alzarla ed abbassarla, l'altra per spostarla verso destra o verso sinistra... in posizione posteriore invece è tutto molto più semplice.
Alcuni momenti del restauro e dell'allestimento della 2840
Esternamente la carrozzeria è stata colorata bianca con sottocassa grigio chiaro e tetto in grigio scuro. Sulle fiancate sono stati applicati degli adesivi richiamanti l'arte decorativa europea espressione degli anni '30, esattamente il periodo di costruzione della vettura. Su un lato troviamo quindi Piet Mondrian che si affaccia dal primo finestrino (bloccato) e osserva la sua "composizione in rosso, giallo e blu" mentre sull'altra fiancata troviamo un artista brasiliano, Hélio Oiticica, con la sua "Metaesquemas".
L'inaugurazione della vettura restaurata avvenne il 23 settembre 2016 in occasione del sedicesimo compleanno della linea turistica (aperta nel 2000). I primi viaggi costavano 15 Reais (2,50 Euro circa), praticamente il doppio rispetto al biglietto per una corsa sui tram storici di linea (7 Reais). E' anche possibile noleggiare l'intera vettura per 360 Reais (60 Euro) all'ora oppure 1000 Reais (165 Euro) forfettari per tre ore perché l'utilizzo immaginato non è soltanto quello di ristorante su rotaia ma anche sala per rappresentazioni teatrali, musicali, esposizioni di quadri e fotografie, feste, presentazioni di libri e altri eventi culturali ed artistici.
Il Bonde Arte in servizio per le strade di Santos
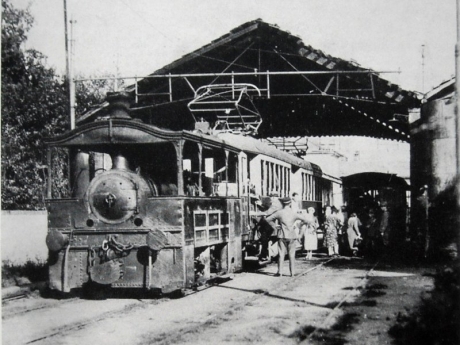
MACIAFER
di Michele Bordone
Maciafer: cosa potrà mai avere in comune questa parola piemontese ormai in disuso con i nostri beneamati tram? Proverò a svelare l’arcano.
Tanti anni fa, nel secolo scorso, quando ero ancora un bambino di pochi anni gli inverni erano veramente freddi, nevicava e poi ghiacciava e nell’immediato dopoguerra non si navigava certo nell’oro per cui per riscaldarsi si utilizzavano le stufe a legna ed a carbone (ma questo non era certo della migliore qualità) il quale dopo bruciato lasciava un residuo ferroso detto appunto in dialetto “maciafer”.
Abitando a Trana nei primi anni cinquanta esisteva ancora l’ultima tranvia intercomunale torinese (la Torino – Giaveno) di cui ho ancora dei bellissimi ricordi.
Uno di questi è legato proprio a questo residuato del carbone. Come accennavo gli inverni erano freddi ed una delle due fermate tranviarie di Trana, quella di San Bernardino era in salita. Le mogli premurose per evitare che i loro mariti scendendo dal tram al ritorno dal lavoro nelle buie serate invernali scivolassero sulla neve ghiacciata spargevano alla fermata il “maciafer” prodotto dalla stufa (si riciclava proprio tutto!). Inoltre era molto comodo anche per non scivolare quando si doveva aiutare il tram a ripartire spingendolo su per la salita (...e la tranvia elettrica si trasformava in tranvia a cristiani non essendoci più cavalli da una cinquantina d’anni circa).
Questa tranvia era molto importante per coloro che dovevano recarsi a lavorare a Torino dove esistevano le più importanti fabbriche prima che queste venissero decentrate nella cintura.
Tra i vari ricordi che mi passano davanti agli occhi vedo mio padre che attraversa il ponte sul Sangone tornando alla sera stanco dal lavoro dopo che il tram era ripartito verso Giaveno ; al mattino purtroppo non ho mai avuto modo di assistere alla sua partenza in quanto si alzava molto presto per arrivare in orario al lavoro: questo tram del resto non poteva certamente chiamarsi “Freccia della Val Sangone“ e per percorrere i 25 Km del percorso sino a Trana impiegava più di 2 ore.
Non penso nemmeno che avesse una grande frequenza in quanto ho persino un ricordo di mio nonno che correva dietro all'ultima corsa del tram per riuscire a salirvi sopra dopo essersi soffermato troppo a salutare i suoi amati nipotini e pur non essendo un grande atleta riuscì a prenderlo...
Una volta che ero a Torino dai miei nonni materni i quali abitavano vicino a Porta Nuova siamo andati ad aspettare mio padre alla fermata di Corso Unione Sovietica all'angolo di Corso Sommelier nel tratto a binario unico che condivideva con le linee 11 e 41 che transitavano in senso contrario. Molto bello era stare qualche giorno con i nonni, ma che gioia vedere mio padre che veniva giù per Via Filangieri a prendere il tram di casa.
Per concludere i ricordi legati al tram di Giaveno in questi anni per me spensierati, ci sono ancora due particolari.
Il primo è che la tratta cittadina della linea era condivisa oltre che con le citate linee ATM, anche con il servizio merci della Satti per conto (presumo) della Fiat, avendo due raccordi addirittura con le Ferrovie dello Stato: uno in Piazzale Caio Mario all'ultimo cancello di Corso Agnelli dove si infilava nello stabilimento immettendosi nel raccordo di Via Vigliani e l’altro in Corso Unione Sovietica all’altezza della trincea ferroviaria del raccordo Porta Susa – Lingotto dove peraltro stazionavano diversi mezzi tra cui dei locomotori assomiglianti alla T450 di Sassi. Questi raccordi con binari e scambi di tipo ferroviario sono esistiti sino agli anni settanta.
Il secondo è un ricordo di un particolare un pò stravagante di cui penso purtroppo nessuno conosca il vero motivo: mi passa nella memoria una vettura passeggeri che oltre al pantografo tipico delle vetture della Torino-Giaveno aveva anche il trolley dei tram ATM e ciò ha colpito il mio precoce interessamento appassionato dei tram.

SOPRA RIO IN CREMAGLIERA
di Roberto Cambursano
Rio de Janeiro è la seconda città del Brasile dopo San Paolo e conta 6.700.000 abitanti (13.300.000 nell’intera area metropolitana). E’ situata sulla riva occidentale della grande Baia di Guanabara ed è contornata da alture che sono le propaggini della lunga catena costiera che corre per 2600 km parallelamente all’Oceano Atlantico (con massima elevazione nel Pico da Bandeira a 2892 metri s.l.m.) e che costituisce la scarpata del vasto altopiano interno brasiliano.
All’interno dell’area metropolitana di Rio è contenuto il Parco Nazionale di Tijuca, che conserva quel che resta della foresta primigenia brasiliana e che include il Monte Corcovado (710 metri s.l.m). Sulla sua cima sorge l’imponente statua del Cristo Redentore, inaugurata nel 1931, raggiungibile da una tranvia a cremagliera. L’altra famosa altura di Rio è il Pan di Zucchero (394 metri s.l.m.), situata su una penisola a ridosso del mare e raggiungibile in funivia. Le colline sul lato settentrionale della baia di Guanabara ospitano località residenziali e di villeggiatura come Petropolis e Teresopolis che in passato erano collegate con tratti a cremagliera alla rete ferroviaria della zona.
Attualmente, Rio de Janeiro dispone di una rete di trasporti pubblici non particolarmente sviluppata ma molto varia: tre linee di metropolitana, nove linee di ferrovia suburbana, tre linee tranviarie moderne (inaugurate in occasione delle Olimpiadi del 2016), due linee storiche residuo della vecchia rete tranviaria (Bonde de Santa Teresa), tre funivie e una tranvia a cremagliera.
Oltre che della linea del Corcovado, che è la linea ad aderenza artificiale più famosa d’America ed è attualmente una delle più frequentate al mondo dai turisti, vogliamo qui parlare anche di altre due linee a cremagliera esistite nella zona, chiuse da sessant’anni e ormai dimenticate.
Iniziamo dalla tranvia del Corcovado.
Il primo tratto di 2730 metri, da Cosme Velho a Paineiras, fu inaugurato nel 1884, mentre la parte restante fu completata l’anno successivo. L’intero percorso è lungo 3824 metri ed è interamente attrezzato con cremagliera di tipo Riggenbach. La pendenza raggiunge un valore massimo del 30%, il che ne fa la linea a cremagliera Riggenbach più ripida del mondo (non considerando il caso particolare della ferrovia di servizio del Canale di Panama). Il binario, a scartamento metrico, è unico con tre tratti di raddoppio che consentono l’incrocio dei convogli in corrispondenza delle tre fermate intermedie: la seconda di esse, Silvestre (oggi chiusa al traffico), era un tempo il punto di interscambio con il tram che giungeva dalla città, il “Bonde de Santa Teresa”, che attualmente è limitato più a valle. Alla stazione di valle è collocato il deposito-officina, mentre la stazione di monte è posta a quota 670 metri s.l.m., appena 40 metri sotto la Statua del Cristo Redentore.
Nei primi anni la linea fu gestita con trazione a vapore: erano impiegate piccole locomotive a due assi fornite dalla ditta svizzera Werkstätte Olten e dalla statunitense Baldwin, che potevano spingere un vagone passeggeri raggiungendo una velocità di appena 6 km/ora sulla massima pendenza.
L’elettrificazione fu attuata nel 1910 con il sistema in corrente alternata trifase alla tensione di 750 Volt con frequenza di 50 Herz. La prima generazione elettrica era rappresentata da quattro motrici a due assi costruite in Svizzera dalla SLM di Winterthur con equipaggiamento elettrico MFO, simili a quelle già in servizio sulla Jungfraubahn ma con presa di corrente a doppio trolley, in grado di raggiungere una velocità massima di 10 km/ora spingendo due vagoni passeggeri; il primo vagone era in configurazione “Rowanwagen”, cioè poggiava da un lato su un carrello e dall’altro era solidale con la motrice.
Nel 1969 il servizio venne fermato per obsolescenza. Dopo lunghi lavori di ristrutturazione, che comportarono tra l’altro la trasformazione dell’alimentazione elettrica a 900 Volt e 60 Hertz sempre in trifase, nel 1979 venne immessa in servizio la seconda generazione di veicoli elettrici: quattro elettromotrici a carrelli fabbricate dalla SLM con equipaggiamento elettrico BBC, lunghe 12,2 metri e larghe 2,65 metri (a doppia cabina di guida con presa di corrente da due pantografi) e tre rimorchiate motorizzate-pilota di uguali dimensioni (a singola cabina dal lato monte e senza pantografo), accoppiabili a formare un convoglio con una capacità totale di 124 passeggeri. Potevano raggiungere una velocità massima di 15 km/ora in salita e 12 km/ora in discesa sulla massima pendenza.
Il materiale rotabile più recente è costituito da tre moderne elettromotrici articolate a due casse consegnate nel 2019 dalla ditta svizzera Stadler. Sono lunghe 26,7 metri a possono trasportare 154 passeggeri; la velocità massima è di 25 km/ora in salita e 18 km/ora in discesa; in discesa la frenatura a recupero consente un risparmio del 75% nei consumi elettrici.
La salita richiede 15 minuti; il servizio è attivo tutti i giorni dell’anno con una programmazione di base di una corsa ogni mezz’ora.
La ferrovia di Petropolis, inaugurata per fasi successive fra il 1883 e il 1900, fu una delle prime linee a cremagliera al mondo e la prima con cremagliera di tipo Riggenbach al di fuori dell’Europa. Fu voluta dall’imperatore Dom Pedro II per collegare la città residenziale di Petropolis (la “Città di Pietro”, sede della sua corte nei mesi estivi e posta a 840 metri di altitudine) in due diverse direzioni: a nord verso Tres Rios (nodo di interscambio con altre linee ferroviarie interne) e a sud verso Inhomirim, stazione di arrivo della ferrovia “Mauà” (che apparteneva alla compagnia privata “Leopoldina e fu la prima ferrovia del Brasile nel 1854). Il tratto da Inhomirim a Petropolis, a scartamento metrico, fu inaugurato nel 1883 e iniziava con una sezione di 5,9 km dotata di cremagliera che terminava in località Alto da Serra, al margine dell’altipiano. La pendenza, che arrivava a un massimo del 19%, veniva superata scomponendo il treno in coppie di vagoni che procedevano a vista a distanza ravvicinata nella stessa direzione, essendo ciascuna coppia spinta da una locomotiva a cremagliera integrale posizionata all'estremità di valle.
Il parco rotabile era variegato e composto da macchine a vapore a cremagliera integrale fornite da diverse ditte (Werkstätte Olten, Maschinenfabrik Esslingen, Baldwin ed SLM), la cui velocità non superava i 10 km/ora.
Tutta la linea Inhomirim-Petropolis-Tres Rios fu chiusa nel 1964. La stazione di Inhomirim è attualmente il capolinea di una ferrovia suburbana proveniente dal centro di Rio de Janeiro.
La ferrovia di Teresopolis, inaugurata nel 1908, ha una storia simile a quella di Petropolis: faceva parte della rete privata “Leopoldina” e collegava la città di Teresopolis (situata a 910 metri di altitudine) con Guapimirim, stazione di arrivo della ferrovia proveniente da Rio. Era a scartamento metrico e comprendeva una sezione lunga 4,4 km attrezzata con cremagliera di tipo Riggenbach su una pendenza massima del 18%, che veniva superata con lo stesso sistema di scomposizione del treno attuato per la linea di Petropolis.
Il parco rotabile era composto da locomotive a vapore a cremagliera integrale fornite dalla ditta tedesca Maschinenfabrik Esslingen, dalla statunitense Baldwin e dalla svizzera SLM.
La linea fu chiusa nel 1957. Anche la stazione di Guapimirim è oggi capolinea di una ferrovia suburbana proveniente dal centro di Rio de Janeiro.
IMMAGINI
fig. 1 SCHEMA FERROVIE RIO/ Elaborazione su base Openrailwaymap / Schema ferroviario della zona di Rio de Janeiro: i tre bollini rossi indicano la localizzazione delle tre cremagliere, le linee arancioni e beige le ferrovie attualmente gestite, le linee blu e azzurre le linee di metropolitana. / 2020.
fig. 2 TRAM MODERNO / Foto M. R. Duran Ortiz-Lic.CC4.0 / Un tram Alstom Citadis con sistema APS in servizio sulla linea 1 presso la fermata Cinelandia a Rio de Janeiro / 2016.
fig. 3 TRAM STORICO / Foto Andre Oliveira-Lic.CC2.0 / Un tram storico in servizio sulla rete “Bonde de Santa Teresa” a Rio de Janeiro / 2009.
fig. 4 CONVOGLIO A VAPORE CORCOVADO / Foto d’epoca da collezione Instituto Moreira Salles / Una locomotiva a vapore Baldwin spinge un vagone passeggeri sul ponte di Sylvestre verso il Corcovado / Anni 1890.
fig. 5 PRIMO CONVOGLIO ELETTRICO CORCOVADO / Immagine tratta da “Brill Magazine” / Convoglio formato da un locomotore SLM-MFO della prima generazione elettrica e da una rimorchiata in servizio sulla linea del Corcovado / 1912.
fig. 6 CONVOGLIO SLM CORCOVADO / Foto H. Pacheco de Oliveira / Convoglio di eletrromotrici SLM-BBC della seconda generazione elettrica in servizio sulla linea del Corcovado presso la fermata di Paineiras / 2013.
fig.7 NUOVO CONVOGLIO CORCOVADO / Immagine tratta da www.tremdocorcovado.rio. / Convoglio articolato Stadler di ultima generazione in servizio sulla linea del Corcovado / 2019.
fig. 8 CREMAGLIERA RIGGENBACH / Immagine tratta da www.tremdocorcovado.rio / La cremagliera di tipo Riggenbach della tranvia del Corcovado / 2019.
fig. 9 FERROVIA DI PETROPOLIS / Foto d’epoca da Collezione Allen Morrison / Un convoglio a vapore in servizio sulla ferrovia di Petropolis / Anni 1940.
fig. 10 FERROVIA DI TERESOPOLIS / Cartolina d’epoca / Un convoglio a vapore in servizio sulla ferrovia di Teresopolis / Anni 1940.
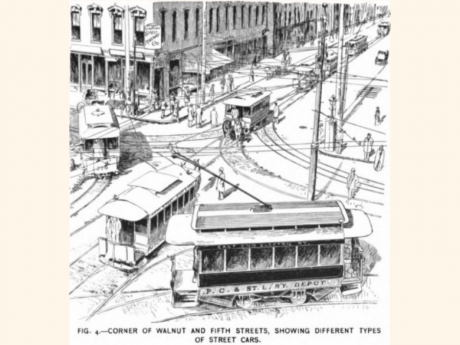
CAVALLI E TRAM A NEW YORK
di Roberto Cambursano
Fino al XIX Secolo il cavallo fu il mezzo di trazione per eccellenza nel campo dei trasporti terrestri e venne quindi massicciamente utilizzato nella prima fase storica di sviluppo del trasporto pubblico, prima dagli omnibus e poi dai tram.
Il tram, cioè un veicolo su rotaia trainato da cavalli e adibito al trasporto di persone, fu inventato in America e ha oggi quasi due secoli di vita: il primo tram della storia prese infatti servizio il 26 Novembre 1832 a New York, quando due carrozze a trazione animale cominciarono a percorrere regolarmente avanti e indietro il binario lungo un miglio che era appena stato posato lungo la Bowery Street, fra Prince Street e la 14^ Strada.
La città vera e propria era in quel tempo concentrata all’estremità meridionale dell’isola di Manhattan (che oggi costituisce uno dei cinque “boroughs” di New York, insieme a Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island) ed era contornata da sobborghi come Harlem (situato a nord sulla stessa isola). Proprio in quegli anni New York stava vivendo l’inizio della prima grande ondata migratoria proveniente dall’Europa, che portò la popolazione a crescere dai 200.000 abitanti nel 1830 agli oltre 800.000 del 1860.
La storia del primo tram è un tipico caso di “sogno americano”: un’idea venuta a un immigrato intraprendente che fece la sua fortuna.
John Stephenson, arrivato dall’Irlanda, aveva impiantato da qualche tempo una fabbrica di carrozze e gli affari gli andavano piuttosto bene, ma evidentemente non era persona che si accontentava facilmente: avendo intuito l’enorme potenzialità e i vantaggi di un sistema a impianto fisso rispetto a quello degli omnibus, pensò di copiare l’idea già sperimentata con le prime applicazioni ferroviarie europee e applicarla all’ambito urbano.
Ottenuta l’autorizzazione delle autorità e convinto il ricco banchiere locale John Mason a elargi-re un congruo finanziamento, realizzò dunque la prima “Street railway” del mondo. Quella inaugurata nel 1832 era la prima tratta della prima linea ferrata costruita in città, la “New York & Harlem Railroad”, destinata a collegare quella che allora era chiamata New York con il sobborgo di Harlem e progenitrice di tutte le future linee tranviarie e ferroviarie della stessa città.
A dire il vero, non fu un inizio accompagnato dai migliori auspici: proprio il giorno del viaggio inaugurale si verificò infatti quello che si può classificare come il primo incidente tranviario della storia, quando una vettura tamponò l'altra che la precedeva nella stessa direzione a causa di un maldestro uso del freno meccanico da parte del cocchiere, per fortuna senza danni alle persone.
Il primo tram di Stephenson pesava 2,5 tonnellate ed era ancora simile a una diligenza, con una cassa montata rigidamente su un truck a due assi; era trainato da una coppia di cavalli manovrata dal cocchiere seduto sul tetto “a cassetta” il quale, oltre alle briglie e al frustino, aveva in dotazione anche un rudimentale freno meccanico azionabile con una maniglia; il vano passeggeri aveva una capienza di 30 persone ed era diviso in tre compartimenti indipendenti, ognuno dei quali era dotato di lussuosi sedili di cuoio e di pedane per l'accesso dall'esterno su ambo i lati; un fattorino in continuo movimento aiutava i passeggeri a salire e a scendere, vendeva i biglietti alla tariffa unificata di 10 cent. e azionava, tirando una cordicella, un campanello per segnalare al conducente di fermarsi e di ripartire. Gli assi della vettura erano dotati di ruote metalliche munite ciascuna di un cerchione e di un bordino sul lato interno che permetteva al binario, anch’esso in metallo, di guidare il veicolo.
A partire dall'anno successivo, la linea venne gradualmente prolungata lungo la 4^ Avenue e nel 1834 arrivò all'altezza della 34^ Strada, per una lunghezza totale di 4 miglia, e l'intervallo dei passaggi venne portato a 15 minuti; questo prolungamento comprendeva un tratto sotterraneo di 500 metri, il “Murray hill tunnel”, che si può considerare la prima sottovia tranviaria della storia.
La “Street railway” ideata da Stephenson aveva però una criticità di fondo: lungo le vie cittadine le rotaie erano posate in rilievo sulla carreggiata stradale ed erano profilate a “L”, costituendo un serio problema per la circolazione e originando spesso degli incidenti a veicoli e pedoni. Questo fece entrare in crisi il sistema, che fu messo sotto accusa perché giudicato poco sicuro, tanto che a New York il servizio fu sospeso per qualche anno e in altre città ebbe ben poche altre applicazioni negli anni immediatamente seguenti.
Bisognò attendere quasi altri vent’anni per arrivare alla soluzione del problema: finalmente un imprenditore francese con interessi in America, Alphonse Loubat, ebbe la geniale idea di realiz-zare una rotaia scanalata, profilata “a gola”, antenata di quella che vediamo ancora oggi incassata nella massicciata. Fu utilizzata per la prima volta a New York nel 1852 su una nuova linea che correva lungo la 6^ Avenue (quindi parallela alla “New York & Harlem Railway”, che nel frattempo è già arrivata ben oltre Harlem) e fu la molla decisiva che fece scattare la fortuna del tram, che a partire dall’America si diffuse ben presto in tutto il mondo.
Dopo questa nuova introduzione, a New York il vecchio omnibus scomparve in tempi rapidissimi e fu soppiantato completamente dal tram che si diffuse in tutta l’area urbana, favorito (al contrario delle città europee) dalla configurazione regolare, larga e diritta delle strade e dall’assenza di restrizioni imposte dalle autorità locali. Con l’avvento del tram, le classi medio-alte furono progressivamente incentivate a traslocare nei nuovi quartieri residenziali esterni sempre più a nord, da dove potevano spostarsi giornalmente per raggiungere il distretto commerciale centrale; i ceti meno abbienti invece rimasero a vivere in centro (“Downtown” come si prese l’abitudine di dire qui, appunto perché il centro della città era situato nella parte “di sotto” di Manhattan), anche perché le tariffe del tram non erano alla loro portata.
Col passare del tempo, la tecnica costruttiva dei veicoli tranviari subì notevoli miglioramenti che portarono ad un certo livello di standardizzazione: vennero realizzate piattaforme aperte di movimentazione alle estremità, dotate di gradini per la salita e la discesa verso l'esterno e separate dal vano passeggeri centrale da una porta scorrevole; il vano centrale fu dotato di sedili e permise di accogliere i passeggeri anche in piedi in un ambiente protetto dalle intemperie; il conducente non stava più in alto all'addiaccio ma guidava in piedi sulla piattaforma anteriore dotata di tettoia (anche se non di parabrezza), con un “volantino” per il comando del freno meccanico, molto più agevole da manovrare rispetto alla primitiva leva. A New York, la nuova generazione di tram era composta da vetture lunghe 7-8 metri tirate da una coppia di cavalli, con una capienza di una trentina di passeggeri, bidirezionali e simmetriche longitudinalmente: al capolinea i cavalli venivano sganciati e riagganciati all'altra estremità e il tram poteva ripartire nella direzione opposta senza bisogno di anelli di binario.
Ma proprio all’apice dell’epoca d’oro della trazione animale, i limiti di questo sistema si fecero sempre più evidenti, non solo in termini di efficienza e di sicurezza di esercizio, ma anche di impatto ambientale: una situazione insostenibile specialmente nelle città più grandi e in continua crescita come New York. Cominciamo col dire che ogni singolo cavallo poteva lavorare solo per un periodo limitato di tempo (quattro–cinque ore e venti chilometri al giorno al massimo), aveva una vita lavorativa utile di soli quattro anni, doveva essere accudito e nutrito e produceva ingenti quantità di letame che l’azienda di trasporto era obbligata a smaltire e che non giovavano di certo al decoro e all’igiene cittadina: si stima che la popolazione equina totale di New York nel 1870 ammontasse a circa 150.000 cavalli, che producevano ogni giorno ben 5.000 tonnellate di letame! Per ogni veicolo tranviario erano necessari fino a undici cavalli (cinque coppie da impiegare in turni di servizio più uno di riserva). Inoltre, a differenza di un qualsiasi motore meccanico, un cavallo consumava anche a riposo (30 libbre al giorno di cereali) e poteva anche ammalarsi: proprio l’America lo imparò a sue spese nel 1872, quando infuriò una grande epidemia di influenza equina che causò una crisi senza precedenti. Come riportato dal New York Times nell’edizione del 30 ottobre 1872, i trasporti di merci e di persone nello stato di New York giunsero a un momento di completa sospensione provocando una grave carenza di beni di consumo. Il tasso di mortalità equina toccò il 10%: molti cavalli non riuscivano a reggersi in piedi e languivano nelle stalle, i meno sfortunati tossivano violentemente ed erano comunque troppo deboli per tirare pesi; la maggioranza di quelli che guarirono fu in grado di riprendere il servizio effettivo solamente nella primavera seguente del 1873. Le aziende furono costrette a reclutare manovalanza umana per tirare i carri a forza di braccia!
Sotto la spinta dei nuovi sistemi di trazione più efficienti che stavano iniziando ad affermarsi, l’era dei tram a cavalli cominciò a declinare nel 1883, quando furono introdotti a New York i “cable-cars” mossi da un sistema a vapore di funi sotterranee (come quelli che si possono vedere ancora oggi a San Francisco): questo sistema sopravvisse fino al 1909, quando fu soppiantato dai tram elettrici che sfruttavano per alimentarsi la cavità sotterranea già usata dai cable-cars (sistema “conduit”). Già nel 1890 erano però apparsi in città i primi tram elettrici con presa di corrente a trolley, (in America chiamati “Streetcars”) destinati a prendere il sopravvento nel secolo successivo.
Non dimentichiamo poi che New York fu la città che per prima introdusse una linea ferroviaria urbana sopraelevata nel 1867, mentre la metropolitana sotterranea arrivò nel 1904. Nel 1912 il numero delle automobili in città superò quello dei cavalli.
Con tutto ciò, il tram a cavalli riuscì a sopravvivere e a convivere con i sistemi più moderni ancora a lungo, vivendo un progressivo e lento declino che si concluse solo il 26 luglio 1917, con la chiusura dell’ultima linea superstite di Bleecker Street.
La ditta Stephenson & Co. di New York diventò la più importante fabbrica di veicoli su rotaia d'America e venne assorbita nel 1904 dalla Brill di Filadelfia, a sua volta destinata a diventare il più grande produttore di tram dell’”epoca d’oro” successiva e ad assorbire varie altre aziende.
IMMAGINI
fig. 1: IL PRIMO TRAM DELLA STORIA /Immagine tratta da "Wonders of the railways", di W.S. Kennedy, ed.Griggs & Co., Chicago 1884 /Il primo tram a cavalli della storia, impiegato sulla "New York and Harlem Railroad" /1832.
fig. 2: FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO /Francobollo da 20 cent. emesso dalle Poste USA, appartenente alla serie “American Streetcars”, raffigurante il primo tram di New York del 1832 /1983.
fig. 3: MAPPA PRIMA LINEA TRANVIARIA /Disegno d’epoca /Mappa della “New York and Harlem Railway” a Manhattan /1847.
fig. 4: ROTAIA LOUBAT /Disegno tratto da “Tramways, constructions et exploitation” di D. Kinnear Klark /La rotaia a gola brevettata dall’imprenditore francese Alphonse Loubat /1880.
fig. 5: TRAM A BROADWAY /Immagine da collezione Seashore Trolley Museum - Kennebunkport /Un tram a cavalli con guida “a cassetta”, costruito nei primi anni Sessanta dell’Ottocento per la linea di Broadway, impegnato in una corsa speciale a Manhattan /1897.
fig. 6: PUBBLICITA’ TRAM /Immagine tratta da “The Street Railway Journal” /Inserzione pubblicitaria raffigurante il primo e l’ultimo tipo di vetture tranviarie prodotte in 54 anni dalla ditta John Stephenson & Co. Ltd. /1886.
fig. 7: TRE TIPI DI TRAM /Immagine tratta da “The Street Railway Journal” /Traffico tranviario a New York con tre tipi di sistemi coesistenti: tram a cavalli, cable-car e tram elettrico a trolley /1893.
fig. 8: ULTIMO TRAM A CAVALLI /Foto Brown Brothers da Archivio New York Times /Lungo la Broadway a Manhattan l'ultimo tram a cavalli di New York incrocia un tram elettrico alimentato col sistema sotterraneo "conduit" /1917.
fig. 9: MURRAY HILL TUNNEL /Immagine tratta da www.wikimapia.org /Il Murray Hill Tunnel sotto Park Avenue a Manhattan al tempo in cui era percorso dai tram elettrici /Anni 1920.

LOS HABANEROS: i tram di La Habana, Cuba
di Marcela Luque
Il tram elettrico fece la sua prima corsa nel capoluogo cubano nel 1901: il 3 settembre per la precisione. Non fu però La Habana la prima città cubana ad avere un tram elettrico: lo fu invece Guanacoba dotandosi di un servizio analogo qualche mese prima.
A quel punto La Havana si scriveva già La Habana e la società Ferro Carril Urbano (FCU) aveva messo a disposizione alcuni servizi di tram a cavalli per il trasporto di passeggeri da e verso le stazioni ferroviarie. Verso la fine del secolo la FCU inizia ad accarezzare il progetto di elettrificare le proprie linee ed ottiene il permesso per poterlo fare nel 1897. Tuttavia il progetto non potè mai essere iniziato per via della guerra tra Cuba e Spagna.
A solo due giorni della firma del Trattato di Parigi che mise fine alla guerra, il 14 dicembre 1898 la FCU vendeva le sue 71 vetture, 6 locomotive, 637 cavalli, 182 muli e 64 chilometri di linea al U.S. Syndacate composto da diverse società di capitali di provenienza francese e canadese. Un anno dopo venne costituita a New Jersey la società Havana Electric Railway Co., che riuscirerà nei primi decenni del ‘900 non solo a controllare la rete tranviaria della città di La Habana ma anche la distribuzione di gas e di energia elettrica in tutto il capoluogo cubano.
La Havana Electric Railway Co. (HER), inizia le opere per l’elettrificazione della linea nel 1900 che fino al 1913 avrebbe contato su un’unica centrale elettrica, quella all’angolo delle vie Aguila e Colòn ormai scomparsa e in pieno centro della città.
Il trattato dell’intera rete approvato dalla amministrazione militare americana nel 1901 raggiungeva i 75 km e lo scartamento era di 1435 mm.
Il 4 di aprile 1901 la HER fece un’ordine di 110 vetture tranviarie alla Jackson & Sharp Co. in Wilmington, Delaware, Stati Uniti. E’ tutt’ora considerata uno degli ordini iniziali più grandi della storia.
Peculiarità dei tram habaneri
Sia Guanacoba che La Habana scelsero il sistema ad asta doppia ritenendolo quello più sicuro visto il clima cubano: pioggie torrenziali alternate con lunghi periodi di siccità rendevano pericoloso il passaggio della corrente elettrica in vicinanza del pavimento percià la scelta fu di tenere la corrente il più lontano possibile del pavimento. La Habana e Guanacoba furono tra le poche città al mondo ad utilizzare il sistema bifilare e la popolazione locale diede ai veicoli di queste due città il simpatico nome di “langostas” (cavallette).
Nei pressi della via San Pedro che scorre lungo il porto, vi era una sezione di circa otto isolati molto congestionata per via dei carri e dei cavalli che trasportavano delle merci al porto. Per evitare che il tram fosse vittima di tale congestione l’amministrazione locale decise di costruire una struttura sopraelevata, simile ad un cavalcavia a mano unica. Così nacque El Elevado, il nome che prendeva questa linea che nella sezione vicina al porto percorreva unicamente verso nord e si fermava in una stazione sopraelevata. Questa struttura fu inaugurata nel 1904 e rimossa verso la fine degli anni ’40.
Durante i primi tempi dopo l’elettrificazione vi erano alla città di La Habana tram di prima e di seconda classe.
Nel 1906 la HER inizia ad acquistare dei truck McGuire e dei motori da General Electric per costruire le proprie nove vetture nelle officine El Carmelo di cui la prima fu messa in servizio quello stesso anno. La HER era della convinzione che le vetture costruite in Cuba fossero meno costose da produrre e la qualità del legno era superiore a quello estero. Sembra che il legno cubano soportasse meglio le condizioni climatiche di quelli americani importati a Cuba. Tuttavia sia le piattaforme che i motori continuavano ad essere importati dagli USA. Queste classiche vetture chiamate “los habaneros” avevano circa 10 m di lunghezza per 2.5 metri di larghezza ed erano per lo più a due assi. La capacità era di 38 passeggeri .
Un curioso sistema di comunicazione fu sviluppato sin dai primi tempi del tram elettrico così che il bigliettaio, sostante nella piattaforma posteriore per dove si doveva salire potesse liberamente comunicare direttamente con il manovratore. Il suono di un campanellino era utilizzato per richiedere la fermata. Con due campanellini il manovratore poteva fare partire il tram e nel caso sentisse tre campanelline sapeva di dover fermare il veicolo immediatamente per gravi motivi. Se invece le campanelline erano quattro indicavano al manovratore di non fermarsi più perchè il tram era già al completo.
Il colore dell’uniforme durante le prime decade del’900 non fu nè grigio, nè blu: era invece bianco! I postini ed i rappresentanti delle forze dell’ordine viaggiavano in modo gratuito purché sostassero nella piattaforma anteriore. Questa agevolazione però era valida solo se fossero in servizio, cosa che era attestata dall’utilizzo della loro uniforme.
L’ultima corsa del giorno partiva del capolinea alle 10:30 e suonavano le campanelline in continuazione per indicare che era proprio l’ultima corsa di quella giornata. Furono chiamati “el tranvia de los novios” (il tram dei fidanzati) in quanto era quello che prendavano i giovani per tornare a casa dopo aver fatto visita alle proprie ragazze.
Nel 1907 la HER vantava 587 impiegati di cui 231 cubani e 351 spagnoli. Il 92% dei dipendenti avevano tra i 20 e i 44 anni ed il 98% sapeva leggere e scrivere pur non contando con nessun tipo di qualifica professionale o accademica. Tuttavia vi erano solo 24 lavoratori di colore, cioè il 4% del totale. Non vi fu un manovratore di colore se non fino alla fine degli anni ’40, fino a quel momento solo il bigliettaio poteva essere cubano purchè fosse bianco mentre il posto di manovratore era riservato esclusivamente agli spagnoli.
Il biglietto consentiva all’utenza di spostarsi da una linea tram all’altra senza per questo dover pagare di nuovo. Nei tram di La Habana si saliva dalla parte dietro, ma col passare degli anni gli utenti persero questa sana abitudine e altrettanto fece il personale tranviario perciò nei tram di La Habana si saliva e si scendeva sia dalla porta dietro che da quella davanti.
Nella piattaforma si potevano trasportare valigie e mobili oppure dei cesti pieni di frutta e verdura che i raccoglitori dell’epoca erano costretti a trasportare tutti i giorni. L’unica regola in vigore era che le dimensione del bagaglio non interrompesse la salita o la discesa dei passeggeri. Per oggi 25 kg. di merce trasportata il proprietario pagava 25 centesimi di dollaro. Un’altra curiosità: da mezzanotte alle 4 di mattina era anche possibile trasportare la spazzatura.
Vi furono più di 30 linee tranviarie a La Havana identificate sia con lettere che con numeri. Le lettere avevano una corrispondeza con il luogo dove iniziava la corsa. Ad esempio la linea V partiva da Vedado, quella C dal Cerro e la S da Santo Suarez. Per agevolare la popolazione analfabeta, di elevato numero all’epoca, fu dato un colore ad ogni linea di modo che non fosse necessario saper leggere per identificare il tram giusto da prendere.
La Habana Electric Railway
Sin dalla sua nascita la HER potè contare sul compromesso del governo americano di commissariamento in Cuba; questo avrebbe bloccato qualsiasi altro progetto tendente a controllare le tranvie di La Habana. Durante la sua esistenza quindi la HER ebbe il pieno monopolio delle line tranviarie a La Habana.
Per fare fronte all’intero progetto di elettrificazion la HER contrabbe diversi debbiti. Il primo fu contratto nel 1899, nei confronti della United Nations Mortgage & Trust Company per 5 milioni di dollari. Un anno dopo vi fu un’altro di un milione di dollari, questa volta nei confronti della Morton Trust Company. Infine nel 1902 la HER si indebbitò per ben 10 milioni di dollari, debito contratto con la Central Trust Company di New York .
Nel 1906 vi era quindi un importante divario tra ingressi della società e l’aumento dei costi di esercizio per via di una politica di investimento sin troppo ambiziosa. Circa un anno dopo la situazione era diventata angosciante. Così la HER dovette fare fronte ad un netto cambiamento organizzativo dando inizio all’era Steinhart (tra il 1907 ed il 1012) che riuscì a rovesciare la situazione della HER riportando la competititività al sistema tranviario habanero.
Frank M. Steinhart era tedesco, naturalizzato cubano e molto vicino all’ amministrazione americana in Cuba. Era contrario al fatto che cubani e spagnoli avessero in loro possesso azioni della HER perciò approfittando la crisi di liquidità della società e la conseguente perdita di valore delle azioni fu lui a comprare un importante pacchetto azionario nel 1907 grazie a un prestito di diverse realtà tra cui l’Archivescovado della città di New York.
Nel 1911, dopo la fusione con la Compañia de Gas y Electricidad de La Habana la HER riuscì non solo a controllare i trasporti a La Habana ma anche le utilities. A questo periodo corrispondono i 372 veicoli acquistati nel 1913 alla Brill.
Nel 1921 la HER contava con 495 veicoli tranviari e in quello stesso anno fu costruito il suo primo tram chiuso con tetto ad arco e 9 finestrini laterali anzichè 8: era la vettura numero 502. Da quel momento in poi tutti i veicoli furono costruiti sotto questo design.
Nel 1928 la EBASCO prende a suo carico la gestione di gas ed elettricità e la HER torna esclusivamente alla gestione tranviaria. Ai tempi della Depressione vi erano 578 vetture che percorrevano 244 km di rotaie nella città di La Habana.
Nel 1949 la HER si dichiara in bancarrotta e viene acquisita dalla società Autobuses Modernos S.A. nel junio 1950 il cui presidente era il figlio di Frank Steinhart. Ormai la situazione locale cubana si stava consolidando.
L’ultima corsa e poi... la barbarie
L’ultimo tram a circolare nei quartieri di La Habana fu il 388 partendo dal capolinea Principe alle 23:22 del lunedì 28 aprile e ritornandoci alle ore 12:08 del martedì 29. Era l’anno 1952.
Il tram arrivò alla stazione tra i pianti di bigliettaio e quelli del manovratore che dovettero pure assistere ai gesti di barbarie successivi: le parti metalliche furono bruttalmente rimosse e la cassa fu demolita a colpi di mazza schiacciando la vettrura dal tetto fino a spezzare le colonne. I sedili, come anche i ruderi del veicolo 388 furono utilizzati per la pavimentazione nei quartieri di Miramar, Carmelo e Vedado.
Ormai il tram era un mezzo non solo superata ma anche odiato in quanto non offriva le prestazioni dei primi anni del ‘900. Decenni di mancati investimenti si tradussero in una rete tranviaria scadente, vetture rumorose e vetuste che si guastavano fermando il traffico cittadino; linee elettriche che cadevano in continuazione paralizzando per ore la circolazione nell’intera città. Persa quindi la fiducia le utenze decisero di migrare le proprie preferenze verso il ben consolidato autobus che diversamente dai colorati predecessori erano dipinti di bianco e per questo furono chiamati “le infermiere”.
Alcune delle vetture della città di La Habana sfuggirono la triste fine della 388 e furono cedute alle aziende tranviarie di Matanzas dove prestarono servizio per altri due anni. Altre invece rimasero abbandonate in balia all’intemperie e successivamente furono utilizzate come “merenderos” cioè bar e caffetterìe nella spiaggia di Mariana e vi furono persino alcune riconvertitie in alloggi.
Immagini
Foto 1 – Biglietto di tram di La Habana che invitava i passeggeri a risparmiare tempo prendendo il primo tram che arrivasse per poi prendere la concidenza in una delle fermate successive.
Foto 2 e 3: Vista di El Elevado fra il 1904 ed il 1906. La struttura fu smantellata nel 1940.
Foto 4: Alcuni marinai in visita alla città di La Habana nel 1908.
Foto 5: Questo biglietto riproduce le vetture costruite nelle Officine El Carmelo con tetto ad arco e 9 finestrini laterali i legittimi “habaneros”.
Foto 6: I gettoni della HER durante primi tempi del tram elettrico.
Foto 7: il servizio tranviario di La Habana che aveva trasportato ben 140 milioni di passeggeri nel 1929 ne trasportava invece 69 milioni nel 1935. Vista di un deposito tranviario della linea Cerro nel 1939.
Foto 8: Due tram attraversano il ponte della Calle 9 di fronte agli uffici della HER nel 1949. Qualche anno dopo le rotaie furono rimosse del ponte per lasciare il passo agli autobus e agli automobili.
Foto 9: l’abbandono nel quale furono lasciate le vetture tranviarie prima di diventare merenderos o abitazioni.
Foto 10: Frank Steinhart, dirigente della HER dal 1907. La sua gestione fu caraterizzata dal rigore finanziario, dal supporto finanziario della Banca Speyer e dei suoi rapporti di vicinanza con il governo il che fece possibile il notevole sviluppo della rete tranviaria metropolitana.
Foto 11: Frank Steinhart Jr, sotto la sua direzione iniziata nel 1938 la HER inizia a languire soffocata dai debiti fino a scomparire a inizio 1950.
Foto 12: uno degli “habaneros” , le vetture costruite a La Habana nelle officine Carmelo. Il motore era General Electric ed i truck McGuire A-1.

ANTENATI DEL TRAM, CON O SENZA ROTAIE
di Roberto Cambursano
Secondo la definizione corrente, il tram è un mezzo di trasporto leggero (normalmente di persone, ma anche di merci) a guida vincolata su rotaia, soggetto alle interferenze della circolazione stradale, con marcia regolata dal guidatore “a vista”. Il primo tram vero e proprio, adibito al trasporto pubblico di persone, comparve in America nel 1832 e perciò questo mezzo ha oggi ufficialmente quasi due secoli di vita, ma i suoi antenati con o senza rotaie circolavano già molto tempo prima.
L’origine della parola “tram” è legata al binario ed è antica, essendo stata usata infatti fin dal XVIII Secolo per indicare il sistema di trasporto di materiali su rotaia all’interno delle miniere inglesi. Il termine è l’abbreviazione della parola inglese “tramway”, a sua volta composta dai termini “tram” (parola arcaica di origine nord-germanica-scandinava) e “way” (= strada). Secondo l’interpretazione più accreditata, il significato originale della parola “tram” è “oggetto di legno”, quindi indica le traversine di legno che sostengono le rotaie di ferro: è curioso notare come nel caso del treno, che pure usa la stessa via di corsa del tram, sia stato adottato il termine inverso, e cioè “rail-way” ovvero “via su rotaia”. Esiste anche un’altra interpretazione etimologica, che trova ancora un certo seguito nonostante sia stata ufficialmente sconfessata da autorevoli fonti dell’Università di Oxford. Nel libro “La vita di George Stephenson” di Samuel Smiles, pubblicato nel 1857, l’autore sostiene infatti che il termine “tram” deriva dal cognome dell’imprenditore inglese Benjamin Outram, il quale nel 1793 aveva impiantato una breve linea extraurbana su rotaia e con trazione a cavalli per il trasporto del carbone fra Derby e Little Eaton: da qui, questo tipo di impianto sarebbe diventato noto come “Outram-way” e successivamente abbreviato in “tram-way”.
Dunque, il primo antenato del tram su rotaia non fu un mezzo di trasporto di passeggeri, bensì di merci. E’ interessante notare che lo sviluppo generale delle ferrovie fu reso possibile proprio dall’invenzione dell’impianto fisso (il binario) e del sistema anti-deragliamento (il bordino delle ruote): questa architettura di sistema rimasta è sostanzialmente la stessa, dalle antiche miniere inglesi fino ai nostri giorni.
Se invece ci riferiamo a un sistema organizzato di trasporto pubblico urbano di persone, occorre andare un po’ più indietro nel tempo e precisamente in Francia a Parigi, capitale della più popolosa nazione europea all’epoca del Re Sole, una città in cui lo sviluppo urbano aveva già dato avvio a quelle problematiche del traffico che oggi ben conosciamo. Fu l’illustre filosofo e matematico Blaise Pascal ad avere per primo l’idea rivoluzionaria: affiancare al tradizionale e caotico sistema di trasporto individuale basato sulle carrozze private e su quelle da noleggio un nuovo sistema di trasporto collettivo organizzato a priori con percorsi fissi, intervalli regolari dei passaggi, e tariffa unificata. Pascal si calò dunque nei panni dell’imprenditore e progettò una rete di cinque linee (quattro radiali e una circolare), servite da carrozze con 8 posti a sedere trainate da cavalli e condotte da cocchieri in uniforme; le fermate fisse non erano previste, ma le carrozze potevano fermarsi ovunque a semplice richiesta; l’effettuazione delle corse programmate era garantita indipendentemente dal numero di passeggeri e quindi anche in caso di carico nullo. Ottenute le necessarie autorizzazioni reali, Pascal fece appena in tempo a vedere avviato l'esperimento il 18 marzo 1662, morendo a Parigi cinque mesi dopo. Proprio a causa della tariffa unificata, questi primi veicoli di trasporto pubblico urbano furono soprannominati “Carrosses à 5 sols”. Ma l'organizzazione sociale della Francia di allora non era pronta per una iniziativa così innovativa: infatti, mentre il servizio era di fatto inaccessibile alle classi sociali più povere che non potevano permettersi di pagare quella tariffa, le classi sociali più abbienti continuavano a usare le loro lussuose carrozze private e non gradivano l’idea di condividere le strade con i mezzi pubblici. Una azione di “lobby” dei cocchieri delle carrozze da noleggio e dei proprietari delle carrozze private portò l’amministrazione locale ad approvare delle restrizioni di accesso al servizio a determinate categorie di persone (ad esempio ai soldati), causando un calo di utenza che rese l’impresa economi-camente insostenibile e costrinse il servizio a chiudere definitivamente nel 1677.
Il concetto fu ripreso solo un secolo e mezzo più tardi, con la comparsa degli Omnibus nelle città. Il termine ha una origine curiosa e fu usato per la prima volta a Nantes nel 1825, dove Stanislas Baudry, un ex colonnello dell’esercito francese che aveva aperto una lavanderia a vapore nel quartiere periferico di Richebourg, impiantò una prima linea regolare. Tutto nacque dall’idea di usare l’acqua calda prodotta dalla lavanderia per alimentare una piscina termale pubblica: per convogliarvi i clienti provenienti dal centro cittadino, pensò di organizzare un servizio di trasporto con un grosso carrozzone da 16 posti marciante sul normale selciato stradale che seguiva un percorso fisso con orari prestabiliti. Ma anziché attrarre clienti per il suo bagno termale, si rese conto che il servizio era in pratica utilizzato dai nantesi semplicemente per spostarsi da una parte all’altra della città: Baudry finì per chiudere la sua attività termale e, a partire da quella prima linea, costituì nel 1826 una impresa di trasporto pubblico e impiantò una rete di omnibus al servizio di tutta la città di Nantes. Vale la pena di raccontare la storia dell’origine del termine "omnibus", che proviene da un gioco di parole contenuto in un’insegna di un negozio di cappelli che era situato al capolinea centrale: il proprietario, che si chiamava Omnes, aveva fatto scrivere il motto "OMNES OMNIBUS" (letteralmente “Omnes per tutti”), da cui i passeggeri presero l’abitudine di dire che “prendevano l’omnibus”.
L’eco del successo ottenuto a Nantes giunse in breve tempo nelle altre città francesi, che anch’esse misero in funzione nuove linee di omnibus, iniziando da Parigi nel 1828 con 12 linee messe in opera dallo stesso Baudry. A cominciare dalla Gran Bretagna (la prima linea di omnibus circolò a Londra nel 1829), il sistema si diffuse contemporaneamente anche in altre città europee e poi al resto del mondo facendo registrare un buon successo di utenza nelle città più grandi che stavano vivendo una fase di espansione senza precedenti legata alla rivoluzione industriale. Furono impiegate in servizio svariate tipologie di veicoli, dalla piccola carrozza tirata da un solo cavallo fino alle pesanti carrozze a due piani che necessitavano anche di quattro animali.
L’omnibus fu impiegato anche sul trasporto interurbano, come evoluzione della vecchia diligenza. In questo campo, nella prima metà dell’Ottocento fu sperimentata la trazione a vapore originando il cosiddetto “pirobus”: questo effimero veicolo circolò in particolare in Gran Bretagna ma fu presto soppiantato dai tram o dai treni a vapore.
In una fase successiva, in Europa furono anche realizzati dei curiosi veicoli “ibridi”, una via di mezzo tra omnibus e tram, dotati di una o due ruotine addizionali retrattili con bordino che all’occorrenza fungevano da guida del veicolo andando a infilarsi nella gola di apposite rotaie. Fra i pochi casi esistiti citiamo: Salford presso Manchester in Inghilterra (il “Perambulator system” con una rotaia centrale introdotto da John Greenwood nel 1861), Ginevra in Svizzera, Amburgo e Berlino in Germania, Copenaghen in Danimarca.
L’Omnibus era però nato già vecchio, perché in quegli stessi anni si era già cominciato a capire che la soluzione ideale su cui puntare per organizzare al meglio il trasporto pubblico di persone era la rotaia. Infatti, la grande resistenza al rotolamento della ruota dell’omnibus sul fondo stradale offriva un basso rendimento energetico e allo stesso tempo uno scarso confort ai passeggeri, provocava una grande rumorosità di marcia e limitava fortemente la velocità di esercizio. Come conseguenza della scarsa efficienza del sistema, le tariffe praticate sulle linee di omnibus erano alquanto elevate e ciò ne limitava l’uso essenzialmente agli spostamenti occasionali e di svago.
Tutti questi difetti furono eliminati contemporaneamente dal più evoluto sistema “Tramway”, che abbinava ruote e rotaie entrambe metalliche.
In alcuni casi, i tram della prima generazione altro non erano che vecchie carrozze di omnibus con le ruote riadattate, che con opportuni accorgimenti potevano ancora essere impiegati al bisogno al di fuori dei binari. E’ emblematico il caso di Parigi, dove i tram a cavalli coesistettero con gli omnibus per tutta la seconda metà dell’Ottocento e le prime vetture furono di tipo “deragliabile”: solo le ruote di destra avevano il bordino, mentre quelle di sinistra erano piatte; l’asse anteriore era sterzante ed era normalmente immobilizzato per mezzo di una leva che poteva essere sbloccata dal cocchiere, permettendo con un piccolo sforzo laterale del cavallo di far uscire la vettura dal binario e di sorpassare ad esempio a sinistra un altro tram fermo o di incrociarne un altro che procedeva sullo stesso binario in senso opposto. Poiché sullo stesso binario transitavano tram di diverse compagnie private fra loro in concorrenza, il “sorpasso con deragliamento” diventò ad-dirittura di uso comune, allo scopo di caricare un maggior numero di passeggeri alle fermate seguenti!
Nel corso dell’Ottocento si assistette dunque alla inesorabile e progressiva affermazione del trasporto su rotaia, anche se tram e omnibus coesistettero per qualche tempo, spesso in una stessa città. A differenza dell’omnibus però, il tram diventò finalmente “la carrozza di tutti”: le sue tariffe più economiche resero il trasporto pubblico fruibile da estese categorie di persone, che cominciarono a usarlo regolarmente per gli spostamenti casa-lavoro.
Gli ultimi pochi omnibus sopravvissuti sparirono definitivamente dalla circolazione nei primi anni del XX secolo.
IMMAGINI
fig. 1: TRAM MINERARIO / Disegno d’epoca / Un primitivo mezzo di trasporto su rotaia in una miniera inglese / Secolo XVII.
fig. 2: LE “CARROSSES A CINQ SOLS” / Disegno da collezione RATP Parigi / Una carrozza in servizio pubblico di linea a Parigi / 1662.
fig. 3: RETE DELLE “CARROSSES A CINQ SOLS” / Disegno Chumwa-Lic.CC2.5 / Mappa del-la rete delle cinque linee di “Carrosses à cinq sols” operante a Parigi nel 1662.
fig. 4: FIGURINO DI OMNIBUS A PARIGI /Disegno tratto da “Revista de Teatros” Madrid /Uno dei primi omnibus in servizio a Parigi / 1843.
fig. 5: OMNIBUS A PARIGI / Quadro di Giovanni Boldrini da collezione Rizzoli Milano / Om-nibus in Place Pigalle a Parigi / 1882.
fig. 6: OMNIBUS A LONDRA / Foto Colin Smith-Lic.CC2.1 / Un omnibus della linea Brixton-Clapham esposto presso il Museo dei Trasporti di Londra / Anni 1850.
fig. 7: OMNIBUS A DRESDA / disegno tratto da “Deutsches Pferdebahnmuseum Döbeln, ed. in proprio, Döbeln 2009 / Un omnibus di piccolo formato in servizio a Dresda / Anni 1850.
fig. 8: OMNIBUS A NEW YORK / immagine da archivio “The New York Times” / Un omnibus in servizio sulla 5th Avenue a Manhattan / Anni 1850.
fig. 9: OMNIBUS A GENOVA / immagine da www.sanpierdarena.net / Un omnibus in servizio a Genova / 1873.

LA REALTA' DI FILADELFIA
di Giovanni Zampa
La città che ho visitato meglio nel mio viaggio negli Stati Uniti è Filadelfia, in Pennsylvania, circa a metà strada tra New York e Washington e sesta città degli USA con circa 1,5 milioni di abitanti. Per servire l'area metropolitana di 6 milioni di abitanti che si estende anche nel vicino New Jersey è dotata di:
- 2 linee di metropolitana pesante,
- 1 linea di metropolitana pesante che esce dallo stato,
- 5 linee di "Subway-Surface Trolley", cioè tram che in centro città entrano in galleria,
- 1 linea gestita con vetture storiche PCC in servizio normale cittadino,
- 2 linee "Suburban Trolley", tram interurbani,
- 1 "High Speed Line", una linea con caratteristiche intermedie tra tramvia e ferrovia,
- 3 linee di filobus,
- 121 linee di bus.
- 13 linee ferroviarie.
Tutto, tranne la metropolitana interstatale, è gestito dalla SEPTA.
Mi permetto di aggiungere una interessante linea di tram-treno diesel che si trova nel confinante stato del New Jersey dall'altra parte del fiume che costituisce la frontiera. (segnata con linea marrone)
Ho passato una giornata intera, 08/08/2014, su alcune linee di quelle elencate usando solo mezzi a trazione elettrica, dalle due linee di metropolitana ai filobus ai vari tram per concludere su un treno sempre elettrico.
Rimanendo nel campo delle linee tramviarie, bisogna premettere una loro caratteristica particolare, lo scartamento noto come "Pennsylvania trolley gauge" di 1,581 mm utilizzato, oltre che qui, solo a Pittsburgh e New Orleans.
La più interessante è la linea 15, di quasi 17 km e sul percorso della prima linea di tram a cavalli del 1859 e poi prima ad essere elettrificata nel 1895. Dal 2005, dopo una serie di lavori di ammodernamento dell'infrastruttura, è gestita interamente con vetture PCC aggiornate (foto 1) ad esempio con aria condizionata ed elevatore per carrozzine.
Tecnicamente sono curiosi il posto di guida con i comandi a pedale (foto 2) e la presa di corrente con l'asta ma con in punta il pattino tipico dei filobus e non la rotella tramviaria.
Su questa linea una parte delle fermate è attrezzata con marciapiedi rialzati protetti da ringhiere, mentre altre non hanno la minima protezione e la salita/discesa viene fatta direttamente in mezzo alla strada.
Una vettura di questo tipo è anche esposta nel piccolo museo nel seminterrato della sede della SEPTA che si trova nella strada principale, Market Street, al curioso numero 1234. Sotto questa strada passa la galleria di una metropolitana che nella foto transita dietro alla vetrata di destra (foto 3).
In città ci sono poi altre 5 linee "Subway-Surface Trolley Lines" per totali 64 km, che in centro corrono in un tunnel parallelo a quello di una linea della metropolitana, mentre ad ovest escono in superficie e poi divergono. Se la galleria non è agibile, ci sono dei binari all'aperto che permettono l'inversione e la continuazione del servizio. Quando sono andato io, ovviamente, non ho potuto percorrere il tratto interrato a causa di una qualche interruzione. Le linee sono servite da vetture monodirezionali ad una cassa di costruzione Kawasaki. (foto 4).
Prima di uscire dalla città, ancora una curiosità. In una via del centro dove rimane l'impianto tramviario che però non viene più utilizzato, ecco uno scambio semplificato che comunque ho visto anche in altri punti: ha un solo ago. (foto 5)
Ad ovest della città si trova un centro importante di interscambio, il "69th Street Transportation Center", dove, oltre a varie linee di autobus, si trovano il capolinea della linea metropolitana, quello delle linee tramviarie interurbane 101 e 102 e della 100, "la Norristown High Speed Line".
Sulle linee 101 e 102, per circa 22 km in totale, sono in servizio vetture Kawasaki molto simili a quelle urbane, anche se bidirezionali, con presa di corrente a pantografo e accoppiabili. (foto 6). Il servizio è organizzato con corse di due tipi: alcune fermano in tutte le fermate mentre altre sono di tipo espresso.
La linea 100, di quasi 22 km e anch'essa con corse di due tipi, ha caratteristiche particolari che la rendono un ibrido tra ferrovia e tramvia interurbana. L'ingresso ai capilinea è fatto da marciapiedi con i tornelli mentre nelle fermate intermedie è controllata dal personale di guida che apre solo la porta anteriore. Esistono anche le fermate con il pulsante a terra per segnalare la richiesta di arresto (foto 7).
I treni sono formati da elettromotrici bidirezionali, accoppiabili, alimentate a 3a rotaia e a scartamento normale (foto 8).
Nello stato oltre il fiume Delaware, il New Jersey, si trova la città di Camden di circa 80.000 abitanti che è un sobborgo di Filadelfia. Da qui parte la "River Line" di 55 km a binario unico che è un tram-treno gestito con le automotrici GTW 2/6 diesel della Stadler, con il caratteristico modulo di trazione (foto 9). La coesistenza tra convogli tramviari e merci è realizzata con "divisione di tempo" in quanto i merci viaggiano di notte (foto 10).
Per concludere, una immagine non tramviaria: porte di uscita da una stazione della metropolitana: difficile entrare dall'uscita e passare in più di una persona!
mappa: linee di TPL su ferro facenti capo a Filadelfia.
foto1: vettura PCC della linea 15.
foto2: posto di guida della PCC.
foto3: vettura PCC esposta nella sede della SEPTA.
foto4: vettura tramviaria urbana.
foto5: scambio ad un solo ago.
foto6: vetture interurbane in attesa di entrare in servizio al 69th Street Transportation Center. A destra un convoglio della metropolitana sull'anello di ritorno.
foto7: pulsante di chiamata per la fermata del convoglio in arrivo sulla linea 100.
foto8: elettromotrice della linea 100.
foto9: automotrice GTW 2/6 della River Line nel tratto sud, lungo una strada di Camden.
foto10: treno merci pronto su un binario a fianco i quello del tram.
foto11: porte di uscita da una stazione della metropolitana.

CREMAGLIERE... NELL’ATLANTICO!
di Roberto Cambursano
Come si è già visto in un altro articolo (“Cremagliere in Costa Azzurra”), le alte montagne non sono gli unici luoghi in cui si possono trovare ferrovie a cremagliera. Ma cosa ne direste se vi dicessi che anche in mezzo all’Oceano Atlantico sono esistiti impianti di questo tipo? Questo nuovo articolo vuole ricordare, in ordine cronologico di apertura, quattro linee ormai dimenticate che facevano servizio su altrettante isole.
Iniziamo con la piccola isola di Mount Desert, appartenente agli Stati Uniti d’America e situata nell'Oceano Atlantico in prossimità della costa dello stato del Maine, un centinaio di km a sud della frontiera canadese. La sua superficie di 280 kmq è oggi in gran parte occupata dal Parco Nazionale Acadia; la massima elevazione di 466 metri si trova in corrispondenza del Monte Cadillac (un tempo chiamato Green Mountain).
Proprio la vetta di questa montagna era raggiunta dall’effimera ferrovia a cremagliera di Green Mountain, inaugurata nel 1883. Fu questa la seconda realizzazione di Sylvester Marsh, l’inventore e imprenditore americano che aveva progettato la vicina ferrovia a cremagliera del Monte Washington, inaugurata nel 1869 e tuttora in funzione. Le caratteristiche tecniche erano simili a quelle della prima e più famosa linea: binario con scartamento di 1411 mm, cremagliera integrale di tipo “Marsh”, pendenza massima del 30%, lunghezza 3,7 km. La trazione era affidata a due locomotive a vapore americane fornite dalla Manchester Locomotive Works, che dopo la chiusura della linea furono acquisite dalla ferrovia del Monte Washington. La linea fu chiusa nel 1892, dopo appena nove anni di servizio, per insufficienza di traffico.
Sempre sul lato americano dell’Atlantico si trova la grande isola di Hispaniola (76.422 kmq), divisa amministrativamente nei due stati di Haiti a ovest (capitale Port au Prince) e Repubblica Dominicana a est (capitale Santo Domingo). L’isola è’ attraversata dalla Cordillera Central, che culmina nel Pico Duarte a metri 3098 s.l.m. e che separa la costa atlantica settentrionale da quella caraibica meridionale.
La ferrovia Puerto Plata-Santiago de los Caballeros era la prima tratta del “Ferrocarril Central Dominicano”, destinato ad attraversare tutta l’isola di Hispaniola da nord a sud arrivando fino alla città di Santo Domingo. La tratta inaugurata nel 1891 (e rimasta l’unica realizzata) aveva scartamento di 762 mm ed era lunga 36 km; includeva due sezioni armate con cremagliera di tipo Abt con una lunghezza addizionata di 6,4 km su una massima pendenza del 9%. Il parco rotabile comprendeva sei locomotive a vapore a tre assi ad aderenza mista fabbricate in parte dalla ditta francese Cail e in parte da quella statunitense Baldwin, che potevano raggiungere una velocità massima di 10 km/ora sulle tratte a cremagliera e di 20 km/ora sulle tratte ad aderenza naturale. La chiusura avvenne a metà degli anni Cinquanta, sotto la dittatura di Trujillo, quando l’esempio degli USA favorì la sostituzione degli impianti su ferro con servizi di autobus.
Dall’altro lato dell’Oceano Atlantico troviamo l’isola vulcanica di Madera, situata a circa 1000 km di distanza dal continente europeo in direzione sud-ovest. Il suo nome in portoghese significa “legno” e fu chiamata così perché ricoperta di boschi. E’ prevalentemente montuosa e ha una superficie di 740 kmq; appartiene al Portogallo da oltre seicento anni assieme ad alcune vicine isole minori e all’arcipelago atlantico delle Azzorre. Il porto di Funchal (112.000 abitanti) è il capoluogo, mentre il Pico Ruivo (1861 metri s.l.m.) è il punto di massima elevazione.
Qui esisteva il “Caminho de ferro do Monte”, una ferrovia a cremagliera realizzata allo scopo di collegare il centro della città di Funchal con il suo quartiere turistico collinare di Monte. Il primo tronco di 1 km fu inaugurato nel 1893 e fu seguito da un secondo tronco l’anno successivo, mentre l’intera linea venne completata nel 1912, raggiungendo la località di Terreiro da Luta situata alla quota di 850 metri s.l.m. La linea era lunga 3.9 km ed era interamente equipaggiata con cremagliera di tipo Riggenbach su una massima pendenza del 24,4%. Il binario aveva scartamento metrico ed era unico, con due tratti intermedi di raddoppio per gli incroci dei convogli. Erano in servizio cinque locomotive a vapore di due tipi: quattro a due assi costruite dalla ditta tedesca Maschinenfabrik Esslingen e una a tre assi fornita dalla ditta svizzera SLM, che potevano spingere ciascuna un vagone passeggeri rispettivamente alla velocità di 8 e di 12 km/ora sulla massima pendenza. Completavano il parco rotabile cinque vetture rimorchiate a due assi dalla capacità di 60 passeggeri e un piccolo carro merci. La crisi del turismo causata dalla Seconda Guerra Mondiale, sopraggiunta dopo un paio di gravi incidenti verificatisi negli anni precedenti, portò alla chiusura del servizio nel 1939 e allo smantellamento della linea nel 1943.
Concludiamo con l’isola africana di Bioko (un tempo chiamata Fernando Poo), situata nel Golfo di Guinea: è un'isola vulcanica di 2017 kmq, lunga 70 km e prevalentemente montuosa (massima elevazione è il Pico Basile, 3012 m). E' situata a 40 km dalla costa del Camerun e, assieme a una zona continentale situata più a sud lungo la costa atlantica africana (ex Rio Muni), costituisce lo stato della Guinea Equatoriale (ex Guinea Spagnola, indipendente dal 1968). Nell'isola è situata la capitale Malabo (già Santa Isabel).
La ferrovia a cremagliera di Fernando Poo fu inaugurata nel 1913: il suo capoluogo Santa Isabel fu stazione di testa di una linea ferroviaria a scartamento ultra-ridotto (60 cm) che la collegava al paese di Banapa. Doveva essere questo il primo tronco del “Ferrocarril economico”, una rete ferroviaria con trazione a vapore adibita essenzialmente al trasporto di legname e di prodotti agricoli, che avrebbe dovuto estendersi su tutta l'isola: rimase invece l'unica realizzazione, non superando la lunghezza di 17 km. In un solo breve tratto di 322 metri (detto “La salita delle febbri”) doveva affrontare una pendenza dell'8,2% ed era perciò armata con cremagliera Abt. Le due locomotive in dotazione, costruite dalla ditta francese Cail, potevano raggiungere la velocità massima di 10 km/h sul tratto a cremagliera e di 20 km/h sui tratti ad aderenza naturale. La linea fu chiusa nel 1930 a causa dei risultati economici negativi di gestione.
IMMAGINI
fig. 1 - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI /Elaborazione grafica da www.openstreetmap.org / Localizzazione delle quattro isole dotate di impianti a cremagliera: 1=Mount Desert; 2=Hispaniola; 3=Madera; 4=Bioko.
fig. 2 - GREEN MOUNTAIN COG RAILWAY /Frontespizio del libro di Peter Dow Bachelder /La locomotiva a cremagliera “Mount Desert” impiegata sulla linea di Green Mountain / 2005.
fig. 3 - FERROVIA PUERTO PLATA-SANTIAGO / Foto Pinterest / La tratta a cremagliera della ferrovia Puerto Plata-Santiago de los Caballeros / 1920.
fig. 4 - PANORAMA SU FUNCHAL /Foto Autore ignoto /Veduta panoramica verso il mare e Funchal dalla linea del “Caminho de ferro do Monte” / 1900.
fig. 5 – STAZIONE DI MONTE A MADERA / Foto autore sconosciuto / Il capolinea superiore del “Caminho de ferro do Monte” / Anni 1900.
fig. 6 – CREMAGLIERA DI MADERA / Foto autore sconosciuto / Un convoglio del “Caminho de ferro do Monte” lungo il percorso / Anni 1930.
fig. 7 – FERROVIA DI FERNANDO POO / Immagine tratta da: www.spanishrailway.com / Un convoglio del “Ferrocarril Economico de Fernando Poo” presso la stazione di Santa Isabel nell’ultimo periodo di esercizio / 1930.

PETER WITT E LA SUBLIME PORTA
di Marcela F. Luque
Inutile sarebbe provare a tracciare la storia tranviaria senza soffermarsi sulla figura di Peter Witt, l’assessore ai trasporti del Comune di Cleveland che sconvolse il flusso dei passeggeri all’interno delle vetture.
Detto questo di Peter Witt se ne parla ben poco. Forse perché il suo contributo poco ebbe a che fare con carrelli, funi, aste o motori. Difatti Peter Witt non era né ingegnere meccanico né ferroviario. Non era affatto ingegnere: non possedeva la laurea e non ebbe opportunità di arrivare nemmeno a prendere il diploma. E quindi di tram, il nostro Witt ben poco ne sapeva. Era invece un appassionato del genere umano e dell’idea di rendere la vita più semplice per le persone.
La documentazione presentata da Witt all’ufficio Brevetti nel 1914 è basata su l’esistenza di una tipologia di vettura con due porte: una anteriore d’ingresso e una centrale di uscita a fianco della quale era prevista la postazione del bigliettaio. La parte anteriore –a panche longitudinali- era destinata ai passeggeri che dovessero effetturare tragitti brevi. Mentre la parte posteriore della vettura rimaneva per l’utilizzo dei passaggeri che percorressero destinazioni più lunghe.
I passeggeri, appena saliti sulla vettura dalla porta anteriore potevano scegliere di pagare immediatamente e sedersi nella parte posteriore della vettura oppure rimanere nella parte anteriore e pagare il biglietto al momento della discesa che avveniva dalla porta centrale. Tutto qui!
Questa idea che ben poco conosce di meccanica ma molto di buonsenso ebbe un impatto fortissimo nella riduzione dei tempi di permanenza delle vetture nelle fermate migliorando notevolmente il flusso tranviario.
Witt presentò la documentazione alla United States Patent Office nel 1914; ottenne il brevetto nel mese di aprile del 1916 e in quello stesso anno la Kuhlman Car Company di Cleveland consegnò le prime 130 vetture tipo Peter Witt.
Da operaio in fonderia a specialista in trasporti
Ma chi era Peter Witt? Il padre di Peter era un artigiano tedesco parte del gruppo “Forty-eighters” cioè quei cittadini arrivati negli Stati Uniti dopo il fallimento del liberalismo nella propria terra. Christopher Witt però non arrivò nel ‘48 bensì nel ‘49 e trovò subito lavoro nella azienda Baldwin Locomotive Works nella città di Filadelfia. Nel 1853 sposò Anna Probeck, tedesca anche lei, arrivata negli Stati Uniti tre anni prima. Witt simpatizò subito con le idee anti schiaviste e si arruolò volonatario nel 1861 prendendo parte alla poco gloriosa battaglia di Bull Run durante la Guerra Civile Americana.
A guerra finita decise di spostarsi con la famiglia nella città di Cleveland per lavorare in una fonderia e acquistare casa. Malgrado i suoi sacrifici il mutuo non era stato ancora saldato al momento della sua morte. Peter Witt nacque a Cleveland il 24 luglio del 1869 ed era il nono di dieci fratelli, non fu ovviamente crescituo nell’apice del lusso e potè frequentare la scuola solo fino alla quinta classe. La grandissima quantità di informazioni acquisita negli anni successivi parte della sua passione per la lettura, tuttavia la sua cultura generale era piena di lacune ed era lui il primo a sostenere che non era un “uomo colto nel significato convenzionale del termine”.
Aveva tredici anni quando iniziò a lavorare in una fabbrica di cestini per seguire poi i passi del padre e lavorare anche lui in fonderia. Peter detestava il sistema industriale e quello della classe dirigente che costringeva lui e tanti altri a soffrire lunghi periodi di dissocupazione perciò trovò nel sindacato "Knights of Labor" lo sfogo perfetto per i suoi ideali umanisti. Come era d’aspettarsi dopo aver preso parte in molti scioperi finì nella lista nera degli imprenditori locali. Già al momento del suo matrimoio, nel 1890, Peter Witt era pieno di debiti. Con le sue caratteristiche ed il suo background la strada al Partito Populista era spianata e nel 1894 Witt era già il delegato locale della convenzione Populista di Springfield, Ohio.
Witt fu sempre considerato un socialista: odiava gran parte degli uomini considerati di successo in quel periodo come tanti dei leader della vecchia guardia compreso Theodore Roosevelt. L’uomo che più influenza ebbe nella sua vita fu Tom L. Johnson, monopolista e uomo di fortuna converso dal libro di Henry George “Progresso e povertà” chi sarebbe diventano uno dei più grandi riformisti americani. Durante la campagna di Johnson per la carica di sindaco di Cleveland nel 1901, Witt era tra la folla spargendo in modo altamente convincente i suoi pensieri a tutti quelli che volessero ascoltarlo. Quel giovane attirò la atenzione di Johnson chi lo invitò a salire sul palcoscenico per sostenere un dibattito.
La sua oratoria era sarcastica, fluida e senza peli nella lingua: “un uomo arrabbiato e sincero, con gli occhi lampeggianti e le ciocche nere che pendevano su un lato della sua fronte,” lo descrisse Tom L. Johnson, l’uomo da lui tanto ammirato.
Una volta sindaco di Cleveland, Johnson costituì un ufficio speciale che aveva per scopo esaminare la situazione catastale a Cleveland ed esporre la inicua distribuzione degli oneri fiscali fra i piccoli contribuenti ed alcune grandi corporazioni nonchè uomini di grandi fortune. Nessuno meglio di Peter Witt, quell’uomo alto e magro il cui unico hobby era parlare per essere incaricato di questa impopolare mansione. Witt fece una mappatura di tutte le proprietà di Cleveland e le confrontò con il contributo di imposta che le era stato assegnato ad ogni parcella. Basandosi sui risultati ottenuti inviò delle lettere a cittadini individuali informandoli che le loro tasse erano più basse oppure pià alte e quindi rivalutate ed aggiustate dalla commissione di revisione locale.
Tra il 1903 ed il 1909 Witt occupò la carica di Segretario del Comune di Cleveland e durante qusto periodo si rifiutò di usare i free pass che gli erano regalati scrivendo persino alla United Labor Carnival, responsabili della sfilata del giorno dei lavoratori che si “opponeva al sistema di privilegi dei pubblici ufficiali nei luoghi di intrattenimento”.
L’amore per la sua Cleveland fece si che Witt creasse il “Cleveland Day” un evento annuo per celebrare la superiorità di Cleveland nei confronti delle altre città di America. Peter Witt sognava una società priva di corruzione e di privilegi e allo stesso tempo piena di comfort e comodità per i suoi abitanti. E fu per via di questo suo ideale che, durante la sua carica di Segretario Comunale si trasformò in modo del tutto autodidatta in uno dei maggiori esperti “di trazione” nell’America del XX secolo. Durante la sua carica aveva difeso accesamente il controllo da parte dei municipi delle tramvie locali ed aveva lavorato senza fatica per migliorare la situazione del trasporto pubblico urbano.
Il Traction Commissioner
Se Peter Witt si fosse presentato ad un concorso pubblico non l’avrebbe sicuramente vinto visto che di titoli e di premi non ne possedeva proprio. Tuttavia , nel 1912 Newton Baker il nuovo sindaco di Cleveland propose a Witt la carica di Traction Commissioner (assessore ai trasporti) con una salario di $7,500 all’anno. Peter Witt si distinse in questa carica per ben tre anni estendendo le reti tranviare locali e milgliorandone orari e percorsi.
Witt però non si fermò qui aprendo Euclid Avenue al traffico tranviario il che era un vero e proprio schiaffo per l’aristocrazia locale. Euclid Avenue era all’epoca sopranominata the "Millionaires’ Row", nota in tutto il mondo per essere la strada la cui valutazione fiscale eccedeva di gran lunga quella della Fifth Avenue di New York. La segretaria personale di Abraham Lincoln, il fondatore della Western Union Telegraph insieme ad imprenditori automobilistici e collezionisti di arte erano alcune delle persone che abitavano ad Euclide Avenue; persino la famiglia Rockefeller ebbe la propria mansione in questa prestigiosa via. Sotto l’ombra degli alberi che popolavano questa Avenue des Champs-Élysées del nuovo mondo si respiravano richezza e prosperità. Il mondo però stava cambiando e doveva farlo anche Euclid Avenue perciò Peter Witt, che di determinazione ne aveva da regalare, decise di aprire questo simbolo della supremazia industriale ed artistica al traffico tranviario simbolo a sua volta, del regolare trasporto di massa.
Alcune delle iniziative più popolari e non di certo prive di demagogia furono l’istituzione delle Sunday Stops ed il Donation Day. La prima obbligava i tram a fermarsi la domenica davanti a tutte le chiese. I Donation Day invece erano delle specifiche giornate durante le quali i viaggiatori introducevano più denaro del dovuto nelle scatole tariffarie con la consapevolezza che l’eccedente del prezzo dei biglietti sarebbe finito nelle mani di diverse associazioni di carità cittadine.
Durante la sua carriera nei diversi uffici pubblici di Cleveland Peter Witt non perse mai aderenza alla realtà che ben aveva conosciuto in passato dedicandosi con speciale attenzione a quei gruppi della società con necessità particolari in materia di trasporto pubblico. Introdusse delle regole specifiche per il trasporto tranviario che incrementavano la sicurezza nelle aree vicine alle scuole, sviluppò nuove linee tranviarie che collegassero i confini della città con il centro metropolitano aggiungendo dei rimorchi alle vetture per aumentare la capacità di passeggeri collegando in questo modo il progressista centro cittadino alle periferie.
Fu questo il momento in cui Peter si dedicò al design del suo “center-exit streetcar” . Questo modello di tram mondialmente adottato e conosciuto come “tipo Peter Witt” permise a Peter di prendere due piccioni con una fava: contribuiva a semplificare il flusso dei trasporti mentre fruttava per lui delle corpose royalties. Furono numerose le città che adottarono questo modello tranviario tramite il pagamento delle dovute royalties, a eccezione della città di Cleveland. Per decisione dello stesso Peter tutte le vetture destinate alla città di Cleveland sarebbero sempre state esonerate del pagamento delle royolties che gli erano dovute.
Dovette fare fronte ad una lunga battaglia quando decise di introdurre il “Rag Time Schedule” che comportava la soppressione di alcune fermate per velocizzare i tempi di percorrenza trasporto. L’opposizione da parte dei lavoratori tranviari fu feroce in quanto essi sostenevano che gli orari non potevano essere mantenuti. Witt perse la causa in tribunale ma continuò con il suo programma basato sugli orari mettendo più vetture a disposizione.
In questo periodo le politiche e le procedure di Witt cominciariono ad essere studiate da diversi sindaci per essere poi applicate anche in altre città americane quali Detroit e Kansas City.
La sconfitta
Nel 1915 decise di candidarsi alla carica di sindaco di Cleveland sostenuto dal Partito Democratico. Come era da aspettarsi vista la sua personalità Witt si rifiutò di spendere dei soldi per fare campagna elettorale e basò la propria campagna sui traguardi raggiunti come Traction Commissioner e nella applicazione di una flat tax. Le statistiche lo davano di due punti superiore al suo contrincante Davis, tuttavia al momendo di votare Davis ottenne 47.471 voti contro i 44.940 di Witt.
Questa sconfitta segnò l’inizio della fine della carriera politica di Witt che, essendosi affermato come uno dei più autorevoli specialisti in materia de trasporti, lavorava in qualità consulente per tante altre città americane quali Boston e Philadelphia e per diverse realtà quali la Metropolitan Utilities Inc. che all’epoca controllava le ferrovie di Cleveland. Si pensi che nel 1930 la città di Seattle pagò $7,000 per un report!
Tentò ancora fortuna nella politica tra il tra il 1923 ed il 1927 senza particolari successi. Dopo aver perso nel 1931 le elezioni a Sindaco di Cleveland per la seconda volta chiuse definitivamente la sua carrera politica e anche quella dei pubblici uffici. Aveva già guadagnato una ingente quantità di denaro per vivere in modo agiato nonchè per provvedere all’educazione dei figli permettendo loro delle opportunità che a lui furono negate.
Non riuscì però a resistere alla tentazione di agitare le folle cosa nella quale era particolarmente bravo: se la prese con l’ufficio cittadino di pianificazione perche contrario alla loro politica in relazione alle ferrovie, supportò la battaglia per i diritti delle donne e combattè contro il Ku Klux Klan.
Per quanto lontano dalla politica la sua ferocia ideologica sembrava non aver diminuito col passo del tempo. Morì convinto della rettitudine dei propri principi e non fece mai nulla a metà: per lui le cose, specialmente se in politica o economia, erano bianche o nere. Nei dibattiti pubblici era un vero showman trasformandoli da eventi piatti e noiosi in veri spettacoli circensi.
Nel 1925 decise di organizzare dei meeting pubblici nel Public Hall la cui ammissione costava un dollaro a testa così si garantiva di abbattere i costi di affitto della sala. Nel 1935 il suo meeting radunò 5.000 persone ed era lui l’unico intrattenimento! Tutti furono passati a settaccio: i quotidiani, le banche, le tasse, i manager, le ferrovie. Appena iniziava a scaldarsi si toglieva il cappotto nero e lo scaraventava in un angolo per continuare ad offrire un show, in parte pieno di verità, che nessuno voleva perdersi. E andava avanti così per circa un’ora e mezza infilato nel suo abito scuro e la cravatta a farfalla a tono.
Peter Witt morì nel 1948, all’eta di 79 anni ed insistette per non ricevere nessun funerale formale. Quattordici anni dopo l’ultimo tram tipo Peter Witt faceva la sua ultima corsa per le vie di Cleveland.
Fonti
- Carl Wittke (2010). Peter Witt- Tribune of the People, Teaching Cleveland Digital.
- Philip W. Porter (2010). Peter Witt, Teaching Cleveland Digital.
- Peter Witt (1907). Discorso Chicago City Club.
- Arthur E. De Matteo (2010). Peter Witt and the Mayoral Election of 1915, Teaching Cleveland Digital.
- Index of Patents Issued from the United States Patent Office - Street Railway Car – US Patent No.1180900, filed - Filed Sep 11, 1915 and issued Apr 25, 1916 to Peter Witt.
- A visual history of Streetcars, Cleveland: https://www.cleveland.com/entertainment/2016/07/a_visual_history_of_streetcars.html
Immagini
Foto 1 – Peter Witt insieme a Tom L. Johnson, l’uomo che fu determinante nella sua carriera politica.
Foto 2 – Euclide Avenue nel 1927
Foto 3- Tram alla fermata Detroit-Superior Bridge, 1918
Per approfondire
Per approfondire si consiglia il libro "Peter Witt da Cleveland a Torino" edito da Atts.

IN TRAM SUL MONTE BIANCO
di Roberto Cambursano
Il Monte Bianco, con i suoi 4809 metri, è la più alta vetta delle Alpi ed è posto al confine fra la Val d’Aosta in Italia e la Valle dell’Arve nell’Alta Savoia francese. Fa parte delle Alpi Graie, estese dal Passo del Moncenisio al Col Ferret. La prima ascensione fino alla vetta lungo la “via normale” (che oggi parte dal capolinea superiore del “Tramway du Mont Blanc”, il “Nido d’aquila”) fu compiuta dai savoiardi Balmat e Paccard nel 1786.
Ma si può andare in tram sul Monte Bianco? Ebbene sì, il “Tramway du Mont Blanc” esiste davvero: così è chiamata infatti una delle due ferrovie a cremagliera che risalgono le pendici del massiccio montuoso dal versante francese (l’altra è la Chamonix-Montenvers). Queste due interessanti linee si trovano nel tratto della valle dell’Arve compreso fra Saint Gervais e Chamonix ed hanno parecchie caratteristiche in comune tra loro. Oltre ad essere quasi coetanee, condividono lo scartamento dei binari (1 metro), il tipo di cremagliera (Strub) e il sistema di alimentazione elettrica (in corrente alternata a 11.000 Volt /50 Hertz, alquanto inusuale).
A partire dall’anno 2000 la loro gestione è stata unificata e affidata alla “Compagnie du Mont Blanc”, che gestisce anche gli impianti di risalita della zona compresi nei vasti e rinomati comprensori sciistici. I due impianti sono collegati tra loro dalla linea ferroviaria internazionale a scartamento metrico che parte da Le Fayet (capolinea della ferrovia statale francese a scartamento ordinario), tocca Chamonix e sconfina in Svizzera dove termina a Martigny.
Cominciamo con la più nota delle due, la Chamonix-Montenvers, che collega la stazione ferroviaria di Chamonix, (situata ad una quota di 1042 metri s.l.m.) con il punto panoramico di Montenvers, posto a quota 1913 metri su un contrafforte che domina il grande e celebre ghiacciaio della Mer de Glace.
Il primo tratto di 4,3 km fino a La Filliaz fu inaugurato nel 1908, mentre l’intera linea, lunga 5,1 km di cui 4,8 armati con cremagliera Strub e una massima pendenza del 22%, entrò in funzione con trazione a vapore nel 1909. Nel 1971 fu montata la cremagliera anche nel tratto iniziale pianeggiante di 300 metri compreso fra la stazione di Chamonix e il primo passaggio a livello, che iniziamente ne era sprovvisto: la linea è perciò ora a cremagliera integrale.
Il materiale rotabile originale comprendeva otto locomotive a vapore a tre assi di fabbricazione svizzera (SLM), ognuna delle quali poteva spingere due vagoni passeggeri alla velocità massima di 7 km/ora. Una di esse è stata restaurata e messa in servizio come veicolo storico nel 2007. La trazione a vapore, seppure ridotta al minimo, scomparve completamente solo nel 1981, con l’arrivo di nuovo materiale di trazione. Si riporta di un tragico incidente avvenuto il 25 agosto 1927, uno dei più gravi nella storia delle ferrovie a cremagliera, quando un errore del macchinista provocò un deragliamento in discesa nei pressi del viadotto di Montenvers con un bilancio di 22 morti e 25 feriti gravi.
Nel 1954 prese avvio la trazione elettrica, con alimentazione in corrente alternata monofase a 11.000 Volt /50 Hertz, e il tempo di viaggio venne ridotto dai 51 minuti della trazione a vapore agli attuali 20 minuti. Furono immesse in servizio le prime quattro automotrici a carrelli, costruite in Svizzera da SLM con equipaggiamento elettrico MFO e quattro rimorchiate a carrelli costruite in Francia da Decauville: tutto questo materiale è tuttora in servizio; le automotrici sono dotate di quattro assi motori a cremagliera, sono monocassa lunghe 15,4 metri e spingono ciascuna una rimorchiata lunga 14,2 metri a una velocità di 15 km/ora sulla massima pendenza e di 20 km/ora sul tratto senza cremagliera. Fra il 1961 e il 1984 il parco rotabile venne integrato da altre due elettromotrici di fabbricazione SLM simili alle prime quattro (solo più lunghe di 50 cm) e accoppiate a due rimorchiate costruite dalla ditta francese Socofer, oltre che da tre locomotive diesel Voith/Poyaud da 7,5 metri, accoppiate a tre rimorchi articolati (ricostruiti dalla ditta francese Belle-Clot a partire da sei vecchi telai dei tempi del vapore). Di queste tre locomotive, destinate ad integrare il servizio nei momenti di massima punta, a sostituire i convogli elettrici in caso di guasti e ad effettuare servizi di sgombro neve e trasporto materiali, ne rimangono attualmente due (non più utilizzate in normale servizio di linea a partire dal 2001), mentre la terza è stata ceduta nel 2001 insieme a una rimorchiata alla linea sorella “Tramway du Mont Blanc” ma poi là mai utilizzata. Alla fine degli Anni Novanta, i convogli elettrici sono stati pesantemente revisionati e le rimorchiate trasformate in semi-pilota, con i comandi di marcia sul lato a monte.
Il servizio è attivo tutto l’anno, con un picco di carico nella stagione estiva, quando l’intervallo delle corse raggiunge il minimo di 20 minuti.
Il “Tramway du Mont Blanc” parte da Le Fayet, stazione di corrispondenza con la ferrovia statale situata nel fondovalle ad una altitudine di 581 metri; dopo un primo tratto urbano pianeggiante, dove transita in sede stradale ed effettivamente si comporta come un tram, inizia la salita con la cremagliera; transita dal paese di Saint Gervais e prosegue a mezza costa prima nel bosco e poi su ripidi costoni pietrosi, terminando a 2372 metri di quota al “Nido d’aquila in prossimità del ghiacciaio di Bionassay.
Le ambizioni dei promotori all’epoca dell’inizio dei lavori erano grandissime: nientemeno che realizzare la più alta ferrovia del mondo e raggiungere la cima del Monte Bianco! Nel 1909 venne messo in servizio il primo tratto di 7,6 km fino al Col de Voza (altitudine 1638 m), nel 1911 venne raggiunto Mont Lachat (altitudine 2073 m) e infine nel 1913 la linea arrivò all’attuale punto terminale. Questo capolinea era destinato ad essere provvisorio, poiché di lì la ferrovia avrebbe dovuto proseguire con una serie di tornanti e gallerie e affrontare nuovi tratti molto impegnativi, arrivando con un tracciato sotterraneo (simile a quello della linea svizzera della Jungfrau) in un primo tempo all’Aiguille du Goûter (altitudine 3817 m) e poi fino alla cima. Invece la Prima Guerra Mondiale arrestò i lavori di costruzione, che non furono mai più ripresi. Il carattere di provvisorietà del capolinea superiore è però rimasto, dato che l’impressione che suscita a chi oggi arriva al “Nido d’aquila” è quella di un binario in piena pendenza che finisce nel nulla.
Le caratteristiche tecniche della linea, lunga in tutto 12,5 km, sono quelle di una ferrovia di montagna: cremagliera di tipo Strub per un totale di 10 km su una massima pendenza del 24%. La trazione è elettrica dal 1957, con alimentazione in corrente alternata a 11.000 Volt /50 Hertz.
Il materiale rotabile originale comprendeva sei locomotive a vapore a due assi costruite dalla svizzera SLM, in grado di spingere un vagone passeggeri alla velocità massima di 7 km/ora. Il viaggio da Le Fayet al Nido d’aquila aveva una durata di 2 ore e 20 minuti. Il materiale rotabile attuale è quello entrato in servizio in occasione dell’elettrificazione nel 1957 e revisionato negli Anni Novanta: tre automotrici a una cassa a carrelli costruite in Svizzera da SLM/MFO dotate di quattro assi motori a cremagliera e lunghe 15,4 metri, in grado di raggiungere una velocità di 15 km/ora sulla massima pendenza e di 20 km/ora sul tratto senza cremagliera, battezzate Marie, Jeanne et Anne dal nome delle figlie del proprietario della società esercente dell’epoca; vi sono poi tre rimorchiate costruite dalla ditta francese Decauville, anch’esse a carrelli e lunghe 14,2 metri. La composizione tipica dei convogli è costituita da una automotrice (sempre posta a valle) e una rimorchiata, con una capienza totale di 200 passeggeri.
Il viaggio di andata dura in tutto un’ora e 15 minuti e la limitata consistenza del parco veicoli non permette grandi capacità di trasporto: nel periodo estivo di massimo afflusso sono previste solo 11 coppie di corse giornaliere.
Nella stagione invernale il servizio del “Tramway du Mont Blanc” è limitato a Bellevue (1756 m) ed è parte integrante del sistema di trasporto del comprensorio sciistico della Valle dell’Arve.
IMMAGINI
fig. 1 - LOCANDINA STORICA / Disegno d’epoca / Manifesto pubblicitario per la linea Chamonix-Montenvers / Anni 1930.
fig. 2 - VECCHIA LOCOMOTIVA / Foto Roberto Cambursano / Una vecchia locomotiva a vapore della linea Chamonix-Montenvers monumentata al capolinea inferiore di Chamonix / 2019.
fig. 3 - CONVOGLIO IN PARTENZA / Foto Roberto Cambursano / Un convoglio ascendente appena partito dalla stazione di Chamonix / 2019.
fig. 4 – TRANSITO AL RADDOPPIO / Foto Roberto Cambursano / Un convoglio in transito su uno dei due tratti di raddoppio intermedi / 2019.fig. 5 - INCIDENTE A-MONTENVERS / Foto autore ignoto / Immagine dai giornali d’epoca del grave incidente accaduto a Montenvers il 25 agosto 1927.
fig. 6 - STAZIONE DI MONTENVERS / Foto Roberto Cambursano / Un convoglio formato da motrice e rimorchiata in partenza dal capolinea superiore di Montenvers / 2019.
fig. 7 - LOCANDINA STORICA / Disegno R. Broders / Manifesto pubblicitario per la linea Saint Gervais-Bionassay / Anni 1930.
fig. 8 - DEPOSITO DI LE FAYET/ Foto Roberto Cambursano / La motrice “Jeanne” fa capolino dal deposito di Le Fayet del Tramway du Mont Blanc / 2019.
fig. 9 - INIZIO TRATTO A CREMAGLIERA / Foto Roberto Cambursano / La prima rampa armata con cremagliera Strub in uscita dall’abitato di Le Fayet / 2019.
fig. 10 - DEVIATOIO STRUB / Foto Roberto Cambursano / Un deviatoio con cremagliera tipo Strub sul “Tramway du Mont Blanc” / 2019.
fig. 11 – PANORAMA DALLA LINEA / Foto Roberto Cambursano / Veduta panoramica dal tratto di percorso nel bosco del Tramway du Mont Blanc” / 2019.
fig. 12 - INCROCIO CONVOGLI / Foto Roberto Cambursano / Incrocio fra le motrici Marie e Anne del “Tramway du Mont Blanc” / 2019.
fig. 13 – FERMATA DI BELLEVUE / Foto Roberto Cambursano / Un convoglio del “Tramway du Mont Blanc” formato dalla motrice “Anne” con la sua rimorchiata al capolinea invernale superiore di Bellevue / 2019.

TRAFFICO SOTTO IL CERVINO
di Roberto Cambursano
La ferrovia del Gornergrat (“Gornergratbahn”) è situata in Svizzera nel Canton Vallese e collega la cittadina di Zermatt con la cima del Monte Gornergrat nelle Alpi Pennine. Raggiunge una massima pendenza del 20%, mantenendosi su una media del 16%, ed è provvista di cremagliera Abt sulla sua intera lunghezza di 9,3 km.
Zermatt è oggi una località turistica di fama internazionale, situata ad una altitudine di 1600 metri al termine della valle percorsa dal torrente Matter Vispa che termina alla base dell’imponente parete nord del Cervino, icona delle Alpi; divenne nota nel 1865 dopo la prima scalata del Cervino (o Matterhorn, alto 4477 metri) ad opera dell'inglese Whymper e prima della costruzione della ferrovia proveniente da Visp era uno sperduta borgata collegata al fondovalle esclusivamente da una mulattiera; a partire dal 1971 i turisti possono arrivarci solo in treno, essendo obbligati a lasciare l’auto alla precedente stazione di Tasch. Le Alpi Pennine delimitano il confine tra Svizzera e Italia e fanno da spartiacque fra il Mar Mediterraneo (bacino del Rodano) e il Mare Adriatico (bacino del Po); comprendono 41 vette alte oltre 4000 metri (la metà del totale delle Alpi), culminando nei 4634 metri s.l.m. della Punta Dufour sul Monte Rosa. Il Gornergrat (3135 metri s,l.m.) è un’altura panoramica a forma di panettone situata su una dorsale che domina il ghiacciaio omonimo alle pendici del Monte Rosa: da esso si possono ammirare molto bene, tra l'altro, le pareti nord ed est del Cervino.
La Gornergratbahn (GGB), oltre ad essere una delle più famose ferrovie di montagna del mondo, detiene il primato di linea a cremagliera più frequentata: il suo livello di carico complessivo sfiora infatti i quattro milioni di viaggiatori all'anno! Aperta al traffico nel 1898, funzionò all'inizio solo d'estate; nel 1927 venne avviato anche il servizio invernale, che dal 1950 superò quello estivo nei valori di affluenza di pubblico e, col crescere della pratica dello sci, divenne sempre più importante: proprio d’inverno l’affluenza raggiunge i massimi livelli, funzionando da impianto di risalita principale per il comprensorio sciistico del Gornergrat.
La stazione di valle è situata nell’abitato di Zermatt, nelle adiacenze della stazione terminale della ferrovia a cremagliera proveniente da Visp nella valle del Rodano gestita dalla compagnia MGB (Matterhorn Gotthard Bahn), che assieme alla GGB fa capo alla stessa holding denominata BVZ. Le due ferrovie hanno in comune lo scartamento (1000 mm) e il tipo di cremagliera (Abt a due lamelle) e sono collegate da un raccordo di servizio che permette il reciproco scambio di veicoli rimorchiati; il sistema di alimentazione elettrica è invece diverso (corrente alternata trifase per la Gornergratbahn e monofase per la Briga-Visp-Zermatt), il che costringe a una gestione separata.
Pur non essendo la linea più alta d'Europa (è superata dalla cremagliera della Jungfrau), è però quella con il percorso sommitale a cielo aperto situato a quota più elevata; le condizioni climatiche avverse furono causa di grandi problemi durante la fase di costruzione e favorirono la scelta della trazione elettrica anziché di quella a vapore, cosicchè il Gornegrat fu la prima ferrovia elettrica a cremagliera della Svizzera e la seconda al mondo (dopo quella del Mont Salève in Francia).
Il tracciato originario era tutto a semplice binario, con brevi tratti di raddoppio per gli incroci in corrispondenza delle quattro stazioni intermedie, e giungeva fino alla località di Giffhüttli, circa 400 metri prima dell'attuale capolinea; nel 1909 il binario raggiunse la nuova stazione sommitale, a 3089 metri di quota, portando la lunghezza complessiva del percorso a 9339 metri e il dislivello tra i due estremi a 1485 metri. In varie fasi successive, fra il 1963 e il 1986, il binario venne parzialmente raddoppiato allo scopo di aumentare la potenzialità della linea nel suo tratto superiore (situato all'interno del comprensorio sciistico): il doppio binario è presente oggi su un totale di 3950 metri di linea e permette di programmare nel periodo invernale una corsa ogni 12 minuti in entrambe le direzioni fra le stazioni di Riffelberg e di Gornergrat, uno spettacolo di intenso traffico nella neve veramente impressionante!
Di notevole interesse ingegneristico è il viadotto sul torrente Findelenbach, lungo 90 metri a alto 50 metri, situato nel secondo chilometro di linea a partire da Zermatt.
Come sistema di alimentazione fu scelto quello in corrente alternata trifase, con tensione di 550Volt e frequenza di 40 Hertz (poi portato nel 1930 a 650 V e 50 Hz e infine a 725 V e 50 Hz nel 1947) secondo il progetto presentato degli ingegneri Charles E. L. Brown e Walter Boveri e giustamente allora ritenuto ideale per una ferrovia di montagna in forte pendenza. Si tratta della prima ferrovia a cremagliera trifase del mondo, in quanto precedette di un solo mese (20 agosto contro 20 settembre!) l'inaugurazione del primo tratto della coeva linea della Jungfrau, costruita con i medesimi criteri.
Il parco rotabile originario comprendeva quattro locomotori a due assi lunghi 4,13 metri, costruiti in Svizzera dalla SLM di Winterthur con equipaggiamento elettrico BBC, poi integrati da una quarta unità nel 1930: ogni locomotore era accoppiabile a un semi-rimorchio tipo Rowanwagen dotato di un carrello sul lato monte; a quest'ultimo poteva essere agganciato un altro rimorchio, sempre a monte del convoglio, portando la capacità di carico a 110 persone per convoglio; la velocità raggiungibile sulla massima pendenza era di 7,3 km/ora. Fra il 1947 e il 1961 furono immesse in servizio 12 elettromotrici a due carrelli da 110 posti lunghe 15,1 metri, che rimpiazzarono i convogli Rowan, seguite fra il 1964 e il 1974 da quattro unità articolate a due casse e quattro carrelli da 240 posti lunghe 30,5 metri, tutte sempre di fabbricazione SLM/BBC e con caratteristiche tecniche simili alle precedenti; con questi veicoli la velocità massima raggiungibile fu elevata a 14,3 km/ora.
Nel 1981 entrarono in servizio due nuovi convogli SLM/BBC formati da una motrice monocassa a due carrelli a trazione integrale e un rimorchio semipilota, in grado di portare 240 passeggeri: furono le prime motrici ad azionamento elettronico, dotate di motori in corrente continua alimentati da un convertitore di bordo per il passaggio da corrente alternata trifase a continua.
Nel 1993 si aggiunsero altre quattro elettromotrici articolate più moderne ad azionamento elettronico, sempre a due casse e quattro carrelli con 256 posti (di cui 128 seduti) lunghe 32,3 metri, che possono circolare in composizione multipla e possono raggiungere sul tratto più acclive la velocità massima di 28 km/ora e compiere l'intero tragitto ascendente in 33 minuti. Anche in questo caso la casa costruttrice fu la SLM, con equipaggiamento elettrico fornito dalla ABB (nel frattempo subentrata alla BBC).
Le motrici più recenti sono le quattro snodate a due casse e tre carrelli a pianale parzialmente ribassato costruite dalla Stadler (la casa svizzera erede della SLM, specializzata in rotabili a cremagliera), lunghe 33,2 metri ed entrate in servizio nel 2006, che possono circolare in multiplo anche accoppiate alle motrici precedenti: sono possibili composizioni fino a quattro unità accoppiate, con una capacità di carico di ben 960 passeggeri per treno!
Completano il parco rotabile numerosi veicoli di servizio (carri merci, spazzaneve e veicoli tecnici ricavati dalla ristrutturazione di vecchie motrici); esiste anche un piccolo scalo merci dotato di due binari presso la stazione di Findelbach.
Per concludere, ecco un particolare curioso: la stazione di Riffelalp è collegata al vicino omonimo Hotel (2211 metri sl.m.) dal “Riffelalptram”: su un tratto di binario indipendente ad aderenza naturale lungo 675 metri e con scartamento di 800 mm circolano d'estate due piccoli veicoli elettrici alimentati a batteria (un tempo erano in servizio motrici alimentate in trifase come la linea a cremagliera).
IMMAGINI
fig. 1 - LOCANDINA STORICA / Manifesto pubblicitario d’epoca della Gornergratbahn con orario di servizio / 1899.
fig. 2 - TARGA GGB / Foto Roberto Cambursano / Targa applicata sulla fiancata di un veicolo costruito nel 1964 con logo GGB e nomi case costruttrici SLM e BBC / 2018.
fig. 3 - STAZIONE DI ZERMATT / Foto Roberto Cambursano / Convogli alla stazione di Zermatt della Gornergratbahn / 2018.
fig. 4 - TRATTO A DOPPIO BINARIO / Immagine da Pixabay / Un convoglio in transito su un tratto a doppio binario della Gornergratbahn / 2017.
fig. 5 – INCROCIO TRENI / Foto Roberto Cambursano / Incrocio di convogli alla stazione di Riffelalp. In primo piano, un deviatoio a cremagliera Abt / 2018.
fig. 6 – CONVOGLIO NELLA NEVE / Foto Roberto Cambursano / Treno ascendente in doppia composizione di motrici articolate / 2018.
fig. 7 - IN ARRIVO AL GORNERGRAT / Foto Roberto Cambursano / Convoglio in arrivo alla stazione di Gornergrat composto da motrice e rimorchiata SLM/BBC del 1981 / 2018.
fig. 8 - DOPPIA COMPOSIZIONE / Foto Roberto Cambursano / Convoglio alla stazione di Gornergrat composto da due diverse motrici articolate (SLM/BBC del 1993 e Stadler del 2006 a pianale parzialmente ribassato) / 2018.
fig. 9 - IL CERVINO DAL GORNERGRAT / Foto Roberto Cambursano / Vista sul Cervino dalla stazione di Gornergrat / 2018.
fig. 10 - RIFFELALPTRAM / Foto Whgler- Lic.CC3.0 / Il tram proveniente dalla stazione di Riffelalp e diretto all’Hotel omonimo / 2007.

SUI PIRENEI IN CREMAGLIERA
di Roberto Cambursano
La catena dei Pirenei separa la Francia dalla Spagna, protendendosi per 430 km dall’Oceano Atlantico al Mar Mediterraneo e raggiungendo la sua massima altitudine di 3404 metri in corrispondenza del Pico de Aneto. Di certo non ricca di ferrovie di montagna come le Alpi, ne ospita tuttavia alcune di grande interesse, tra cui due linee a cremagliera (una sul versante francese e una su quello spagnolo), oltre a una terza linea francese oggi non più esistente: in questo articolo le descriviamo in ordine cronologico di apertura.
Cominciamo con la defunta linea francese di Superbagnères de Luchon, che collegava la stazione ferroviaria di testa dell'importante località turistica idrotermale di Bagnères de Luchon, posta alla quota di 630 metri s.l.m. nell’alta valle della Garonna (regione Occitania), con il comprensorio sciistico di Superbagnères, situato ad una altitudine di 1800 metri. Fu inaugurata nel 1912 ad opera della “Societé des Chemins de fer et Hotels de Montagne des Pyrénées” (CFHMP), una filiale della intraprendente compagnia ferroviaria francese “Chemins de fer du Midi” che aveva lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico della zona. La linea, a scartamento metrico, era lunga 5460 metri e interamente armata con cremagliera di tipo Strub, con una pendenza massima del 25,5%. La linea fu alimentata elettricamente fin dall'inizio, con l'adozione del sistema a corrente alternata trifase a 3000 Volt /50 Hz.
Il parco rotabile era composto da quattro locomotori a due assi di fabbricazione svizzera (SLM/BBC), lunghi 5 metri, ognuno dei quali poteva spingere due rimorchi alla velocità massima di 8,5 km/ora.
La crisi iniziò nel 1961, quando l'apertura della strada carrozzabile fece dimezzare il numero dei passeggeri trasportati e convinse la società esercente alla chiusura della linea, avvenuta nel 1966. In seguito, due motrici finirono alla linea della Rhune, dove sono ancora oggi in servizio. Oggi Luchon è collegata a Superbagnères da un impianto a fune dotato di telecabine.
La linea Saint Ignace-La Rhune è situata nei Paesi Baschi francesi all’estremità occidentale dei Pirenei in stupenda posizione panoramica sul Golfo di Biscaglia e sull’Oceano Atlantico. I lavori di costruzione iniziarono nel 1912, furono interrotti dalla Prima Guerra Mondiale e furono completati solo nel 1924, l’anno di inaugurazione.
Le caratteristiche tecniche sono identiche a quelle della vicina scomparsa linea di Superbagnères: scartamento metrico, cremagliera integrale di tipo Strub e alimentazione elettrica a corrente alternata trifase a 3000 Volt /50 Hz (in origine 25 Hz). La linea è lunga 4200 metri, senza fermate intermedie, con una pendenza massima del 25%; il capolinea inferiore è situato al Colle di Saint Ignace a 169 metri sul livello del mare, mentre quello superiore si trova sulla cima della Rhune a quota 901 metri sulla linea di confine con la Spagna.
Il colle di Saint Ignace fu collegato con una tranvia alla città Saint Jean de Luz, sulla costa atlantica, fino al 1936.
Il tempo di percorrenza è di 35 minuti in entrambi i sensi di marcia; a metà percorso, presso la località di Trois Fontaines, è presente un tratto di binario di raddoppio per l’incrocio dei treni, che nei periodi di maggiore affluenza possono essere in numero di quattro complessivamente presenti in linea (una coppia di treni che si segue a distanza ravvicinata per ciascuna direzione di marcia).
Il materiale rotabile è interamente storico originale: i sei locomotori in servizio (compresi i due provenienti dalla linea di Superbagnères) sono stati costruiti dalla svizzera SLM con equipaggiamento elettrico BBC; dotati di due assi motori a cremagliera e lunghi 5 metri, hanno una velocità massima di 8,5 Km/ora. La composizione tipica dei convogli è costituita da un locomotore (sempre posto a valle) e due vagoni, ciascuno dalla capienza di 75 passeggeri. Il servizio è sospeso nella stagione invernale. Tutto il materiale rotabile ha le casse in legno, con una bella livrea in tinta naturale.
La terza linea a cremagliera, l’unica sul versante spagnolo, è la ferrovia Ribes-Nuria, situata in Catalogna, che collega la stazione di Ribes de Freser (raggiungibile direttamente da Barcellona con una ferrovia locale lunga 120 km) con Nuria, località sciistica e sede di un importante santuario situata alla quota di 1965 metri s.l.m. al termine dell’omonima valle.
Inaugurata nel 1931, adotta lo scartamento metrico ed ha una lunghezza totale di 12,5 km; la tratta superiore di 7 km è attrezzata con cremagliera di tipo Abt su una pendenza massima del 15%; il dislivello complessivamente coperto è di 1059 metri. Il binario è unico, con tre tratti di raddoppio in corrispondenza delle stazioni intermadie e un ulteriore tratto a doppio binario all’interno della galleria Roc del Dui. Elettrificata fino dalle origini, ha una alimentazione in corrente continua alla tensione di 1500 Volt. Dopo il subentro della società FGC (la stessa della linea di Montserrat) nella gestione, avvenuto nel 1984, furono condotti grandi lavori di rinnovo di impianti e materiale rotabile. Nel 2008 fu inaugurata una variante di percorso nella tratta superiore a cremagliera che include una nuova lunga galleria lunga 1330 metri (il Tunel Roc del Dui): tale variante sostituisce un precedente percorso più sinuoso, soggetto a frequenti frane e dotato di gallerie più corte.
Il parco rotabile di prima generazione comprendeva quattro locomotive a tre assi accoppiati costruite da SLM con equipaggiamento elettrico BBC, (una delle quali è tuttora funzionante) che potevano procedere alla velocità massima di 15 km/ora sulla tratta a cremagliera e di 30 km/ora sulle tratte ad aderenza naturale, avendo a disposizione 15 rimorchiate a carrelli di fabbricazione tedesca (VWW).
La seconda generazione comprende quattro elettromotrici articolate dalla capacità unitaria di 200 passeggeri, le prime tre realizzate nel 1985 dal consorzio di imprese spagnole MTM su licenza SLM e la quarta fornita nel 1995 dal consorzio ABB, GEC Alsthom e SLM, che possono all’occorrenza rimorchiare ciascuna due vagoni passeggeri supplementari. La velocità massima raggiungibile è di 37 km/ora sui tratti in aderenza naturale e di 19-21 km/ora sul tratto a cremagliera di massima pendenza. Inizialmente tutte e quattro le elettromotrici erano strutturate a due casse e quattro carrelli con una lunghezza di 28 metri, ma dal 2019 due di esse sono state allungate con l’interposizione di una terza cassa intermedia a pianale ribassato.
La terza generazione è costituita da due elettromotrici articolate Stadler GTW 2/6 a pianale parzialmente ribassato, identiche a quelle della linea di Montserrat tranne che nella livrea (blu anziché verde), entrate in servizio nel 2003. Sono impiegate anche in coppia in trazione multipla e la loro velocità massima sulla tratta a cremagliera è di 24 o 30 km/ora (rispettivamente in discesa o in salita).
Nel 2019 è stato consegnato un nuovo locomotore diesel-elettrico prodotto da Stadler destinato a treni passeggeri di rinforzo e treni merci. Completano il parco rotabile in servizio un locomotore diesel, quattro carrozze passeggeri, alcuni carri merci e di servizio e un carro spazzaneve.
Il servizio è attivo tutto l’anno; il tempo di viaggio è di 40 minuti per ogni direzione di marcia.
IMMAGINI
fig. 1 - LOCANDINA STORICA / Disegno d’epoca / Manifesto pubblicitario per la linea di Superbagnères / Anni 1930.
fig. 2 - LINEA DI SUPERBAGNÈRES / Cartolina d'epoca / Un convoglio in servizio sulla linea di Superbagnères de Luchon in transito presso la curva di Mail Soulan / 1917.
fig. 3 - CAPOLINEA DI SAINT IGNACE / Foto Roberto Cambursano / La stazione di Saint Ignace, capolinea inferiore della linea della Rhune / 2019.
fig. 4 - CONVOGLIO IN ARRIVO A SAINT IGNACE / Foto Roberto Cambursano / Un convoglio in arrivo al colle di Saint Ignace / 2019.
fig. 5 – DEPOSITO VEICOLI / Foto Roberto Cambursano / Il deposito del materiale rotabile della linea della Rhune / 2019.
fig. 6 - INCROCIO TRENI / Foto Roberto Cambursano / Incrocio di convogli sulla linea della Rhune presso Trois Fontaines / 2019.
fig. 7 - PANORAMA DALLA LINEA DELLA RHUNE / Foto Roberto Cambursano / Panorama dal tratto superiore della linea della Rhune: sullo sfondo l’Oceano Atlantico / 2019.
fig. 8 - CAPOLINEA SUPERIORE LA RHUNE / Foto Smiley.toerist-Lic.CC3.0 / Un convoglio al capolinea superiore della Rhune / 2009.
fig. 9 - LOCOMOTORE TRIFASE / Immagine tratta da opuscolo “Chemin de fer a crémaillère de la Rhune” / Disegno tecnico del locomotore SLM/BBC del 1924 per la linea della Rhune.
fig. 10 - LOCANDINA STORICA / Disegno M.J. Morell /Manifesto pubblicitario della linea Ribes-Nuria / Anni 1930.
fig. 11 - LINEA RIBES-NURIA / Foto Alberto G. Rovi-Lic.CC3.0 / Un convoglio della linea Ribes-Nuria in transito presso il Lago Vall de Nùria / 2009.
fig. 12 - NUOVO TRENO RIBES-NURIA / Foto Victor Molas-Lic.CC3.0 / Un convoglio di due motrici Stadler GTW2/6 in trazione multipla sulla linea Ribes-Nuria / 2012.

IN VETTA AL PUY DE DÔME
di Roberto Cambursano
Il Puy de Dôme (1465 metri s.l.m.) è la cima più alta di una catena formata da ottanta vulcani spenti (detti “puys”) estesi su una fascia di 5 km di larghezza e 45 km di lunghezza, facenti parte del Massiccio Centrale francese e ricompresi nel Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. L’ultima eruzione risale all’8500 a.C. Fin dall’antichità, il Puy de Dôme fu sede di cerimonie religiose e vi si costruirono numerosi templi, di uno dei quali (dedicato a Mercurio) sono oggi visibili le rovine.
Il Puy de Dôme sorge nei pressi di Clermont-Ferrand, (situata a un’altitudine di 360 metri s.l.m.), città di 145.000 abitanti capoluogo del dipartimento del Puy de Dôme nella regione Auvergne-Rhône-Alpes: qui è in funzione una tranvia urbana su gomma che è stata la prima al mondo ad essere realizzata con il sistema “Translhor” nel 2006.
Nel 1907 venne inaugurata una tranvia interurbana con trazione a vapore che congiungeva direttamente la città di Clermont-Ferrand con la cima del Puy de Dôme. Lo scartamento metrico era lo stesso della rete tranviaria cittadina, con la quale questa linea era integrata. Le due tratte con le pendenze maggiori (una tratta intermedia con pendenza massima dell’11,8% e la parte superiore con pendenza del 15,5%) venivano superate in aderenza artificiale con il Sistema Hanscotte. Esso, adottato in questo unico caso, era una variante del più conosciuto Sistema Fell (introdotto per la prima volta sulla ferrovia del Moncenisio nel 1868) e consisteva in una rotaia supplementare posata al centro del binario con la testa sagomata a “doppio fungo”, su cui rotolavano delle speciali ruote orizzontali mantenute pressate dall’aria compressa con funzioni di trazione e di frenatura, ad integrazione del lavoro svolto dalle normali ruote verticali della locomotiva. La composizione massima dei convogli era di una locomotiva e tre vagoni, con una capacità di carico di 120 passeggeri; la velocità massima era di 8 km/ora. Il primo tratto di linea da Clermont Ferrand a Quatre Routes fu elettrificato nel 1912; la Prima Guerra Mondiale, oltre a mettere fine al progetto di proseguimento dell’elettrificazione, costrinse anche alla sospensione del servizio, che fu ripristinato nel 1923 solo sul tratto superiore ma poi chiuso definitivamente nel 1925 e soppiantato da un servizio di autobus.
La tranvia attuale, denominata “Panoramique des Dômes”, detiene il primato mondiale della linea a cremagliera di più recente realizzazione: è infatti stata inaugurata nel 2012, anche se ricalca il tratto superiore del percorso dell’antica linea interurbana.
Il tracciato ha origine nei pressi della località Font de l’Arbre, a circa 10 km di distanza dal centro di Clermont Ferrand e, superando un dislivello di 500 metri, arriva quasi in vetta alla quota di 1406 metri senza fermate intermedie con un tracciato di 5,1 km che si avvita a spirale intorno al vulcano. Il binario ha scartamento metrico ed è interamente attrezzato con cremagliera di tipo Strub, con una pendenza massima del 15,5%. L’alimentazione elettrica è in corrente continua alla tensione di 1500 Volt. Il binario è unico, con un breve tratto di raddoppio a metà percorso per l’incrocio dei treni; anche i due capilinea sono a semplice binario. Dal capolinea inferiore, un prolungamento di 200 metri del binario permette di raggiungere il deposito del materiale rotabile, situato poco più a valle. La massima potenzialità della linea è raggiunta in alta stagione, con una frequenza di 20 minuti e due convogli in servizio, formati da due unità accoppiate.
Il materiale rotabile è costituito da quattro elettromotrici articolate bidirezionali a pianale parzialmente ribassato di tipo GTW 2/6 fabbricate dalla casa svizzera Stadler, del tutto simili a quelle in servizio sulla cremagliera spagnola di Montserrat, che possono procedere accoppiate in trazione multipla. Ogni motrice ha una capienza di 200 passeggeri, è lunga 36,4 metri e larga 2,60 metri, con due casse dotate di carrelli portanti raccordate da un carrozzino centrale a due assi fissi motori. Ciascuno dei due assi fissi traziona sia sulle due ruote ordinarie ad aderenza naturale sia su una corona dentata centrale che ingrana sulla cremagliera. Anche un asse di ognuno dei carrelli portanti è dotato di corona dentata, utilizzata solo per la frenatura. La velocità massima è di 24 o 30 km/ora (rispettivamente in discesa o in salita)
IMMAGINI
fig. 1 - TRANVIA DEL PUY DE DÔME / Brochure d’epoca / Un volantino pubblicitario della prima tranvia a vapore: a sinistra è disegnato lo sviluppo dell’intero tracciato / Anni 1900.
fig. 2 - SEZIONE LOCOMOTIVA SISTEMA HANSCOTTE / Disegno da Archives Départementales Puy de Dôme / Il Sistema Hanscotte ad aderenza artificiale: si nota la coppia di ruote orizzontali sotto la locomotiva pressate sulla rotaia centrale / 1907.
fig. 3 - TRANSLHOR A CLERMONT-FERRAND / Foto Roberto Cambursano / Un tram su gomma Translohr in servizio sulla linea A in Place Jaude a Clermont-Ferrand / 2019
fig. 4 - CAPOLINEA INFERIORE “PANORAMIQUE DES DÔMES” / Foto Roberto Cambursano / Il primo tratto di binario in uscita dalla stazione di valle / 2019.
fig. 5 - CONVOGLIO NELLA STAZIONE DI VALLE /Foto Roberto Cambursano / Un convoglio in partenza dalla stazione di valle / 2019.
fig. 6 - RADDOPPIO A META’ PERCORSO /Foto Roberto Cambursano / Il tratto di raddoppio di binario a metà percorso che permette l’incrocio dei convogli / 2019.
fig. 7 - ARRIVO AL PUY DE DÔME” / Foto Roberto Cambursano / Un convoglio in arrivo al capolinea superiore. Sullo sfondo si intravede la città di Clermont-Ferrand / 2019.
fig. 8 - STAZIONE DI MONTE / Foto Roberto Cambursano / Un convoglio in partenza dalla stazione di monte / 2019.
fig. 9 - PANORAMA SUI PUYS / Foto Roberto Cambursano / Panorama sulla catena dei Puys dalla stazione di monte / 2019.

UN TRAM APPESO A UN FILO.....IL CABLE-CAR
di Roberto Cambursano
Il termine “cable-car” è indissolubilmente legato a San Francisco: oltre ad essere stata la prima a metterli in funzione, la città californiana dispone infatti oggi delle uniche tre linee superstiti al mondo, che costituiscono tra l’altro una celeberrima attrattiva turistica, inserita nel “National Register of Historic Places” come patrimonio culturale dell’umanità.
Il “cable-car” è un veicolo su rotaia mosso da una fune metallica sotterranea: a differenza della “funicolare” propriamente detta, i movimenti dei veicoli sono comandati da bordo, e dunque il ca-ble-car non va confuso con altri sistemi anch'essi ancora oggi esistenti (come il “Great Orme tramway” nel Galles e gli “Elevadores” a Lisbona), che sono invece vere e proprie funicolari in quanto i veicoli sono permanentemente agganciati alla fune.
Agli albori della trazione tranviaria, prima dell’affermazione dell’elettricità, questo sistema di trazione meccanica raggiunse un considerevole sviluppo mondiale. La forza motrice era in origine fornita dal vapore prodotto in grandi centrali fisse: da qui le macchine a vapore mettevano in movimento a una velocità costante un complesso sistema di funi, completamente collocate in cavità sotterranee, che si collegavano alle varie linee e quindi seguivano l’asse dei binari, sostenute e guidate da pulegge rotanti. In origine le vetture erano a due assi e potevano trainare un rimorchio, in seguito si diffuse un tipo di vettura più grande a carrelli, detta “combination car” in quanto racchiudeva in un unico veicolo la combinazione di una motrice e di un rimorchio (lo stesso concetto della motrice tranviaria MRS di Roma!).
Il primo cable-car in servizio regolare fu progettato e realizzato da un imprenditore scozzese emigrato a San Francisco, Andrew Smith Hallidie. La storia racconta che l'idea nacque a seguito di un brutto incidente a cui Hallidie aveva assistito in città: quattro cavalli trainavano in salita un pesante carro carico di materiali su una strada in forte pendenza con l'acciottolato reso viscido dalla pioggia, quando uno di essi scivolò e cadde all'indietro; il carro cominciò a indietreggiare tirandosi dietro tutti gli animali che finirono travolti e uccisi. Ispirandosi ai vari sistemi di trazione a fune già sperimentati nel mondo (la prima funicolare completa del mondo, quella della Croix Rousse, era stata inaugurata a Lione nel 1862, mentre già negli anni precedenti erano stati provati con deludenti risultati alcuni primitivi sistemi di ausilio alla trazione ferroviaria che si avvalevano di funi agganciabili dai convogli su alcuni tratti di binario particolarmente ripidi), Hallidie per-fezionò un affidabile sistema di aggancio e sgancio dalla fune in linea che ben si prestava a un servizio di trasporto urbano con fermate frequenti e che garantiva allo stesso tempo un adeguato grado di sicurezza di esercizio.
La prima linea venne inaugurata il 2 agosto 1873 lungo la Clay Street di San Francisco e si dimostrò subito affidabile, tanto da stimolare la nascita di altre linee (le successive furono quella di Sutter Street nel 1877 e quella di California Street, in funzione ancora oggi, nel 1878). La massima espansione della rete di San Francisco fu raggiunta nel 1890 con 23 linee in esercizio su 177 km di rete, mentre il declino cominciò nel 1906 con il devastante terremoto e la seguente ricostruzione che diede avvio a una forte espansione del tram elettrico. Benchè il sistema risultasse parti-colarmente indicato per il superamento di discrete pendenze (come appunto nel caso di San Francisco), ciò non gli impedì di estendersi in città anche totalmente pianeggianti e di soppiantare nell’arco di un ventennio i preesistenti sistemi di tram a cavalli, in particolar modo in America.
Il secondo sistema di cable-car nel mondo fu realizzato a Dunedin, in Nuova Zelanda, nel 1881 (questo, a parte il caso di San Francisco, fu il sistema più longevo al mondo, chiuso nel 1957); seguirono due grandi città americane, Chicago nel 1882 e New York nel 1883. Le più vaste applica-zioni in assoluto si ebbero in America a Chicago (il cui sistema, che vantava già alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento la più estesa rete di cable-car del mondo con 3 compagnie che possedevano 710 vetture e 132 km di binario, fu chiuso già nel 1906 e completamente soppiantato da una ancora più vasta rete tranviaria elettrica) e in Australia a Melbourne (sistema operativo dal 1885 al 1940 con 592 tram circolanti su 74 km di binario).
In Europa invece il cable-car si rivelò poco adatto, a causa del gran numero di curve e della ristrettezza delle vie cittadine, e perciò ebbe pochissime applicazioni: la prima linea europea, quella di Highgate a Londra, venne inaugurata nel 1884 e sopravvisse solo fino al 1909, mentre la seconda linea, quella di Belleville a Parigi, rimase in funzione dal 1891 al 1924. Un sistema di trazione a cavo del tutto analogo al cable-car di super-ficie venne adottato anche sulla “Glasgow Subway”, inaugurata nella città scozzese nel 1896 (terza linea di metropolitana al mondo dopo Londra e Budapest), e rimase in funzione fino al 1935.
Le reti di cable-car furono progressivamente soppiantate dall’avvento del tram elettrico, risultando evidenti gli svantaggi di questo sistema: alti costi delle infrastrutture (cavi e condotte sotterranee, pulegge, motori di trazione a terra), complicazioni di costruzione e di gestione (specie negli scambi e negli incroci), scarsa sicurezza di esercizio, bassa potenzialità di trasporto.
Solo a San Francisco il cable-car riuscì a sopravvivere, anche se solo su una minima parte della vasta storica rete (la prima linea di Clay Street era stata chiusa nel 1941), grazie alla forte volontà popolare culminata in un referendum tenuto nel 1947 in cui venne respinto il progetto di chiusura delle ultime linee superstiti sostenuto dal Comune. Oggi sono operative tre linee di cable-car nella parte alta della città: la Powell-Mason line, la Powell-Hyde line (che hanno un tratto di percorso in comune) e la California line, su cui circolano complessivamente 40 vetture (in parte sono “replica-car”, cioè veicoli costruiti ex-novo con sembianze antiche). Il sistema attuale, completamente rinnovato nel 1984, è composto da una centrale di produzione della forza motrice alimentata da motori elettrici e collegata con un sistema meccanico di pulegge e rinvii a quattro funi di trazione (una per l’intera California line, una per il tratto in comune fra le altre due linee e una per ciascun ramo differenziato delle stesse), che corrono alla velocità costante di 9,5 miglia/ora su una pendenza massima del 21%
Per muoversi o fermarsi lungo la linea, la vettura si aggancia o si sgancia dalla fune situata sotto il piano stradale mediante una pinza (detta “grip”, la cui versione attuale fu perfezionata nel 1880 dal collaboratore di Hallidie William Eppelsheimer), comandata da bordo tramite un sistema di leve; in asse al binario è presente una scanalatura metallica continua che consente lo scorrimento longitudinale del sistema di aggancio. La velocità della fune corrisponde alla normale velocità di crociera delle vetture, che è costante a prescindere dalla pendenza della linea ed è perciò identica in piano, in salita e in discesa; in caso di marcia in piano o in salita, il guidatore (detto più propriamente “gripman”, il “pinzatore”) può decelerare o accelerare al di sotto della velocità di crociera semplicemente tirando la leva di comando con una forza variabile e facendo così variare la pressione di aggancio della pinza sulla fune; le ganasce della pinza sono quindi solidali con la fune solo quando si viaggia alla velocità di crociera, mentre negli altri casi la pinza striscia sulla fune a velocità minore (fino eventualmente a fermarsi o addirittura a scivolare in senso contrario se si trova in salita e la pressione è insufficiente) con l'interposizione di apposite guarnizioni costituite da materiale metallico di consumo; più il tram è carico e più la linea è in salita, maggiori sono le pressioni di aggancio necessarie; in discesa, la decelerazione avviene solo a fune sganciata con l'ausilio dei sistemi frenanti.
Ogni vettura è dotata di ben tre sistemi di frenatura meccanica: un freno a ceppi metallici sulle ruote, un freno a pattini in legno sulla rotaia e un freno di emergenza consistente in un braccio che interagisce con la scanalatura metallica a centro binario; il freno sulle ruote posteriori è comandato dal bigliettaio, che comunica col gripman mediante un sistema di campanelli.
Particolarmente complicati sono gli incroci e gli scambi: nelle intersezioni fra due binari, mentre le due rispettive funi sotterranee non interferiscono in quanto viaggiano ad altezze diverse, possono transitare agganciati alla fune solo i tram che procedono su uno dei due binari (quello che ha la fune che scorre più in alto), mentre le vetture che procedono sull'altro binario devono transitare sull'incrocio per inerzia sganciate dalla fune; gli scambi sono rari e comandati a mano tramite un' apposita leva, sempre posizionati in piano o in discesa: il tram può oltrepassare uno scambio rimanendo agganciato alla fune solo se deve procedere nella direzione principale (normalmente in retta); se invece intende svoltare, deve sganciarsi dalla fune e procedere per inerzia fino ad agganciare l'altra fune che scorre sotto il binario di destinazione.
Le curve sono affrontate con due diversi sistemi: nel primo caso (“pull curve”) la fune segue esattamente la mezzeria del binario in curva tramite una serie di pulegge di rinvio e non è richiesta al gripman nessuna manovra particolare, mentre nel secondo caso (“drift curve”, solo per curve di raggio stretto e solo se la pendenza lo consente) la fune esce dall’asse del binario seguendo le due tangenti della curva e ruota su una puleggia esterna posta all’intersezione delle tangenti stesse: il gripman deve perciò essere molto abile per sganciarsi dalla fune all’inizio della curva e a riagganciarsi alla fine dopo aver proceduto per inerzia.
L’inversione del senso di marcia ai capilinea avviene in due diversi modi. La “California Line” dispone di “combination-car” bidirezionali e quindi tale operazione si attua automaticamente mediante uno scambio di traversa azionato da una molla che, una volta transitato il veicolo in una direzione, riporta gli aghi nella posizione precedente e si predispone per il transito nella direzione opposta; sulle altre due linee sono invece impiegati tram monodirezionali più piccoli, che vengono ruotati di 180 gradi su piattaforme girevoli mosse a mano dal personale di bordo.
IMMAGINI
fig. 1 - PRIMO CABLE-CAR HALLIDIE / Foto Collezione Richard Schlaich / Il primo cable-car progettato da H. S. Hallidie in servizio a San Francisco sulla linea di Clay Street / 1873.
fig. 2 – GRUPPO MOTORE CENTRALE / Illustrazione da “Street Railway Journal” / Centrale a vapore per la movimentazione delle funi del sistema di cable-car a Baltimora / Anni 1880.
fig. 3 – GRIP / Illustrazione da “Street Railway Journal” / La pinza di comando (“Grip”) brevettata da Eppelsheimer per i cable-car di San Francisco / Anni 1880.
fig. 4 - TRAFFICO A SIDNEY / Immagine da archivio Powerhouse Museum NZ / Intenso traffico di cable-car a Sidney / Anni 1900.
fig. 5 – CABLE-CAR A LONDRA / Cartolina d’epoca / Un cable-car a due piani in servizio sulla linea di Highgate a Londra / Anni 1900.
fig. 6 – INCIDENTE A PARIGI / Illustrazione da “Le Parisien” / Uno spettacolare incidente accaduto sulla linea di Belleville a Parigi / 1906
fig. 7 – ULTIMO CABLE-CAR A SEATTLE / Immagine da Seattle Municipal Archives / Un cable-car in servizio sull’ultima linea superstite a Seattle / 1940
fig. 8 – CABLE-CAR OGGI A SAN FRANCISCO / Foto Rossana Conti / Uno storico cable car in servizio sulla linea Powell-Mason a San Francisco / 2018.
fig. 9 - GIRATURA A CAPOLINEA / Foto Toni Fisher-Lic.CC2.0 / Un cable-car viene girato a mano al capolinea della Powell-Mason Line a San Francisco / 2010.

MANCHESTER: DEREGULATION E BANCHINE ALTE
di Roberto Cambursano

CASTELLAMONTE IN SCALA HO
di Roberto Gallo Pecca
Una passione nata molto tempo fa.
L’interesse per le ferrovie in miniatura mi è stato trasmesso da mio padre quale retaggio di una passione che lui, per svariati motivi, non ha mai potuto perseguire se non in maniera molto sporadica. Grazie comunque ai suoi modellini, edifici in miniatura e le innumerevoli riviste del settore ho passato l’infanzia e buona parte dell’adolescenza a montare e smontare, fare e disfare, pseudo plastici ferroviari e a sognare di poter un giorno possedere un plastico come uno di quelli che vedevo e ‘mangiavo con gli occhi’ nelle riviste lasciatemi in eredità. Una volta cresciuto ed ottenuto una maggior consapevolezza dei miei mezzi e delle mie capacità, provando e sperimentando son riuscito a realizzare dei plastici ferroviari e diorami, secondo il mio modesto parere, di tutto rispetto anche se fanno arricciare il naso a certi perfezionisti del settore. La mia passione purtroppo, oltre che di nicchia, è anche discretamente onerosa, ma questa caratteristica alquanto insormontabile per i sogni di un bambino e poi ragazzino ha fatto sì che sin da subito dovessi arrangiarmi con tutto ciò che la mia fantasia e creatività con un minimo di limitatissime finanze potessero permettermi. In tal maniera ho sposato la filosofia del fai da te modellistico utilizzando qualsiasi materiale povero di recupero per poter realizzare i plastici e la maggior parte dei suoi componenti, edifici, piante, lampioni, armamenti ecc. spendendo il meno possibile in base alle mie capacità economiche.
C’era però un piccolo sogno nel cassetto: una grande sfida modellistica!
Ho sempre provato dispiacere per la chiusura del ramo ferroviario della Canavesana tra Rivarolo e Castellamonte; il primo viaggio su un treno era stato proprio su quel tratto e ogni volta che con la mia famiglia andavo a Castellamonte in auto dai miei nonni ammiravo dal finestrino dell’auto quelle rotaie, passaggi a livello, il ponte sull’Orco, le stazioni e gli sporadici passaggi del treno che mi riempivano il cuore di gioia. Fatto ancor più triste che accompagnò la mia infanzia per tale chiusura fu che se ne dovette occupare proprio mio padre che all’epoca rivestiva la carica assessore dei Lavori Pubblici a Rivarolo. A malincuore pose fine alla ferrovia Canavesana SATTI tra Rivarolo e Castellamonte. Col passare degli anni, poco alla volta e poi grazie all’avvento di internet, son riuscito a recuperare materiale documentale e fotografico della tratta ferroviaria. Da qui ho rilevato, ridisegnato e ricostruito graficamente tutti gli edifici ferroviario delle varie stazioni e poi ho stilato un progetto planimetrico del plastico ferroviario con ovvie licenze modellistiche. Per comodità operativa e per una maggior quantità di documentazione ho iniziato prima col realizzare a mano e con tutti materiali di recupero i vari edifici ferroviari della stazione di Castellamonte, dopodiché son passato alla realizzazione dei moduli del plastico partendo ovviamente dalla stazione ferroviaria castellamontese. L’ambientazione riprende l’area ferroviaria nel periodo storico tra gli anni ’60 e gli anni ’80, soprattutto basandomi sulle mie scarne rimembranze. Gli edifici sono stati realizzati partendo dal progetto grafico e utilizzando cartoncino, fogli di plastica, cartoncini ondulati recuperati dagli incarti delle brioches, pezzetti di legno, filo di rame e profilati metallici. Molti di questi materiali sono di recupero, altri ereditati da mio padre che era anche lui un accumulatore seriale di materiali che potessero servire alla causa modellistica. I mattoni dei vari edifici sono stati tutti incisi a mano uno ad uno utilizzando le basi dei pennelli da pittura privati delle setole, così come la pavimentazione a pavé del percorso della filovia Cuorgnè-Ivrea che transitava proprio davanti alla stazione. Le piante sono state realizzate utilizzando un arbusto usato nel modellismo, la Teloxis Aristata, il filo di rame e spezzoni di rametti di pungitopo. Tali piante sono state realizzate utilizzando del ‘fogliame’ modellistico incollato con acqua e vinavil e colla spray. Ovviamente ci sono anche diversi elementi commerciali acquistati apposta per perorare la causa perché in fondo tutto tutto non si riesce mai a realizzare a mano. Il primo modulo realizzato ricostruisce lo scorcio comprendente il fabbricato viaggiatori comprensivo del bar della stazione, il deposito delle locomotive lungo e la piattaforma girevole per poter manovrare la fantomatica T3 a vapore. Le siepi e alcune recinzioni sono commerciali con modifiche personalizzate, così come i personaggi presenti e alcuni piccoli dettagli.
Il modulo è arricchito da lampioni e luci funzionanti auto costruiti e da automatismi quali la piattaforma girevole e gli scambi. Il tutto posa su un pannello sagomato di poliuretano espanso di 5 cm di spessore.
Al momento è in produzione il secondo modulo su cui trova luogo, oltre a tutto il fascio di binari, il caricatore porticato, il magazzino merci, il deposito locomotive piccolo, i bagni e il marciapiede salvagente, che dovrebbe essere pronto a breve.
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook "Plastici-Diorami-Modelli".
Foto Roberto Gallo Pecca

AUTUNNO E SABBIA
di Luca Giannitti
L'autunno è una stagione dai colori molto caldi, le foglie passano dal verde al giallo e poi all'arancione fino ad arrivare al bruno, il sole rende le fronde delle piante quasi dorate e con le giornate ventose i rami si alleggeriscono velocemente di buona parte delle foglie, creandone a terra lunghe distese. Molti binari si trovano lungo i viali alberati e spesso il tram sembra dipinto come in un quadro, bellissimo da vedere ma non per tutti questo spettacolo è così idilliaco.
Il tram ha un rapporto di amore-odio con l'autunno, le foglie che cadono sulle rotaie vengono pressate dalle ruote tanto da diventare una poltiglia che annerisce il metallo e riduce sensibilmente l'aderenza delle ruote, con conseguente peggioramento dell'efficienza dell'impianto frenante. I passeggeri iniziano a sentire il tipico odore di foglie secce bruciate dagli archi voltaici che si iniziano a formare sui binari quando lo sporco rende difficoltoso il passaggio della corrente. Capita anche (raramente) che le foglie siano così secche che si innescano anche dei piccoli incendi. Un altro suono tipico è quello dei pattini elettromagnetici che vengono largamente usati per sopperire agli spazi di frenata maggiori dovuti proprio al binario sporco. In autunno i tram iniziano a sollevare polveroni, un po' dovuti alle foglie sminuzzate, un po' per la sabbia che viene gettata sulle rotaie dalle vetture. La sabbia, a grana grossa, nella giusta quantità con l'ausilio delle ruote produce un effetto abrasivo sulla superficie della rotaia, aiutando a rimuovere la poltiglia nera e incrementando così l'aderenza. Purtroppo dopo alcuni passaggi i granelli vengono anch'essi polverizzati e dopo aver perso la loro efficienza più facilmente vengono dispersi in aria dal vento o dal passaggio delle motrici. I tram hanno un contenitore di sabbia posto in prossimità di ogni carrello, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità, ovvero quando l'aderenza è scarsa ed è difficoltosa la trazione oppure la frenata è problematica e il tram slitta. Nel mese di novembre, per contrastare il problema delle foglie, viene immessa in servizio una motrice speciale che si occupa di "sabbiare" le rotaie e il suo nome è proprio "sabbiera".
La sabbiera è un tram speciale dedicato allo spargimento di sabbia sul binario tranviario in modo da permettere un aumento dell'aderenza tra le ruote dei carrelli ed la rotaia. Nei paesi centro-Europei le sabbiere sono funzionalmente unite ai tram spandisale, cosa che a Torino non è mai stata presente. Nel corso dei decenni, l'azienda municipale di Torino ha avuto tre principali sabbiere, numerate negli anni sessanta 426, 427 e 434 (successivamente ridenominate T426, T427 e T434). Mentre la T434 derivava da una motrice serie 100 (identico al tram storico 116), le altre due derivano da motrici passeggeri della Sbt-Stt (la compagnia Belga) costruite su licenza dalla Diatto nel 1911. Accorpate al parco ATM questi tram avevano ricevuto le matricole della serie 446-500 e la coloritura rosso-crema, quasi subito mutata nel verde in due toni imposto dalle norme governative del 1927. Il servizio passeggeri nel parco ATM durò poco tempo dato che le due vetture erano passate in fretta a compiti di servizio, dopo essere state reimmatricolate 426 e 427. Il loro primo compito era quello di tradotte, ma quasi subito erano state trasformate in sabbiere con l'apertura di un portellone per il carico della sabbia nei tre finestrini centrali. Per tutte le sabbiere, alla prima livrea di servizio (grigia) è seguita l'attuale blu scura con bande diagonali gialle. La T434 e la T426 sono state ritirate dal servizio negli anni Novanta e solo più la T427 presta ancora tutt'oggi servizio. La T434 è stata sommariamente restaurata e portata nel museo di Piana delle Orme (Latina): il restauro l'ha riportata nelle condizioni di tram passeggeri ma si è perso qualunque riferimento alla città di Torino. Invece, la T426 è stata restaurata dai soci ATTS e fedelmente riportata alle condizioni d'origine con la numerazione 209.
La T427 è stata totalmente ricostruita nel 1989, quando la cassa originaria in legno è stata modificata e sostituita da una nuova in lamiera che ne ha notevolmente mutato la fisionomia. Il futuro prevede per questo tram ancora qualche anno di servizio prima del pensionamento.
In foto la T427 ripresa a Sassi (1), in piazza Statuto (2) e in corso Tassoni (3). Vista interna (4) e dei macchinari di bordo (5) infine un'immagine di un binario sporco di poltiglia di foglie schiacciate (6).
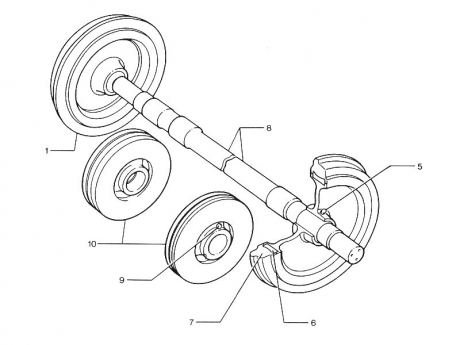
COME FARE A MENO DEL DIFFERENZIALE
di Luca Giannitti
I tram sono veicoli molto particolari e tra le tante peculiarità ve n'è una che ben pochi conoscono: i tram sono in grado di fare a meno del differenziale!

Le motrici dotate di carrelli o truck tradizionali hanno le ruote di uno stesso asse rigidamente collegate tra loro, quindi ruotano sempre alla medesima velocità, ma come si comportano in curva? I veicoli su gomma, come le automobili o gli autobus, hanno il differenziale (immagine in alto) che rende indipendenti le ruote una dall'altra, in modo che nelle curve possano compiere un numero diverso di giri dato che percorrendo una traiettoria non rettilinea la ruota interna compie meno strada di quella esterna. I tram no, non hanno nessun differenziale e quindi come compensano il diverso sviluppo delle due rotaie?
In curva le due ruote di un medesimo asse devono percorrere distanze diverse, poiché i raggi delle due rotaie differiscono dello scartamento, per cui la ruota esterna si trova su una traiettoria con un diametro maggiore. Per evitare i conseguenti scorrimenti e le elevate forze d’attrito che ne deriverebbero per l'assenza di un differenziale, sveliamo ora il segreto che rende le ruote dei tram uniche nel loro genere: i cerchioni delle ruote si sviluppano su superfici tronco-coniche!

La conicità nell’intorno della circonferenza di rotolamento varia in base alla tipologia di linea, maggiori sono le velocità, minore è la conicità. Sulle linee convenzionali come quelle tranviarie o ferroviarie tradizionali la conicità ha un rapporto compreso tra 1:10 e 1:20 (a Torino i tram utilizzano una conicità pari a 1:20); sulle linee ferroviarie ad alta velocità le conicità aumentano fino a 1:40 - 1:50.
Per effetto della forza centrifuga generata dalla curva, il tram viene spinto verso l’esterno e ciò ha come effetto che il punto di contatto della ruota esterna si sposta nella parte in cui ha un raggio di rotolamento maggiore (verso la base del tronco di cono) mentre la ruota interna si sposta su un raggio di rotolamento minore (verso la punta del tronco di cono): il bordino rappresenta quindi il "fine corsa", il punto oltre il quale la ruota non può più spostarsi trasversalmente. Con raggio minore per la ruota interna alla curva e raggio maggiore per la ruota esterna alla curva, a parità di giri delle ruote, lo spazio percorso risulta proporzionale al raggio di rotolamento.
In ogni caso, lo scartamento nominale in curva passa da 1445 mm a 1450 mm: questo incremento è strettamente legato ai movimenti trasversali della ruota tranviaria e ne facilita il comportamento in curva. Inoltre per ottenere un elevato comfort di marcia, i tratti di binario curvo non sono a raggio costante ma a raggio variabile nel passaggio rettifilo-curva circolare o nei raccordi di continuità. Questi raccordi di transizione sono anche detti clotoidi: con clotoide si indica una curva la cui curvatura varia linearmente lungo la sua lunghezza, studiata per la prima volta probabilmente dal matematico Bernoulli nel XVII secolo. La rete tramviaria torinese presenta raccordi di transizione fra curva e rettilineo (si è adottata una policentrica di Searles o spirale Lorraine-Allen) per i raggi più stretti, compresi fra 15 e 60 m, mentre non sono presenti raccordi di transizione per le curve a raggio superiore.
Quindi la forma della ruota, l'allargamento dello scartamento e lo sfruttamento della fisica (per la forza centrifuga) permettono al tram di fare a meno del differenziale, una peculiarità specifica dei veicoli su ferro!
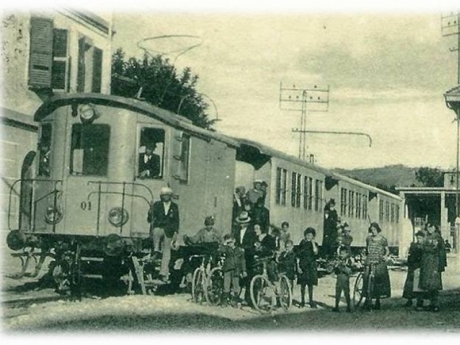
LA TRANVIA MONCHIERO - DOGLIANI
di Davide Fenoglio
In passato lo sviluppo delle reti tranviarie interurbane era molto esteso e non solo limitato alle aree intorno alle città più grandi. Molto spesso i centri rurali erano collegati alle linee ferroviarie principali tramite tranvie o ferrovie economiche, nate, in diversi casi, per agevolare il trasporto delle merci dalla campagna alle città o verso i centri di smistamento ferroviari. Una tranvia di questo tipo è quella collegava Monchiero, sulla ferrovia Torino- Bra-Ceva-Savona, con Dogliani.
Fu classificata "tranvia" per l’utilizzo di una sede promiscua su gran parte del percorso. Tranviarie sono anche la tensione di alimentazione e la presa di corrente ad archetto dei locomotori, mentre gli organi di aggancio del materiale rotabile sono tipicamente ferroviari per consentire l’invio dei carri merci sulla rete FS.
Dogliani è una cittadina di oltre 4.500 abitanti nella Langa cuneese. È ricca di storia e di testimonianze artistiche e si caratterizza come importante centro agricolo e commerciale. Ha dato i natali a personaggi illustri tra i quali il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. All’epoca dello sviluppo delle prime vie di comunicazione molti progetti di ferrovie tradizionali o economiche hanno interessato il territorio cittadino, ma nessuno alle fine si è concretizzato. La stessa linea ferroviaria Torino – Savona, nel suo primo itinerario via Bra, aveva escluso il transito da questo comune privilegiando l’itinerario lungo il fondovalle del Tanaro tra Farigliano e Monchiero. Perciò, a partire dagli anni Dieci del Novecento, iniziano a svilupparsi idee e progetti riguardanti il collegamento con la stazione FS di Monchiero, soprattutto per agevolare l’inoltro delle merci via ferrovia. Per questo motivo venne deciso fin da subito l’utilizzo dello scartamento ordinario. Inizialmente si immaginava anche l'utilizzo di locomotori ad accumulatori (progetto del 1914-1916).
Nel giugno 1916 la Deputazione provinciale di Cuneo diede parere favorevole all’utilizzo della strada di sua competenza e nell’ottobre dello stesso anno il Consiglio Provinciale approvò il contributo economico, ma la Prima Guerra Mondiale inevitabilmente bloccò il progetto. Solo il 13 settembre 1920 fu costituita la Società Anonima per l’esercizio della Tranvia Elettrica Monchiero-Dogliani (SATED) e successivamente furono formalizzati tutti i passaggi burocratici necessari per la costruzione della linea che iniziò nell’ottobre 1921 e terminò con l’inaugurazione il 5 agosto 1923.
La linea, lunga poco più di 5 km, fu costruita quasi completamente in sede promiscua sulla strada provinciale ed alimentata a 600 Volt. Lo sviluppo altimetrico procedeva dai 235 m slm di Monchiero ai 295 m di Dogliani con la livelletta più ripida al 35%. In totale erano presenti 5 fermate intermedie ed il tempo di percorrenza era di circa 20 minuti. La fermata “Segheria” era dotata di binario di carico e raccordo per la fornace di San Rocco e l’adiacente impianto di lavorazione del legname. Anche la fermata “Cascina Pieve Sottana” era dotata di binario di raddoppio con piano caricatore. Il traffico merci era in prevalenza alimentato dal trasporto di carbone per alcune fornaci e per una distilleria, dal legname destinato al taglio per le segherie di Dogliani, da vino, materiali edili ed agricoli, principalmente legati all’attività di un mulino.
La stazione di Monchiero aveva quattro binari, di cui uno raccordato con l’adiacente stazione FS e una piccola rimessa. Ben più ampia era la stazione di Dogliani, alla quale si accedeva attraverso un cancello. Era dotata di un piano di carico, una rimessa con tre binari ed una sottostazione di conversione dell’energia elettrica da trifase a continua. Analogo macchinario era presente nella stazione di Monchiero.
Il materiale rotabile era costituito da due locomotori elettrici a 2 assi di forma squadrata, con testata poliedrica, costruiti dal TIBB di Vado Ligure nel 1923. Erano dotati di doppi respingenti e gancio a maglia con tenditore del tipo ferroviario. La presa di corrente avveniva tramite archetto tranviario e la velocità massima era pari a 40 Km/h. Il materiale trainato era costituito da 4 carrozze a due assi a terrazzini di colore verde vagone (due di sola terza classe e due miste seconda-terza) e da diversi carri merci (carri chiusi, a sponde alte e basse). Una delle carrozze passeggeri si salvò, dal momento che fu acquistata da un privato per essere trasformata in casetta per vacanze da porre in un terreno di campagna. Fu scoperta e recuperata dal Museo Ferroviario Piemontese che tuttora la preserva in attesa di un futuro restauro.
La linea visse tra alti e bassi fino alla Seconda Guerra Mondiale quando il servizio, gestito con i soli locomotori dotati di panche per i passeggeri, fu prolungato sulla linea FS da Monchiero fino al ponte di Narzole in seguito all’interruzione della stessa causata dai danni bellici patiti dall’infrastruttura.
Nel 1948 una disastrosa alluvione danneggiò parzialmente anche la linea, che però fu ripristinata e tornò in servizio qualche anno dopo. In quell’epoca, per modernizzare la tranvia, si ipotizzò anche l’acquisto e la messa in servizio di un tram bidirezionale dall’ATM Torino, poi non concretizzatasi.
Nei primi anni Cinquanta l’infrastruttura e gli impianti erano piuttosto degradati. La concorrenza delle autolinee e la diffusione del traffico privato contribuirono, come avvenne in tutta Italia in quel periodo, alla fine della nostra linea, la cui ultima corsa fu effettuata il 31 gennaio del 1956.
Se fosse sopravvissuta fino ad oggi sarebbe bello immaginare un servizio con materiale storico in un territorio che ormai è meta consolidata del turismo internazionale, magari recuperando a tale scopo parte della ferrovia Bra-Ceva, dismessa dal 1994.
Le immagini e le informazioni sono tratte dal grandissimo lavoro di ricerca di Paolo Guglielminetti, autore del volume “Il Sogno dei padri” edito dagli Amici del Museo “Giuseppe Gabetti” di Dogliani nel 2013.

NOVITA' TRANVIARIE DAL MONDO
di Roberto Cambursano
Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo, intervenute nel periodo dicembre 2019-novembre 2020. Sono evidenziate in giallo le “nuove città tranviarie” e in azzurro le reti soppresse. Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Railway Gazette International; Urbanrail.net.
Aggiornamento al 1° dicembre 2020
AUSTRALIA
SIDNEY (New South Wales): il 14 dicembre 2019 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria (L2) da Circular Quai a Randwick. Il tracciato si sviluppa su 7,3 km e incrocia la preesistente linea L1 alla Stazione Centrale.
Il 3 aprile 2020 è stata inaugurata la terza linea (L3) da Circular Quai a Juniors Kingford, che sfrutta un nuovo tratto di linea di 3,2 km.
La rete tranviaria di Sidney ha raggiunto uno sviluppo di 24,7 km, con una flotta di 72 tram a pianale interamente ribassato (12 CAF Urbos3+60 Alstom Citadis 305). Su un tratto centrale di 2 km, comune alle linee L2 ed L3, non è presente la catenaria e i tram usano il sistema APS.
AUSTRIA
VIENNA: Il 2 dicembre 2019 la linea D è stata prolungata su un nuovo tratto di 1,1 km da Hauptbahnhof Ost a Absberggasse, dove incontra le linee 6 e 11.
Il 3 ottobre 2020 la linea O è stata prolungata su un nuovo tratto di 0,8 km da Nordbahnstrasse a Bruno-Marek-Allee.
La grande rete tranviaria della capitale austriaca conta oggi 28 linee urbane e ha un’estensione totale di 167 km (+28 km della linea interurbana per Baden).
BELGIO
ANVERSA: l’8 dicembre 2019 è stato inaugurato un nuovo tratto di 3,5 km da Stadspark a Havenhuis, utilizzato dalle linee 1(nuova linea) e 24. La rete tranviaria di Anversa conta attualmente 14 linee e 89 km di sviluppo (di cui 11 km in sotterraneo con sistema “pre-metro”).
CECA, REPUBBLICA
PILSEN: Il 16 dicembre 2019 è stato inaugurato un prolungamento di 1,4 km della linea 4 da Bory a Univerzita.
CINA
CANTON (Guangdong): il 1° luglio 2020 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria, al servizio del quartiere di Huangpu nella periferia nord-est; la lunghezza della prima tratta è di 7,7 km; sono impiegati tram a pianale totalmente ribassato dotati di supercapacitori; tutta la linea è sprovvista di alimentazione aerea.
CHENGDU (Sichuan): Il 27 dicembre 2019 è stata completata la sottorete tranviaria nella zona nord-ovest, con l’inaugurazione di tre nuovi tratti di linea per complessivi 25,6 km. La rete tranviaria ha raggiunto una estensione complessiva di 39,2 km su due linee; la flotta dei tram in servizio è formata da 40 tram lunghi 33 metri a pianale totalmente ribassato di tipo Citadis 302 costruiti in loco dalla CRRC su licenza Alstom.
FOSHAN (Guangdong): il 30 dicembre 2019 è stata inaugurata la prima linea di questa grande città attigua a Canton, che è diventata la diciottesima città tranviaria cinese. Il primo tratto, da Zhihu a Cangjiang Road, è lungo 6,6 km. Vi fanno servizio tram allestiti dall’aziende cinese CRRC su modello Skoda 15T, che montano batterie integrate con fuell-cells a idrogeno.
SANYA (Hainan): il 10 ottobre 2020 la linea tranviaria esistente è stata prolungata di 4,5 km da Jiefang Road a Jangang Road. I piani di sviluppo prevedono una rete di quattro linee tranviarie per complessivi 60 km, totalmente senza catenaria.
MENGZI (Yunnan): il 1° ottobre 2020 è stata inaugurata la prima linea tranviaria. Il primo tratto, che collega la stazione ferroviaria di Mengzi-Nord con la stazione degli autobus, è lungo 13 km e vi fanno servizio 34 tram forniti dalla CRRC, a pianale interamente ribassato e dotati di supercapacitori per la ricarica delle batterie in fermata. La linea è totalmente sprovvista di catenaria.
SHANGHAI: Il 30 dicembre 2019 la linea T1 è stata prolungata di 3,9 km da Jinxi Road a Xinqiao Railway Station. La sottorete tranviaria nella zona sud-ovest ora ha una estensione complessiva di 34 km e comprende due linee. La flotta in servizio è formata da 30 tram a pianale totalmente ribassato di tipo Citadis 402 costruiti in loco dalla CRRC su licenza Alstom. La più grande metropoli cinese dispone anche di una linea di “tram su gomma” (sistema Translhor), in funzione dal 2010 nel quartiere di Zhangjiang alla periferia est. Tutte le linee tranviarie hanno funzione di adduzione alla vasta rete di metropolitana, la cui costruzione ebbe inizio nel 1995 e che oggi conta 17 linee sviluppate su oltre 600 km.
TIANSHUI (Gansu): il 1° maggio 2020 è stata inaugurata la prima linea della diciannovesima città tranviaria cinese. Il primo tratto in esercizio, dalla Stazione ferroviaria a Wulipu, è lungo 12,9 km. Vi fanno servizio 17 tram a pianale interamente ribassato forniti dall’azienda cinese CRSC (al suo debutto sulla scena tranviaria) che montano supercapacitori. La linea aerea è completamente assente.
ECUADOR
CUENCA: Il 25 maggio 2020 un nuovo paese tranviario ha fatto la sua comparsa sulla scena, con l’inaugurazione della linea tranviaria della città di Cuenca, lunga 10,7 km e parzialmente dotata di sistema APS. Sono in servizio 14 tram Alstom “Citadis 302” a cinque casse, a pianale interamente ribassato e lunghi 32,4 metri.
FRANCIA
BORDEAUX: Il 29 febbraio 2020 la linea D è stata prolungata da Mairie de Bouscat a Eysines-Cantinolle, su un tratto di nuova costruzione lungo 5,5 km.
La rete tranviaria di Bordeaux è composta ora da quattro linee e, con uno sviluppo complessivo di 75 km, è la seconda rete urbana di Francia per estensione dopo Parigi. Il parco rotabile è composto da 130 motrici a pianale interamente ribassato tipo Alstom Citadis 302/402, dotate di sistema APS.
NIZZA: il 14 dicembre 2019 la linea T2 è stata completata con l’apertura al pubblico della tratta sotterranea da Jean Médecin a Port Limpia di 1 km. La rete tranviaria di Nizza si sviluppa ora complessivamente su 25 km e conta 3 linee.
PARIGI: Il 14 dicembre 2019 è stata inaugurata una diramazione lunga 4,7 km della linea T4 da Gargan a Arboretum. La linea T4 è gestita da SNCF con materiale rotabile tipo tram-treno ed è stata aperta al traffico nel 2006 su un tratto ferroviario in disuso lungo 7,9 km tra Bondy e Aulnay, nella Banlieue nord-est della capitale francese. Il 31 agosto 2020 la linea T4 (Tram-treno) è stata ulteriormente prolungata di 0,9 km da Arboretum a Hôpital de Montfermeil, su una tratta a binario unico.
La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 128 km ed è composta da nove linee gestite in modo indipendente (e non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono una linea urbana tangenziale, quattro linee periferiche, due linee di tram su gomma e due linee di tram-treno.
STRASBURGO:Il 29 agosto 2020 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,7 km da Faubourg National a Comtes, sul quale è stata instradata la linea F. La rete tranviaria di Strasburgo è composta da sei linee (di cui una internazionale che arriva in Germania a Kehl) e ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 50 km.
TOLOSA: il 31 agosto 2020 la linea T1 è stata prolungata di 0,8 km da Aéroconstellation a Meett.
GERMANIA
BOCHUM (Nord Renania-Westfalia): il 1° novembre 2020 è stato inaugurato un nuovo tratto di rete tranviaria alla periferia est fra Langendreer Markt e Papenholz, percorso dalle linee 309 (linea di nuova istituzione) e 310, che sostituisce un tratto dismesso tra Unterstrasse e Papenholz (che era a binario unico e attraversava una zona boscosa).
La rete di Bochum/Gelsenkirchen è formata attualmente da 9 linee tranviarie con scartamento di 1000 mm e da una linea di Stadtbahn con scartamento 1435 mm. Entrambe le sottoreti hanno tratti sotterranei e tratti in superficie. La rete di Bochum totalizza 99 km ed è fisicamente collegata a quella di Essen tramite altre due linee provenienti da quest’ultima città. A sua volta, Essen è collegata ad altre reti tranviarie a formare l’agglomerazione Reno-Ruhr, il cui sviluppo totale raggiunge i 450 km.
KARLSRUHE (Baden-Würrtenberg): il 28 novembre 2020 la linea 2 è stata prolungata su un tratto di nuova costruzione (lungo 1,6 km) alla periferia nord, da Siemensallee a Knielingen Nord. Karlsruhe dispone di una smisurata rete interurbana di 565 km che, sommata a una rete urbana di 77,5 km, forma la più grande agglomerazione tranviaria del mondo.
LETTONIA
DAUGAVPILS: il 5 febbraio 2020 la linea 3 è stata instradata su un percorso di nuova realizzazione fra Bralu Kapi e Stropu Ezers, lungo 2,2 km a binario unico. La rete tranviaria, a scartamento largo “russo” (1524 mm), è composta da 3 linee ed ha un’estensione totale di 27 km.
PAESI BASSI
UTRECHT: il 16 dicembre 2019 è stata inaugurata la linea 22, lunga 7,5 km, dalla Stazione Centrale a Science Park. Questa nuova linea è servita da tram a pianale interamente ribassato di tipo CAF Urbos3 ed è per il momento scollegata dalle altre due linee esistenti (60 e 61), che sono gestite con materiale a pianale alto con caratteristiche di “Sneltram” (l’equivalente della Stadtbahn tedesca). E’ previsto nei prossimi anni l’abbassamento delle banchine alte della rete di Sneltram e l’unione con la linea 22.
POLONIA
DANZICA: il 30 giugno 2020 è stato inaugurato un nuovo tratto di 3,2 km da Migowo a Lawendowe Wzgórze, che costituisce il prolungamento della linea 12. La rete tranviaria di Danzica è composta da 10 linee e ha un’estensione totale di 58 km.
POZNAN: il 1° settembre 2020 è stato inaugurato un nuovo tratto di 0,7 km da Zegrze I a Unii Lubelskieij, che costituisce il prolungamento della linea 5. La rete tranviaria di Poznan è composta da 18 linee e ha un’estensione totale di 69 km.
STETTINO: il 25 luglio 2020 la linea 3 è stata prolungata da Las Arkonski a Rondo Olszewskiego su un nuovo tratto di 1,5 km. La rete tranviaria di Stettino è composta da 12 linee e ha un’estensione totale di 52 km.
QATAR
DOHA: Il 24 dicembre 2019 è stato inaugurato il primo tratto di 2,2 km della sottorete tranviaria “Education City”, destinata a raggiungere un’estensione totale di 11,5 km e situata nella zona universitaria alla periferia ovest della città, con funzione di adduzione alla “Green Line” di metropolitana. Sono in servizio 19 tram Siemens Avenio a pianale interamente ribassato lunghi 27,7 metri ed equipaggiati con il sistema “Sitras” a supercapacitori. Tutta la linea è completamente sprovvista di catenaria.
REGNO UNITO
BIRMINGHAM (Inghilterra): l’11 dicembre 2019 la linea tranviaria esistente (“West Midlands Metro”) è stata prolungata nel centro cittadino da Grand Central a Library/Centenary Square. Il nuovo tratto comprende due fermate ed è completamente senza catenaria, essendo percorso a batteria (i tram in servizio sono CAF Urbos3 retrofittati).
MANCHESTER (Inghilterra): il 22 marzo 2020 è stato inaugurato un nuovo tratto di rete tranviaria lungo 5,5 km da Pomona a Trafford Centre. Per il momento è gestito come navetta da Cornbrook a Trafford Centre. Quella di Manchester è l’unica rete tranviaria di grandi dimensioni nel Regno Unito: si sviluppa su 98,5 km e conta 9 linee, con un parco rotabile circolante totalmente omogeneo (Bombardier M5000 a pianale alto, ora in numero di 120 ma che diventeranno 147 entro il 2020)
ROMANIA
BOTOSANI: dal 1° agosto 2020 il servizio tranviario è stato soppresso per obsolescenza e sostituito con autobus. La rete era stata inaugurata nel 1991 e si sviluppava su 7 km con due linee.
RUSSIA
MAGNITOGORSK: Il 31 dicembre 2019 è stato attivato un nuovo tratto di linea di 2,2 km fra Pros. Karla Marksa/ul. Truda e Zelenyi Log. L’importante rete tranviaria della città siberiana conta ora 37 linee ed un’estensione complessiva di 73 km.
SPAGNA
VITORIA/GASTEIZ: il 15 febbraio 2020 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,4 km da Angulema a Universidad. La rete tranviaria del capoluogo basco si compone di due linee a scartamento metrico per un totale di 9,5 km di rete.
STATI UNITI D'AMERICA
SAINT LOUIS (Missouri): Il 29 dicembre 2019 la linea tranviaria storica “Delmar Loop” è stata soppressa per insufficiente redditività economica. Era stata inuaugurata poco più di un anno prima ed era lunga 3,5 km.
TAIWAN
TAIPEI: Il 15 novembre 2020 è stata inaugurata una diramazione tranviaria di 2,4 km da Binhai Shalun a Tamsui Fisherman’s wharf ed è stata istituita una seconda linea (“Blue coast line”) della sottorete “Danhai Light Rail” situata nel quartiere di Tamsui alla periferia nord della capitale.
INDUSTRIA TRANVIARIA
Ad inizio 2020, Alstom ha reso nota la sua intenzione di acquisire la divisione materiale ferroviario di Bombardier, che sta vivendo una grave crisi finanziaria. La Commissione Europea ha dato parere favorevole a luglio. Ad operazione avvenuta, entro il 2021, Alstom diventerà la seconda azienda costruttrice al mondo (ma comunque grande solo la metà della cinese CRRC).

IL GRANDE PLASTICO IN SCALA H0 DELL’ATTS
di Gruppo Modellismo ATTS
Fra le tante attività dell’ATTS il modellismo riveste un ruolo importante coinvolgendo molti soci e declinandosi in vari aspetti. In quest’articolo approfondiremo le caratteristiche, le tecniche e la storia costruttiva del plastico tranviario in scala "HO", che nasce da oltre dieci anni di esperimenti ed è realizzato in modo modulare, ovvero ogni socio, può unire il proprio lavoro a quello degli altri, formando un diorama di grandi dimensioni con molteplici possibilità di esercizio.
La sua particolarità è la costruzione integralmente artigianale perché i tram non hanno mai avuto grossa considerazione da parte dei produttori di treni in miniatura, specie in scala H0 (1:87). Può raggiungere i 13 metri di estensione assemblando tutti i moduli finora realizzati.
Il plastico, rappresenta uno scenario urbano di fantasia ma ispirato ad ambientazioni realmente esistenti. Il capolinea del Gerbido esiste anche al vero, ma è solo automobilistico. L’adiacente "museo del tram" è ispirato al fabbricato della tranvia Sassi-Superga e alla rimessa tranviaria di Cuneo. Il deposito, uno dei moduli più scenografici (grazie ai "pettini" che permettono l’ingresso e l’uscita dei tram dal fabbricato a tre binari) riprende la vecchia struttura della tranvia Torino-Rivoli a Collegno. I moduli di piazza Statuto, ne riproducono la disposizione degli anni ’40. Visto che la maggior parte dei moduli rappresenta, con le dovute licenze modellistiche, un angolo di realtà, l'unica strada percorribile era quella dell’autocostruzione degli edifici in modo da renderli il più possibile aderenti al vero. La chiesa del Gerbido è realizzata in Forex mentre il "museo del tram" è di cartone vegetale tagliato al laser: questa tecnica permette di tagliare in modo preciso ed economico tutte la parti dell’edificio, specialmente quelle con parti curve. La decorazione finale è stata fatta con accessori del commercio e qualche piccola fotoincisione dedicata (come ad esempio le finestre). L'asfalto è realizzato con la malta che si usa per riempire le fughe delle piastrelle: granulometria e colore sono perfetti. Esso viene posato in polvere su una base di colla uniformemente stesa sulla superficie da coprire. Recentemente è stata realizzata la segnaletica stradale orizzontale. Altri moduli ritraggono scene di vita cittadina: un animato mercato con banchi di frutta e verdure, una piazza aulica con al centro una fontana, parchi giochi, capilinea di autobus, distributori di benzina: insomma tutto quello che non può mancare in un ambiente urbano.
I tre moduli che rappresentano un viale con i binari hanno poi una storia particolare. Nel 1978 l'ATM di Torino aveva allestito un bus a due piani come "mostra bus" con l'intento di spiegare ai cittadini possibilità e prospettive della rete dei trasporti. All'interno del mezzo era stato esposto un plastico che anticipava la struttura che avrebbero avuto i nuovi corsi: corsie riservate, fermate con pensilina, banchine sotto le alberate. Questo diorama dopo vari giri all'interno dell'azienda, è stato recuperato dall'Atts che ne ha restaurato i pregevoli edifici per creare tre nuovi moduli con palazzi in stile barocco, raffiguranti un tipico viale torinese. Recentemente è stata realizzato un modulo angolare con la facciata di una villa che consente di disporre l’intero plastico a “L” anziché in lunghezza. In questo modo si risolvono i problemi di spazio e si creano configurazioni differenti. Altri moduli via via si aggiungono anche con sviluppo non rettilineo, ma disposi perpendicolarmente agli altri come il vecchio capolinea con la trattoria.
Per quanto riguarda il tracciato, la linea a doppio binario corre sul bordo dei moduli (dal lato del pubblico) per poi addentrarsi nei moduli in corrispondenza di capolinea, deposito, museo, cappi di inversione, ecc. Questa scelta è stata presa per evitare tracciati ad anello che sono poco realistici specie nel mondo tranviario. Vista l’assenza in commercio di binari adatti all’uso tranviario, gli stessi sono ottenuti tramite la fotoincisione di una lastrina di ottone spessa 0,7 mm; nella lastra sono inclusi tratti rettilinei, curvi, scambi, incroci e tutte le parti che permettono di realizzare le configurazioni più disparate, tra cui scambi compenetrati, in curva o tripli. La precisione estremamente elevata della fotoincisione ha permesso di realizzare un impianto altamente affidabile e a prova di deragliamento. Le varie parti foto-incise sono semplicemente incollate sul basamento del plastico, senza la necessità di traversine o altri sistemi di aggancio. Il raggio minimo delle curve è 180 mm, corrispondenti in scala a circa 15,5 metri reali. Una misura davvero tranviaria, pensando che a Torino il raggio minimo della rete è di 15 metri. Agli inizi, però, i binari a gola erano realizzati saldando le classiche rotaie "codice 100" su traversine in vetronite ramata, costruendo con questa tecnica anche scambi e incroci. Per quanto funzionale, questa tecnica era estremamente lunga da applicare, per cui si andò alla ricerca di altre soluzioni, trovando oltreoceano binari, scambi e incroci con rotaie Phoenix (con gole), prodotti dall’americano Richard Orr. Per quanto permettessero di realizzare diverse configurazioni, la qualità di marcia non era soddisfacente e così si tornò a studiare nuove alternative finché non si è giunti all'idea della fotoincisione.
Poiché era estremamente difficile isolare le rotaie, specialmente in corrispondenza di scambi e incroci, si è deciso di realizzare una linea aerea funzionante che, insieme al binario, costituisse uno dei due poli di alimentazione dei modelli. Il filo di contatto è realizzato da un tondino di ottone da 0.7 mm di diametro, sostenuto da supporti da 0.5 mm. La palificazione è composta da più tipi: dai classici pali a sezione cilindrica ottenuti grazie a tubetti di ottone da 2 e 3 mm di diametro e da pali a traliccio realizzati tramite fotoincisione. Non mancano i portali liberty della Sommerfeldt e altri autocostruiti. I primi tram prendevano corrente grazie ad un pantografo o archetto, ma anche questo aspetto è stato migliorato. Oggi infatti la maggior parte dei tram prende la corrente tramite l’asta, altra peculiarità del plastico. Per permetterne lo scorrimento è stato necessario rifare tutta la linea area interponendo dei distanziali fotoincisi tra linea di contatto e filo di supporto: in questo modo la rotella (in realtà sostituito da un pattino, come quello dei filobus) può scorrere liberamente lungo il cavo. In corrispondenza dei deviatoi è stato necessario inserire uno scambio aereo realizzato esattamente come quelli reali.
Riguardo al materiale rotabile anche in questo caso il commercio è avaro di modelli di tram, con qualche rara eccezione: ottime sono le Peter Witt prodotte dalla Spectrum-Bachmann e i tram tedeschi della Kato. Ma l’unico modo di vedere tram italiani era autocostruirli. I primi esperimenti sono realizzati con carrozzerie in plasticard e motorizzazioni Bec-kits, ma le soddisfazioni arrivarono ancora dalla fotoincisione: grazie a questa tecnica i modelli hanno raggiunto un livello di dettagli superlativo, e con le meccaniche austriache della Halling hanno una marcia estremamente regolare. Il tetto, per contro, è realizzato mediante la clonazione con resine di un master realizzato a mano, ma che negli ultimi modelli è stato ottenuto mediante stampa 3D. Oggi sono presenti svariati modelli di tram di Torino, ad assi, a carrelli e articolati oltre al tram di Napoli tipo ‘Meridionale’ di produzione ModelTramTorino e Mr.Hobby. Inoltre è in funzione qualche modello di Milano della N3C. La collezione, come è facile immaginare, è destinata ad espandersi sempre più.
Il plastico è controllato digitalmente tramite un sistema che consente la circolazione contemporanea di oltre 10 mezzi che accelerano e frenano in modo realistico e percorrono linee prestabilite. Anche questo aspetto, come tutto il resto del plastico, ha avuto notevoli sviluppi dagli albori ad oggi. Inizialmente la gestione era analogica, ma questo era un grosso limite per la difficoltà di sezionare i binari e realizzare delle tratte isolate in cui fermare le vetture. Durante le manifestazioni ci si era resi conto che 2-3 tram in movimento non erano più sufficienti su un plastico di dimensioni ormai notevoli. Per questo motivo si è passati a un dispositivo di controllo digitale, che permettesse accodamenti realistici ai capolinea o nel deposito mantenendo semplice la struttura dell'impianto. La scelta del sistema di controllo è ricaduta sulla centrale digitale Claudia CS realizzata da Nuccio Raneri che la fornisce anche in kit di montaggio. La centrale riceve degli impulsi dai 32 sensori di assorbimento collocati sottoplancia nel plastico, li trasmette al PC dove il software di controllo (Rocarail) li elabora e rinvia alla centrale i comandi per ogni tram e scambio. In questo modo è possibile avere in movimento, in contemporanea sul tracciato, anche 10 tram che accelerano e frenano in modo realistico e percorrono delle linee prestabilite. Il sistema funziona con il principio del blocco automatico: il tram non può entrare nel blocco successivo se questo è occupato. Il software però consente di creare degli itinerari che consistono in serie blocchi, "le linee", e di inserire fermate temporizzate, accensione delle luci, rallentamenti, e di simulare precedenze nel caso, ad esempio, di svolte a sinistra. Tallone d’Achille di tutto il sistema è lo sporco: la presa di corrente da linea aere è molto sensibile, specialmente per i tram con l'asta. La soluzione trovata è quella di installare a bordo di ogni vettura un gruppo di condensatori che accumulano energia comportandosi come dei gruppi di continuità in caso di mancata captazione di corrente, permettendo alla vettura di superare i punti sporchi senza fermarsi.
Il plastico è stato esposto in fiere nazionali ed internazionali (Arcamodellismo, GrugliascoFest, Prossima Fermata Candelo Hobby Model Expo Novegro, Model Expo Italy Verona) dando lustro all’ATTS e alle sue attività. Di particolare importanza è stata la presenza alla “Klein Bahn Ganz Groβ” organizzata a Monaco nel 2019, manifestazione dedicata esclusivamente al modellismo tranviario che si tiene ogni anno in Germania.
Il lavoro dei soci Atts si è evoluto anno dopo anno. Sembra davvero ieri che si tracciava a matita l’asse del binario sulla plancia del primo modulo, ma le idee per il futuro sono molte: dagli indicatori di direzione funzionanti agli stop, passando per le microtelecamere sui tram per finire con l’ampliamento dei percorsi e dei moduli realizzati.
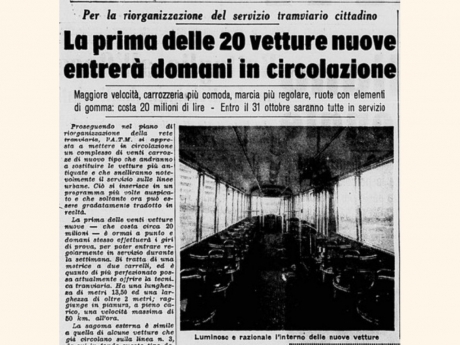
IL SERVIZIO TRANVIARIO A TORINO NEL SECONDO DOPOGUERRA
di Mauro Pellegrini
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che ebbe gravi ripercussioni sul servizio tranviario torinese, sia a causa dei bombardamenti, con conseguente distruzione di depositi e vetture, sia per la mancata o scarsa manutenzione dell’infrastruttura, nella seconda metà degli anni ’40 la città iniziò un lungo processo di ricostruzione, che non poteva prescindere dalla riorganizzazione della rete tranviaria. In quel periodo l’opinione pubblica lamentava i disservizi quotidiani di un sistema, che a fronte della popolazione in continua crescita, e quindi di un aumento costante della domanda, scontava però una disponibilità di risorse limitate, e concentrate in primis sulla ricostruzione delle vetture sinistrate e sul ripristino delle numerose linee interrotte a causa degli eventi bellici (rifacimento binari e linea aerea). La scarsità di materie prime, e le interruzioni dell’erogazione di energia elettrica, che avvennero sporadicamente fino al 1950, non contribuivano a rasserenare gli animi. I quotidiani dell’epoca fungevano da cassa di risonanza per le lamentele dei cittadini, alle quali l’ATM cercava di porre rimedio, non sempre con successo.
Ecco un articolo apparso sulla Stampa del 14 gennaio 1949:
“Se i tram funzionano bene, o discretamente, nelle altre città, non c’è ragione perché a Torino funzionino nel peggiore dei modi possibili. I tecnici dell’ATM sostengono trattarsi di forza maggiore. Nessuno lo vuol mettere in dubbio. Come si spiega, però, la scarsa velocità del servizio? Nelle ore di punta, con il grande numero di vetture sulle linee, l’affollamento eccessivo e le lunghe soste alle fermate, si può anche comprendere che si perda tempo e che la velocità diminuisca. Ma nelle altre ore, questi motivi non sussistono: le vetture circolanti sono poche, le linee pressoché sgombre. Sono i periodi in cui i tram potrebbero raggiungere buone velocità. Avviene, invece, esattamente il contrario. […] Se un viaggiatore sale sul 6 alle 10 in piazza Rivoli per giungere a Porta Nuova alle 10.40 (ora in cui, facciamo una ipotesi, parte il suo treno), ha tutto il diritto di pensare che è in anticipo, poiché normalmente il 6 non impiega più di mezz’ora per coprire quel percorso. Sbaglia nove volte su dieci, e a Porta Nuova arriva quando il treno è già partito. […] Ad aggravare la situazione è intervenuta ora l’azienda elettrica con le interruzioni di corrente: una, di mezz’ora, a mezzogiorno di ieri l’altro, due nel pomeriggio di ieri, alle 17 e poco dopo le 18. Si tratta di guasti ai cavi dell’alta tensione, che non sembrano evitabili.. Ma non vorremmo che anche questi si aggiungessero ai mali cronici del servizio tranviario: ce ne son già troppi da curare”.
La situazione non diede segno di migliorare nei mesi a seguire, e infatti il quotidiano ritornò sull’argomento il 18 maggio, segnalando le lamentele dei cittadini per la soppressione di alcune linee:
“Non tutti gli ingranaggi del servizio tranviario funzionano perfettamente. Se ne è parlato più volte su queste colonne, riferendo i rilievi dei lettori che maggiormente erano colpiti dalle deficienze delle varie linee. L’Azienda stessa è intervenuta nel dibattito, recando le proprie giustificazioni ed esponendo i criteri che sovra-intendono alla organizzazione del servizio. Ora, fra le altre migliorie che si è creduto di apportare alla rete tranviaria, v’è la soppressione della linea 16. Era […] una linea ‘passiva’ che gravava sul bilancio dell’Azienda senza peraltro riuscire utile a nessuno. Di parere diverso gli abitanti del rione Vanchiglia, per il quale la linea 16 rappresentava il legame con il centro città. Dopo la sua soppressione, gli abitanti di numerosi isolati sono costretti, se vogliono andare a Porta Nuova, a percorrere oltre mezzo chilometro per raggiungere il tram più vicino. […] Per mancanza di energia elettrica era stata abolita la linea 4 non sbarrata che faceva capo alla barriera Piacenza: era rimasta la linea sbarrata cha ha il capolinea alla Gran Madre. Il servizio nel tratto Gran Madre - barriera di Piacenza era disimpegnato da un autobus. Ora, tornata l’energia elettrica, l’autobus è sparito e il tram fino alla barriera non è più ricomparso. […]
Un argomento che rimane all’ordine del giorno, e che minaccia di rimanerci sino a quando vi sarà a Torino un servizio tranviario, è la lentezza delle corse. L’inconveniente lo si nota con maggiore fastidio […] nelle ore centrali del mattino, del pomeriggio e della sera (cioè nelle ore non di punta), quando tutti i tram di tutte le linee procedono tranquillamente a passo d’uomo”.
Un mese dopo questo articolo, la linea 4 fu ripristinata nel tratto Gran Madre - Barriera di Piacenza, fino alla soppressione definitiva con la riorganizzazione della rete del 1966. Per quanto riguarda il 16, fu unificato con la vecchia linea 1 per la creazione della nuova circolare (per maggiori dettagli si rimanda al libro ‘Torino in circolare’ edito da ATTS nel 2018), e su tale linea entrarono in servizio successivamente le nuove vetture della serie 3100, la cui presentazione al pubblico fu pubblicizzata dalla Stampa del 22 luglio 1949:
“La prima serie delle venti nuove vetture tramviarie - che entreranno in servizio sulle linee cittadine entro il 30 ottobre p.v. - è stata inaugurata ieri alla presenza del sindaco dottor Coggiola, al deposito dell’Azienda Tramviaria in piazza Carducci. Questa vettura di nuovo tipo è costruita dalla ‘Fiat’: essa ha il cassone esterno in acciaio, simile a quello usato dalle vetture ‘3000’ già in servizio; ma l’interno è di linea completamente nuova. Originale è l’illuminazione, costituita da sei tubi fluorescenti schermati. Il rivestimento delle pareti interne è di masonite temperata con cornici in profilato ‘anticorodal’. Il pavimento è ricoperto di gomma rigata. La nuova vettura ha buoni caratteri di silenziosità. L’isolamento termico e acustico è ottenuto, in modo soddisfacente, da lana di vetro pressata nelle intercapedini. I motori sono quattro, collocati su carrelli a ruote elastiche con elementi di gomma incorporati: essi sviluppano una potenza di 45 cv, e possono raggiungere una velocità di circa 55 km all’ora. […] Da stamane sono entrate in funzione: la nuova linea circolare 16, la linea 1 limitata (p. Castello - O. Mauriziano) e la 13 modificata, con deviazione in corso Galileo Ferraris al posto del tragitto per corso Re Umberto. Circa la deviazione della linea 13 un lettore ci scrive: ‘Con la decisione di modificare il percorso della linea 13 si ledono particolarmente gli interessi di tutti gli abitanti delle zone di Lucento e S. Donato, non permettendo loro il passaggio in piazza Solferino ed il conseguente contatto con la zona delle banche, della Posta, del telegrafo e telefono, dell’Esattoria Comunale e di tutti gli altri enti pubblici […]’”.
Da parte sua, l’Azienda tranviaria municipale, tramite le pagine del giornale, cercò di giustificare i propri interventi con la necessità di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico, e sottolineando l’evidente impossibilità di accontentare le richieste di tutti. Questo l’articolo apparso sulla Stampa il 25 ottobre 1949:
“‘Se si dovessero accogliere tutte le richieste del pubblico, anche quelle che possono sembrare giustificate - ci diceva qualche giorno fa un dirigente dell’ATM - dovremmo rivoluzionare l’intero servizio tranviario. E quasi certamente, la cittadinanza nel suo complesso non avrebbe alcun vantaggio. Anzi, ne sarebbe danneggiata’. Non si può negare che l’affermazione sia esatta. Tutti vorrebbero la fermata del tram dinanzi al portone di casa e pretenderebbero che le linee che direttamente li interessano seguissero i percorsi più cervellotici. Chi si serve del tram dimentica troppo spesso che si tratta di un servizio pubblico, e cioè condiviso con altri, che hanno altre esigenze. E troppo spesso l’ATM, esaminando le richieste del pubblico, si trova fra l’incudine e il martello e deve cercare tra le molte soluzioni offerte quella che rappresenta il compromesso meno peggiore fra tutte, se non addirittura lasciare le cose come stanno, data la pratica impossibilità di trovare il compromesso ideale. Dopo molte esitazioni e lunghi studi è stata varata la ‘circolare’, ed il percorso scelto […] soddisfa i bisogni di una parte considerevole del pubblico. Della nuova circolare ha fatto le spese la già asmatica linea 1, che ha subito una amputazione tale da renderla praticamente inservibile, o quasi. Gli abitanti della Crocetta, e quelli delle vie San Massimo, Mazzini e dintorni hanno protestato più volte, ma senza esito. […] Altre migliorie si chiedono, e queste potrebbero essere senz’altro attuate senza provocare alcuna confusione. Al contrario, accontentando tutti i passeggeri. Molte vetture sono prive dei cartelli indicatori, sui fianchi e sulla parte posteriore (ed è perciò difficile sapere a quale linea appartengano); troppe fermate importanti mancano della pensilina (sicché Il passeggero si trova in difficoltà nello scendere e nel salire, senza contare che corre il pericolo di essere investito da qualche veicolo)”.

Le donne e il tram
di Marcela Luque
Una miscela tra madre, figlia e moglie senza trascurare le mansioni di chef e colf familiare. Questo fu il primo ruolo della donna sui tram all’inizio... un ruolo silenzioso, ma continuo che sin dalla fredda sera del 29 dicembre 1871, in cui un tram a cavalli fece la sua prima corsa per le vie di Torino, si sarebbe sviluppato e ridimensionato fino a raggiungere traguardi, all’epoca, difficili da immaginare.
Visti gli orari prolungati dei lavoratori tranviari sin dall’inizio dei servizi tranviari la società Torinese mise a disposizione un servizio assai particolare e paragonabile alle “mense” di oggi: le vivandiere. Si trattava di carrozze che partivano dal deposito diretti a Porta Palazzo, all’epoca di De Amicis punto d’incontro di 5 delle 7 linee della società. Queste carrozze trasportavano i canestri per il pranzo dei dipendenti, pranzo che era procurato dalle donne di casa: madri, figlie o sorelle. Così mentre per gli scapoli se ne occupava la Cucina Economica della Società Torinese, i più fortunati potevano godersi un bel pranzo o una bella colazione fatta in casa dalle donne della famiglia. Esse si recavano al deposito prima che partisse la vivandiera per lasciare i canestri con le pietanze per i propri congiunti che, al primo incrocio, sarebbero recapitati al fattorino (come veniva chiamato spesso il bigliettaio) o conducente in questione. Tuttavia e per ragioni di comodità le donne di casa potevano anche portare i cestini ad un punto di incontro per darlo in mano al marito, padre o fretello appena il tram ragiungesse la fermata.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale le donne continuarono a salire sui tram questa volta però senza un cestino in mano. Come in tanti altri settori industriali anche in quello del trasporto pubblico, venendo a mancare gli uomini che erano al fronte, le donne furono chiamate come manodopera di riserva per ricoprire i ruoli tranviari fino a quel momento legati esclusivamente al mondo maschile. Così le donne passarono da portatrici dei sapori di casa a ostentatrici del ruolo di testimonial del conflitto bellico, situazione questa che suscitò molti interrogativi e non poche critiche nell’opinione pubblica di allora. D’altronde la reazione dei colleghi maschi non fu delle più consenzienti.
Un piccolo esercito di 434 tranviere lavorava nei trasporti pubblici di Roma nel 1918: erano 304 fattorine e 109 conducenti, il resto erano operaie e cantoniere. Indossavano un cappello e uno spolverino d' ordinanza.
Milano invece aveva iniziato a discutere se accettare donne o no già nel 1916. La Lega dei Tranvieri però si mostrò subito contraria allegando che in uno stato di anarchia come quello del trasporto pubblico tranviario senza fermate fisse e con vetture stracariche nelle ore di punta, le donne non si sarebbero mai adattate a sgomitare tra la folla. Firenze in quel periodo aveva già adottato la manodopera femminile sul tram. “E’ un ambientaccio il tramvai per la donna: corrompe fisicamente e se la donna è modesta, timida ed educata finisce con lo stancarsi dell’ambiente. Se invece è vivace, ardita e spavalda non nè fa in quell’ambiente una bella figura,” sosteneva un tranviere fiorentino sul quotidiano Avanti. Così si scatenò un via vai di articoli sui quotidiani dell’epoca che mitigarono le orrende notizie del fronte tra i mesi di marzo e quello di giungo di 1916.
Il Sindacato Italiano dei Tranvieri sosteneva che la donna avesse bisogno di emanciparsi e quindi doveva poter fare la tranviera se era questo che voleva. Tuttavia molti tranvieri uomini si chiedevano cosa avrebbe fatto una donna se si fosse trovata davanti -come spesso accadeva- dei teppisti armati da coltelli.
Curiosamente queste discussioni incentrate sul nuovo ruolo della donna erano però guidate, sostenute e incoraggiate da uomini finché fu una tranviera fiorentina a dare la propria opinione sostenendo che era meglio essere tranviera con tutti i problemi che quello comportasse e che una buona organizzazione poteva ben risolvere i problemi piuttosto che fare altre tipologie di lavoro ritenute molto più umili, quale la serva in case dei ricchi dove si mangiavano gli avanzi di tutti gli altri in un angolo della cucina. Inoltre sosteneva che fare la tranviera era meglio che essere sottomessa ad un marito ubriacone che le copriva di improperi e riteneva che questa opinione dei colleghi era mossa più dall’egoismo maschile che dalla preoccupazione per la interesse materiale e morale della donna.
Fu in effetti questo intervento, fatto da una donna, a fermare le obiezioni all’ingresso delle donne nel mondo tranviario. Rimaneva però la questioni del salario che per i lavoratori tranviari era cruciale. All’epoca il salario dei tranvieri era in media di L 3,40 al giorno. Tuttavia quello che era considerato una miseria anche per i disoccupati, per la donna era uno stipendio da non rinegare perciò le domande di assunzione iniziarono ad arrivare numerose. Durante i primi tempi le donne guadagnavano un salario inferiore a quello degli uomini ed erano escluse dei turni serali che erano coperti dal personale anziano maschile esentato di andare in guerra. Ma andando avanti nel tempo l’accordo non fu più praticabile in quanto il personale anziano maschile non era abbastanza per coprire i turni serali. Le donne furono quindi integrate al servizio tranviario con lo stesso regime degli uomini: sia per i turni che per lo stipendio.
Per l’assunsione del personale femminile le diverse società tranviarie privelegiarono mogli e parenti di quei tranvieri chiamati alle armi così che esse non potessero poi avere delle pretese sulla conservazione del posto di lavoro alla fine del conflitto e fornendo allo stesso tempo un sussidio a quelle famiglie.
Lavorare sui tram non era per tutte le donne un mestiere molto gradito e per quanto possa sembrare che le donne avessero vinto la battaglia, purtroppo nella quotidianeità la guerra sembrava continuare: era a loro costantemente ribadita la temporaneità del lavoro e quindi molte donne preferivano fare le operaie in quanto si trattava di un lavoro che offriva loro più continuità. Inoltre il lavoro sui tram comportava passare lunghe ore in piedi e affrontare dei rischi non da poco. Vi fu il caso di una tranviera romana che nel 1918 fu insultata da un passeggero. Lei lo inseguì dopo che lui fosse sceso dal tram e le sparò per essere subito dopo arrestata.
Molti cittadini erano altresì preoccupati che il tram diventasse luogo di appuntamenti amorosi che potevano turbare la pace di tante famiglie, come il caso della donna che fu accompagnata a casa da un collega e la portinaia lo cacciò via dicendo che intrattenersi con la signorina dopo l’orario di lavoro era proibito.
Durante la Grande Guerra, Torino assunse le donne solo con la qualifica di bigliettaie. Appena finito il conflitto bellico, le donne furono tutte licenziate tra il 1919 ed il 1920 e dovettero aspettare una seconda guerra per poter tornare sui tram come lavoratrici.
Nel 1943 lavoravano 523 donne nei servizi tranviari di Roma dotate da una giacca, gonna, cappello e cappotto blu. Le prime donne erano state assunte nel 1940 e furono licenciate dopo due mesi su disposizione del Centro Nazionale di Mobilitazione Civile. Furono poi riassunte per essere licenziate di nuovo alla fine del conflitto risparmiando solo quelle che non avessero una fonte di sostentamento cioè un padre o un marito. A queste donne dopo esserle state tolte le mansioni di conducente e fattorina, le furono assegnate quelle di pulitrice.
A Torino le donne presero servizio il 10 giugno di 1940 e vi fu un unico gruppo di 19 bigliettaie, senza altri mezzi di sussistenza che riuscì a lavorare fino al 1948. Insieme a quello di portalettere il ruolo di donna bigliettaia fu uno dei simboli del lavoro femminile nella Torino della Seconda Guerra. Oltre l'indennità di licenziamento venne loro riconosciuta una somma pari a due mensilità.
Settanta anni dopo, nel 2018 lavoravano in GTT ben 723 donne, circa il 16% della forza lavora dell’azienda di trasporti di Torino delle quali il 9% (195 donne) svolge le mansioni di conducenti di linea.
Didascalie
Foto copertina: Roma, 30 giugno 1940. Fattorine in posa per una foto di gruppo. Foto archivio storico fotografico ATAC s.p.a.
Foto 2: Via Labicana, Roma, 1915. Motrice ambulanza del Comune adibita al trasporto dei feriti con vettura passeggeri a rimorchio durante la Prima Guerra Mondiale.Foto archivio storico fotografico ATAC s.p.a.
Foto 3: Roma, 1940. Prova della divisa da fattorina. Foto archivio storico fotografico ATAC s.p.a.
Foto 4: Roma, 17 giugno 1940. Allieve fattorine all'interno di un tram.Foto archivio storico fotografico ATAC s.p.a.
Foto 5: Torino, convoglio su linea 3 con personale femminile, Prima Guerra Mondiale. Foto archivio GTT - ATTS
Foto 6: Torino, donna bigliettaia a bordo di un tram della linea 3, anni '40. Foto archivio GTT - ATTS
Le foto di Roma sono gentilezza dell'Archivio Storico Fotografico di ATAC S.p.A. che ringraziamo per la concessione della pubblicazione.
Fonti
Operaie e socialismo: Milano, le leghe femminili, la Camera del lavoro (1891-1918), Fiorella Imprenti, Franco Angeli Editore, 2018
Tempo di guerra, arrivano le donne a fare le bigliettaie sui tram e le portalettere, Torino Top News, 2018
Quando i tram erano guidati dalle donne, La Repubblica, 2001
Tranviere romane nelle due guerre, Archivi dell’Atac, 2018

DESIDERIO, TRAM ETNICO DI RICHI FERRERO
di Luca Giannitti
Questa storia rappresenta il canto del cigno di una motrice serie 3250, la 3263 per la precisione, protagonista di uno spettacolo (l'installazione itinerante "progetto Desiderio - Tram Etnico") in occasione della Festa del Piemonte, tenutasi tra il 22 maggio e il 5 giugno 1994. Da un’idea di convivenza multietnica prese il via "Desiderio - Tram Etnico", nato dalla opportunità di ascoltare le voci di tutti i gruppi etnici presenti nella regione Piemonte. Per dare voce e significato alla proposta fu scelto il tram, che per antonomasia raccoglie al suo interno persone di ceto, origini e appartenenze differenti.
L'allestimento prevedeva un mosaico di specchi realizzati con pellicola riflettente, che ricopriva interamente l’esterno del tram, su cui si sarebbero specchiate vie e piazze, creando suggestioni di architetture in movimento. Colori fluorescenti trasformavano l’interno del tram in un luogo irreale, quasi onirico, dove trovavano posto vere e proprie sculture: uomini e donne di un futuro prossimo, simili a noi, ma morfologicamente diversi: braccia lunghissime, teste sovradimensionate... Sedici statue in rappresentanza di tutte le etnie presenti sul territorio. Questi uomini del futuro interagivano coi viaggiatori reali parlando piemontese, arabo, francese, italiano, africano, cinese ed occitano e un sistema video a circuito chiuso restituiva in tempo reale le immagini di una Torino dell'anno 4.000: palazzi dai colori fluorescenti; il Po con le acque argentee; la Gran Madre trasformata in moschea; piazza Vittorio Veneto trasformata come in un quadro metafisico.
Il tram, esso svolse servizio tra piazza Castello, via Po e la Gran Madre con partenze ogni 25 minuti nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 5 giugno 1994. Dopo questo servizio il tram venne alienato e alcune immagini lo ritraggono presso il demolitore ancora con la pellicola riflettente esterna.
Immagini
1-2 allestimento della vettura presso l'officina centrale
3 bozzetto della vettura
4-8 allestimento dei manichini
9-13 vettura 3263 in servizio
14 la 3263 presso il demolitore
Il progetto fu ideato e diretto da Richi Ferrero con la compagnia di teatro di ricerca "Granserraglio", da lui fondata nel 1971 con Mariano Meli, Gianna Franco e gli attori della compagnia sperimentale Zoo di Michelangelo Pistoletto. Per la realizzazione si avvalse della collaborazione di svariati enti come Casa delle Culture, Centro Iniziative per l’Europa, Amnesty International, Teatro Stabile Torino e Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.
Richi Ferrero nasce a Torino il 25 marzo del 1951. A quindici anni inizia un lungo viaggio (durato 4 anni) in autostop per l’Europa e l’Oriente, nei quali si mantiene suonando nelle metropolitane delle grandi città. Sono anni ricchi di incontri e di esperienze significative, che avranno per Ferrero un peso determinante in tutto il suo percorso artistico e creativo. Tornato a Torino, fonda nel 1971 la compagnia di teatro di ricerca il Granserraglio che, dieci anni dopo, s’imporrà a livello nazionale con lo spettacolo "Donne: Storie di ordinaria follia" nel quale Ferrero interpreta Charles Bukowski: due stagioni per duecento repliche in tutta l’Italia, da Bolzano a Messina. Tra il 1988 e il 1989 Ferrero ritorna al teatro di palcoscenico, con particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea. Con "Desiderio - Tram etnico" (1994), una installazione itinerante, è sempre più evidente la vocazione di Ferrero di eleggere a palcoscenico la città, teatralizzando elementi tipici del tessuto urbano come il tram. Nello stesso anno cura la regia per il Granserraglio di un colossale spettacolo nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi: "Il Teatro del Fuoco". Nel 1997 Ferrero è incaricato dalla Regione Piemonte e dal Museo Nazionale della Montagna dell’illuminazione permanente del Forte di Exilles: si tratta della prima applicazione dei criteri illuminotecnici teatrali ad un’opera architettonica. Nel 1998 nasce a Torino “Luci d’Artista”, rassegna d’arte sul tema della luce con installazioni inserite nel tessuto urbano. Ferrero per la prima volta viene chiamato a partecipare ad una "collettiva" che vede coinvolti importanti nomi dell’arte visiva. Una gigantesca gru edile trasformata in scultura di luce è l’elemento dominante delle tre opere presentate nelle tre edizioni consecutive della manifestazione: "Porto Palazzo", "Imbarco Torino", Lucedotto". Nel 2009 il suo ventennale lavoro di sperimentazione con la luce nera di wood, viene presentato in una mostra personale, "Luce Nera", presso la Gagliardi Art System Gallery di Torino. In occasione della mostra viene realizzato l'intervento artistico "Re di Fiori" sul monumento a Vittorio Emanuele II.

RITROVARE UN VECCHIO COMPAGNO
di Luca Giannitti
Ci sono oggetti che utilizziamo o vediamo quotidianamente, magari talmente diffusi che non ci passa per la mente che potrebbe arrivare il giorno in cui scompaiono. Un caso emblematico è quello della prima generazione di obliteratrici a bordo dei veicoli, prima bus e poi tram, in servizio a Torino. Detta così, ben pochi sapranno di cosa si parla (e bisogna avere almeno 35 anni circa per potersele ricordare), ma se queste obliteratrici venissero descritte come "quelle macchinette che tagliavano un quadratino del biglietto", sicuramente sarebbero in tanti a ricordarle meglio. La loro dismissione è avvenuta nei primi anni Novanta, anni luce prima della nascita di Atts e praticamente tutti gli esemplari sono finiti nel ferrovecchio. Non è escluso che qualche appassionato sia riuscito a recuperarne qualcuna dai veicoli in demolizione, tuttavia nessun pezzo risulta noto. Nel vecchio deposito Regina Margherita, a bordo di un tram, era stata recuperata una carcassa incompleta (parzialmente ricostruita senza però alcuna documentazione precisa) successivamente esposta nel museo di Sassi. Per lunghi anni si è ritenuto quel ritrovamento il massimo che la sorte avesse riservato, purtroppo tutto il resto era andato perso. Nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe mai immaginato che una quindicina di anni dopo sarebbe avvenuto il miracolo: su segnalazione di un addetto del magazzino complessivi dell'officina centrale Gtt sono riemersi ben 4 vecchie obliteratrici! Quasi 30 anni dopo la loro dismissione, nei magazzini erano presenti ancora degli esemplari! Atts ha quindi preso contatto con i responsabili affinché i pezzi in questione potessero essere acquisiti dall'associazione e, ottenute tutte le autorizzazioni, il magazziniere ha potuto finalmente liberare prezioso spazio, consegnando ad Atts le vecchie obliteratrici, due delle quali ancora funzionanti! Le condizioni dei quattro reperti erano piuttosto precarie, necessitavano di un restauro estetico, ma erano completi. Sorpresa nella sorpresa, esaminando le carcasse delle obliteratrici se ne sono trovate due ancora dotate del foro dove era alloggiato l'orologio della primissima versione! Per questo motivo si è optato per un restauro in tre esemplari, mentre il quarto è stato ricostruito nella versione antecedente dotata di orologio. In soccorso a questi interventi sono arrivate le informazioni trovate nel Centro di Documentazione Gtt che nel frattempo era stato dato in gestione all'associazione: grazie a tutto questo materiale è stato possibile procedere alla ricostruzione dell'obliteratrice RCS Pandozy (questo il suo nome!) quando ancora era dotata di orologio ed era colorata in rosso e grigio. Solo nei primi anni Ottanta, con l'arrivo della versione "semplificata" l'orologio fu rimosso e tutta l'obliteratrice venne dipinta in arancione, lo stesso arancione utilizzato dai veicoli privati del bigliettaio. Uno degli esemplari restaurati in arancione è ora esposto nel rinnovato museo di Sassi mentre l'obliteratrice ricostruita con l'originale orologio è conservata ed esposta nella sede Atts di Ponte Mosca. Come questi esemplari siano sopravvissuti allo smaltimento è ancora un mistero, tuttavia era destino che a distanza di tanti anni si potesse ritrovare un vecchio compagno di innumerevoli viaggi.
Immagine 1: il fascicolo RCS del centro di documentazione Gtt
Immagini 2-3: immagini dell'obliteratrice Pandozy presente nel fasciscolo del centro di documentazione
Immagine 4: le quattro vecchie obliteratrici nel giorno del loro recupero
Immagine 5: una obliteratrice nello stato arancione
Immagini 6-7-8: fasi di restauro dell'obliteratrice nello stato originario, come da fascicolo RCS
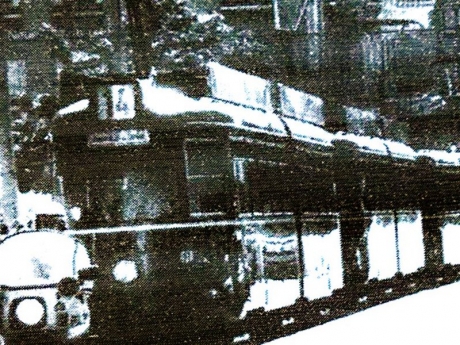
IL PIÙ LUNGO TRAM DEL MONDO
di Luca Giannitti
16 luglio 1986, una normale giornata estiva a Basilea, in Svizzera. Radio Basilisk, una radio locale di Basilea, per molti anni sfruttava la calma estiva per creare eventi (oggi li chiameremmo "flash mob") in occasione dell'annuale "Summer Fun". Di norma la mattina intorno alle ore 6, veniva annunciato in radio che qualcosa di speciale sarebbe accaduto in città la sera stessa. Molte di queste leggendarie notizie hanno portato a memorabili "flash mob", come la Brasil Night con oltre 8000 persone che si ritrovarono per una festa presso la centrale elettrica di Birs, sull'isolotto posto nel tratto cittadino del Reno, o quando diverse migliaia di persone arrivarono all'Älplerchilbi sulla Münsterplatz e rimasero stupite alla vista di capre e mucche scorrazzare sul Münsterberg come se fossero in viaggio alpino. Ma la sera del 16 luglio circa 10.000 curiosi sarebbero rimasti sbalorditi di fronte a uno spettacolo grande, lungo e verde che si stava muovendo lentamente attraverso il centro di Basilea.
Con il supporto della BVB (l'azienda locale di trasporti) era stata allestita "una composizione lunga e ubriaca", come il vicepresidente della BVB Christoph Stutz aveva ironicamente commentato l'eccezionale tram lungo ben 108 metri che si è fatto strada attraverso i binari della città: essa era formata da quattro veicoli articolati a sei assi e due rimorchi monocassa a quattro assi. Tale convoglio si conquistò un posto anche nel libro del "Guinness dei primati". Il pilota del record mondiale era il tranviere Walter Wüthrich che manovrò con sicurezza la composizione lunga 108 metri e dalla massa complessiva di 122 tonnellate, dalla Wiesenplatz attraverso il Mittlere Brücke, fino alla piazza del mercato. Qui vi era anche l'unica fermata del tram dei record, dove lo attendevano circa seicento persone desiderose di salire nel più lungo mezzo pubblico che Basilea abbia mai visto.

Per ovvi motivi il tram fu opportunamente scortato dalla polizia che non solo si occupò di fermare il traffico dove necessario, ma tenne a bada i tantissimi curiosi accorsi in centro per assistere all'evento eccezionale.
I tram protagonisti del record mondiale erano in ordine le motrici unificate Düwag matricole 650+643+651+649 e i rimorchi standard svizzeri 1489+1503. Delle motrici sopravvive solo più una coppia a Basilea, utilizzata come Partytram e delle vetture utilizzate quel giorno del 1986, solo i tram 649 e 659 sono tutt'ora esistente, ceduti alla città di Belgrado rispettivamente nel 2009 e nel 2016 (le restanti sono state demolite); dei due rimorchi, oggi esiste (ed è in servizio) solo più la vettura 1503, modificata con un terzo accesso ribassato per l'incarrozzamento dei disabili.
Per onore di cronaca, attualmente il veicolo tranviario più lungo al mondo è in servizio a Budapest dal 2016 per una lunghezza complessiva di 56 metri. Prodotto da CAF è il modello Urbos 3.
Immagini dei tram oggi in servizio a Belgrado, un momento del trasporto nel 2016 e la foto del 1986 del convoglio eccezionale (fonte Barfi.ch)

Axtratta, un plastico speciale
di Davide Fenoglio
La Città di Axtratta è un plastico molto particolare realizzato da Aldo Gigli, compianto presidente di Arcamodellismo, associazione presente a Torino da oltre 45 anni e punto di riferimento per gli appassionati del settore.
Dal 2010 un gemellaggio “formale” unisce l’ATTS all’Arcamodellismo, ma fin dall’inizio le due associazioni hanno collaborato organizzando eventi ed iniziative comuni
Non è semplice diorama costruito ad uso e consumo del modellista che lo ha creato, ma un progetto ben preciso realizzato con cura ed attenzione. Ogni particolare è studiato nei dettagli e non posizionato a caso o con finalità puramente estetiche. Ogni edificio, ogni via, ogni piazza cela un riferimento puntuale e preciso ad un evento storico.
Il plastico rappresenta una piccola città circondata da una linea tranviaria e in cui si trovano numerosi edifici di varie epoche, dalle rovine romane fino alle strutture più moderne. Alla scomparsa del suo creatore, l'opera nel 2015 viene donata dalla famiglia ad Arcamodellismo che in virtù del gemellaggio e del tema del plastico, lo consegna ad Atts. I soci modellisti di Atts si prendono cura del plastico, restaurandolo, revisionandolo e rimettendolo in funzione dopo alcuni anni di fermo. Sul plastico possono girare tram analogici che captano la corrente esclusivamente dai binari.
Ma cos'è Axtratta? La descriviamo con le parole del suo realizzatore, Aldo Gigli: si tratta di una città-museo di fantasia, materializzazione di un'idea, più che la riproduzione di una realtà, dedicato alla storia del tram elettrico, dove circolano modelli di tram storici di epoche e nazionalità diverse, americani, austriaci, tedeschi e italiani, nell'aspetto dal 1900 al 1960. Il diorama rappresenta quindi una città ambientata nei primi anni '60 del '900. Anche i veicoli statici sono molto eterogenei, spaziando dagli anni '10 agli anni '70. Da destra verso sinistra del diorama (vista lato pubblico) sono riprodotti:
- un capolinea tranviario
- una zona archeologica dedicata alla romanità
- il palazzo del Comune con adiacente arco della pace
- il borgo vecchio con la Piazza del mercato
- il Giardino della cultura
- i nuovi quartieri
- la chiesa di San Rocco
- il Giardino dei bimbi
- il palazzo della Regione con stemma e formelle in rilievo
- il Palazzo Viotti, ad angolo con portici
- il palazzo prefettizio (in stile "littorio" in quanto ex casa del Fascio)
- il monumento ad Arnaldo Pocher
La topografia di Axtratta è ad assi ortogonali, molto simile alla città di Torino.
Alcuni luoghi possono essere descritti dettagliatamente. Il Giardino - piazza della cultura è dedicata ai due filoni principali dell'espressione culturale: l'umanismo con il monumento ai poeti Goethe e Schiller, la scienza con la fontana del mondo rappresentata da simboli quali la terra (la sfera), l'universo (l'ellisse), la natura (l'acqua e i cavalli) e l'umanità futura (i due bambini).
La Fontana ARCA raffigura in modo surreale il simbolo storico dell'ARCA, una vela, un’ala a delta e una ruota: la rappresentazione dei tre mezzi di locomozione. Il baleno, simbolo elettrico, e l’acronimo Arca sono stilizzati e contenuti nel Triangolo. È l'essenza stessa dell'associazione, un insieme di persone (i fiori meccanici) unite dalla stessa passione per il modellismo. Tutti i manufatti, ad esclusione dei lampioni illuminabili, dei pali tranviari, dei binari e del monumento ai poeti, sono stati auto-costruiti. I corsi e le vie sono dedicati a persone scomparse ma note in ambito modellistico, quali: Arnaldo Pocher, Enrico Milan, il socio ARCA Mario Castaldi, Erminio Mascherpa, Francesco Ogliari, Giovanni Cornolò, oltre ai realizzatori delle prime tranvie, come ad esempio Werner von Siemens, Frank Sprague e Mario Urbinati, l'ingegnere inventore della famosa articolazione.
A proposito di modellisti famosi, grazie al progetto MaToSto ® - Marchi Torinesi nella Storia (http://matosto.it/), la banca dati che la Camera di commercio di Torino ha creato per mettere a disposizione del pubblico i verbali delle domande di registrazione di marchi nazionali ed internazionali che fanno parte dell’archivio storico dell’ente, possiamo pubblicare in esclusiva tra le immagini il verbale della registrazione del marchio Pocher del 1958.
Un’altra chicca è rappresentata dal “quadro di comando” utilizzato per fare muovere i modellini che simula un banco di manovra di un tram vero con tanto di inseritore, campanella, comando apertura porte: un vero simulatore che permette un esercizio molto realistico.
Atts conserva orgogliosamente e porta a varie manifestazioni questo plastico, non solo per il valore dato della realizzazione modellistica, ma anche soprattutto per il forte legame con Aldo Gigli e con gli amici di Arcamodellismo.
Foto Archivio ATTS

I TATRA T6 NELLA FLOTTA DEI TRAM STORICI DI PRAGA
di Gianpiero Bottazzi
Ultimi mesi di servizio ordinario per i Tatra T6 di Praga che a breve entreranno a far parte della flotta dei tram storici della città boema. Con una scelta lungimirante l'azienda dei trasporti di Praga DPP ha infatti deciso di conservare tre vetture T6 che saranno restaurate e custodite nel deposito di Střešovice.
Il rinnovo del parco tranviario di Praga negli ultimi anni ha portato all'acquisto di 250 Skoda 15T “Forcity: vetture multiarticolate di grande capienza, molto affidabili, entrate in servizio tra il 2009 e il 2018. Con la consegna dei nuovi tram, dal 2015 è iniziato l'accantonamento dei Tatra T6: venti sono stati venduti a Sofia in Bulgaria, altri sono stati destinati a Brno e alle città ucraine di Kiev e Kharkiv. A maggio 2020 a Praga erano ancora in servizio 10 T6, la maggior parte impiegati sulla linea 32 e custoditi nel deposito di Motol. Nel febbraio scorso è stata accantonata la vettura 8739 e ora ne sono rimaste in servizio tre: 8637, 8658, 8748. Nei mesi scorsi questi tram hanno viaggiato accoppiati, ora viaggiano invece da soli. Si prevede che rimangano in funzione ancora fino a novembre, quando raggiungeranno il chilometraggio che richiederebbe una manutenzione straordinaria, e poi verranno demoliti.
Ma per fortuna resterà una testimonianza di questo modello grazie alle tre motrici che saranno restaurate e conservate nel deposito di Střešovice, dove si trova anche il Museo del Tram: si tratta delle motrici 8601, 8702 e 8750.
La storia dei Tatra T6 (versione A5) di Praga inizia nei primi anni '90 quando l'azienda DPP ordina 150 tram di questo modello, per modernizzare la sua flotta composta principalmente da Tatra T3. Sono tram monocassa dotati di due carrelli e 4 motori, lunghi 14,7 metri con tre porte e ampi finestrini. Le vetture, numerate da 8601 a 8750, sono state consegnate dal 1995 al 1997. In questi anni sono state utilizzate sia singolarmente che in coppia. Poiché entrambi i veicoli sono collegati elettricamente quando sono accoppiati, solo uno dei pantografi è collegato alla rete aerea (normalmente quello del primo veicolo).
Il modello T6 fu lanciato sul mercato da Tatra nei primi anni '80 e acquistato da diverse città in Russia e in Ucraina, nella versione B5 (complessivamente 1279 vetture). Successivamente la nuova versione A2 fu esportata in Germania Orientale e in Ungheria (256 unità). Infine la versione T6A5 (297 unità) fu destinata al mercato interno della Cecoslovacchia e venduta, oltre che a Praga, anche a Bratislava, Brno, Kosice e Ostrava. Sommando le tre versioni, furono costruiti 1832 tram modello T6. Queste motrici sono conosciute anche con il soprannome di “ferro da stiro” perchè il loro design ricorda la forma triangolare dei ferri da stiro se vengono viste dall'alto.
Foto di František Zahnáš
1. Tatra T6 8658 8739 accoppiati al capolinea di Barrandov (27/11/2020)
2. Tatra T6 8658 a Lidicka (12/2/2021)
3. Tatra T6 8658 al capolinea di Radlická della linea 21 (12/2/2021)
4. Tatra T6 8658 al capolinea di Radlická della linea 21 (12/2/2021)
5. Tatra T6 8658 (linea 21) e Skoda 15T “Forcity” 9407 (linea 7) al capolinea di Radlická (12/2/2021)
6. Tatra T6 8637 e 8748 accoppiati al capolinea di Lihovar (17/2/2021)

Requiem per i tram della Coruña
di Roberto Cambursano
La Coruña (ufficialmente “A Coruña”, in lingua galiziana) è una città di circa 250.000 abitanti che si trova all’estremità nord-occidentale della Spagna”, dotata di un importante porto sull’Oceano Atlantico. Il nucleo storico sorge su una penisola, sulla cui estremità si trova la “Torre di Ercole”, un faro di origine romana che è il simbolo della città.
I primi tram a cavalli iniziarono a circolare alla Coruña nel 1903, poi soppiantati dalla trazione elettrica nel 1913. La rete tranviaria originale, seguendo il destino comune a tutte le città spagnole, fu chiusa nel 1962 e rimpiazzata dai filobus, che a loro volta cedettero presto il passo agli autobus.

IL PLASTICO DELLA STAZIONE SASSI
di Davide Fenoglio
Nel piccolo museo della stazione di Sassi, fra i tanti interessanti cimeli, è custodito un diorama rappresentante la stazione stessa e realizzato da Arcamodellismo. Il diorama rappresenta l’area prima della ristrutturazione effettuata all’inizio degli Anni Duemila.
L’idea nasce da una visita svolta a fine anni Novanta al Museo dei Trasporti di Ranco (Varese), collezione unica nel suo genere, messa insieme in lunghi anni di ricerca e lavoro appassionato dal professor Francesco Ogliari. Tale pregevole collezione era priva di un cimelio rappresentante la cremagliera Sassi – Superga. Il fondatore del museo accolse, perciò, con entusiasmo l’idea dei soci Arcamodellismo di realizzare un diorama in scala 1:87 della stazione di Sassi, l’impianto più interessante della linea. Il lavoro procedette per gradi in modo corale, poiché vi parteciparono molti soci, ciascuno realizzando una parte, un mezzo, un edificio e mettendo le proprie specifiche competenze a servizio del completamento dell’opera. Innanzitutto fu interpellata l’azienda che allora gestiva l’impianto, il Consorzio Trasporti Torinesi, antenato dell’attuale GTT che mise a disposizione il materiale necessario, oltre a concedere i permessi per fare rilievi e realizzare foto utili alla riproduzione dei molteplici particolari. Tutti le varie parti componenti il plastico, ad eccezione della linea aerea, sono stati autocostruite riproducendo le caratteristiche particolari dell’impianto. La parte più difficile è stata la posa dell’armamento dal momento che si sono dovuti realizzare dal nulla binari e deviatoi dotati di cremagliera e terza rotaia. Sono stati fedelmente riprodotti in legno e plastica tutti i fabbricati allo stato dell’epoca compresa la caserma dei Carabinieri sita in Strada al Traforo di Pino. Oltre a edifici, binari, vegetazione non poteva mancare il materiale rotabile. Anche questo è stato costruito appositamente non essendo presente in commercio. Sono stati riprodotti una motrice a carrelli, una rimorchiata chiusa ed una aperta, un carro merci attrezzato per l’ingrassaggio della cremagliera e l’immancabile locomotore da manovra T450.
Al termine della realizzazione è stato portato in varie esposizioni tra cui l’Hobby Model Expo di Novegro e poi collocato nel Museo dei trasporti di Ranco. Alla morte dell’ideatore purtroppo il museo è stato chiuso e la collezione trasferita in parte al Museo Volandia di Somma Lombardo. Il plastico è stato recuperato, restaurato e donato all’ATTS a suggello del gemellaggio tra le due associazioni nel corso della cerimonia di presentazione della trentacinquesima mostra Arcamodellismo, svoltasi il 24.05.2010 presso il deposito di Sassi.
Ha trovato così collocazione definitiva all’interno della stazione di Sassi, dove è ammirato quotidianamente dai visitatori del museo e dagli utilizzatori della tranvia di Superga.

Chemnitz: Karl Marx Tram
di Roberto Cambursano

Il recupero del tram 3201
di Davide Fenoglio
La 3201 è una vettura appartenente alla serie 3100-3224, costruita dalla Fiat Materfer tra il 1949 e il 1958 sullo stesso schema del prototipo 3001 e delle motrici serie "1000" delle tranvie di Madrid.
Diversi tram della stessa serie sono stati recuperati nel corso degli anni. Nel 2001 l'ATM ha restaurato parzialmente la 3203 e la 3279 che vennero ridipinte nella livrea originale degli anni Cinquanta in due toni di verde. Fu ripristinato il posto bigliettaio, ma non furono fatte modifiche né nel numero di porte, né alla cassa. La 3279 ha partecipato alle riprese del film di Gianni Amelio "Così ridevano", girato a Torino ed ambientato negli anni dell'immigrazione dal sud Italia. Nel 2009 la 3265 è stata donata dal GTT alla rete di Santos, in Brasile, per ampliare il parco veicoli della loro linea tranviaria storica, divenendo il “Tram Cafè” (ne abbiamo parlato nel Tranvai di luglio 2020). Nel 2007 la 3179 è stata modificata in "Tram Teatro" con l’apertura quasi completa di una fiancata, che è stata modificata e resa ribaltabile creando così un palco. È il primo ed unico tram al mondo allestito con questa funzione. La 3262 è stata concessa in comodato d’uso all'associazione Diogene ed utilizzata come sede del progetto “Bivacco Urbano”, originale residenza per artisti. La cassa della 3186 è stata donata al comune di Gabiano, in provincia di Alessandria in cambio della cassa della più storica 614. Nel corso del 2009 ATTS ha recuperato la 3104 al fine di riportarla alle condizioni pre-1977. Il tram è stato restaurato e dall'ottobre 2010 è parte del parco storico torinese. L’ATTS ha preservato anche la 3216 per un futuro restauro.
Ma torniamo alla nostra 3201.
Come tutte le altre vetture della serie nel 1977 è stata ricostruita dalla Viberti-Seac. L'operazione, necessaria per adeguare la motrice alla riscossione a terra, ha comportato l'apertura di una quarta porta, la sostituzione delle testate anteriore e posteriore e la riverniciatura in arancione e grigio. Il mezzo è rimasto attivo fino al 2003 quando, insieme ai rimanenti tram della serie, è stato tolto dal servizio. Inizialmente è stato portato nel tunnel tranviario dello Stadio delle Alpi, che in quel periodo non era utilizzato e poi nel deposito abbandonato “Regina Margherita” di Collegno.
Nel 2013 l’ATTS ha acquisito il tram per salvarlo dalla demolizione in occasione dello svuotamento dello stesso deposito. Era una delle vetture meno danneggiate dagli atti vandalici compiuti durante il periodo di accantonamento. È stata poi trasferita presso la Metalmeccanica Moretta, in provincia di Cuneo. La ditta offre uno spezzone di binario dove poter tenere sotto un telone il tram. Dopo quasi due anni di permanenza all’aperto il telone utilizzato per proteggere il tram è molto danneggiato e non offre più la protezione che garantiva fino a poco tempo prima. Inoltre la distanza da Torino limita molto le occasioni in cui fare degli interventi di manutenzione ordinaria e protettivi.
Nel 2016 l'azienda viene posta in liquidazione e il tram deve essere sgombrato anche da Moretta. L’ATTS riporta il tram a Torino dove, per concessione di Gtt, è disponibile un tratto di binario all'interno del deposito della metropolitana a Collegno. Il deposito della metropolitana è un sito molto più vicino e grazie alle autorizzazioni concesse da Gtt ai soci operativi ATTS addetti al restauro, è possibile intervenire sui tram ospitati per una serie di manutenzioni indispensabili per preservare nel tempo lo stato del mezzo. Tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 il primo intervento è stato quello della rimozione dei graffiti che deturpavano il tram da lunghi anni. Contemporaneamente si è ripresa la carrozzeria nei punti in cui la ruggine stava iniziando a "mangiare" le lamiere e si è ripulito l’interno.
A cinque anni dal suo arrivo a Collegno, il 9 aprile 2021 la 3201 lascia il deposito della metropolitana diretta verso la provincia di Brescia, dove presso la ditta BM Carrozzerie s.r.l. inizierà un percorso di ristrutturazione. Grazie all'interessamento della ditta Fiammengo Federico s.r.l. e al suo indispensabile contributo il tram sarà restaurato inizialmente staticamente per poi, dopo un ulteriore intervento, tornare a circolare.
1. La 3201 in servizio sulla linea 12 (anni ’90) - foto archivio ATTS
2. La 3201 accantonata al deposito Regina Margherita di Collegno (2013) - foto LG - ATTS
3. La 3201 presso la Metalmeccanica Moretta (2013) - foto LG - ATTS
4. La 3201 presso la Metalmeccanica Moretta (2015) - foto LG - ATTS
5. La 3201 al deposito della Metropolitana di Collegno (2016) - foto LG - ATTS
6. La 3201 dopo i primi lavori a cura dei soci operativi ATTS (2017) - foto LG - ATTS
7. La 3201 durante le operazioni di carico in vista del trasferimento presso la ditta che curerà il restauro (2021) - foto archivio ATTS
8. La 3201 durante le operazioni di carico in vista del trasferimento presso la ditta che curerà il restauro (2021) - foto archivio ATTS
9. La 3201 durante le operazioni di carico in vista del trasferimento presso la ditta che curerà il restauro (2021) - foto archivio ATTS

La Notte degli Archivi 2021
di Davide Fenoglio e Marcela Luque
L’Associazione Torinese di Tram Storici partecipa con piacere e da diversi anni a un format che via via si è arrichito fino a diventare Archivissima: un contenitore che aggrega i più importanti eventi incentrati sugli archivi e che si svolge nell’arco di più giornate.
L’archivio Atts dispone di moltissimi documenti, foto, libri inerenti ai trasporti pubblici, non solo torinesi che ripercorrono i diversi periodi della loro storia e sono stati raccolti nel corso del tempo grazie alle donazioni di soci ed appassionati. Inoltre gestisce l’archivio storico fotografico ed il centro di documentazione del Gruppo Torinese Trasporti. Tutti i materiali conservati ed in via di catalogazione costituiscono un patrimonio ricco, variegato e unico nel suo genere. Molti sono utilizzati per svolgere al meglio i restauri dei nostri mezzi storici, altri vengono resi noti grazie alle pubblicazioni storico-fotografiche dell’associazione.
Perciò è naturale che ci si sia sentiti a casa sin dalla prima edizione di questo evento basato sulla valorizzazione della memoria, così abbiamo reso i nostri tram protagonisti delle tante serate organizzate. Finchè è arrivata la pandemia e di conseguenza la manifestazione è rimasta solo in modalità online quindi privata della sua caratteristica principale, quella di aprire la memoria al pubblico. Come spesso accadde di fronte alle sventure si trova sempre il modo di innovare ed esperimentare. Nell’adeguarsi, ATTS e i propri soci hanno scoperto gli ambiti dei video, delle dirette (anche internazionali) e dei podcast.
Quest’anno, per fortuna la situazione è un po’ migliorata perciò si è optato per una manifestazione mista, in parte on line e in parte in presenza. #generazioni è il tema scelto per il 2021 da Archivissima e per noi è stato immediato pensare alle generazioni di persone che hanno viaggiato e lavorato sui nostri tram nel passato, quando erano in servizio e a coloro che li vivono, ci viaggiano, li restaurano nei tempi presenti. Perciò ci è sembrato naturale parlare di restauri e far sentire la voce dei nostri soci che si danno da fare per portare a nuova vita questi gioielli. Sono così state realizzate le nostre “pillole di restauro”: ben nove video in cui i volontari raccontano aneddoti, episodi curiosi e motivazioni che li hanno spinti ad unirsi a noi. Gli altri protagonisti della narrazione sono stati i tram 209 e 116 che quest’anno compiono ben 110 anni. La loro storia, il contesto in cui sono stati costruiti e la loro ristrutturazione sono stati oggetto di quattro podcast letti ed interpretati dagli attori del Gruppo Amatoriale Teatro I viandanti della Cojtà Gruliascheisa, con cui collaboriamo da diversi anni.
Non vogliamo anticiparvi troppo i contenuti perciò vi invitiamo a consultare il nostro canale YouTube dove trovate tutti i contenuti oppure il sito www.archivissima.it.
Oltre a ciò, venerdì 4 giugno dalle 19 alle 21:30 non sono mancati i nostri tram “dal vivo” in piazza Castello. La motrice 116 del 1911, a cui si stanno facendo restauri conservativi, è stata esposta in piazza Castello, mentre il tram 3104 del 1949 ha svolto servizio per il pubblico percorrendo le vie del centro e facendosi ammirare in tutta la sua eleganza.
Nonostante in questi mesi non siano mancate le iniziative con i tram, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in vigore, "La Notte degli archivi" ha rappresentato il ritorno a una importante iniziativa con il pubblico, il cui riscontro è stato notevole in termine di partecipazione ed interesse.
Atts, insieme a ben 300 archivi di enti pubblici, istituti culturali e grandi aziende ha messo in campo le sue energie per raccontare le proprie attività e far conoscere a sempre più persone il grande lavoro di salvaguardia dei mezzi storici che porta avanti. Il nostro “museo in movimento” si è rimesso in moto e lo fa con lo sguardo rivolto al 2022, anno del centocinquantenario del tram in Italia che è partito proprio da Torino.
Foto Archivio ATTS
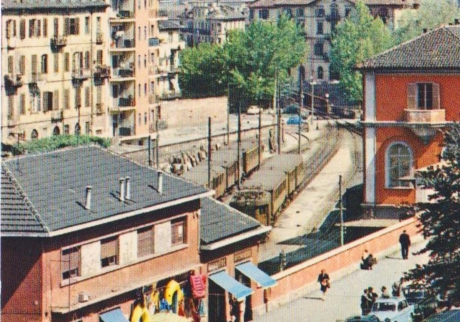
Un binario militare a Borgo Dora
di Paolo Arlandi
In zona Borgo Dora, sulle rovine dell’antica “Fabbrica delle Polveri” distrutta dalla tragica esplosione del 26 aprile 1852, sorge nel 1862 l’Opificio Militare dove, nell'Arsenale di Costruzioni e nell’Officina di Artiglieria si fabbricano affusti per cannoni e relativi carriaggi. Alcune tettoie verso la Dora sono utilizzate per la stagionatura dei legnami. Un ampliamento del 1869 comprende l’edificio dell’ex Ammazzatoio Municipale, ceduto dal Comune all’Amministrazione militare e nel 1879 è incorporato l’adiacente ex Mercato del bestiame, trasformato in caserma.
Le macchine dell’Arsenale e delle Officine sono mosse dalla forza idraulica del canale dei Molassi, che corre sul lato Ovest dello stabilimento. Per un certo periodo anche un impianto telodinamico contribuisce a fornire la forza motrice. Tale impianto, il cui motore idraulico è situato presso il canale della Ceronda, trasmette il moto tramite cavi aerei che scavalcano la Dora e raggiungono il luogo di utilizzo, dove un volano è collegato a un albero di trasmissione che aziona i macchinari della segheria.
Il trasporto delle materie prime e dei pezzi lavorati, di peso e dimensioni sempre più importanti, si svolge con carri a trazione animale, in maniera però del tutto insufficiente. Il problema trova una soluzione dopo l’apertura della ferrovia delle Valli di Lanzo, la cui stazione torinese viene a trovarsi a pochi metri dall’Opificio Militare. “In seguito a considerazioni speciali al servizio d’Artiglieria e per il bisogno di facilitare il trasporto degli affusti delle grosse bocche da fuoco, il Ministero della Guerra è pervenuto alla determinazione di costrurre un apposito binario di ferrovia fra l’Arsenale di Costruzioni di Borgo Dora e la vicina stazione della ferrovia Torino - Lanzo”. Il progetto del raccordo porta la data del 9 giugno 1879. La convenzione, fra Amministrazione militare e FTCL, si stipula il 7 luglio. Il 28 agosto si appaltano i lavori per “la preparazione del piano stradale per il tronco di ferrovia […], con apertura del passaggio nell’Arsenale e opere correlative”.
Il 23 marzo 1880 l’Arsenale di Borgo Dora è raggiunto da un corto binario, che si diparte dalla vicina stazione FTCL. Il traffico effettivo inizia il 1° ottobre, con l’attivazione del binario di collegamento fra FTCL e SFAI presso la Barriera di Lanzo. Il traffico dell’Opificio, infatti, non è rivolto alla linea delle Valli di Lanzo ma alla rete ferroviaria nazionale.
Il raccordo ha origine da uno scambio, posto sull’ultimo binario del piazzale di stazione. Tramite un cancello il binario esce sulla piazza Borgo Dora, che attraversa quasi diametralmente con una curva. Mediante un altro cancello, aperto nel muro di cinta dell’Arsenale, il raccordo entra nell’area militare. Qualche lamentela si leva nei giorni di mercato sulla piazza, poiché la striscia di terreno occupata dal binario deve essere mantenuta sgombra. All’interno dell’Arsenale il binario passa sotto un carro ponte e si affianca a un piano caricatore, quindi prosegue rettilineo e parallelo alla sponda destra della Dora fino a una piattaforma girevole, posta fra i due magazzini del legname, che permette di indirizzare i carri a un binario perpendicolare che raggiunge un cortile interno. Tale binario ha la particolarità di essere dotato, nello spazio fra le rotaie, di un altro binario a scartamento ridotto tipo Decauville, posato nel 1888 e utile a movimentare i carichi di legname dai magazzini citati. La lunghezza del raccordo è di 275 metri, di cui 75 su suolo pubblico. I carri, carichi principalmente di legname, affusti di artiglieria e materiale accessorio, sono inizialmente trainati da animali, occasionalmente da locomotive FTCL e, in seguito, da un veicolo ad accumulatori fornito dalla ditta STAE.
Nel 1923 il Comune acquista dall’Autorità militare la tettoia dell’ex macello per adattarla a mercato, insieme all’ex chiesa di Borgo Dora. A cominciare dal secondo dopoguerra avviene per gradi il trasferimento delle attività produttive dell’Arsenale. La convenzione con l’Amministrazione militare per il rinnovo del sedime stradale e la revisione del raccordo, del 23 maggio 1966, recepisce una rettifica di tracciato da operarsi all’interno dello stabilimento. Il binario è raddrizzato in prossimità del carro ponte e le curve di un flesso che consentono l’affiancamento al piano caricatore sono portate a un raggio di 120 metri.
Le vicende del complesso militare si concludono nel 1980, con la cessione della Caserma Sacchi al Comune di Torino. Nel progetto di riuso come edilizia scolastica, del dicembre 1981, è previsto un “accesso indipendente, poiché il raccordo ferroviario tuttora utilizzato dall’arsenale, situato a Nord-Est della piazza, non può essere eliminato”. Infatti la convenzione per il mantenimento e l’esercizio del raccordo è formalmente ancora attiva. La soluzione viene trovata con l’apertura di un ingresso in via del Fortino e comunque il raccordo risulta cessato nel novembre 1982. Il 3 agosto 1983 il “Servizio Missionario Giovani” (SERMIG), fondato nel 1964, trova negli spazi dell’ex Arsenale la sede adatta. Durante i lavori di rifacimento della linea Torino - Ciriè, dal settembre 1988 gli autobus del servizio sostitutivo hanno il capolinea nel piazzale interno della stazione, dove i binari 1 e 2 sono asportati per far posto a una corsia asfaltata. La pista per l’ingresso e l’uscita degli autobus coincide con il tracciato dell’ex raccordo per l’Arsenale e comporta la rimozione dell’antico cancello a due battenti dal recinto della stazione. Nell’occasione viene tolto anche il binario dal selciato della piazza di Borgo Dora.
Didascalie foto
Foto 1. 1880 circa. L’area libera fra la sponda della Dora e gli edifici dell’ex Ammazzatoio e dell’Arsenale, sarà interessata dalla posa del binario ferroviario. (Ingrandimento da cartolina. Collezione Arlandi)
Foto 2. Inizialmente il binario di raccordo termina con una piattaforma girevole, per inviare i carri all’interno dei magazzini. Particolare da: “Piano generale della Città di Torino”, litografia Fratelli Doyen, Torino, 1884.
Foto 3. 1910 circa. Il raccordo ferroviario attraversa piazza Borgo Dora. Un muro di recinzione, con un cancello per il binario, chiude l’area destinata a magazzino scoperto all’interno dell’Arsenale. (Ingrandimento da cartolina. Collezione Arlandi)
Foto 4. 1900 circa. La stazione ferroviaria e la piazza Borgo Dora. (Ingrandimento da cartolina. Collezione Arlandi).
Foto 5. Binario interno all’Arsenale nella sistemazione finale. (Arsenale dell’Esercito, Torino, planimetria generale. In: “Archeologia Industriale”, n. 1, giugno 1983).
Foto 6. 1966 circa. Sulla sinistra dei binari, l’origine del raccordo e il cancello verso piazza Borgo Dora. (Ingrandimento da cartolina. Collezione Arlandi).

UN CANTIERE CHE FA RIEMERGERE UN PASSATO INASPETTATO
di Luca Giannitti
Via XX Settembre è da tempo oggetto di un impegnativo cantiere che vede coinvolte diverse aziende tra cui il Gtt in quanto sono in fase di rinnovo diversi sottoservizi (come l'impianto fognario) ed è previsto anche il rinnovo dei binari del tram nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Bertola. Le rotaie della via sono piuttosto malandate sia per il forte utilizzo, sia per l'età avanzata: l'ultimo rinnovo risale all'estate del 1984. A nord di via Bertola i binari erano già stati cambiati con la riqualificazione del 2004 mentre il breve tratto all'altezza di piazza Paleocapa era stato rinnovato in occasione della rimozione del binario di via San Quintino (estate 2003), ma tutto il resto ha raggiunto la veneranda età di 37 anni.
Durante un sopralluogo di routine si è finito con il fare una scoperta inaspettata. I lavori non stanno ancora interessando l'armamento del tram, ci sono scavi legati all'impianto fognario con svariati pozzi di ispezione che occupano il lato sinistro della strada. Salvo le transenne di chiusura della strada, dal punto di vista dell'impianto tranviario il cantiere non presentava nulla di rimarcabile finché non si è notato un pezzetto di binario lungo circa 40 cm appoggiato vicino a un escavatore.
Il primo pensiero sovvenuto era che la rotaia fosse stata interrotta per uno scavo trasversale: ma tornando indietro ed esaminando con più cura tutto, non si è trovato nessuno spezzone mancante. Com'era quindi possibile? Da dove veniva quel binario? L'immagine in basso è stata scattata quasi all'angolo con via Arcivescovado e un flash riporta alla memoria una immagine anni '30 (poco più in basso):
Al tempo via XX Settembre era percorsa in un doppio senso tranviario, solo il 15 giugno 1951 la via diventerà definitivamente a senso unico e i tram diretti verso Porta Nuova verranno spostati su via Arsenale (un tentativo era stato fatto già nel 1934-38 senza però successo). I binari saranno quindi stati rimossi negli anni successivi, ma la particolare tecnica costruttiva ha portato a una rimozione parziale. Qui sotto si vede una cartolina anni '50 in cui si può notare in primo piano il binario ovest di via XX Settembre tagliato ma non ancora rimosso. Curioso il fatto che nel tratto a nord di via Bertola, la strada tornerà a doppio senso di marcia fino al 2000 quando il completamento del sottopasso di Porta Palazzo modificherà la viabilità nella condizione odierna, ovvero con il senso unico da sud verso nord.
Può essere che quel binario fosse ancora un resto di quel binario antico?
Negli anni Trenta, soprattutto in epoca di autarchia, l'uso di tutte le materie prime subì una forte razionalizzazione e per risparmiare un po' ovunque si escogitarono degli accorgimenti tecnici che in questo caso prevedeva l'assenza di traversine e la presenza di numerosi piccoli plinti in calcestruzzo in cui venivano annegate le "caviglie" che avrebbero fissato le rotaie.
Nelle due foto storiche qui in alto si nota molto bene sia il plinto sia l'attacco, esattamente lo stesso del pezzo riemerso in via XX Settembre. Questo significa che quando rimossero le rotaie tagliarono le parti non fissate agli attacchi mentre lasciarono sepolti gli spezzoni legati ai plinti. Spezzoni che oggi riemergono dal sottosuolo della via. Incredibile ma vero, dopo una settantina di anni dalla loro scomparsa questi binari tornano alla luce, per altro in condizioni di conservazione più che buoni. La rotaia è piuttosto usurata, si vedono segni anche nella gola (segno che il binario era giunto a fine vita), ma gli attacchi per il calcestruzzo sono integri o quasi. Sembra impossibile, tutto questo denota come in tutti questi anni nessuno ha mai scavato a fondo nella strada, ma ci si è sempre solamente fermati ai centrimetri superficiali.
Tornando alla tecnica costruttiva, occorre dire che tutt'oggi è utilizzata e sulla rete torinese si può incontrare in corso Svizzera: in fin dei conti le idee innovative applicate negli anni Trenta non erano poi così sbagliate.

Ritorno in Fiera. Model Expo Italy 2021
di Davide Fenoglio
Negli ultimi mesi molte nostre attività sono gradualmente riprese, seppur in forma ridotta.
Tra queste mancava ancora la partecipazione a fiere o eventi espositivi. Negli scorsi anni l’ATTS ha partecipato a numerose manifestazioni di questo tipo in Italia e all’estero. In particolare il settore modellismo è quello che più si muove verso destinazioni lontane dalla nostra città, portando in giro la nostra storia, i nostri progetti, le nostre realizzazioni. Model Expo Italy è un evento a cui partecipiamo da molto tempo, grazie anche alla preziosa collaborazione che si è instaurata con l’ente fieristico di Verona. Di anno in anno il nostro plastico, composto da oltre 10 moduli, realizzati dai soci modellisti si è ingrandito ed arricchito proprio in vista della partecipazione a questa fiera che in genere si tiene nel mese di marzo. A causa della pandemia l’edizione del 2020 è stata più volte rinviata fino a essere spostata a settembre 2021.
Così il 4 e 5 settembre ci siamo ritrovati tra i padiglioni della Fiera di Verona ed è stata l’occasione per rivedere tante persone, salutare vecchi amici e confrontarsi con altri esperti di modellismo.
Sul nostro plastico la novità di quest’anno è rappresentata del modulo “Trattoria”. Prima dal deposito tranviario due binari si staccano dalla linea principale e conducono ad un capolinea con raddoppio seguito dall’anello di inversione, situato in mezzo al verde. Dal punto di vista di chi sta sul tram, superato l’anello e ritornati sulla linea principale, è visibile l’edificio della trattoria, elemento da cui il modulo trae il nome. L’edificio conferisce a quella parte del plastico un aspetto quasi di campagna. Infatti è un capolinea che si trova in periferia dove i grandi palazzi e le strade trafficate cedono il passo alle casette e ai campi coltivati. Poco oltre si arriva al capolinea del Gerbido, ormai limite esterno della città.
Dal lato opposto, invece i binari proseguono verso il centro cittadino. Il primo spazio che si incontra è una piazza con mercato, seguita da un’altra piazza più aulica con una fontana al centro. Da lì si apre il grande e trafficato viale che conduce in piazza Statuto. Siamo così arrivati nel pieno centro cittadino.
Dal deposito fanno capolino anche nuovi mezzi: sono i tram serie 3000 dell’ATM Torino realizzati sia nella versione originale in due toni di verde, che in quella post ricostruzione. Dal momento che questi tram sono stati prodotti anche per la città di Madrid non poteva mancare la versione bianca e blu in servizio in questa città.
Il plastico ATTS non solo è affollato di tram di varie epoche e città, ma una grandissima collezione di autobus, automobili e altri mezzi particolari popola le strade di questa Torino in miniatura. Così le varie scenette ci raccontano di incidenti con intervento delle forze dell’ordine e di carri attrezzi, di lavori di ristrutturazione di palazzi ed edifici con impalcature, di manutenzioni stradali, di passeggeri alle fermate, di bambini al parco e di tanto altro.
L’arredo urbano è arricchito dalla segnaletica orizzontale e verticale, dai bidoni per la raccolta dei rifiuti, dai lampioni funzionanti, da fontane, panchine, edicole, parcheggi, capilinea. Tutto è molto realistico e realizzato con cura e attenzione ai particolari.
Infine non poteva mancare un grande espositore con i modelli di autobus più grandi, in scala 1:43. I bus di vari colori, epoche e dimensione hanno attirato l’attenzione dei visitatori quanto i numerosi tram in funzione sul plastico.
Sicuramente l’entusiasmo che ci ha dato la partecipazione alla fiera e il divertimento che scaturisce dalla nostra passione, ma anche dallo stare insieme ci fa ben sperare per il futuro e la ripresa di questa attività. Quello che è certo è che il plastico ATTS non si ferma ed i nostri soci hanno già in progetto grosse novità che sperano di poter presentare al più presto.
Foto Archivio ATTS
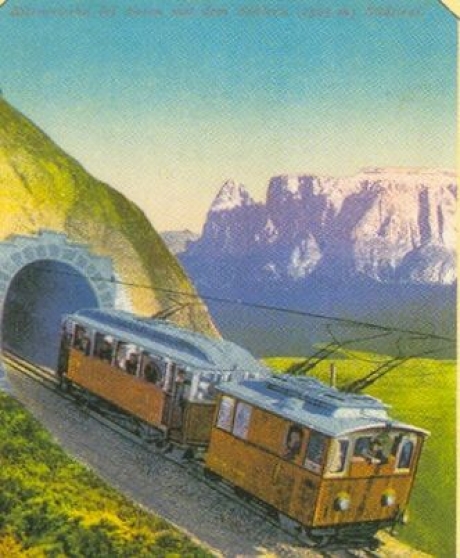
IN TRAM SULL'ALTOPIANO: LA RITTNERBAHN
di Roberto Cambursano

I TRAM DI DEBRECEN
di José Banaudo (traduzione Michele Bordone)
Durante il nostro soggiorno a Debrecen nei giorni 1 e 2 Settembre abbiamo avuto l'occasione di visitare le linee tranviarie gestite dalla compagnia DKV (Debreceni Kozlekedesi Vallalat - Compagnia dei Trasporti di Debrecen).
A scartamento normale e con una lunghezza di 19 Km, il servizio si compone di due linee aventi un tronco in comune dalla stazione ferroviaria principale Nagyallomas alla Piazza Calvin. (foto n° 01)
Da qui le due linee si separano:
- la linea 1 si dirige verso Klinikak (ospedale) e Egyetem (università) effettuando un anello di capolinea
- la linea 2 si dirige verso Doberdo Utca ugualmente con un anello di capolinea.
La dotazione di servizio comprende undici vetture Ganz Hunslet KCSV6-1S costruite tra il 1994 ed il 1997 (numerate da 500 a 510) e diciotto vetture CAF Urbos 3 consegnate nel 2013-2014 (numerate da 511 a 528). Le motrici articolate a due elementi serie 500-510 sono state costruite a Budapest negli stabilimenti Ganz in collaborazione con l'inglese Hunslet. Hanno una capacità di 163 passeggeri ed una potenza di 340 kW / 460 Cv con quattro motori Ansaldo. Le vetture Urbos 3 a cinque elementi serie 511 - 528 prodotte dalla spagnola CAF negli stabilimenti di Beasain nel 2013 - 2014 hanno una capacità di 221 passeggeri ed una potenza di 336 kW / 455 Cv.
Il gestore DKV possiede anche come riserva di esercizio cinque vetture modello FVV CMS 4 costruite nelle proprie officine tra il 1994 ed il 1997 più quattro motrici storiche e due motrici di servizio.
La vettura CAF Urbos 3 n° 511 sulla linea 2 incrocia la 518 della linea 1 alla fermata VAROSHAZA (municipio) davanti al Kistemplom, piccolo tempio riformato che due tempeste successive hanno privato della sua copertura a forma di bulbo... (foto n° 02)
Sulla linea 1 si può vedere la vettura 501 nella PLAC UTCA e la 503 al capolinea della stazione ferroviaria NAGYALLOMAS. (foto n° 3 - 4)
Le vetture sono decorate con una fenice, uccello mitico simbolo della città di Debrecen come si può vedere sulle vetture 515, 511 e 518 alla fermata VAROSHAZA (municipio) nella Plac utca. (foto n° 02 - 05 - 06)
Per andare dalla stazione al centro città il tronco in comune alle due linee segue la PLAC UTCA lungo la quale si possono ammirare alcune belle opere di "Art Nouveau " tipiche del l’Europa Centrale come questo ingresso ad un' antica galleria commerciale. (foto n° 07)
Lungo la centrale PLAC UTCA si trova la fermata VAROSHAZA, dove si incrociano le vetture 512 e 524, la quale serve il municipio ed il piccolo tempio riformato. La città di Debrecen è stata nel XVI secolo il punto più attivo di partenza della riforma protestante in Ungheria. (foto n° 08)
Le vetture 514 e 515 si incrociano sulla KOSSUTH TER dove sta passando anche la più agiata 504 in direzione della stazione. Questa piazza è dedicata a Lajos Kossuth, giornalista, uomo politico e rivoluzionario ungherese del XIX secolo. E' in questa piazza che si erge il Nagytemplom, principale tempio protestante della città. (foto n° 09 - 10)
La vettura 511 lascia la KOSSUTH TER con i suoi pali di sostegno della linea aerea artisticamente lavorati diretta verso la biforcazione della Kalvin tér molto vicina, mentre la motrice 510 si dirige verso la stazione decorata con una pellicola pubblicitaria della compagnia aerea ungherese Wizzair. (foto n° 11 - 12)
Le vetture 504 e 503 attraversano la KOSSUTH TER in direzione della stazione Nagyallomas. Nella lingua magiara il termine "stazione" si traduce indifferentemente "allomas" come a Debrecen o a Szeged oppure "palyaudvar" come a Budapest o a Miskolc. (foto n° 13 - 14)

TORINO TROLLEY FESTIVAL: PARATA DI MEZZI PER I 150 ANNI DI TRAM, E SIAMO ALLA 15° EDIZIONE...
di Alessio Pedretti
Nella giornata di Domenica 5 Dicembre 2021, si è potuta svolgere una nuova edizione del Torino Trolley Festival, giunto alla sua 15° edizione, la prima nella nuova era Covid-19, un segno di rinascita. Per l'occasione in quest'anno ricorrono anche i 150 anni di tram a Torino, degnamente ricordati con una parata di vetture tranviarie che non si vedeva da diverso tempo nel nostro paese. Pur nel rispetto delle regole l'avvenimento è stato decisamente sentito da parte dei torinesi che hanno partecipato alla sfilata, ai viaggi in vettura prenotabili ed hanno preso d'assalto il gazebo di ATTS ovvero la nota Associazione Torinese Tram Storici che da oltre un decennio ci allieta con notizie, eventi, lavori di restauro e recuperi tangibili e sotto gli occhi di tutti, a differenza di altre città ove ad esempio le aziende ignorano il proprio passato non riuscendo più a gestire il presente e mettendo in pericolo il proprio futuro vivendo d'immagine.
L'evento ha visto la parata di numerose vetture tranviaria che si sono sostanzialmente distinte percorrendo il tratto tra la Gran Madre, Piazza Vittorio Veneto, Via Po, Piazza Castello, i Giardini Reali e Rondò Rivella, parata alla quale hanno partecipato non solo gli "storici" torinesi ma anche gli esemplari ospiti di Roma e Trieste ed anche vetture utilizzate in regolare servizio passeggeri, come la 2828 per la omonima serie e la capostipite unidirezionale matricola 6000 per la famiglia dei Cityway, presente di sfuggita la 2823 "Gustotram" la quale tuttavia non ha partecipato alla sfilata principale in quanto già impegnata in altro servizio.
Queste di seguito le vetture impegnate nella parata e rilevate in piazza Castello intorno alle ore 12.00/12.30:
- elettromotrice 116, serie 101/150, costruzione Diatto-Siemens del 1911, trasformata in motrice di servizio da anni '50 al 1976, indi preservata.
- elettromotrice 502, serie 501/506, costruzione Ansaldo-Siemens del 1924, trasformata in motrice di servizio T433 sino al 2000 c.ca, recuperata prima staticamente e poi integralmente
- elettromotrice 2598, serie 2500/2599, costruzione FIAT-TIBB-CGE del 1933, restaurata e ritornata a Torino nel 2009, con mezza porta posteriore
- elettromotrice 2759, serie 2700/2771, costruzione Officine SNOS Savigliano del 1959, realizzata mediante unione casse motrici ex serie 600 e 700, preservata e funzionante dal 2012 cca.
- elettromotrice 2828, serie 2800/2902, costruzione Moncenisio-TIBB-Retam del 1933/37 come motrici serie 2100-2200, ricostruita nel 1979/81 da Seac Viberti, utilizzata tuttora in regolare servizio
- elettromotrice 2841, serie 2800/2902, costruzione Moncenisio-TIBB-Retam del 1933/37 come motrici serie 2100-2200, ricostruita nel 1980 da Seac Viberti, trasformata in "Ristocolor" nel 2001.
- elettromotrice 2847, serie 2800/2902, costruzione Off. Moncenisio-Tibb-Retam del 1933/37 come motrici serie 2100-2200, ricostruita nel 2009 con cassa "originale".
- elettromotrice 3104, serie 3100/3279, sottoserie 3100/3164, costruzione FIAT-TIBB-CGE del 1949, ricostruita da Seac Viberti nel 1976/77 e "dericostruita" nel 2009.
- elettromotrice 3179, serie 3100/3279, sottoserie 3165/3224, costruzione FIAT Materfer-CGE del 1958, ricostruita da Seac Viberti nel 1976/77, modificata nel 2007 come Tram Teatro.
- elettromotrice 3501, esemplare unico, costruzione Officine ATM-CGE del 1946, con parti meccaniche della 3001 del 1942, soprannominata "la sposa".
- elettromotrice 6000, serie 6000/6005, sottoserie "Cityway monodirezionali", costruzione Alstom del 2001, primo esemplare della serie, velettato per l'occasione "Trolley Festival".
- elettromotrice T427, costruzione Diatto-TIBB-CGE del 1911, trasformata ATM anni '50, dotata di nuova cassa nel 1989, vettura in origine ex serie 446/500, già 174/230 della "Belga".
- elettromotrice MRS 312 ex STEFER Roma, costruzione Carminati & Toselli del 1935, serie 301/312, completamente ristrutturata onde esser preservata dinamica
- elettromotrice 447 ex ACEGAT Trieste, costruzione OMS Stanga del 1938, poi STEFER Roma dal 1963, recuperata nel 2015 a Torino
Un grazie particolare ad ATTS ed a tutti i soci operativi che hanno reso possibile questo avvenimento e che si impegnano ogni giorno per gestire eventi del genere e preservare la storia della propria città, un particolare grazie va anche all'azienda GTT Torino che rende possibile tutto questo, generando interesse nei cittadini e nella storia della propria città e dell'azienda stessa; un particolare spesso dimenticato da aziende di altre città particolarmente miopi e che non sanno far tesoro del valore della propria storia.
Nelle FOTO, tutte del 5 Dicembre 2021, è possibile osservare le vetture impegnate nella parata mentre sfilano in Piazza Castello davanti al Teatro Regio, oltre che in un paio di scorci ai Giardini Reali.

Novità tranviarie dal mondo al 12/2021
di Roberto Cambursano
Si riportano le principali variazioni riguardanti il “Sistema tram” nel mondo, intervenute nel periodo dicembre 2020-novembre 2021. Sono evidenziate in giallo le “nuove città tranviarie”. Le notizie provengono principalmente dalle seguenti fonti: Tramway and urban transit (LRTA); Metro Report International; Railway Gazette International; Urbanrail.net.
Aggiornamento al 1° dicembre 2021
ALGERIA
COSTANTINA: il 29 settembre 2021 la linea tranviaria esistente (inaugurata nel 2013) è stata prolungata di 3,5 km verso sud da Chahid Kadri Brahim a Université Abdelhamid-Mehri. La linea ha ora una lunghezza complessiva di 18,2 km e il parco rotabile è formato da 47 tram Alstom Citadis 402 a pianale interamente ribassato, la seconda serie dei quali è stata fabbricati in Algeria dalla Cital (azienda partecipata al 49% da Alstom e al 51% da imprese algerine)
AUSTRIA
GRAZ: il 26 novembre 2021 sono stati inaugurati due nuovi tratti di rete tranviaria nella zona ovest della città: da Alte Poststraße a Reininghaus (Linea 4: +1.8 km) e da Daungasse/Hbf a Smart City (Linea 6: +1.5 km). La rete tranviaria del capoluogo della Stiria ha ora un’estensione complessiva di 36,8 km con 6 linee.
CINA
CANTON: il 28 dicembre 2020 la linea tranviaria di Huangpu è stata prolungata di 7,3 km da Changping Subway Station a Xiangxue Subway Station; su questa linea sono impiegati tram a pianale totalmente ribassato dotati di supercapacitori; tutta la linea è sprovvista di alimentazione aerea. Attualmente Canton dispone di due linee tranviarie, con uno sviluppo totale di rete di 22 km. Esse servono da adduzione alla vasta rete di metropolitana.
FOSHAN: il 18 agosto 2021 è stata inaugurata la seconda linea tranviaria della città (Nanhai line), a standard di LRT, da Sanshanxinchengbei a Leigang (dove c’è l’interscambio con la linea metropolitana interurbana per Canton). La lunghezza è di 9,5 km. Sono in servizio 16 tram CRRC a pianale interamente ribassato. Attualmente lo sviluppo totale della rete tranviaria di Foshan è di 16 km. Sulla prima linea (Gaoming line) sono in servizio 8 tram allestiti dall’aziende cinese CRRC su modello Skoda 15T, che montano batterie integrate con fuell-cells a idrogeno.
JIAXING: il 25 giugno 2021 è stata inaugurata la prima linea di questa città situata a metà strada tra Shanghai e Hangzou. Il primo tratto, dalla stazione ferroviaria Sud a Fanggong Road, è lungo 10,6 km. Sono in servizio 20 tram a pianale interamente ribassato prodotti da CRRC che montano supercapacitori. La linea aerea è completamente assente.
SHENYANG: il 3 febbraio 2021 la linea 5 è stata prolungata di 5.2 km da Xuantujun Heritage Park a Lishizhai. La rete tranviaria, che copre la zona sud della città al di là del fiume Hunhe, si estende ora su 60 km ed è composta da sei linee con una flotta complessiva di 35 tram. I veicoli, fabbricati in Cina da un consorzio che comprende la locale Changchun Railway Vehicles Company e la casa tedesca Voith, sono a pianale interamente ribassato e sono dotati di supercapacitori per il superamento di alcune tratte non dotate di linea aerea.
WENSHAN: il 15 maggio 2021 è stata inaugurata la linea 4, prima linea tranviaria della città. Ha una configurazione di percorso ad Y, con uno sviluppo totale di 14 km, e collega la stazione ferroviaria di Puzhehei con il Tourist Center e con Jaolian Plaza nel sobborgo di Qiubei. Vi fanno servizio 15 tram a pianale interamente ribassato prodotti da CRRC che montano supercapacitori. La linea aerea è completamente assente.
FINLANDIA
HELSINKI: il 6 aprile 2021 la linea 6 è stata prolungata di 1 km su un tratto di nuova costruzione da Hietalahdentori a Eiranranta; il 3 maggio 2021 la linea 9 è stata prolungata di 0,9 km su un ulteriore tratto di nuova costruzione da Saukonkatu a Länsiterminaali T2. La rete tranviaria della capitale finlandese ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 48 km (a scartamento metrico) su 10 linee.
TAMPERE: il 9 agosto 2021 è stata aperta la nuova rete tranviaria che si estende su 14,2 km e comprende due linee (1: Sorin aukio - Kaupin kampus e 3: Hervantajärvi - Pyynikintori). Sono in servizio 19 tram Skoda Forcity Smart Artic bidirezionali articolati lunghi 37,3 metri a pianale interamente ribassato.
FRANCIA
LIONE: il 1 febbraio 2021 è stata attivata la linea T7, da Vaulx-en-Velin/La Soie) a Décines/OL Vallée), che percorre integralmente binari già esistenti. Il 24 marzo 2021 la linea T2 è stata prolungata da Gare Perrache a Hôtel de Région/Montrochet, a rafforzamento della linea T1 sugli stessi binari già esistenti. La rete tranviaria di Lione si sviluppa ora complessivamente su 73 km e conta 8 linee, di cui una interurbana che collega l’aeroporto Saint Exupéry (Rhonexpress). Il parco rotabile è composto da 103 motrici a pianale interamente ribassato tipo Alstom Citadis 302/402 e 6 tram Stadler Tango a pianale parzialmente ribassato per il Rhonexpress. Vi sono inoltre 2 linee di tram-treno (“tram-train de l’ouest”) gestite da SNCF che utilizzano linee ferroviarie dismesse completamente separate dalla rete tranviaria urbana, per complessivi altri 40 km.
PARIGI: il 10 aprile 2021 è stata inaugurata la linea T9, lunga 10,3 km, da Porte de Choisy a Orly Gaston Viens. Sono entrati in servizio 22 tram Alstom Citadis 405 lunghi 45 metri. La rete tranviaria della capitale francese ha caratteristiche atipiche: è estesa su un totale di 138 km ed è composta da dieci linee gestite in modo indipendente (e non compatibili tra loro in quanto dotate di sistemi differenti). Tra di esse vi sono una linea urbana tangenziale, cinque linee periferiche, due linee di tram su gomma e due linee di tram-treno.
GERMANIA
BERLINO: Il 31 ottobre 2021 è stato inaugurato un nuovo tratto di 2,7 km alla periferia sud-est tra Schöneweide e Karl-Ziegler-Straße, che collega due tratti di rete già esistenti: sui nuovi binari sono state instradate le linee M17 e 61, entrambe prolungate. La rete tranviaria di Berlino è attualmente la terza al mondo per estensione, con 178 km e 22 linee (oltre a 2 linee suburbane per altri 20 km di rete), quasi integralmente comprese nella parte est della città (ex DDR).
DRESDA: il 10 dicembre 2020 ha cessato definitivamente di circolare il “Cargotram”. Il servizio, attivo dal 2001, trasportava componenti automobilistici fra due stabilimenti della Volkswagen lungo un tratto di 5,5 km della rete tranviaria cittadina, operando in convogli lunghi fino a 59,4 m formati da motrici (5 di dotazione) e rimorchi (7 di dotazione) ricavati dalla ristrutturazione di vecchi tram Tatra.
FRIBURGO: il 13 dicembre 2020 la linea 4 è stata prolungata su un nuovo tratto di 1 km da Technische Fakultät a Messe. La rete tranviaria di Friburgo conta 5 linee per complessivi 36 km.
MAGDEBURGO: il 16 dicembre 2020, è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,1 km tra Raiffeisenstraße e Warschauer Straße, di collegamento fra due tratti di rete esistenti. Il 29 novembre 2021 è stata prolungata la linea 1 su un nuovo tratto di 1 km fra Milchweg e Kannenstieg. La rete tranviaria di Magdeburgo si estende su 60 km e conta 9 linee.
LUSSEMBURGO
LUSSEMBURGO: Il 13 dicembre 2020 l'unica linea tranviaria esistente è stata prolungata da Place de l’Etoile a Gare Centrale su un nuovo tratto di 2 km completamente sprovvisto di catenaria. Il parco rotabile è composto da 32 tram CAF Urbos 100 articolati da 45,4 metri a pianale interamente ribassato, equipaggiati con il sistema ACR a supercapacitori.
MAURITIUS
PORT LOUIS: il 20 giugno 2021 la linea tranviaria interurbana "Metro Express" è stata prolungata di 2,6 km da Rose Hill a Quatre bornes. La linea è ora lunga 15 km. Il materiale rotabile è costituito da 18 tram Urbos LRV bidirezionali a pianale parzialmente ribassato costruiti da CAF.
NUOVA ZELANDA
AUCKLAND: il 7 febbraio 2021 è stato ripristinato il servizio della linea storica (“Wynard Quarter heritage tramway”), che era stato sospeeso a causa di grandi lavori di riqualificazione della viabilità nella zona del porto. La linea, inaugurata nel 2011, impiega 2 tram su un anello di 1,5 km.
POLONIA
BYDGOSZCZ: il 6 dicembre 2020 è stato inaugurato un nuovo tratto di 0,7 km tra Rondo Kujawskie e Zbozowy Rynek, di collegamento fra due tratti di reti esistenti. La rete tranviaria ha raggiunto un’estensione totale di 41 km con 11 linee.
BRESLAVIA: il 26 giugno 2021 è stato inaugurato un nuovo tratto di collegamento tranviario di 1,5 km fra Plac Orlat Lwowskich e Srubowa. La rete tranviaria di Breslavia (Wroclaw) è composta da 22 linee e ha un’estensione totale di 92 km.
POZNAN: il 21 agosto 2021 la linea 3 è stata prolungata su un nuovo tratto di 1 km da Wilczak a Ul. Wlodarska. La rete tranviaria di Poznan è composta da 18 linee e ha un’estensione totale di 71 km.
VARSAVIA: il 4 settembre 2021 le linee 2 e 17 sono state prolungate di 1,2 km su un nuovo tratto da Nowodwory a Winnica alla periferia nord. La rete tranviaria della capitale polacca è composta da 25 linee (più una linea storica) e ha uno sviluppo complessivo di 127 km.
QATAR
DOHA: il 17 novembre 2021 è stato inaugurato il secondo tratto di 2,6 km (linea gialla) della sottorete tranviaria “Education City”. Destinata a raggiungere un’estensione totale di 11,5 km, è situata nella zona universitaria alla periferia ovest della città ed ha funzioni di adduzione alla “Green Line” di metropolitana. Sono in servizio 19 tram Siemens Avenio a pianale interamente ribassato lunghi 27,7 metri ed equipaggiati con il sistema “Sitras” a supercapacitori. Tutta la rete è completamente sprovvista di catenaria.
RUSSIA
PERM: il 12 gennaio 2021 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1 km fra Dinamo e Dvorets Sporta Orlyonok, che collega due tratti di linea già esistenti. Su di esso sono state instradate le linee 6 e 11.
SAN PIETROBURGO: il 6 ottobre 2021 la linea 7 è stata prolungata di 1,4 km da Granitnaya a Metro Ladozhskaya. La rete municipale si sviluppa ora su 208 km con 37 linee e 730 veicoli in servizio ed è la più estesa della Russia. Dal 2018 è inoltre in funzione una sottorete tranviaria privata ("fast tram") nella zona est, che comprende quattro linee per complessivi altri 14 km di rete e con una flotta di 23 unità di tipo Staldler Metelitsa.
STATI UNITI D’AMERICA
CHARLOTTE (North Carolina): il 30 agosto 2021 è stata attivata la seconda linea di LRT (Lynx Gold Line) da French Street a Sunnyside Avenue, su una lunghezza di 6,4 km. Vi fanno servizio 6 nuove unità Siemens S700 a pianale parzialmente ribassato. La tratta compresa fra Transportation Center e Hawthorn/5th era già stata aperta nel 2015 e provvisoriamente esercitata fino al 2019 con tram storici. L'altra linea è la "Lynx Blue line", lunga 30 km, che incrocia la Gold Line a Transportation Center/Arena.
GALVESTON (Texas): il 1° ottobre 2021 è stato riattivato il servizio sulla linea storico-turistica "Galveston island trolley", che era stato inaugurato nel 1988 ed interrotto nel 2008 dall'uragano "Ike". La linea, non elettrificata, è lunga 11 km e vi sono impiegati 4 tram storici sui quali sono montati motori diesel che fungono da generatori di corrente per i motori elettrici.
SAN DIEGO (California): il 21 novembre 2021 la “Blue Line” è stata prolungata su un nuovo tratto di 17.5 km verso nord lungo il litorale a fianco dell’autostrada I-5 da Old Town a UTC (zona universitaria). Il sistema di LRT della città californiana, denominato “San Diego Trolley” ha raggiunto uno sviluppo complessivo di 100,5 km con 3 linee (blue, orange e green) e una flotta di 146 veicoli, più una linea storica circolare centrale (silver line).
SEATTLE (Washington): Il 2 ottobre 2021 la linea “Link” di LRT, ridenominata linea 1, è stata prolungata di 6,9 km su un tratto quasi interamente sotterraneo da University of Washington a Northgate. La linea 1 è ora lunga 39 km e vi è impiegata una flotta di 62 veicoli. Seattle dispone anche di due linee tranviarie centrali sviluppate in totale su altri 6 km di rete.
SVEZIA
LUND:un nuovo nome si è aggiunto all’elenco delle città tranviarie svedesi, con l’inaugurazione avvenuta il 13 dicembre 2020 della linea 1 (anche denominata "LundaExpressen"), che collega la stazione ferroviaria di Lund con il complesso ESS. Il percorso è lungo 5,5 km e vi fanno servizio 7 tram CAF Urbos 100 bidirezionali articolati lunghi 32 metri a pianale interamente ribassato.
STOCCOLMA: il maggio 2021 è stato inaugurato un nuovo tratto di 1,1 km da Norra Ulvsunda all’aeroporto di Bromma. La ex linea 22 (tangenziale) è stata rinominata 30, mentre è stata istituita la nuova linea 31 da Alviks Strand a Bromma. La rete tranviaria della capitale svedese conta oggi 5 linee completamente separate tra loro, di cui 4 periferiche a standard di LRT completamente in sede propria e una centrale di tipo più tradizionale con transito stradale promiscuo. Vi è anche la linea storica 7N, gestita regolarmente dall’Associazione SSS su una parte del tracciato della linea 7 con veicoli d’epoca restaurati. L’estensione complessiva della rete è di 40 km.
SVIZZERA
LUGANO: a partire da settembre 2021 sono entrati in servizio sulla ferrovia locale a scartamento metrico Lugano-Ponte Tresa i nuovi tram fabbricati da Stadler, destinati a sostituire integralmente il vecchio materiale ferroviario. La nuova flotta è composta da 9 "Tramlink" a pianale interamente ribassato. La linea, inaugurata nel 1912, è attualmente lunga 12 km. Nei prossimi anni sono previsti grandi lavori di ampliamento, con un nuovo tunnel che diminuirà la tortuosità del percorso e un prolungamento verso il centro di Lugano. Riclassificata come una tranvia interurbana, correrà interamente in sede propria. Si può anche definirla come un "tram-treno improprio" (in quanto percorre binari ferroviari completamente separati dal resto della rete ferroviaria).
KAOHSIUNG: Il 12 gennaio 2021 la linea di LRT (futura circolare) è stata prolungata alle due estremità da per un totale di 4,1 km, che portano provvisoriamente la lunghezza complessiva a 12,8 km. Sono entrati in servizio 15 tram Alstom Citadis 305 dotati di supercapacitori, che si aggiungono ai 9 CAF Urbos già in servizio (dotati di sistema ACR). L’intera linea è completamente sprovvista di catenaria: la ricarica si effettua alle fermate tramite contatto dall’alto con apposite sezioni di alimentazione.
TURCHIA
ANTALYA: il 25 ottobre 2021 la linea T3 è stata prolungata di 6,5 km da Atatürk a Müze, saldandosi così alla rete delle altre due linee esistenti. La rete tranviaria locale dispone ora nel suo complesso di tre linee, di cui due (T1 e T3) a standard di LRT e una (T2) gestita provvisoriamente con materiale storico ex-tedesco, destinata ad essere ammodernata e assorbita dal futuro prolungamento della linea T3. In totale sono in esercizio 47,5 km di rete moderna, con una flotta composta da 14 tram forniti dalla casa spagnola CAF e da 18 tram Eurotem (costruiti in collaborazione fra la casa coreana Hyundai Rotem e quella turca Tüvasaş), oltre a 4,7 km di binario unico di linea storica nel centro cittadino su cui corrono due tram ex-Norimberga.
ISTANBUL: Il 4 gennaio 2021 è stata inaugurata la linea T5 su un primo tratto di 8,8 km fra Alibeyköy e Cibali lungo la costa meridionale del Corno d’Oro. Sono stati immessi in servizio 30 tram Durmazlar LRV costruiti in Turchia che montano un equipaggiamento elettrico Alstom; l’alimentazione avviene esclusivamente da terra col sistema APS. La rete tranviaria di Istanbul conta 3 linee moderne per complessivi 43 km (T1, T4 e T5) e 2 storiche (T2 e T3) che si sviluppano su altri 4 km. Il parco circolante conta 200 unità (+7 vetture storiche).
ESKISEHIR: il 12 marzo 2021 la linea 12 è stata prolungata da Ökyü a 75 Yil su un nuovo tratto di 4,6 km, mentre il 14 giugno 2021 la linea 10 è stata prolungata da Opera a Kumlubel su un ulteriore nuovo tratto di 2,4 km. La rete tranviaria a scartamento metrico della città è la più estesa della Turchia e ha raggiunto l’estensione complessiva di 54,5 km, con 8 linee gestite.
UNGHERIA
SZEGED (Seghedino): il 29 novembre 2021 è stata inaugurato un collegamento di tram-treno con la vicina cittadina di Hódmezövásárhely (prolungamento linea 1). Il servizio è effettuato con 12 veicoli bimodali elettrici/diesel Stadler Citylink: la prima parte della linea utilizza la rete tranviaria urbana a doppio binario già esistente nella città di Szeged, segue poi un tratto ferroviario non elettrificato a binario unico delle ferrovie statali tra Szeged-Rókus e Hódmezövásárhely-Népkert per 22km e infine percorre un nuovo tratto tranviario urbano di 3,6 km a binario unico nel centro di Hódmezövásárhely.

Il restauro del tram 614
di Davide Fenoglio
Il tram n° 614 del 1928 è l’unico esemplare rimasto della serie 600-625, ultima interamente costruita nelle officine dell’allora Azienda Tranvie Municipali (ATM). Le 600, vetture a due assi, sono le prime dotate di cassa metallica e sono soprannominate “ferri da stiro” per il vapore acqueo che si forma sulle resistenze poste sul tetto durante determinate situazioni atmosferiche. Nascono bidirezionali, ma in occasione delle prime revisioni generali vengono modificate in unidirezionali e dotate di porte pneumatiche. Vestono dapprima la caratteristica livrea rosso crema, ma quasi subito vengono ricolorate nel nuovo “bi-verde” previsto dal decreto ministeriale del 1929. Il tram 614 ha prestato servizio sulla rete urbana di Torino fino alla fine degli anni Cinquanta. Successivamente, non più idonee per l’accresciuto volume di passeggeri del dopoguerra, le vetture della serie 600 vengono progressivamente dismesse. Alcuni esemplari sono utilizzati per la realizzazione di altri tram, mentre la vettura 614 è accantonata a Torino presso un demolitore. Nel 1968 viene acquistata da un gruppo di appassionati che decide di utilizzarla per farne il proprio luogo di ritrovo. Privata del truck, viene quindi trasportata nella frazione Piagera di Gabiano in provincia di Alessandria, dove trova collocazione presso il parco fluviale del Po e viene utilizzata come zona coperta di un’area pic-nic. Il tram caratterizza quel luogo tanto da fargli assumere il toponimo “Località Tram”.
A partire dagli anni 2000 la vettura viene progressivamente abbandonata ed è oggetto di atti vandalici. Inoltre, patisce sempre più l’esposizione alle intemperie. Nel 2012 l’ATTS si interessa alla 614 e la recupera scambiandola con la cassa del tram 3186 che viene posizionata nella stessa area. Il tram viene portato prima in terreno privato a Leini, poi nel 2015 nel deposito GTT della Metropolitana a Collegno, dove sono ospitati i mezzi ATTS in attesa di restauro. In questo sito è oggetto dei primi interventi dei soci operativi finalizzati a prevenire un ulteriore deterioramento del mezzo: applicazione vernice protettiva, rimozioni parti lignee e metalliche danneggiate, pulizia generale. Il tram, anche se protetto, è all’aperto e necessita di una nuova collocazione e di un urgente intervento di restauro.
Atts, perciò si mette alla ricerca di contributi per iniziare le attività di ripristino estetico e funzionale e per portare il mezzo in luogo coperto. Grazie all’interesse di alcuni soci, nella primavera dello scorso anno, viene avviata una nuova e interessante collaborazione con la Cooperativa Liberi Tutti. Essa è una realtà radicata sul territorio che si occupa, tra le tante cose, di progettazione e sostegno alle associazioni nella ricerca e nell’elaborazione di bandi. Questa partnership permette l’avvio di un’azione di ricerca di possibili finanziamenti finalizzati al ripristino di qualcuno dei nostri mezzi storici non ancora restaurati.
Sono attivati una serie di contatti molto proficui e si elabora un progetto articolato e compartecipato di restauro del tram 614 che ha finalmente permesso l’assegnazione del “Bando Restauri - Cantieri Diffusi 2021” di Fondazione CRT. La finalità di questo bando è sostenere interventi di recupero del patrimonio storico artistico e architettonico regionale per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di un ampio pubblico. Si tratta di un grande risultato dell’associazione, non solo perché permette di avviare i lavori su un mezzo unico e bisognoso di un intervento urgente, ma anche perché, per la prima volta un tram viene riconosciuto come parte del patrimonio storico-artistico collettivo. La quota di cofinanziamento del bando è garantita dalla generosa donazione di un socio.
Questo contributo permetterà l’avvio dei lavori e la creazione di una serie di relazioni utili a far conoscere l’operato dell’ATTS e ad avvicinare nuove persone e nuove professionalità alle nostre attività. Si è pensato di lavorare ad un progetto di “Tram di quartiere” coinvolgendo realtà operative collocate nei pressi della sede ATTS di Ponte Mosca, nel quartiere Aurora di Torino. Il cantiere sarà ospitato dalla Casa del Quartiere “Cecchi Point” di via Antonio Cecchi, dove in uno spazio coperto all’interno del cortile sarà collocata la vettura. Le lavorazioni saranno realizzate dalle Officine Creative, spazio per artigiani presente nella stessa Casa del Quartiere. Anche i soci operativi ATTS daranno il loro competente contributo sia nel cantiere, che attraverso la ricerca di materiale e documentazione. L’intervento finanziato si svolgerà nel corso del 2022. I lavori sono incentrati essenzialmente sul risanamento della cassa e degli interni del tram, mentre è rimandato ad una fase successiva il più complesso ripristino funzionale. Inizialmente, le singole parti del tram verranno smontate, pulite, catalogate e restaurate. Qualora le condizioni di conservazione non consentano un ripristino dei pezzi originali, verranno realizzate copie anche sulla base di progetti e documentazione presenti nei nostri archivi e tra le nostre foto. Parallelamente il cantiere si occuperà anche del telaio del tram, sul quale saranno applicati in modo da non essere visibili i nuovi impianti elettrici a bassa tensione e le nuove condotte pneumatiche. Per motivi di sicurezza ed esigenze di omologazione i comandi della vettura saranno simili a quelli presenti sui tram storici attualmente in circolazione. L’ultima fase del restauro prevede la verniciatura finale, fatta a mano coerentemente con le modalità operative dell’epoca, la realizzazione delle decorazioni, delle scritte e dei particolari. La colorazione scelta sarà quella bi-verde che ha caratterizzato la vettura dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 1929. Il tram sarà quindi fruibile in forma statica, ma predisposto per il prosieguo dei lavori sulla parte meccanica di trazione.
La collocazione in luogo accessibile a tutti consentirà un ampio coinvolgimento del pubblico, anche attraverso la realizzazione di appositi eventi e permetterà una ampia visibilità delle varie fasi operative del cantiere. Con questo si apre un nuovo approccio al restauro da parte di ATTS, più inclusivo, aperto a tutti e incentrato sul territorio. Sicuramente l’associazione beneficerà delle competenze delle nuove professionalità presenti e dell’inserimento in un contesto operativo diverso. In cambio restituirà alla città e ai suoi abitanti un nuovo e prezioso bene culturale che porta con sé una storia unica e particolare.
L'intervento di restauro è realizzato grazie al contributo di Fondazione CRT ![]()
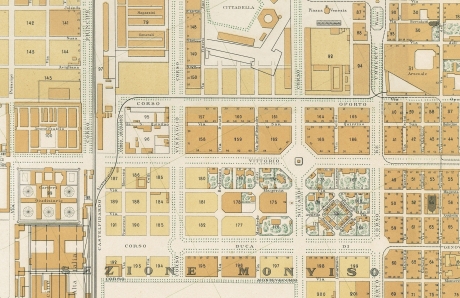
Il raccordo dell'Arsenale Militare
di Paolo Arlandi
La prima ipotesi di una ferrovia per raggiungere l’Officina di Artiglieria dell'Arsenale risale al 13 maggio 1871. Secondo quanto proposto dal servizio del Genio Militare la linea, allacciata allo scalo di Porta Susa, avrebbe compreso tre segmenti di binario rettilinei, perpendicolari fra loro, collegati con piattaforme girevoli. Un disegno adatto al tipo di trazione animale previsto, ma che avrebbe limitato il traffico all’inoltro di un carro per volta. La dimensione ridotta delle piattaforme, inoltre, avrebbe imposto un passo assiale assai limitato.
Il 27 novembre 1872, il Genio Militare trasmise un nuovo progetto con indicazione di un diverso tracciato per la linea di raccordo, dettato dalla scelta di sostituire la trazione animale con quella a vapore e di consentire il traffico di interi convogli. Dal nuovo elaborato scomparvero le piattaforme girevoli, il binario presentò una sola curva fra corso Oporto e corso San Martino e l'innesto direttamente sulla linea ferroviaria principale. La soluzione fu anche conseguente al divieto che la SFAI oppose all’ingresso del raccordo nello scalo di Porta Susa.
Il 7 luglio 1877 si stipularono la convenzione e l’atto di concessione del Comune per la costruzione del tratto di linea. All’Officina di Artiglieria i lavori per l’apertura del nuovo ingresso destinato ai carri ferroviari, in corso Re Umberto 7 angolo corso Oporto, terminarono il 10 aprile 1879. La “linea di diramazione” o “ferrovia militare”, com’è indicata sulla cartografia coeva, fu completata il 25 aprile 1879.
Intanto, a dicembre 1877, si conclusero gli studi per la fusione di un cannone da 100 tonnellate destinato alla Regia Marina. A fine marzo 1879 il cannone fu approntato e si attese la consegna dell’apposito carro a 12 assi, costruito dalla ditta Schneider di Le Creusot, per il trasporto alla Spezia.
Dopo una circolazione sperimentale, il primo trasporto sul raccordo avvenne il 5 luglio 1879, quando s’inviarono alla stazione di Torino Porta Susa tre cannoni di grosso calibro. Infine, il 26 dicembre alle ore 13, “un denso fumo di vaporiera e un sibilo acuto richiamava all’angolo di via Oporto e corso Re Umberto gran folla di curiosi e di passanti. S’era spalancato poco prima il nuovo portone che dall’interno dell’Arsenale riesce in via Re Umberto e da cui parte il nuovo binario che per via Oporto conduce alla ferrovia di Porta Susa. Una vaporiera d’alta forza ne era uscita lentamente, mandando frequenti sbuffi di fumo nerastro. Appena oltrepassata la soglia del portone la macchina si arrestò e comparvero un nuovo immenso carro ferroviario con suvvi un cannone colosso”.
Sul binario militare si svolse negli anni successivi un raro traffico, legato a saltuari invii di pezzi di artiglieria pesante. Pertanto l’articolo 2 della convenzione con il Comune, rinnovata il 12 ottobre 1907, impose all’Amministrazione militare, durante gli intervalli di non utilizzo del raccordo, “di riempire lo spazio compreso fra rotaia e controrotaia con ghiaietta e sabbia, in modo da eguagliare il piano stradale”.
Il progetto di abbassamento del piano nel ferro del nodo di Torino vide una prima attuazione nel 1915, con il posizionamento in trincea del tratto di linea fra Bivio Crocetta e Torino Porta Susa. Le opere inizialmente compresero in pratica solo il cavalcavia di corso Vittorio Emanuele II e la conseguente eliminazione del trafficato passaggio a livello, ma la nuova sistemazione della linea ferroviaria non consentì più la diramazione a raso su corso Castelfidardo. In conseguenza il raccordo militare rimase allacciato alla stazione di Porta Susa tramite il binario posato nel 1906 su corso Grugliasco, a favore della Società Tranvie e Ferrovie Economiche.
L’Officina di Artiglieria, cessata l’operatività nel 1925, fu ceduta con il raccordo al Comune il 30 giugno 1926. La demolizione fu deliberata a fine 1927. I lavori di abbattimento degli impianti della fonderia terminarono, per il fronte di corso Oporto, a giugno 1933. Il binario di raccordo fu smantellato durante la demolizione degli edifici.
IMMAGINI
Fig. 1 - 1884. Raccordo per l'Officina di Costruzioni di Artiglieria (Piano Generale della Città di Torino, ASCT, Tipi e Disegni, 64.5.15, edizioni Fratelli Doyen)
Fig. 2 - 1926. Particolare dell'innesto del binario militare sul raccordo dello Scalo di Porta Susa, dopo l'abbassamento del piano della ferrovia (Piano Regolatore Generale 1926, F03-F04, edizioni Fratelli Doyen).
Fig. 3 - 1925. Curva del binario militare fra corso Oporto e corso Grugliasco (Ferrovie dello Stato, convenzione con STTFE, archivio Compartimentale FS Torino, collezione FERALP Bussoleno).

IL TRAM AL FEMMINILE
LE PIONIERE: MANOVRATRICI E BIGLIETTAIE DI FINE '800 SUI TRAM CILENI
di Marcela F. Luque
Nel mese di marzo del 1888, la Empresa de Ferrocarril Urbano (incaricata della gestione della rete del tram a cavalli di Santiago del Cile tra il 1873 e il 1898) decise di aumentare di mezzo centesimo la tariffa di seconda classe sui tram che operavano in città.
Il Partito Democratico organizzò per la domenica 8 aprile 1888 una manifestazione per protestare contro l'aumento del biglietto di seconda classe: vi furono dei tram sganciati dai cavalli e ribaltati dalla forza della folla e alcune delle vetture furono persino date alle fiamme. Più di cinquanta persone furono arrestate per aver contribuito ai disordini e vi furono almeno tre donne che testimoniarono sui molteplici disordini accaduti durante la manifestazione. Emilia Morales, Carmen Navarrete e Marìa Luisa Navia erano tutte e tre manovratrici tranviarie che si trovarono, durante il proprio turno di lavoro, in mezzo al fuoco incrociato di quella che sarebbe stata considerata dalla Storia la prima grande manifestazione allo scopo di chiedere miglioramenti nel sistema di trasporto della città.
Mancavano ancora tren’anni perchè in Europa si sfiorasse l’idea di impiegare donne come lavoratrici tranviarie: il che avvenne per via della scarsità di mano d’opera maschile dovuto alla Grande Guerra. E in quello stesso periodo giù nei confini del mondo, nella sponda occidentale del Sudamerica, nel Cile per la precisione esse rappresentavano una forza lavoro diventata non solo più numerosa, ma anche più visibile nello scenario delle trasformazione urbane di fine ‘800. E nella semplicità della loro uniforme composta da un cappello, una borsa e un grembiule bianco queste donne sfidarono i pericoli dell'ingresso nel mondo del lavoro e i rischi di esporre la propria natura di donna nell'esercizio di compiti poco coerenti con il proprio sesso.
La guerra come motore di cambiamento
Le donne iniziarono ad essere impiegate come bigliettaie tranviare nel Cile nel contesto della Guerra del Pacifico combattuta dal Cile e gli alleati Bolivia e Perù dal 1879 al 1884. Proprio nel momento in cui lo sviluppo delle città richiedevano il potenziamento dei trasporti urbani la guerra spostava la manodopera proletaria maschile verso Nord dove si eseguivano i combattimenti. Ecco il connubio perfetto per la comparsa delle donne nel mondo dei trasporti tranviari.All’inizio furono considerate delle sostitute temporanee alla manodopera maschile ma finirono per diventare una parte attiva della corporazione dei tram sia come bigliettaie che come manovratrici e rimasero al loro posto per diversi decenni.
L’autore inglese Theodore Child nel suo libro Santiago nel 1890 ne fu stupito nel vedere che vi erano delle donne lavoratrici nei tram urbani: “Dalla guerra con il Perù, a quanto pare, le donne sono state impiegate come conducenti sui tram. La loro uniforme è composta da un cappello da uomo, una borsa e un grembiule bianco; Il resto è lasciato al gusto o alle risorse di ciascuno. Questo è l'unico paese al mondo in cui ho visto donne in una tale occupazione".
Le manovratrici proiettavano un'immagine potente forse per via della stranezza causata nel vederle svolgere un'attività dinamica e agile. Queste lavoratrici lontane dall'inerzia legata al lavoro di casa si trovavano a dover gestire la maleducazione e la prepotenza altrui che dovevano affrontare quotidianamente nello svolgere le loro funzioni.
“Queste dipendenti pubbliche – sostiene il giornalista e caricaturista cileno Jorge Delano- hanno richiamato l'attenzione dei visitatori stranieri. Sull'enorme e intricato ciuffo di capelli, il capello di paglia sembrava tenuto come per miracolo, in una posizione così civettuola che l'ala quasi copriva gli occhi. Parte della loro uniforme era un grembiule e una valigetta di pelle appesa alla spalla dove tenevano le carte; perché a quel tempo c'era una moneta d'osso, speciale per viaggiare in tram. C'erano gettoni rossi e neri, per la prima e la seconda classe."
Scandalo!
Le bigliettaie erano quindi diventate le nuove donne perverse, protagoniste di uno scandalo. E la stampa di fine secolo ne ha lasciato traccia, forse l’unica che ad oggi è soppravissuta sul passaggio di queste donne agli albori del trasporto metropolitano.
Juan Rafael Allende dramaturgo, giornalista e scrittore ce ne lascia diverse descrizione delle lavoratrici dei tram di Valparaíso nelle pagine del proprio quotidiano El Ferrocarrilito, rivista sugli usi e costumi largamente diffusa in quegli anni. Allende non esita a coprirle di improperi dando per scontato che fossero sempre pronte a mangiarsi gli uomini e a provocare putiferio: "[...] donne perverse che trascorrono tutto il giorno e tutta la notte in vettura a formare assembramenti e commettere disordini".
Le accusava inoltre di "comportamenti inappropriati", e aveva persino consacrato una sezione permanente alle bigliettaie, dove dettagliava con ironia e mordacità le presunte incursioni di queste donne. Aiutato da alcuni collaboratori Allende rendeva conto dei comportamenti "irregolari delle autiste” fornendo i loro nomi e numero di vettura, oltre al soprannome con cui erano conosciuti per strada. Così la Ramona, la Maruja e la Petronila rimasero immortalate nelle pagine del Ferrocarrilito fino ai nostri giorni.
Eccone un esempio della rubrica Conductoras pubblicata dalla rivista El Ferrocarrilito nel 1885: “La pasticciona numero 105 che lavora nel tram dell'Alameda la notte di martedì 22, nella vettura 138, ha rubato 11 centesimi ad alcuni passeggeri e poi li ha insultati cercando inoltre di farli arrestare. A Macúl (comune di Santiago de Chile) ancora chiedono di lei”.
E denuncia ancora: “Alla manovratrice che martedì 2 era nell'auto n. 79 da Santa Rosa, chiedo di non essere così spudorata da camminare con il sig. E.M. della cartoleria sita in via Estado numero 12.”
Sempre dalla penna di Allende vi era inoltre una sezione chiamata Temples che si occupava delle storie d'amore emerse tra manovratrici, manovratori e cotrollori della Compañía de Tranvías.
Le cronache dell’epoca erano piene di racconti, versi e caricature che alludevano alle tranviere nello sforzo di denigrare pubblicamente la loro immagine e ritenendole inefficienti nel loro mestiere, promiscue, corrotte e vanitose.
Nell’articolo Las cobradoras pubblicato dalla rivista Zig-Zag nel mese di agosto del 1905 si fa riferimento ad un articolo pubblicato all’estero nel quale le bigliettaie venivano rittratate come "donne che trascorrono le più complete cortesie con il passeggero [...] attente, galanti in guanti bianchi e divise scure, e che sicuramente vengono educate fin dall'infanzia [...] tutto lo rivela: l'eleganza dei loro modi colti, e anche la discrezione con cui a volte ricevono insulti da qualche impertinente della plebe che pretende di viaggiare gratis [. ..]”. In risposta a questa garbata descrizione la rivista Zig-Zag sosteneva che: “l'esperienza ci insegna che la triste realtà di ciò che accade non corrisponde alla descrizione lusinghiera con cui scorre il giornale estero che non è altro che una rosea fantasia...”.
E il discorso non si limitava alle considerazione legate al genere delle lavoratrici ma invadeva anche la dimensione della classe sociale di appartenenza di manovratrici e bigliettaie. Le lavoratrici tranviare, per la maggior parte, appartenevano al mondo proletario, il che li rendeva doppiamente sospettose agli occhi degli accusatori più accanniti. Si diceva che approfittassero delle loro funzioni, rubando sia ai passeggeri che alla compagnia dei tram. Venivano sovente accusate di utilizzare trucchi per ottenere dividendi a loro favore, come ad esempio rifiutarsi di dare il resto oppure sostenere di non avere gettoni, mantenendo così il valore del biglietto interamente per loro.
Le vetture tranviarie, sotto il controllo delle manovratrici donne, erano ritenuti luoghi conflittuali, poiché ciò che accadeva all'interno dipendeva, in definitiva, dalla volontà o dal favore di queste donne. Queste erano quindi giudicate come spazi in cui i comportamenti scomodi si accavallavano ai personaggi popolari irriverenti che agivano a danno dei residenti più illustri della città.
Le bigliettaie erano considerate insolenti e arroganti ed erano spesso oggetto di denunce che riscontravano un successo amplificato quando le persone colpite erano persone perbene ovvero membri della illustre società. Nei media dell’epoca le tranviere venivano spesso rappresentate in disegni e caricature con serpenti, rospi, ragni e altri tipi di animaletti indesiderati che uscivano dalla loro bocca e dalle loro mani.
“C'è un grave abuso […] che la direzione dell'impresa deve correggere per rispetto del pubblico e della morale e per la propria convenienza e decoro,” denunciava il quotidiano El Chileno nel mese di gennaio del 1885. “Ci riferiamo alla brutta usanza di lasciare che l’imperiale diventi una sorta di spettacolo itinerante, dove miserabili cantanti esibiscono le loro voci di cicala, suonano a graffi la chitarra e si lasciano andare agli applausi ed alle acclamazioni degli ubriachi che fanno delle battute inconvenienti. Che questa scena semibarbarica avvenga nelle vetture tranviarie, anche quando attraversano il centro della città, è veramente intollerabile, e che la polizia, in qualità di pubblico guardiano, dovrebbe impedire. Nelle notti d'estate, quando molti gentiluomini e intere famiglie della migliore società salgono sull’imperiale per godersi il fresco, sono inflitti da un tale disordine che spesso sono costretti ad astenersi da un onesto svago scendendo subito dall'auto [... ] Uno straniero che vede folle di ubriaconi e cantanti attraversare il centro di Santiago, gridando a loro piacimento e insultando il pubblico, crede senza dubbio, di essere in mezzo agli indios”.
Il miracolo...
Tuttavia vi era qualche occasione nella quale la figura delle bigliettaie venne presa seriamente nelle pagine di alcun giornale o rivista dell'epoca. E ciò accadde nell'accennare alla loro partecipazione agli scioperi e alle manifestazioni organizzate di volta in volta dal sindacato dei lavoratori tranviari.
In queste frangenti, le bigliettaie potevano essere descritte in modo rispettoso dagli stessi media che prima le avevano degradate senza troppe cerimonie. Nel 1912, la rivista Zig-Zag, in occasione dello sciopero dei tram a Valparaíso, pubblicò una foto di quattro bigliettaie che partecipavano alla giornata di sciopero oltre ad esprimersi in nuovi termini:: “il venerabile sindacato dei bigliettai e dei manovratori tranviari, insieme alla simpatiche manovratrici, si era svegliato di cattivo umore e si era rifiutata di lavorare... secondo loro, la Società non ha mantenuto le promesse fatte nello sciopero precedente; per il contrario sostengono che la Società continua a trattenere il loro stipendio a forza di multe costringendoli a fare dei malabarismi per ottenere il salario giornaliero, e quel che è peggio, secondo le bigliettaie costringendole a lavarsi le mani dove l'acqua non la userebbero neanche i dipendenti comunali […]”.
Ironie mediatiche a parte il fatto che le bigliettaie siano state riconosciute come parte di una corporazione forte e combattiva come quella dei lavoratori tranviari, ha dato loro un certo sostegno. Fu difatti nel contesto della lotta per le rivendicazioni sociali che furono considerate per la prima volta come individui e lavoratrici con dei diritti.
La rivista El Tranviario, organo ufficiale dei tranvieri affiliati alla Federazione dei Lavoratori Cileni chiedeva, nel 1920 il rispetto di un accordo con la Società Tranviaria, di cui avrebbero beneficiato direttamente le bigliettaie: "Qualche tempo fa è stata inoltrata alla Direzione la richiesta di fornire un posto a sedere per i bigliettai nella parte posteriore del tram. Ma ad oggi l'azienda non ha rispettato l'impegno preso... Intanto continua la diffusione della malattia varicosa, principalmente tra il personale femminile”. A questo punto alcune bigliettaie come Ana María Vilches avevano raggiunto un ruolo di primo piano nell'agenda degli affari sindacali. Ana María ad esempio, bigliettaia n. 463 dei Tram di Valparaìso fu l’incaricata della propaganda e della organizzazione del Consiglio n. 6 dei lavoratori tranviari della sua città.
Da un punto di vista di classe, le tranviere vennero anche considerate astute, vivaci e capace di realizzare con le proprie forze e le proprie risorse ciò che era stato loro negato. Tuttavia l'impronta negativa che dovettero sopportare in molti casi era decisamente maggiore di quella di altre occupazioni lavorative svolte dalle donne quali sarte e operaie nelle fabbriche.
Se dover lavorare per necessità era una cosa, un'altra era optare per un lavoro di strada. La loro manifesta esposizione ha innescato un duplice effetto di accettazione e repulsione all'interno di una società sospettosamente alterata dall’entrata in scena di uno dei simboli per eccellenza della modernità: il tram.
Fantasmi della storia
Nonostante le numerose testimonianze storiche e letterarie sulla vita lavorativa delle bigliettaie e manovratrici negli ultimi decenni dell'ottocento nei tram cileni, le fonti del censimento le omettono completamente fino a buona parte del novecento. Nel 1907 un censimento registra per la prima volta le manovratrici che raggiungono il numero di 19 mentre quello del 1920 individua 564 donne tranviarie, senza specificare se si trattasse di bigliettaie o di altro mestiere svolto da donne all'interno della Compañía de Ferrocarriles (nei paesi sudamericani il trasporto tranviario nacque come supplemento di quello ferroviario).
Diversamente di ciò che accade alle loro simili lavoratrici nelle fabbriche, opifici e persino dinamitifici quelle prime lavoratrici tranviarie sembrano aggirarsi tra le pagine della Storia come dei fantasmi senza nome, senza volto e senza voce. Nel contesto urbano di fine ottocento e inizio novecento si fa riferimento quasi esclusivamente a quelle donne impiegate nei settori industriali per lo più in qualità di operaie dimenticando che tale sviluppi coinvolsero il lavoro femminile anche in altri campi e altri mestieri come è il caso delle bigliettaie e manovratrici tranviarie.
Al peso della dottrina della domesticità impartita come il più importante commandamento sin dalla nascita, queste donne dovettero fare fronte anche a un clima che sembrava volerle cancellare dalla Storia. Forse per questo motivo di queste coraggiose e spavalde pionere dei primi trasporti urbani ad rimangono solo quei versi -per lo più diffamatori- che la letteratura e il giornalismo di un tempo abbiano voluto dedicare.
Immagini
Immagine 1. "Manovratrice di tram urbano"
Frank Carpenter, Sud America, 1899 http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/56152/img-1.jpg
Immagine 2. Rivista El ferrocarrilito, 46, 17.5.1886
http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/56152/img-2.jpg
Immagine 3. “A través de Santiago”, rivista Zig Zag, 63, 24.4.1906
http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/56152/img-3.jpg
Immagine 4. “La huelga de empleados de tranvía”, Zig-Zag, 369, 16.3.1912
http://journals.openedition.org/nuevomundo/docannexe/image/56152/img-4.jpg
Fonti
- Elisabet Prudant Soto, « Entre la infamia y el deleite. Las cobradoras de tranvías en Santiago de Chile y Valparaíso, 1880-1920 », Nuevo Mundo Mundos Nuevos.
- Necrol Theodore Child, San Francisco Call, Volume 72, Number 171, 18 November 1892.
- Child, Theodore, “Santiago en 1890”, Estampas del Nuevo Extremo, Ricardo Latcham, ed., Santiago, Editorial Nacimiento, 1941.
- El chileno,“Las cobradoras”, 02/10/1885.
- El ferrocarrilito,“Conductoras”, 28/12/1885, 05/02/1886.
- Zigzag, “Las cobradoras”, 20/08/1905.
- El chileno,“Un desorden que debe corregirse”, 16/1/1885.
- Zig Zag,“De Valparaíso. La huelga de empleados de tranvías”, 16/3/1912.
- El tranviario, “Asiento para el personal de cobradores”, 23/10/1920.

IL TRAM AL FEMMINILE
INTERVISTA A UNA MANOVRATRICE DI TRAM STORICO
di Marcela F. Luque
La storia ebbe inizio nel lontano 2007 quando la cameriera di un bar della città balneare di Mar del Plata, a sud della provincia di Buenos Aires ebbe il suo primo incontro con un tram: “un giorno alzai lo sguardo e mi trovai davanti questo tram portoghese appena acquisito per recuperare la memoria dei tram di Mar del Plata, scomparsi cinquanta anni prima”. Essendole sempre piaciute “le cose antiche e ferroviarie” iniziò a partecipare alle corse del tram storico e imparò anche a guidarlo. La storia di quella cameriera di poco più di 20 anni che guidava il tram portoghese per le strade di Camet (Mar del Plata) arrivò a conoscenza della Asociaciòn Amigos del Tranvìa de Buenos Aires (AAT) i cui membri decisero di farle visita.
Così offrirono il loro sostegno al progetto tranviario, “all’epoca -racconta- vi erano pochissimi collaboratori al progetto del tram storico di Mar del Plata e il sostenere il progetto era diventato una impresa ardua.” Fu il Presidente della Asociaciòn Amigos del Tranvìa de Buenos Aires, Aquilio Podestà, a coinvolgerla per frequentare i corsi di formazione per ottenere l’abilitazione alla guida dei tram storici della associazione. “Mi recavo a Buenos Aires alcuni weekend e oltre a lavorare in officina imparavo a guidare le diverse vetture del parco tranviario della Asociaciòn.” Fu così che conobbe Pablo, uno dei formatori ed il suo attuale compagno.
Oggi Guadalupe ha 46 anni, cinque figli, vive a Buenos Aires e di lavoro fa la consulente in gestione culturale, alimentare e ambientale. È una delle tante donne che collaborano con la AAT ma è la sola a ricoprire la mansione di motorwoman (il termine utilizzato in Argentina per fare riferimento alle oramai numerose manovratrici/conduttrici di tram). Ricopre tutt’ora diversi ruoli presso la AAT: da quello di motorwoman a quello di accompagnatrice e nel tempo libero continua anche a lavorare in officina. Anche i suoi figli più piccoli, di 10 e 12 anni partecipano alla vita dell’associazione. “Al momento in tutta la Argentina vi sono delle donne che guidano il Metrotram (Mendoza) e furono anche numerose le manovratrici di filobus nella città di Còrdoba. Anche la metropolitana di Buenos Aires annovera delle manovratrici donne ma quando io ho iniziato a guidare, nel 2007 ero un po’ la pecora nera: ero l’unica donna a guidare un tram!”
I tempi sono cambiati e per fortuna oggi Guadalupe non è la sola donna a collaborare con la AAT e nemmeno l’unica ad aver frequentato dei corsi di formazione per imparare a guidare un tram: “ma rimango comunque l’unica ad avere la patente che l’abilita a svolgere mansioni di motorwoman esclusivamente nelle vetture storiche della AAT.” Non essendovi un servizio tranviario attivo nella città di Buenos Aires la AAT eroga dei corsi di formazione per l’ottenimento della patente abilitante alla guida dei tram storici della AAT.
“Tante sono state le donne che hanno fatto storia nei 46 anni della AAT -ricorda Guadalupe- e di tutte loro ricordo in modo speciale Olga Fernàndez Arroyo che è stata un po’ la mamma dell’associazione. Molti dei traguardi raggiunti le dobbiamo a lei, al suo sforzo, al suo coinvolgimento. Era una che non accettava mai un NO per risposta”. Olga ad oggi non c’è più e Guadalupe si ritiene una di quelle fortunate che insieme alle altre colleghe donne sono riuscite a renderle omaggio mentre era ancora in vita e tutt’ora la ritengono il guardiano dei tram.
Guadalupe si sorprende che non sia ancora esaurita la discussione delle donne come lavoratrici nei trasporti metropolitani: “siamo tutte uguali e chiunque con le proprie capacità può imparare a guidare. Sono convinta che il ruolo della donna in quanto lavoratrice tranviaria abbia molto a che fare con la guida, che è uguale e forse anche più efficiente di quella maschile. Per quale motivo allora continuare a pensare che sia un mestiere di un solo orientamento o genere?”. E Guadalupe va oltre “Tutti al mondo abbiamo le potenzialità di imparare un mestiere e nel caso non fossimo bravi non è di certo dovuto a una questione di genere. Credo che la discussione della donna discriminata sia una cosa obsoleta. Mi auguro che presto parleremo di capacità e abilità e non di genere oppure di orientamento sessuale.”
La Asociación Amigos del Tranvía de Buenos Aires (AAT)
La Asocación Amigos del Tranvía è un ente civile senza scopo di lucro fondato il 16 luglio del 1976 che svolge una serie di attività culturali e ricreative volte a diffondere al pubblico l'importanza storica ed i pregi attuali del tram. La loro iniziativa più importante è quella del Tram Storico di Buenos Aires, un museo vivente di tram restaurati che dal 1980 opera tutti i fine settimana nel quartiere di Caballito, offrendo delle corse gratuite lungo un percorso di 2 km dei quasi 900 che hanno caratterizzato la rete tranviaria di questa città nel suo miglior momento.
Oltre alla conservazione, alla restaurazione e alle numerose conferenze sul passato, presente e futuro del tram la Asocación Amigos del Tranvía gestisce la Biblioteca Popolare "Federico Lacroze", centro di documentazione che conta con una sezione specializzata nel trasporto urbano, con approfondite informazioni sugli aspetti storici e tecnologici dei mezzi di trasporto.
Immagini

I TRAM DELL'UCRAINA IN GUERRA
di Gianpiero Bottazzi
La guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina sta causando morte e distruzione e ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo, come mai avremmo potuto immaginare fino a poco tempo fa. Nelle foto che pubblichiamo si vedono gli effetti dei bombardamenti, del 3 marzo, sulla rete tranviaria e sul deposito dei tram di Kharkiv, la seconda città del Paese. Le immagini trasmesse ininterrottamente da social e reti televisive raccontano le città assediate sotto i bombardamenti, senza acqua ed elettricità e dove cominciano a mancare i beni di prima necessità. Milioni di persone sono in fuga con qualunque mezzo, anche a piedi per decine e decine di chilometri, immagini di donne che vagano per i sotterranei della metropolitana di Kiev si alternano con quelle di bambini che salutano i papà affacciati ai finestrini del treno alla stazione di Dnipro.
In questa situazione tragica anche i tram subiscono le conseguenze dagli attacchi sulle città. L'Ucraina ha una grande tradizione tranviaria e, prima dell'invasione russa, aveva più di 2.200 tram in 19 città con una rete complessiva di quasi 1.000 chilometri e 159 linee. La capitale Kiev ha la rete più estesa: 145 chilometri percorsi da 19 linee con più di 400 tram. La seconda città tranviaria (oltre che per numero di abitanti) è Kharkiv con 300 tram su 109 chilometri di rete e 13 linee. Sulla città dell'Ucraina settentrionale si sono susseguiti in questi giorni pesanti bombardamenti che non hanno risparmiato il deposito dei tram di Saltovske che ha subito gravi danni. Una buona notizia è che la città di Praga ha annunciato l'intenzione di donare 15 Tatra T6 a Kharkiv. Le immagini mostrano la rete tranviaria e molti tram pesantemente danneggiati. Una foto singolare, e drammatica nello stesso tempo, è quella di un missile inesploso con sullo sfondo un Tatra T6 ex Praga: tornano alla mente le immagini delle distruzioni sui tram di Torino durante la seconda guerra mondiale.
In questi giorni Zaporozhye, sede della più grande centrale nucleare in Europa, è diventata nota in tutto il mondo per il rischio di una esplosione atomica. Si tratta di una città di 700.000 abitanti con una rete tranviaria di 50 chilometri, 122 tram e 10 linee. Una delle città più colpite dalla guerra è Mariupol, importante centro industriale sul mar d'Azov con 500.000 abitanti: qui ci sono 80 tram che viaggiano su 11 linee e 50 chilometri di rete. Infine un cenno alla terza città ucraina: Dnipro, importante porto fluviale con un milione di abitanti, ha una vasta rete tranviaria di 88 chilometri e 250 tram su 14 linee.
IMMAGINI
fig. 1 - Tram Tatra T3 n° 708 nel deposito Saltovske dopo il bombardamento (foto H_Saltovka)
fig. 2 - Tram storico MTV-82 n° 844 nel deposito Saltovske dopo il bombardamento (foto H_Saltovka)
fig. 3 – Tram distrutti dopo il bombardamento nel deposito Saltovske (foto H_Saltovka)
fig. 4 - Tram Tatra T6 n° 8648 nel deposito di Salt dopo il bombardamento (foto TVCR)
fig. 5 – I tram Tatra T6 dismessi da Praga promessi all'Ucraina (foto TVCR)
fig. 6 – Missile inesploso con sullo sfondo un tram Tatra T6 ex Praga
fig. 7 – Tram danneggiati nel piazzale innevato del deposito Saltovske (foto H_Saltovka)
fig. 8 – I danni delle bombe sulla rete tranviaria (foto Анатолий Афейчук)
fig. 9 - Tram Tatra T6 pesantemente danneggiato nel piazzale del deposito Saltovske (foto Andrej Seva)

IL TRAM MTV-82 DI KHARKIV
di Luca Giannitti
Tra le terribili immagini delle devastazioni dovute alla guerra tra Russia e Ucraina non potevano passare inosservate quelle del deposito tranviario di Kharkiv1, seconda città per popolazione dopo la capitale Kyïv2. Il bombardamento è avvenuto nella notte del 3 marzo 2022 e non è noto il numero di vittime, ma le fotografie dei tram distrutti hanno fatto il giro del mondo (Russia esclusa). Il deposito Saltovske è stato quasi completamente distrutto, il 50% dei tram sono stati distrutti e i restanti gravemente danneggiati (solo un paio di dozzine di vetture sono ancora integre). Le vetture danneggiate, spesso in modo irreparabile, sono perlopiù Tatra (T3 e T6) ma anche altri mezzi sono stati colpiti. Uno in particolare merita di essere ricordato per il suo peculiare valore storico e non ci stupiremmo se venisse un giorno ricostruito: la vettura 844 modello MTV-82 (МТВ-82 in cirillico).
L'MTV-82 è un tram sovietico a quattro assi e l'acronimo è composto dall'abbreviazione di "Veicolo Tranviario di Mosca" con il luogo di produzione originario, ovvero la fabbrica militare n°82. La produzione iniziò nel 1947 e nel 1949 venne trasferita a Riga dove proseguì fino al 1961. In tutto sono stati realizzati 2160 tram (453 in Russia e 1707 in Lituania) che hanno prestato regolare servizio fino ai primi anni '80 in numerose città. I tram erano molto apprezzati per la loro semplicità, robustezza e longevità, tanto che molte vetture dismesse vennero riconvertite in mezzi di servizio.
L'esterno del tram si presenta con una carrozzeria tondeggiante dalle linee vagamente riecheggianti le PCC americane. E' monodirezionale e dotato di due porte pneumatiche poste alle estremità (solo sulla linea 19 di Odessa e a Zaporizhia sulla linea 5 gli MTV-82 vennero modificati in bidirezionali e restarono in servizio fino al 1989). Anche l'impianto frenante principale è pneumatico. I due carrelli ospitano ciascuno due motori da 55 kW che permettono di raggiungere i 55 km/h di velocità massima e il controller è di tipo reostatico. Inizialmente tutti gli impianti erano alimentati a 600Vcc (i primi con dotati di un pantografo, la produzione successiva con un archetto) poi, come successo un po' ovunque, è stata introdotta la bassa tensione (24Vcc) per l'illuminazione e la fanaleria. Complessivamente lungo 13,6 metri, largo 2,55 metri e alto 3 metri, dispone di 40 posti a sedere (in alcune versioni addirittura 55) e una capacità di circa 120 passeggeri.
La parte più curiosa dell'MTV-82 è come si è giunti alla sua realizzazione. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale in molte città dell'URSS si resero necessari nuovi filobus e il NAMI (l'istituto scientifico centrale di ricerca e sviluppo automotive) predispose un nuovo telaio unificato per autobus e filobus, copiando un prodotto della General Motors. Ma se la richiesta di filobus era di una settantina di veicoli, il numero di telai realizzati fu molto maggiore e non essendo disponibili motori a sufficienza per completarli tutti, le eccedenze vennero accumulate nei magazzini della fabbrica. Il destino sembrava segnato fino a quando un capo ingegnere della commissione tranviaria di Mosca, Anton Ivanovich Livinenko, non ebbe l'idea di riciclare i telai per realizzare un modello di tram. L'operazione di "adattamento" avvenne nell'officina SVARZ (lo stabilimento Sokolniki a Mosca, specializzato nella riparazione e produzione di mezzi pubblici, filiale dell'impresa statale Mosgortrans) e l'idea riscontrò subito un buon successo. Anche se i primi veicoli erano privi di rastremature che rendevano i tram molto ingombranti in curva, con il proseguo delle lavorazioni si ovviò anche a questo problema. Il tram, tuttavia, non era progettato per lavorare in trazione multipla o con rimorchi ma la sua grande capacità sopperì questa limitazione. Tre vetture MTV-82 sono conservate nei musei in condizioni pressoché originali e per la precisione nelle città di Mosca, Ekaterinburg e Nizhny Novgorod. A Odessa uno degli MTV-82 sopravvissuti è stato modificato in una versione a "giardiniera" con parte delle fiancate sostituite da una cancellata.
In foto l'MTV-82 preservato storico a Mosca e l'MTV-82 di Odessa modificato in tram-cisterna, anch'esso preservato nel locale museo. Foto tratte da Transphoto.org
Tra le varie città dove i tram MTV-82 hanno prestato servizio vi era la città di Kharkiv, la cui rete tram era nel 2017 estesa per 217 km di binario e 469 km di linee (13 regolari più una turistica), con 276 tram di linea e 42 di servizio. Nel 2006 a Kharkiv erano attivi una cinquantina di MTV-82 usati tutti come veicoli di servizio (al tempo su 62 vetture totali utilizzate come tram da lavoro). Tra questi vi era l'unità di servizio 844, costruita nel 1957, che non essendo stata troppo modificata, venne scelta per il restauro. Il tram aveva prestato servizio di linea fino al 1971 quando venne dirottato come veicolo per misurazioni. Ma quali misurazioni venivano effettuate? Erano molteplici: si misurava lo scartamento, la rettilineità delle rotaie (sia sul piano verticale che orizzontale), lo stato dei giunti. Cercando sul web alcuni video di tram a Kharkiv (in fondo all'articolo ne trovate alcuni), noterete uno stato dei binari decisamente precario, tuttavia i tram li percorrevano incredibilmente senza particolari difficoltà. Le misurazioni venivano effettuate da sensori posti sul secondo carrello, demotorizzato, mentre il primo era utilizzato per la propulsione.
In foto la 844 nello stato di tram di servizio ripreso nel 1971, 1989, 1990 e 2001. Foto tratte da Transphoto.org
Nel 2006, nell'ambito delle celebrazioni del 100° anniversario del tram elettrico di Kharkiv, la vettura fu restaurata con la peculiare livrea rosso-gialla nonché rinumerata 055, utilizzando lo stile tipico "stencil" delle matricole sovietiche. Tuttavia nel 2021, per l'occasione della sfilata e della mostra dei tram dedicata al 115° anniversario dell'apertura della prima linea di tram elettrici, la vettura 055 è stata nuovamente sottoposta a restyling, riottenendo la sua matricola originale 844. Dal 2006 il tram è stato utilizzato come vettura per noleggi ed era regolarmente impiegato sulla linea storica 12, insieme o in alternativa agli altri tram storici della città. A Kharkiv il parco storico era composto da 9 motrici e 4 rimorchi.
In foto l'MTV-82 restaurato, prima con la matricola 055 e poi 844. Foto tratte da Transphoto.org
Una delle ultime foto del tram è datata 31 dicembre 2021, in occasione dell'uscita per i festeggiamenti del nuovo anno, tuttavia il 2022 non è per nulla iniziato bene per l'Ucraina dato che il 24 febbraio, alle 5 del mattino, è cominciata l'invasione russa. La città di Kharkiv è stata ripetutamente bombardata e già nei primi giorni di combattimento ha riportando i peggiori danni. Il 28 febbraio è stato l'ultimo giorno di servizio dei tram, i cui percorsi erano stati nel frattempo improvvisati sui tracciati non colpiti. La notte del 3 marzo è stato bombardato il quartiere residenziale di Saltkov dove è localizzato anche il deposito dei tram, colpito da numerosi razzi che hanno distrutto molti veicoli parcheggiati all'esterno e hanno fatto crollare parte del capannone dove erano ospitati vari tram, in particolare quelli della flotta storica. La vettura 844 è rimasta schiacciata dalle travi in cemento e un suo ripristino appare al momento molto improbabile. Tuttavia date le caratteristiche costruttive, la robustezza delle parti e la loro semplicità, non è escluso che un giorno il tram possa tornare in vita. Al momento la situazione è completamente instabile ed è impossibile fare previsioni. Tra le varie vetture colpite occorre anche menzionare il tram storico numero 100, un raro modello X degli anni Venti restaurato nel 2005 e utilizzato per le riprese cinematografiche dei film "Liquidation" (2005) e "Dow" (2008). Anche questo tram si trovava nel deposito Saltovske durante il bombardamento ma è rimasto danneggiato in misura minore rispetto all'MTV-82.
In foto la 844 ripresa il 31 dicembre 2021 e poi dopo i bombardamenti del 3 marzo 2022; in foto anche la vettura 100 danneggiata. Foto tratte da Transphoto.org
Video sui tram di Kharkiv:
https://www.youtube.com/watch?v=jSgfvMtU-88
https://www.youtube.com/watch?v=iI2mclCno8c
https://www.youtube.com/watch?v=_-d5X6ip0yI
https://www.youtube.com/watch?v=RQ0LM7ZIbsM
1) Kharkiv è la versione ucraina del nome della città (Харків) mentre Kharkov è russo (Харьков)
2) Kyïv è la traslitterazione dalla lingua ucraina (Київ), il più noto Kiev deriva invece dalla lingua russa (Киев)
Слава Україні!

DA TORINO A CUNEO IN TRAM
di Davide Fenoglio
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, anche grazie ad appositi contributi pubblici, vengono costruite molte tranvie interurbane e ferrovie economiche che costituiscono vere e proprie reti interconnesse tra loro ed indispensabili per movimentare merci e persone in un’epoca in cui non esistono quasi i mezzi di trasporto privati. Una di questa è la linea che congiungeva Torino a Cuneo passando per Carignano e Saluzzo con numerose diramazioni. Questa rete fa capo alla Compagnia Generale dei Tramways Piemontesi, società per azioni con capitale belga, sede legale a Bruxelles ed amministrativa a Torino.
Il centro dei traffici passeggeri e merci nonché sede della principale officina è la città di Saluzzo, fin dal Medioevo importante snodo amministrativo e commerciale di tutta l’area circostante che si estende dalle Alpi alla pianura cuneese. La Compagnia Generale dei Tramways Piemontesi (CGTP) si costituisce nel 1882, ma già negli anni precedenti erano stati avviati studi, progetti e la costruzione delle prime linee.
Aiutati dalla cartina vediamo quali sono state le date di apertura di questa fitta maglia di collegamenti intercomunali che dal capoluogo regionale si estendeva fino alla provincia cuneese.

(cartina da Nico Molino, Il trenino di Saluzzo: storia della Compagnia Generale Tramways Piemontesi – Torino, 1981)
- 1881 Torino – Carignano – Moretta e diramazione Carignano – Carmagnola
- 1882 Moretta – Saluzzo
- 1881 Pinerolo – Cavour
- 1882 Cavour- Saluzzo
- 1879 Cuneo- Dronero
- 1880 Saluzzo – Cuneo
- 1887 Costigliole - Venasca
- 1903 Cuneo – Boves
- 1881 Saluzzo – Revello
- 1905 Revello – Paesana
- 1915 Revello – Barge
La rete, costruita con scartamento ridotto pari a 1100 mm, al suo apice si estende per quasi 190 km. È collocata prevalentemente in sede stradale promiscua e ha fermate piuttosto ravvicinate. È dotata di punti di interscambio con le Ferrovie dello Stato a Pinerolo, Saluzzo e Costigliole. In queste stazioni, brevi raccordi sono utilizzati per il trasbordo delle merci dai carri a scartamento ridotto a quelli a scartamento ordinario. Non abbiamo notizia di carri a scartamento standard trasportati su carrelli a scartamento ridotto come avveniva abitualmente altrove. La circolazione promiscua su strada probabilmente ha ostacolato questa pratica. Lungo la rete sono presenti anche cinque incroci a raso con la ferrovia con precise regole di attraversamento a Moncalieri, Saluzzo, Moretta, Pinerolo e Busca. La massicciata è costituita in genere, anziché da pietrisco, da più economici ciottoli e le rotaie erano da 18 Kg/m. La scelta dello scartamento a 1100 mm è dovuta a ragioni economiche. Inoltre, sul mercato è disponibile un buon assortimento di materiale rotabile con quelle caratteristiche. Solo le località principali sono dotate di stazioni con tutti i servizi per i passeggeri e le merci: biglietteria, sala d’aspetto, dormitori per i dipendenti, rimesse, piani caricatori e magazzini per le merci. Sono molte le fermate prive di strutture ed eventualmente dotate solo di piccoli locali in affitto per le esigenze del personale presente.
A Torino in alcuni tratti la circolazione avviene promiscuamente con la rete tranviaria urbana a 1445 mm: i due sistemi a diverso scartamento condividono una sola rotaia. Inizialmente il capolinea viene posto in via Nizza a fianco della stazione di Porta Nuova ed il deposito è situato nei pressi di piazza Carducci tra via Nizza e via Chisola. Nel 1928 il capolinea è spostato in piazza Nizza ed il deposito in corso Spezia angolo via Genova, luogo che nel secondo dopoguerra diventa anche il punto terminale della linea.
La dotazione originale della trazione a vapore comprende una quarantina di locomotive di varia tipologia e fattura (ognuna è “battezzata” con un nome proprio), una settantina di carrozze inizialmente a terrazzini e a due assi di colore verde scuro e centinaia di carri merci. Sono presenti carri di servizio, per lavori ed un carro gru, costruiti dalle officine aziendali trasformando altri rotabili.
Si racconta anche che fu allestita una carrozza speciale per Giovanni Giolitti che viaggiava saltuariamente sulla tratta Pinerolo - Cavour. Il Presidente del Consiglio, però non la utilizzò mai dal momento che preferiva “mischiarsi” con la gente comune. La stessa era stata realizzata anche per trasportare il vescovo di Saluzzo, il quale, però fece la stessa scelta del politico e la carrozza fu presto riconvertita agli usi ordinari.
La linea ha numerosi raccordi merci e dal Saluzzese legname, prodotti agricoli e manufatti giungono direttamente nella città più grandi, dove vengono trasbordati sui vagoni a scartamento ordinario delle Ferrovie dello Stato. I carri merci spesso sono agganciati ai convogli viaggiatori dando vita a convogli “misti”.
La possibilità di trasportare merci rappresenta una vera e propria rivoluzione per alcune economie locali che finalmente trovano sbocchi su mercati più ampi. Si pensi, ad esempio alle castagne raccolte nei boschi delle vallate alpine che da cibo indispensabile per la sussistenza diventano oggetto di commercio. Questo avviene principalmente grazie al tram che semplifica molto il trasporto. I contadini, gli allevatori, i commercianti utilizzano i convogli della CGTP trasportando con sé i loro prodotti ai mercati.
Sul finire degli anni Venti si sperimentano delle motrici ad accumulatori, sistema ritenuto più economico della classica elettrificazione con filo aereo. In questo modo si evitano tutti i costi dell’infrastruttura: pali, cavi e centrali di trasformazione. La sperimentazione parte nel 1925 con due elettromotrici che fanno servizio sulla tratta Torino - Carmagnola. I risultati sono molto positivi e i tempi di percorrenza si riducono del 30%. I passeggeri, molto soddisfatti anche per la presenza di riscaldamento ed illuminazione elettrica, aumentano notevolmente su quella tratta. Ai tempi del vapore si va da Torino a Saluzzo in tre ore e mezza, con i tram elettrici bastano poco più di due ore. Tra il 1925 ed il 1932 vengono costruite 6 motrici ad assi dalla SNOS ed altrettante a carrelli congiuntamente da TIBB e Carminati & Toselli. Queste consentono di ridurre notevolmente l’utilizzo delle locomotive a vapore, soprattutto in città e migliorare il confort di viaggio. I Tram a vapore non spariscono, ma sono concentrati sui servizi merci e di manovra.
Ma proprio in questi anni iniziano i tagli sulle linee meno frequentate: a partire dal 1935 i due rami per Paesana e Barge, la Cuneo-Boves ed anche il tronco Saluzzo – Pinerolo sono soppressi e gestiti con servizi automobilistici della Società Anonima Autolinee Piemontesi, consorziata della CGTP.
Nel 1936 la società cambia denominazione in Società Anonima Tramvie Interprovinciali Piemontesi (SATIP) a capitale totalmente italiano, con sede a Torino e direzione d'esercizio a Saluzzo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale le linea svolge un’importante funzione nel consentire agli abitanti della città di rifugiarsi in campagna durante i bombardamenti. Infatti, in questi anni il numero dei passeggeri aumenta notevolmente. I tram elettrici vengono sfruttati molto anche a causa della carenza di carbone, che era per la gran parte importato dall’estero. Perciò le elettromotrici sono utilizzate anche per il traino dei convogli merci. Come possiamo vedere dalle foto a corredo di questo articolo, gli impianti escono molto danneggiati dal conflitto così come parte del materiale rotabile e nel 1948 vengono soppresse le tratte Saluzzo - Cuneo, Costigliole – Venasca, Cuneo – Dronero e Carignano - Carmagnola. La tratta Torino – Saluzzo subirà la stessa sorte nel 1950, dopo che il capolinea era stato ancora stato arretrato in piazza Bengasi. I servizi automobilistici sostitutivi fanno capo alla Nuova SATIP.
Da allora cala il sipario su un sistema di trasporto con caratteristiche particolari che si è sviluppato a cavallo di due secoli fondamentali per l’evoluzione della società moderna. Il “trenino di Saluzzo” ha portato numerosi benefici ai paesi attraversati, ha collegato paesi di campagna e montagna alle città, spostato merci e persone. In un’epoca in cui viaggiare non era una cosa abituale, l’andare al mercato, a studiare o a lavorare in città con la tranvia diventa una grande opportunità. Il tram era molto più economico del treno e ha consentito a tante persone che prima non lo facevano, di spostarsi.
FOTOGRAFIE:
1) Il capolinea torinese quando era a fianco della stazione di Porta Nuova (collezione Paolo Chiesa)
2) Locomotiva “Dronero” con personale in posa (collezione Paolo Chiesa)
3) La Stazione di Cuneo (collezione Paolo Chiesa)
4) Carrozza a due assi (collezione Paolo Chiesa)
5) Locomotiva tranviaria “Garibaldi” con treno merci (collezione Paolo Chiesa)
6) La stazione di Revello (collezione Paolo Chiesa)
7) La stazione di Pinerolo di fronte alla Scuola di Applicazione di cavalleria (collezione Paolo Chiesa)
8) La fermata di Piasco (collezione Paolo Chiesa)
9) Il tram a Carignano (collezione Paolo Chiesa)
10) Convoglio con motrice ad accumulatori a Torino (collezione Paolo Chiesa)
11) Orario del 1937 (collezione Paolo Chiesa)
12) Orario del 1944 (collezione Paolo Chiesa)
13) Cartina della rete CGTP
Di seguito alcune foto del deposito di Torino dopo un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale (tutte foto Collezione Paolo Chiesa)
FONTI CONSULTATE:
Nico Molino, Il trenino di Saluzzo: storia della Compagnia Generale Tramways Piemontesi – Torino, 1981
Mario Bocca, Mario Governato, Tranvie intercomunali di Torino nelle immagini d'epoca 1880-1950 – Torino, 1999
Valter Bruno, Gian Vittorio Avondo, Tranvie di montagna del Piemonte – Torino, 2020
Paolo Arlandi, Binari per gli stabilimenti: il tempo dei raccordi industriali a Torino – Pinerolo, 2016

SPOSI IN TRAM
di Serena De Gaspari, introduzione di Luca Giannitti
Il 10 giugno 2022 sarà il decennale del primo (e finora unico) impegno della motrice storica 116 in veste "nuziale". Antonella e Stefano, soci Atts, scelsero il tram più antico per far arrivare in chiesa la sposa e ripartire uniti nella buona e nella cattiva sorte. Per preparare la giornata, fu necessario un lungo lavoro di squadra che impegnò i soci operativi in un profondo, quanto rapido restyling della motrice al tempo da poco ultracentenaria. Per celebrare l'anniversario riportiamo di seguito le memorie della socia Serena, testimone di nozze e impegnata in prima persona per i preparativi. Tutti i legni del tram vennero ravvivati, sulla carrozzeria si ripresero i piccoli danni dovuti al tempo, il controller fu dotato di nuove maniglie dorate come le originali e si preparò una insegna unica ed emblematica per la giornata: davanti riportava "Speciale 10-6-2012" e dietro l'iconico "Oggi sposi". Queste tabelle furono poi donate da Atts ai due neo-sposi. Negli anni successivi altri tram storici sono stati impegnati in servizi matrimoniali, ma in nessun caso con le modalità della veterana 116 nel 2012. L'evento di Stefano e Antonella attrasse addirittura la troupe del TG Regionale che viaggiò insieme alla sposa dalla sua abitazione in borgo Santa Teresina fino alla chiesa di San Tommaso. In calce all'articolo è possibile rivedere il servizio confezionato dall'indimenticabile Gianfranco Bianco.
Alcune immagini dei lavori di restyling del tram:
Serena ricorda: "Non capita tutti i giorni di essere scelti come testimone di nozze: è stato un grande onore ma anche una grande responsabilità perché oltre i tradizionali impegni ce n’è stato uno alquanto insolito, ovvero preparare l’ultracentenaria motrice 116. I due sposi, Antonella e Stefano, appassionati di tram e storia, avevano deciso di noleggiare il tram più antico e bello, per accompagnarli nel loro giorno più importante.
Tutto è iniziato a febbraio, quattro mesi prima delle nozze, quando la sposa mi ha chiesto di supportare Luca, colui che avrebbe poi manovrato il tram nel grande giorno, nella preparazione della 116 e nell'ideazione degli addobbi nuziali. Era importante la competenza tecnica del tranviere unita al mio gusto estetico femminile...
Uno dei primi incontri “progettuali” è avvenuto in occasione di un apericena in centro, dove mi aspettavo di discutere a tavola, tra salatini e pizzette, e così è stato ma a un certo punto a Luca i disegni e i fogli non bastavano più e, incurante della pioggia, mi ha trascinato fuori dalla caffetteria per fare un sopralluogo davanti alla chiesa, all'incrocio tra le vie S. Tommaso e Pietro Micca.
Al vaglio sono passati tutti i possibili scenari e le alternative adottabili qualora si fosse presentato qualche imprevisto. Chiedendomi se e quando Luca si sarebbe accorto della pioggia, ho ascoltato pazientemente la sua spiegazione, cercando di memorizzare il più possibile le informazioni. Mi sono altresì accorta che l’acqua e la (mia) stanchezza non costituivano elemento rilevante per Luca quando al posto di una proposta di andare a casa ha ribattuto con un “vieni qua, Serena, al centro dei binari in mezzo all'incrocio: c’è una visione ottimale e completa…”
Ricordo con simpatia anche la fiorista che, dopo essersi stupita per le mie richieste di rose bianche ed edera da sistemare su punti specifici di un tram storico, è stata molto collaborativa ed interessata, tanto che ha chiesto di vedere successivamente qualche bella foto degli sposti sul tram addobbato!
A questo punto occorreva dare una rinfrescata al tram. Povera 116, ne aveva di lavoretti necessari! È stata in gran parte smontata, ripulita, riverniciata e lucidata, con una partecipazione di soci sempre maggiore: più il tempo stringeva, più persone partecipavano ai lavori. Ancora la sera prima si lavorava sul tram: doveva essere tutto più che perfetto.
Il tocco di classe è stata la creazione delle velette: un gran lavoro di squadra mio e di Luca.
Il grande giorno è arrivato. Ho provato una forte emozione nel vedere la 116 avanzare, oscillando, con il suo inconfondibile scampanellio, sotto il viale alberato di corso Duca degli Abruzzi.
La sposa sorride entusiasta, da vicino si ammira meglio: perfetta, lucida, con una bellissima rosa bianca sotto il parabrezza e due festoni laterali bianchi e verdi.
Antonella sporge la mano per chiamare la “sua” 116, non vede l'ora di salutare il tranviere Luca, con la divisa d'epoca e il cappellino, e di salire all'interno: il legno ora è splendido, pulito e lucidato, i vetri sono assolutamente trasparenti e due piccoli vasi di rose ed edera fanno bella mostra di sé all’interno.
È stata una giornata intensa, perfetta sotto tutti gli aspetti, una grandissima festa, una serie interminabile di foto, una ricca folla di sguardi curiosi e stupiti per le vie del centro che si voltavano per ammirare questo piccolo gioiello tirato a lucido, con due sposi sopra!
Questo matrimonio è stata un'esperienza indimenticabile per tutti noi, e ancora una volta la 116 si è ritagliata un ruolo da protagonista: fiera, splendida e impeccabile come sempre, anche in veste “nuziale”".














